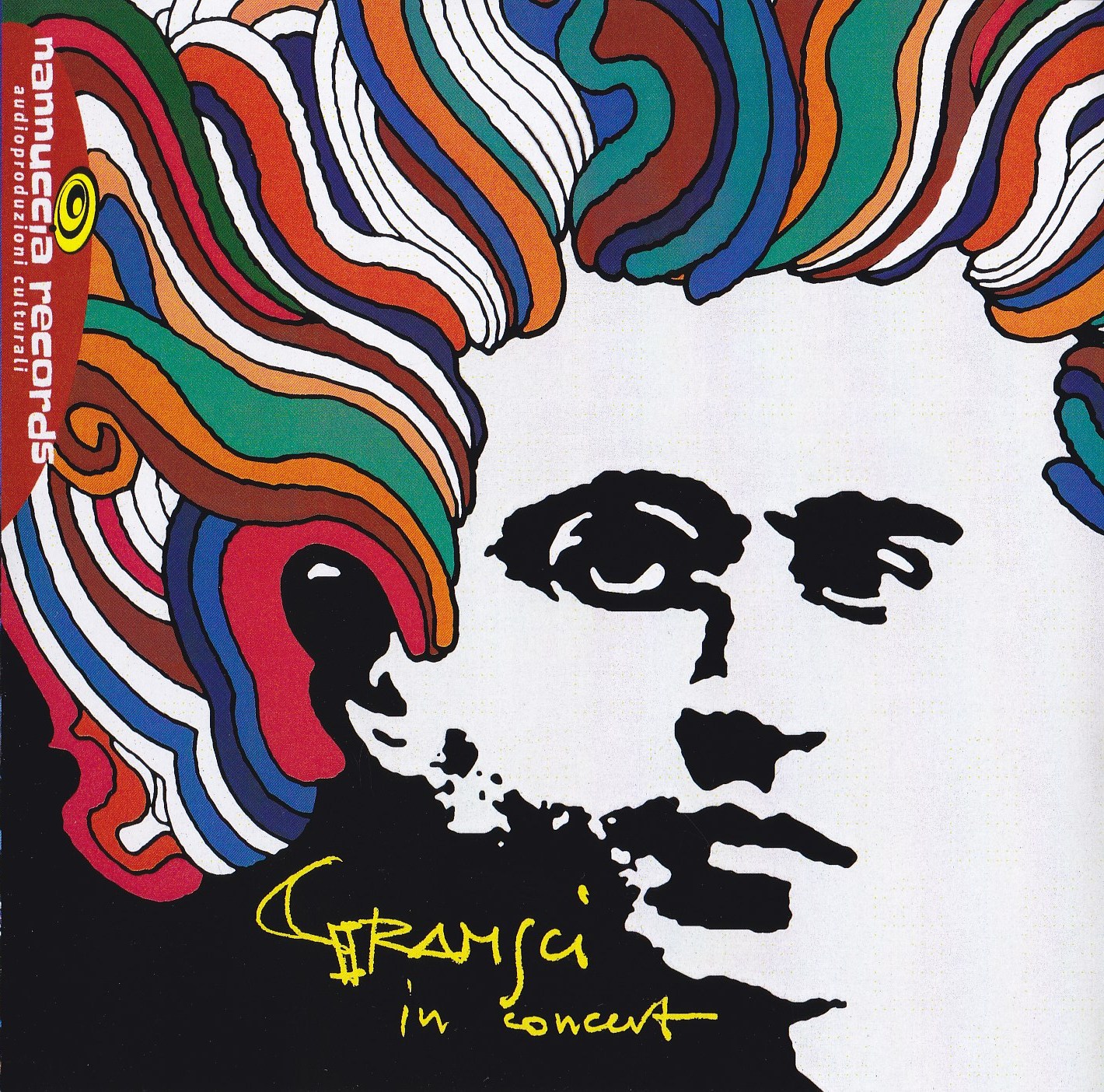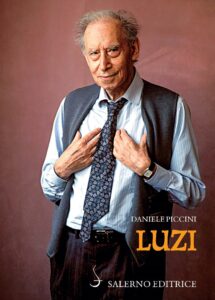trad. isometra di Daniele Ventre (da Omero, Odissea, ed. Mesogea, Messina, 2014)
Dentro la sala, frattanto, lo splendido Odísseo rimase,
e per i proci tramava insieme ad Atena l’eccidio:
Dunque a Telemaco in fretta parlò con alate parole:
«Dentro, Telemaco, è bene che tu le armi d’Ares deponga,
sì, tutte quante; ed ai proci, invece, con dolci parole
parla, se mai ne cercassero e ne domandassero conto:
«Le ho allontanate dal fumo, ché più non sembravano quelle
che nel partire per Troia Odísseo ci aveva lasciate,
sono annerite, fin dove è giunta la vampa del fuoco.
Ansia più grande mi pose un nume nel cuore, per giunta,
che suscitiate discordia fra voi nell’ebbrezza del vino,
che vi feriate l’un l’altro e poi funestiate il banchetto
e il corteggiare; da solo è stimolo agli uomini il ferro!»
Sì, così disse, e a suo padre Telemaco allora obbediva;
dunque chiamandola fuori, parlò alla nutrice Euriclea:
«Nonna, suvvia, nelle stanze per me tu trattieni le donne,
fino a che l’armi del padre al chiuso io non abbia riposte,
belle, che dentro la sala il fumo consuma d’incuria,
ora che il padre è lontano; io prima ero ancora un fanciullo;
voglio riporle, ora, dove il fumo del fuoco non giunga».
E di rimando gli disse la cara nutrice Euriclea:
«Figlio, se infine volessi avere una volta attenzione,
sì da curare la casa e guardare tutti i tuoi beni!
Ora però chi, venendo al tuo fianco, ti farà luce?
Serve, che luce t’avrebbero offerta, non vuoi far uscire».
Ed a lei dunque l’accorto Telemaco disse, per contro:
«L’ospite: non lascerò che rimanga inerte, colui
che del mio pane si ciba, benché da lontano sia giunto!»
Egli così le parlò: le restò senz’ali la voce:
chiuse la vecchia le porte alle ben tenute dimore.
Dunque balzarono in piedi Odísseo e il suo splendido figlio,
dentro portarono gli elmi e gli scudi adorni d’umboni
e acuminate le lance; ed innanzi Pallade Atena
con una lampada d’oro spandeva bellissima luce.
Ecco che allora si volse Telemaco in fretta a suo padre:
«Padre, che grande prodigio è questo che vedo con gli occhi!
Ecco, le mura di casa e insieme le belle campate,
come le travi d’abete e i pilastri in alto levati,
sono visibili agli occhi, nemmeno avvampasse una fiamma.
Sì, nella casa c’è un dio che abita il cielo spazioso!»
E gli diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Resta in silenzio, il pensiero racchiudi e non fare domande:
tale è l’usanza dei numi che hanno dimora in Olimpo.
Ora tu va’ a riposare, ché qui rimarrò solo io,
provocherò nuovamente le ancelle e con esse tua madre;
addolorata com’è, mi domanderà d’ogni cosa».
Sì, così disse; andò via, Telemaco, lungo la sala,
sotto il brillio delle lampe, a dormire nelle sue stanze,
là dove sempre giaceva, raggiunto da sonno soave;
lì si distese anche allora e attese la splendida Aurora.
Dentro la sala, frattanto, lo splendido Odísseo rimase,
e per i proci tramava insieme ad Atena l’eccidio:
E dal suo talamo uscì Penelope ricca di senno,
ed in figura eguagliava Artemide o l’aurea Afrodite.
Presso il camino le misero un trono–e su quello s’assise–,
ch’era intarsiato d’avorio e d’argento e dal carpentiere
fu fabbricato, da Icmalio, ed uno sgabello da piedi
ebbe adattato vicino, su cui un gran vello era steso.
Sì, su quel trono sedé, Penelope ricca di senno.
Bianche di braccia le ancelle le vennero intanto di sala.
Ed abbondanza di pane portarono via, con le mense
e con le coppe da cui bevevan potenti signori;
via dai bracieri gettarono i tizzi, poi molta altra legna
su vi disposero, sì che recasse luce e calore.
Ma nuovamente Melanto a Odísseo rivolse rampogna:
«Ospite, ancora sèi qui, per infastidirci di notte,
mentre t’aggiri per casa, magari a spiare le donne?
Vattene fuori, meschino, e contèntati del banchetto;
o te n’andrai fuori presto, colpito da qualche tizzone».
La guardò bieco e rispose Odísseo ricco d’ingegno:
«Trista, perché mi tormenti così, con la collera in cuore?
Forse perché sono logoro, indosso ho ben misere vesti,
mèndico in mezzo alla gente? La necessità mi costringe!
Già, sono fatti così i girovaghi e i mendicanti.
Ed anche io abitavo fra gli uomini un tempo una casa
prospera, ricca di beni e molto donavo a un mendico,
quale che fosse, qualunque bisogno l’avesse a me spinto;
e servitori infiniti avevo, e tant’altra ricchezza,
quanta ne hanno coloro che han fama d’agiati e di ricchi.
Pure, ogni bene distrusse Zeus Cronide –già, l’ha voluto–.
Donna, per questo ora bada anche tu a non perdere tutta
la vanagloria che adesso inalberi in mezzo alle ancelle,
se la padrona alla fine dovesse colpirti, adirata,
o ritornasse qui Odísseo (la sorte ha con sé la speranza)!
Anche se fosse perito e non più vedesse il ritorno,
pure, Telemaco ormai per grazia d’Apollo è cresciuto,
il figlio suo: fra le donne, nessuna a palazzo gli sfugge,
che sia sleale, poiché non ha più l’età d’un fanciullo!»
Sì, così disse e l’udì, Penelope ricca di senno,
mosse rampogna all’ancella, parlò, le rivolse parola:
«Certo che no, non mi sfuggi, tu, cagna impudente, sfrontata,
tale misfatto hai commesso, che lo laverai col tuo capo!
E ben sapevi ogni cosa, poiché da me stessa tu udisti
ch’io avrei fatto domande all’ospite nelle mie stanze,
quanto al mio sposo, poiché per lui ho crudele tormento!»
Disse, e rivolse parola a Eurinome, la dispensiera:
«Porta tu dunque un sedile, Eurinome, e sopra anche un vello,
sì che si possa sedere e parlare e udire parola,
l’ospite, presso di me: desidero fargli domande».
Sì, così disse e la donna in fretta si mosse a portare
un levigato sedile ed un vello sopra vi stese;
là si sedette a sua volta lo splendido Odísseo costante;
prima fra loro parlò Penelope ricca di senno:
«Ospite, questo da prima ti domanderò io in persona:
chi sèi al mondo, e di dove? E dove hai città, genitori?»
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Donna, di te fra i mortali nessuno su terra infinita
mai sparlerà: la tua gloria si leva nel cielo spazioso,
fama d’un sire impeccabile e incline a temere gli dèi,
d’uno che regni sovrano su eroi numerosi e valenti,
ben ministrando giustizia; e la nera terra produce
orzo e non meno frumento, son gli alberi colmi di frutti,
sana progenie han le greggi, e procura pesci anche il mare,
grazie al suo saggio governo, per lui la sua gente fiorisce.
Ora, però, tutto quanto domandami, nella tua casa,
ma della stirpe non chiedermi e non della terra dei padri,
per non riempire più oltre il mio cuore di sofferenze
a ricordarle; son troppo afflitto ed a me non bisogna
in una casa di genti straniere fra gemiti e pianti
starmene, no, poiché è male aver sempre pena infinita;
che non s’adiri con me un’ancella o forse tu stessa,
che non si dica che piango dal cuore oberato di vino!»
Gli rispondeva a sua volta Penelope ricca di senno:
«Il mio valore e il mio aspetto, o straniero, ed anche il mio corpo
han gli immortali disfatto, da quando per Ilio gli Argivi
sono partiti e partì Odísseo con loro, il mio sposo.
S’egli, una volta tornato, mi risollevasse alla vita,
anche più grande e più bella sarebbe così la mia fama!
Ora m’angoscio, poiché troppi mali un dio m’ha scagliato.
Tutti i più nobili, quanti sull’isole hanno potere,
tanto a Dulichio che a Same e a Zacinto verde di selve,
tutti coloro che sono i signori d’Itaca impervia,
a mio dispetto mi fanno la corte e distruggon la casa.
Ecco perché non mi curo dei supplici e degli stranieri,
né degli araldi, di quanti del popolo sono al servizio.
Dentro il mio cuore mi struggo e l’amato Odísseo rimpiango.
Gli altri m’affrettan le nozze; io frattanto inganni dipano.
Prima l’inganno del manto un dio m’ispirò nella mente,
prendere a ordire a palazzo una grande tela e imbastirla,
tela sottile ed immensa; ed in mezzo ai proci poi dissi:
«Giovani proci, poiché Odísseo splendido è morto
pur impazienti di nozze, attendete, fino a che un manto
non compirò –che le fila non vadano perse nel vento–,
funebre manto a Laerte eroe, per il giorno che a lui
venga la Moira funesta di morte diuturna di pene,
che fra le schiere d’Achee con me non si sdegni nessuna,
se giacerà senza veste chi già possedé tanti beni».
Sì, così dissi ed in loro persuaso fu l’animo altero.
Ecco che allora di giorno tessevo la grande mia tela,
e la sfacevo di notte, avendo le fiaccole accanto.
Dunque occultai per tre anni l’inganno e persuasi gli Achei;
ma, come fu il quarto anno, tornarono indietro stagioni,
al declinare dei mesi, e lunghi passarono i giorni,
ecco che allora per colpa di ancelle, di cagne impudenti,
vennero a cogliermi in fallo, e poi mi gridaron minacce.
E così io la compii, benché non volessi, di forza;
ora alle nozze non posso sfuggire, né più nessun altro
piano riesco a trovare; e mi pressano i genitori
a maritarmi, s’infuria mio figlio –gli ingoiano i beni–
ché ne ha coscienza; oramai è un uomo che più d’ogni cosa
è della casa sollecito, e Zeus gli concede fortuna.
Ora, però, la tua stirpe rivelami, donde tu venga;
certo non già dalla quercia primeva, non già dalla roccia!»
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«O venerabile sposa di Odísseo nato a Laerte,
dunque non recederai dal chiedermi della mia stirpe?
Ecco che a te la dirò; mi consegnerai a un dolore
grande più d’altro che soffro; ed è giunsto, se dalla patria
sua manca un uomo per tutto il tempo ch’io ora ne manco,
fra le città dei mortali errando e soffrendo dolori.
E tuttavia ti dirò ciò che tu mi chiedi e domandi.
Creta, una terra, si leva nel mare colore del vino,
bella e opulenta, dall’onde accerchiata; e d’uomini accoglie
gran moltitudine, stuolo immenso, e città ne ha novanta
–ha la sua lingua ogni popolo, è un misto; e vi sono gli Achei,
gli Eteocretesi dal cuore magnanimo, e anche i Cidoni,
e le tre stirpi dei Dori e splendide genti, i Pelasgi–,
Cnosso è fra quelle, la grande città di cui re fu Minosse
che s’incontrava con Zeus il grande, ogni nove stagioni,
e di mio padre era padre, di Deucalïone animoso.
Me generò Deucalione, e insieme Idomèneo sovrano;
questi però verso Ilio a bordo di navi ricurve
se ne partì con gli Atridi; Etone è il glorioso mio nome,
sono minore per nascita; il primo è Idomèneo e il più forte.
Là vidi Odísseo io in persona e gli diedi doni ospitali.
Già, ché l’aveva sospinto a Creta la forza del vento,
mentre puntava su Troia, dal capo Malea lo distolse;
egli in Amniso approdò, dove è l’antro sacro a Ilizia,
dentro non facili cale, a stento evitò le procelle.
Ci domandò d’Idomèneo, appena fu giunto alla rocca;
si proclamava suo amico ed ospite suo riverito.
Era oramai alla decima o forse all’undecima aurora,
dalla partenza per Ilio a bordo di navi ricurve.
Io lo condussi alla mia dimora e un buon ospite fui,
con ogni cura l’accolsi, poiché c’era molto a palazzo;
doni anche agli altri compagni che s’erano mossi al suo fianco
feci, prendendo farina dal popolo e limpido vino
ed immolando giovenchi, perché si saziassero in cuore.
Dodici giorni laggiù restaron gli splendidi Achei;
li tratteneva gran vento di Bòrea, e non ci lasciava
sorgere in piedi, anche a terra: un avverso iddio lo destava;
nel tredicesimo il vento cessò, se ne andarono tutti».
Molte menzogne fingeva, dicendone simili al vero;
ella, ascoltandole, ruppe in pianto e si sciolse il suo volto.
Come la neve si scioglie sui monti dagli alti crinali,
quella su cui soffia l’Euro, da poi che l’ha Zefiro sparsa,
e della neve disciolta si riempiono i corsi dei fiumi:
tali si sciolsero a lei, profusasi in pianto, le guance,
mentre piangeva il suo sposo a lei prossimo. Odísseo frattanto
s’impietosiva di cuore, al piangere della sua donna,
ma come corno i suoi occhi restavano, o simili a ferro,
sotto le palpebre immoti: celava le lacrime ad arte.
Ma non appena fu sazia del suo lacrimevole pianto,
ella di nuovo rispose con queste parole e gli disse:
«Ospite, adesso però di te voglio fare la prova,
se veramente laggiù coi compagni pari agli dèi
hai ospitato il mio sposo a palazzo, come tu dici.
Dimmi che foggia di vesti indossava sulle sue membra,
e quale aspetto egli avesse e i compagni giunti al suo fianco».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Donna, è difficile prova, poiché tanto tempo è trascorso
da quel momento; oramai il ventesimo anno è venuto
da che laggiù se n’è andato, è partito dalla mia patria;
e tuttavia ti dirò come sembra fosse al mio cuore.
Folto, purpureo mantello lo splendido Odísseo portava,
doppio; ed inoltre una fibbia a duplice scanalatura,
aurea, v’era attaccata; e un bel fregio aveva davanti:
fra le sue zampe anteriori un cane stringeva e guardava
uno screziato cerbiatto guizzare; ammiravano tutti
come quel cane, pur d’oro, stringesse e guardasse il cerbiatto
come, proteso alla fuga, guizzasse il cerbiatto coi piedi.
Vidi all’eroe sulle membra un chitone tutto sgargiante
ed era morbido al punto da rassomigliare alla buccia
d’una cipolla essiccata, e splendente, simile a un sole.
E lo guardarono in molte, davvero, ammirate, le donne.
E un’altra cosa ti dico, tu ponila dentro il tuo cuore;
io non lo so, se già a casa Odísseo li avesse sul corpo,
se da un compagno egli li ebbe, salendo sull’agile nave,
se da un suo ospite, già, poiché a molti Odísseo era stato
caro; ed in mezzo agli Achei in pochi eran simili a lui!
Ed anche io gli donai una spada bronzea e un chitone
tutto di porpora, doppio, e leggiadro e adorno di frange,
lo accompagnai con onore alla nave salda di banchi.
Ed al suo fianco un araldo di poco più avanti negli anni
era; e non meno di lui dirò quale fosse l’aspetto:
curvo di spalle, di scuro incarnato, chioma ricciuta,
ed il suo nome era Euribate; Odísseo pregiava più lui
di tutti gli altri compagni, ché avevano in cuore concordia».
Disse ed in lei ben più grande destò desiderio di pianto:
ben riconobbe quei segni sicuri che Odísseo svelava;
ma non appena fu sazia del suo lacrimevole pianto,
ecco che allora rispose con queste parole e gli disse:
«Ospite adesso davvero, se prima apparivi pietoso,
nelle mie case sarai ben accetto nonché riverito:
già, ché io stessa gli diedi le vesti di cui tu mi dici,
le dispiegai dalle stanze, appuntai il lucente sperone
sì che gli fosse ornamento… Ma non lo potrò riabbracciare,
ché non ritornerà a casa, alla cara terra dei padri.
Certo per triste destino Odísseo su concava nave
se ne partì per vedere Ilio infausta, l’innominanda».
E le diceva in risposta Odísseo ricco di ingegno:
«O venerabile sposa di Odísseo nato a Laerte,
non consumare il carnato gentile piangendo il tuo uomo,
non macerarti nell’animo. Oh, io non ti biasimo certo,
no, ché ogni donna s’affligge, se perde il legittimo sposo,
quello a cui diede dei figli, congiuntasi a lui nell’amore,
sia pur da meno di Odísseo, che dicono eguale agli dèi!
Smetti di piangere, dunque, e le mie parole comprendi:
ti parlerò con parola sincera e non celerò nulla
di quanto io del ritorno di Odisseo ho già appreso da tempo,
che non lontano, sul suolo opimo di genti Tesprote,
egli, ancor vivo, assai doni trasporta alla propria dimora,
chiestili in quella contrada. Sul mare colore del vino
perse i diletti compagni e insieme la nave leggera,
dalla Trinachia partendo, da un’isola; l’ebbero in odio
Zeus ed il Sole: i compagni uccisero i bovi del Sole.
Essi morirono tutti sul mare agitato dall’onde:
lui su una chiglia di nave i flutti han gettato a una costa,
terra di genti feaci, che sono congiunte agli dèi;
queste accordarono a lui di cuore gli onori d’un dio,
molto gli offrirono in dono, e volevano anche scortarlo
senz’altro danno qui in patria. E da tempo Odísseo sarebbe
qui: ma diverso disegno al suo cuore parve più saggio,
di radunare ricchezze scorrendo ampio tratto di terra:
già, poiché Odísseo più d’altri, in mezzo alle genti mortali,
vie di guadagno conosce, mortale con lui non gareggia!
Proprio così mi narrò il re dei Tesproti, Fidone:
egli giurò al mio cospetto, ed intanto in sala libava,
ch’era già in mare la nave ed erano pronti i compagni,
quelli che qui scorteranno Odísseo, alla terra dei padri.
Ma rimandò prima me; andava per caso una nave
di marinai dei Tesproti a Dulichio ricca di grano.
e mi mostrò tutti quanti i beni che Odísseo raccolse.
D’altri potrebbe allevare la decima generazione,
tanti tesori a palazzo del sire giacevan riposti!
Disse che s’era recato a Dodona, inteso a carpire
piani di Zeus dalla quercia divina dall’alto fogliame,
come potrà ritornare ad Itaca, terra opulenta,
–n’era lontano da tempo–, se incognito oppure palese.
Egli così s’è salvato, perciò, ti sarà ben vicino
presto, ed ancora lontano dai cari, da terra di padri,
non rimarrà lungo tempo: suvvia, ne farò giuramento.
Sappia per primo ora Zeus, lui, ottimo e sommo fra i numi,
e il focolare di Odísseo impeccabile, a cui son giunto:
si compirà senza dubbio ogni evento come t’annuncio.
Ora che muta è la luna Odísseo verrà a questi luoghi,
al declinare del mese, o al nascere del successivo».
E di rimando gli disse Penelope ricca di senno:
«Ospite, questa parola potesse adempirsi davvero:
conosceresti da me ben presto amicizia, con molti
doni, così che ti chiami beato chiunque t’incontri!
Altro s’attende il mio cuore, per come s’annuncia il futuro:
no, non ritornerà a casa Odísseo, e da lui tu congedo
non otterrai, poiché più non esiste in casa un padrone
simile a ciò che fu Odísseo fra gli uomini, se lo fu mai,
nel dare asilo e congedo agli ospiti suoi riveriti.
Ora lavacro fornitegli, ancelle, apprestategli il letto,
coltri e non meno lenzuola e anche coperte sgargianti,
giunga fra quieti tepori all’aurora trono-tutt’oro!
E l’indomani lavatelo e ungetelo presto, all’aurora,
che nella casa il banchetto vicino a Telemaco goda,
dentro la sala sedendo. E male per quello fra i proci
che roso in cuore gli dia fastidio, ché più nessun frutto
qui fra di noi coglierà, per molto che s’incollerisca!
Ospite, come di me capiresti che fra le donne
su tutte l’altre io eccello per mente e saviezza d’ingegno,
se mal vestito e dimesso dovessi sederti a banchetto
dentro la sala? Destino degli uomini è un vivere breve.
Uno che appaia crudele e crudeli azioni conosca,
ha per augurio dolori da tutti i mortali in futuro
mentre è ancor vivo, e da morto lo coprono tutti d’infamia;
Uno che candido appaia e candide azioni conosca,
vede fra gli uomini tutti diffondersi l’ampia sua gloria
grazie ai suoi ospiti, e sono in molti a chiamarlo valente».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«O venerabile sposa di Odísseo nato a Laerte,
no, le lenzuola, per me, nonché le coperte sgargianti
sono aborrite, da quando i monti innevati di Creta
abbandonai, e salii sulle navi dai lunghi remi;
io dormirò come ho sempre dormito le insonni mie notti.
Già, ché su turpe giaciglio di notti oramai ne ho trascorse
molte ed ho atteso la bella sul trono, la splendida Aurora.
Né tantomeno al mio cuore il lavacro per i miei piedi
giunge gradito; i miei piedi non li toccherà, no, una donna
fra tutte quante le serve che vivono nella dimora:
solo un’anziana, una vecchia che probi pensieri conosca,
una che avesse sofferto le pene ch’io pure ho sofferte:
ad un’anziana non io vieterei toccare i miei piedi».
E di rimando gli disse Penelope ricca di senno:
«Ospite mio, mai, finora, un uomo di tanta accortezza,
fra gli stranieri lontani, o più caro, in casa mi giunse,
con tale senno tu trovi per tutto un’accorta parola!
Vecchia un’ancella, sì, l’ho, chiude in cuore saggi pensieri,
quella che ben accudì l’afflitto, colei che lo crebbe,
presolo fra le sue braccia, appena lo fece la madre;
ella ti laverà i piedi, sebbene sia ormai senza forze.
Lèvati, adesso, suvvia, Euriclea, tu, ricca d’ingegno,
lava un coetaneo del tuo signore; anche Odísseo, magari,
è diventato così, nei piedi, e così, nelle mani:
nella sciagura i mortali raggiungono presto vecchiaia».
Sì, così disse, e l’anziana celò fra le mani il suo volto,
lacrime calde versò, e parlò parola di pianto:
«Ah, per te, figlio, rimango sgomenta! Te Zeus più degli altri
uomini ha preso ad odiare; e hai mente che teme gli dèi.
Mai un mortale bruciò per Zeus il signore del lampo
in tale numero cosci opulenti e scelte ecatombi,
quante ne offristi tu a lui, pregandolo, per arrivare
alla felice vecchiaia, e allevare il fulgido figlio;
ora a te solo del tutto fu tolta ogni luce al ritorno!
Forse lui stesso così ricopron d’infamie le donne
degli stranieri lontani, se è giunto a gloriose dimore,
come anche te queste cagne ricoprono tutte d’infamia,
e per fuggire le loro offese e le troppe insolenze,
tu non ti lasci lavare; oh, non m’ha forzata nolente,
no, non la figlia d’Icario, Penelope ricca di senno!
Sia per Penelope stessa io dunque ti laverò i piedi,
sia per pietà verso te, ché dentro hai commosso il mio cuore
con le tue pene. Ma via, ascolta parola ch’io dico:
qui sono giunti stranieri e miseri supplici, in molti;
mai prima d’ora, lo affermo, altri tanto simili ho visto,
quanto somigli tu Odísseo d’aspetto e di voce e di piede».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Vecchia, hanno detto lo stesso coloro che han visto con gli occhi
noi, tutt’e due, che davvero assai simili l’uno all’altro
siamo, così come tu, che hai mente assennata, confermi».
Disse; la vecchia prendeva intanto un bacile lucente,
dove soleva lavare i piedi ed in esso molta acqua
fredda versò, poi v’infuse acqua calda. E Odísseo, frattanto
presso il camino sedeva, ma svelto si volse nel buio:
all’improvviso temé nell’animo che ravvisasse
la cicatrice, prendendolo, e fosse palese il suo piano.
S’appressò ella, a lavare il suo re; all’istante conobbe
la cicatrice già inferta da un verro col candido dente,
quando al Parnaso l’eroe andò presso Autòlico e i figli,
da quel buon nonno materno che in mezzo alle genti brillava
per latrocinio e spergiuro; e questo fu dono d’un dio,
Hermes: infatti per lui i cosci d’agnelli e capretti
egli bruciò, ben graditi; e il dio gli era amico e compagno.
Come fu Autòlico giunto ad Itaca, terra opulenta,
vi ritrovò quel fanciullo che appena era nato a sua figlia;
ecco che allora Euriclea glielo mise sulle ginocchia,
mentre finiva la cena, parlò, gli rivolse parola:
«Trovalo dunque tu stesso, Autòlico, il nome che al figlio
d’una tua figlia imporrai: atteso da tempo a te viene».
E dispiegò la sua voce, Autòlico, e disse in risposta:
«Genero mio, figlia mia, imponete il nome che dico:
io sono giunto fin qui maturando l’odio per molti
uomini e donne su tutta la terra nutrice di genti:
dunque sia Odísseo il suo nome veridico. Ed io, per mio conto,
quando egli giunga nel fiore e la grande casa materna
abbia raggiunta, in Parnaso, nel luogo in cui sono i miei beni,
gliene darò parte in dono e poi lo rimanderò lieto».
E venne Odísseo da lui, perché desse doni stupendi.
E con abbracci e parole di miele accoglienza all’eroe
diedero subito Autòlico e i figli d’Autòlico insieme;
strinse a sé Odísseo anche Anfìtea, che fu di sua madre la madre,
e lo baciò sulla testa, e su tutt’e due gli occhi belli.
Ed ai suoi figli gloriosi Autòlico allora ordinava
di preparare un banchetto: ne udirono tutti l’invito.
Ed all’istante condussero un bove, un giovenco cinquenne;
trassero il cuoio, l’approntarono e tutto lo fecero a pezzi,
lo sminuzzarono accorti, l’infissero sugli schidioni,
con attenzione lo cossero e fecero infine le parti.
Quindi, per tutto quel giorno e fino al calare del sole,
si banchettò, nulla al cuore mancò d’un banchetto abbondante.
Ma, come fu tramontato il sole e la tenebra scesa,
tutti al riposo pensarono ed ebbero il dono del sonno.
Quando apparì mattutina l’aurora che ha dita di rosa,
mossero, andarono a caccia i figli d’Autòlico stessi
con i levrieri, e lo splendido Odísseo vicino ai levrieri
li accompagnò: del Parnaso raggiunsero l’erta montagna,
cinta di selve, arrivarono in fretta alle balze ventose.
E da non molto già il Sole veniva irradiando le terre
dall’instancabile fiume Oceano gorghi-d’abisso,
che i cacciatori alla valle pervennero, prima di loro
erano i cani, cercando le tracce, e frattanto a seguirli
c’erano i figli di Autolico; Odisseo splendido a questi
si accompagnava, squassando una lancia d’ombra allungata.
Là, nella fitta boscaglia un gran verro s’era annidato:
mai vi spirava la furia di vènti dall’umido soffio,
mai una volta coi raggi il sole fulgente passava,
mai vi scorreva la pioggia attraverso, tanto intricati,
erano, e vi s’ammassava un enorme mucchio di foglie.
Strepito d’uomini e cani e di passi giunse al cinghiale,
quando avanzarono in caccia; e la bestia incontro dal bosco
venne, rizzando le setole e fuoco le ardeva negli occhi;
prossimo a loro ristette. Ecco Odísseo prima degli altri
correre: alzò con la grave sua mano la lunga sua lancia,
già di colpire impaziente; però lo ferì prima il verro
sopra il ginocchio, e lambì molta carne con la sua zanna
–era balzato di fianco–, ma non sfiorò l’osso dell’uomo.
Colpo anche Odísseo vibrò, colse il verro all’òmero destro,
da parte a parte passò la punta dell’asta lucente;
cadde alla polvere il verro gemendo, e volò via la vita.
I cari figli d’Autolico allora gli furono intorno,
ed alla piaga di Odísseo impeccabile, pari a un dio,
posero accorto rimedio e col canto il livido sangue
gli tamponarono, e giunsero in fretta alle case del padre.
Cure giovevoli a lui prestarono e doni stupendi
diedero subito, Autòlico e i figli d’Autòlico insieme,
lo rimandarono lieto ad Itaca, in lieta amicizia,
rapidamente. E per lui il padre e la nobile madre,
quando tornò, s’allegrarono e gli domandarono tutto,
la cicatrice, e che fosse accaduto; egli appieno narrava
come, cacciando, fu còlto da un verro col candido dente,
quando era andato coi figli d’Autolico, là, sul Parnaso.
Su quella piaga la vecchia passò con aperte le mani,
e la tastò, la conobbe, e lasciò cadere il suo piede:
dentro il bacile piombò la gamba, echeggiò così il bronzo,
si reclinò da una parte e l’acqua si sparse per terra.
Gioia e dolore le avvinsero a un tempo i pensieri, i suoi occhi
furono pieni di pianto, la florida voce si spense.
Accarezzandogli il mento, a Odísseo così si rivolse:
«Figlio, davvero tu sèi Odísseo! Eppure non io
t’ho ravvisato, non prima d’aver ben tastato il mio sire…»
Ella gli disse e a Penelope intanto si volse con gli occhi,
tesa com’era a svelarle che in casa era giunto il suo sposo.
Ma non poteva, Penelope, in viso guardarla o vederla,
no, poiché Atena annebbiò la sua mente. Odísseo, frattanto,
con la sua destra sfiorò la gola alla donna e la strinse
l’accostò a sé con la mano sinistra e spiegò la sua voce:
«Balia, perché mi vuoi perdere? E ben m’hai nutrito tu stessa
alla mammella; ecco, adesso, pur molti dolori sofferti,
dopo vent’anni, son giunto alla cara terra dei padri.
Dunque poiché l’hai compreso –nell’animo un dio te l’ispira–,
taci, perché nessun altro qui dentro il palazzo lo sappia.
Sì, poiché questo ti dico e sarà già evento compiuto:
se per mia mano un dio faccia sterminio dei proci superbi,
anche se sèi mia nutrice, non te salverò, quando l’altre
donne mie ancelle dovrò uccidere dentro il palazzo!»
E di rimando gli disse Euriclea la ricca d’ingegno:
«Ah, figlio mio, che parola t’è uscita dal chiuso dei denti!
E tuttavia lo sai bene che è saldo il mio cuore e non cede:
io come duro macigno me ne rimarrò, come ferro.
E un’altra cosa ti dico, tu ponila dentro il tuo cuore;
se per tua mano dio faccia sterminio dei proci superbi,
t’indicherò una ad una qui dentro il palazzo le donne,
quelle che ti disonorano e quelle che sono innocenti».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Balia, perché tu dovresti svelarmele? A te non compete:
bene le ravviserò io stesso e conoscerò tutte;
serba il segreto in silenzio, piuttosto, e confida nei numi!»
Sì, così disse e l’anziana si mosse attraverso la sala,
acqua al lavacro portando, ché l’altra era tutta versata.
Poi, come l’ebbe lavato ed unto con olio lucente,
trasse di nuovo vicino al camino Odísseo il suo seggio,
per asciugarsi e celò sotto i cenci la cicatrice.
Prima fra loro parlò Penelope ricca di senno:
«Ospite, ti parlerò ancora per brevi momenti:
presto difatti vedrà il tempo del dolce riposo,
chi sarà colto da sonno soave, sia pur nell’angoscia.
Senza misura a me invece un nume ha donato il dolore:
già, poiché tutti i miei giorni di pianto e afflizione mi sazio,
alle mie opere bado e anche alle ancelle per casa;
quando però si fa notte e per tutti viene il riposo,
dentro il mio letto mi giaccio e fitte nel cuore oberato
e lancinanti mi pungono a darmi afflizione le cure.
Come la figlia che nacque a Pandàreo, il verde usignolo,
quando diffonde il bel canto, se ormai primavera s’appressa,
e tra le foglie addensate degli alberi sta appollaiata,
e di continuo volando effonde la voce echeggiante,
a lamentare il suo Itilo, il figlio che un tempo col bronzo
ella stroncò per follia, il seme di Zeto sovrano;
tale il mio cuore, di dubbio in dubbio, è indeciso fra due,
se rimanere col figlio e serbare tutto al sicuro,
tanto i miei beni che i servi e la grande, eccelsa dimora,
ed onorare il mio letto nuziale e la pubblica voce,
o accompagnarmi oramai al migliore che fra Achei
me nel palazzo corteggia e mi porge doni infiniti.
E il figlio mio, fino a quando era ancora ingenuo, un fanciullo,
non mi voleva sposata e via dalla casa nuziale;
ora che invece è cresciuto e giunto nel fiore degli anni,
quasi piuttosto mi prega di andarmene via dal palazzo,
per la ricchezza s’adira che stanno ingoiando gli Achei.
Ora, però, dammi ascolto e interpreta questo mio sogno.
Nel mio cortile ci sono venti oche che mangiano grano
fuori dall’acqua, e di loro io m’allieto, solo a mirarle;
ma calò enorme dal monte un’aquila adunca di becco,
tutte nel collo ferì e le uccise; a terra per casa
giacquero in massa, ma l’aquila all’etere splendido ascese.
Ecco che allora gemei e in pianto scoppiai, anche in sogno,
mi si raccolsero intorno le Achee dalle trecce gentili,
pietosamente piangevo per le oche dall’aquila uccise.
L’aquila s’appollaiò, tornata, sul bordo del tetto,
e mi calmò con parole umane e spiegò la sua voce:
«Abbi coraggio, tu, figlia d’Icario l’illustre di glorie:
vero presagio è, non sogno, e sarà già evento compiuto.
Erano i proci, quelle oche, ed io, ch’ero prima un uccello,
l’aquila, sono a mia volta il tuo sposo, io, che ora ritorno,
e getterò sopra tutti i proci un ignobile fato».
Disse così; mi lasciò il sonno soave di miele;
io nel palazzo osservai le mie oche, allora, e le vidi
che becchettavano il grano al trogolo, come da sempre».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Donna, davvero non è possibile intendere il sogno
se lo si spiega altrimenti, da poi che a te Odísseo in persona
svela che deve compirsi: palese è il destino dei proci
tutti, non uno potrà sfuggire alla morte, alle chere!»
E di rimando gli disse Penelope ricca di senno:
«Ospite, duri a spiegarsi, difficili a intendersi i sogni
sono, e per gli uomini certo non giungono a compiersi tutti.
Duplici s’aprono infatti le porte dei diafani sogni:
una ha battenti di corno e l’altra ha battenti d’avorio.
Quelli fra i sogni che vanno fra porte d’avorio tagliato,
solo producono inganno, recando parole incompiute;
quelli che vengono fuori passando fra il corno polito,
compiono schietti presagi, se appaiono ad uomo mortale.
Temo però che da qui non passasse, quel prodigioso
sogno: davvero una gioia sarebbe per me, per mio figlio!
E un’altra cosa ti dico, tu ponila dentro il tuo cuore;
questa sarà la funesta aurora, che condurrà via
me dal palazzo di Odísseo: voglio oggi proporre una gara,
sì, quelle scuri che Odísseo, qui dentro il palazzo ch’è suo,
come taccate ordinava in linea, dodici in tutto;
poi vi lanciava attraverso, da molto lontano, una freccia.
E sarà questa la gara che stabilirò per i proci;
l’uomo che tenda quell’arco con più faciltà fra le mani
e fra le scuri, fra tutte e dodici, lanci una freccia,
io seguirò e non altri, abbandonerò la dimora
delle mie nozze, assai bella, ricolma com’è di ricchezze,
quella di cui serberò il ricordo, io credo, anche in sogno».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«O venerabile sposa di Odísseo nato a Laerte,
non rimandarla oramai questa gara nelle tue case,
già, che da te tornerà Odísseo ricco d’ingegno,
prima che abbiano i proci toccato quell’arco polito,
prima che tendano il nervo e col dardo passino il ferro!»
E di rimando gli disse Penelope ricca di senno:
«Ospite, presso di me volessi sedere a palazzo
per confortarmi, mai il sonno mi si verserebbe sul ciglio.
Non è concesso però che sempre rimangano insonni
gli uomini, no, che per tutti i bisogni han posto misura
numi immortali ai mortali, su terra nutrice di biade.
Ed è perciò che oramai me ne salirò al piano alto,
mi giacerò dentro il letto ch’è fonte per me di lamento,
madido sempre di pianto si fa, da che Odísseo s’è volto
alla partenza, a vedere Ilio infausta, l’innominanda!
Lì cercherò il mio riposo; tu qui nella sala riposa,
o che ti stenda per terra o che ti preparino coltri».
Come ebbe detto, salì al piano più alto, sgargiante,
ma non da sola: con lei andavano l’altre, le ancelle.
Al piano alto salì, insieme alle donne sue ancelle,
e rimpiangeva il suo sposo, Odísseo, finché sulle ciglia
sonno soave le infuse, Atena dagli occhi di strige.

















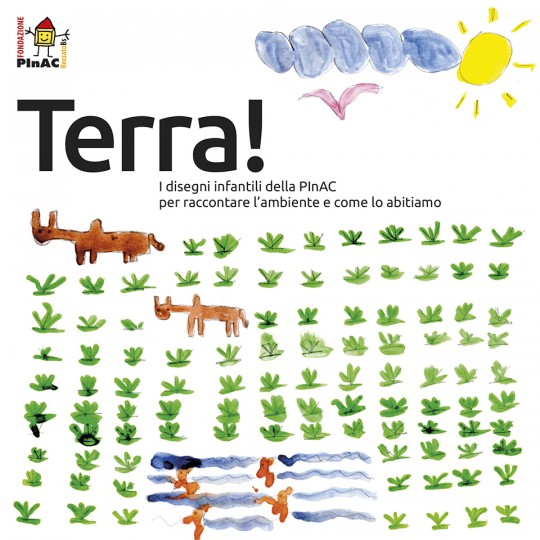
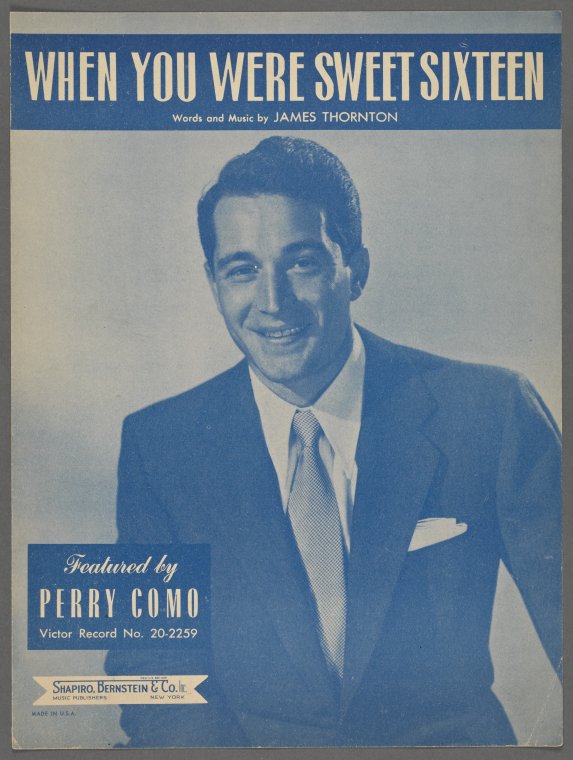


 Ettore Filibustiere, a dispetto del suo cognome, non era un uomo molto sveglio. Questa sua forma di pigrizia mentale gli aveva fatto perdere il lavoro presso la farmacia di paese, dove era stato assunto come aiuto-magazziniere. Proprio nello stesso piccolo negozio in cui dopo alcuni anni di (poco) onorato lavoro avevano assunto un giovane dalle braccia più veloci delle sue. Un operaio capace di essere anche più puntuale sul lavoro ben prima del momento in cui bisognava timbrare il cartellino e dare inizio alla giornata di lavoro. Eppure lui, Ettore, ogni giorno si alzava dal letto; per fare la sua parte. Guardandosi allo specchio diceva a se stesso frasi a effetto sentite dalla bocca del prete di paese. Parole che suonavano più o meno così:
Ettore Filibustiere, a dispetto del suo cognome, non era un uomo molto sveglio. Questa sua forma di pigrizia mentale gli aveva fatto perdere il lavoro presso la farmacia di paese, dove era stato assunto come aiuto-magazziniere. Proprio nello stesso piccolo negozio in cui dopo alcuni anni di (poco) onorato lavoro avevano assunto un giovane dalle braccia più veloci delle sue. Un operaio capace di essere anche più puntuale sul lavoro ben prima del momento in cui bisognava timbrare il cartellino e dare inizio alla giornata di lavoro. Eppure lui, Ettore, ogni giorno si alzava dal letto; per fare la sua parte. Guardandosi allo specchio diceva a se stesso frasi a effetto sentite dalla bocca del prete di paese. Parole che suonavano più o meno così: