
di Paola Ivaldi (testo e foto)
“… le cose sono là che navigano nella luce, escono dal vuoto per aver luogo ai nostri occhi. Noi siamo implicati nel loro apparire e scomparire, quasi che fossimo qui proprio per questo”
Gianni Celati (1989)

di Paola Ivaldi (testo e foto)
“… le cose sono là che navigano nella luce, escono dal vuoto per aver luogo ai nostri occhi. Noi siamo implicati nel loro apparire e scomparire, quasi che fossimo qui proprio per questo”
Gianni Celati (1989)




di Jewelle Gomez, traduzione di Michela Martini
per Dolores Has No Horses LeClaire
Mia madre è una turista in visita da me come io da lei
quando ero una bambina allevata da altri,
sempre preoccupata che mi dimenticasse.
Ora facciamo finta che mi abbia insegnato
a leggere o andare in bicicletta;
che mi aspettasse dalla porta
quando rientravo da scuola o mi guardasse
mentre mi vestivo per il primo ballo.
Ci comportiamo come se avessimo condiviso segreti
quando ero adolescente, ansiosa allora
che il mondo mi vedesse
per quella che sono… una bambina separata
dalla madre.
Mentre ci imbarchiamo sul traghetto
non siamo esattamente estranee;
ma neanche la piacevole evocazione
di mondi vissuti l’uno accanto all’altro
che si plasmano a vicenda.
Siamo due donne in età avanzata
che comprano ricordi dal
chiosco umido dei souvenir
vicino alla passerella,
facciamo fotografie che
ci ricorderanno di come ci assomigliamo.
È un’esperienza fredda e perversa
essere tra gente che non vede l’ora di
sbirciare attraverso le sbarre della prigione e
dare un’occhiata a una miseria trascorsa da tempo,
a fantasmi di rabbia incessante e
paura ingabbiata così vicini alle luci della città.
Solo quando tocchiamo terra la scintilla
dei Wampanoag e degli Ioway riempie i suoi occhi
come ha fatto con quelli di sua madre, come fa con me.
La polvere della prateria e le erbe marine dell’Atlantico
abbracciano questo litorale scosceso –
ostile e familiare;
mappatura delle origini.
Gli altri ci passano accanto su per il sentiero verso
il folclore del carcere. Noi andiamo in profondità, sotto
le spesse mura fatiscenti dove
la roccia incontra la roccia. Uno spazio sacro, non prigione.
Attraversiamo la distanza che ci separa
in quel luogo duro, rubato –
Ioway e Wampanoag incontrano
Ohlone, Pomo, Yurok, Hupa, Shasta e
Hopi, Modoc, Sioux, Paiute,
Inuit, Chocktaw. Una nazione di nazioni,
un leggero strascicare di piedi sulla pietra
in una danza destinata
a unirli tutti.
Sedute su una panchina alla fine ci diamo la mano
come forse abbiamo fatto quando ero bambina.
Tenendoci strette come se la pressione
dei palmi possa permetterci
di leggere nel nostro passato.
for Dolores Has No Horses LeClaire
Mother is a tourist visiting me as I did her
when I was a child being raised elsewhere,
always worried she’d forget me.
Now we pretend she taught me
how to read or ride a bicycle;
that she waited by the door for me
to arrive after school or watched me
dress for my first dance.
We act as if we shared secrets
when I was a teen, anxious then
the world would see me
for who I am… a child separate
from a mother.
Boarding the ferry
we are not exactly strangers;
nor are we a fragrant recollection
of worlds lived side by side
giving shape to each other.
We are two aging women
buying memories from
the souvenir stand
damp by the gangway,
taking snapshots that will
remind us how alike we are.
It’s a cold ride and perverse
to be among those eager to
peer through the prison bars and
glimpse long-passed misery,
the ghosts of anger pacing and
fear caged so close to city lights.
Only when we land does the spark
of Wampanoag and Ioway fill her eyes
as it did with her mother, as it does with me.
Prairie dust and Atlantic sea grasses
embrace this precipitous shoreline –
harsh and familiar;
mapping the beginnings.
Others stroll past us up the path toward
prison lore. We go deep, beneath
the thick, crumbling walls where
rock meets rock. Sacred space, not prison.
We cross the distance between us
on that hard, stolen place –
Ioway and Wampanoag meeting
Ohlone, Pomo, Yurok, Hupa, Shasta and
Hopi, Modoc, Sioux, Paiute,
Inuit, Chocktaw. A nation of nations,
the soft shuffle of their feet on stone
in a dance meant to
bind all together.
Sitting on a bench finally we hold hands
as we might have done when I was a child.
Clinging tight as if the pressure
of our palms will allow us to
read each other’s pasts.
NdR: sul sito di Jewelle Gomez, e qui, si possono trovare molte informazioni sull’autrice, poetessa/romanziera/critica e militante. Questa poesia, tradotta qui da Michela Martini, fa parte dell’installazione permanente della mostra sui nativi americani ad Alcatraz.
Michela Martini è nata a Genova e vive negli Stati Uniti, dove ha insegnato lingua, cultura e letteratura italiana presso la Indiana University, la Suffolk University e la University of California Santa Cruz. Ha co-fondato e diretto la Società Dante Alighieri di Santa Cruz in California e ha lavorato per la rivista «Chicago Quarterly Review». Le sue traduzioni in inglese di poesie e brani di Edoardo Sanguineti, Giorgio Caproni, Cristina Alziati, Gabriella Leto, Patrizia Valduga, Emanuele Trevi, Rossana Campo sono apparse su diverse riviste letterarie americane e nell’antologia curata da Geoff Brock The FSG Book of Twentieth-Century Italian Poetry. Per la rivista «Alfabeta2»ha tradotto il racconto di Scott Hutchins L’evoluzione del desiderio e per «Filigrane» e «Cenobio» raccolte di poesie di Ellen Bass.

Marìe canta la famiglia del secolo di Ida Travi è il settimo libro dei Tolki e il decimo titolo dei Cervi Volanti, la collana di scritture poetiche che curo insieme a Giuditta Chiaraluce all’interno del progetto Edizioni Volatili.


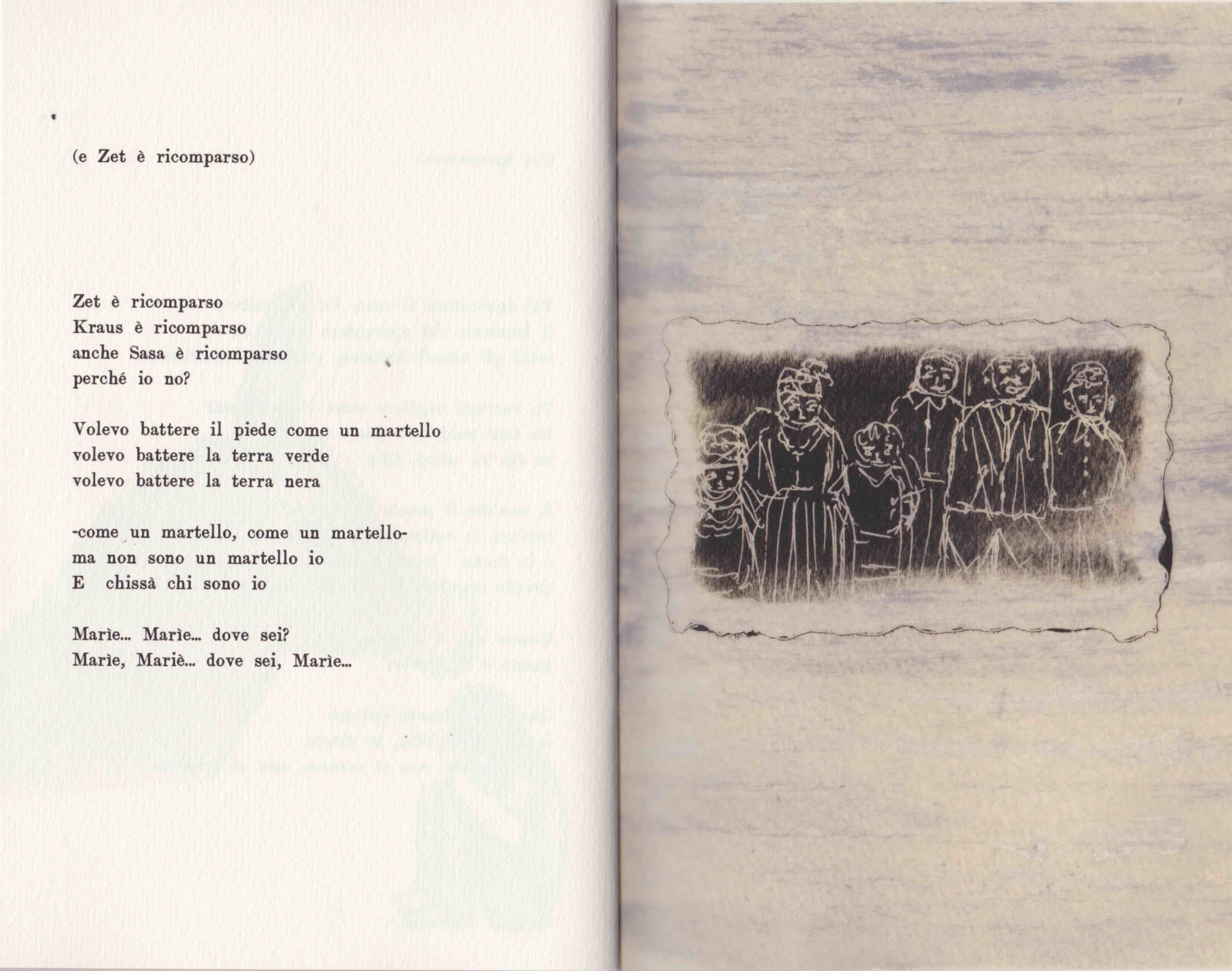
Ida Travi nasce a Cologne, Brescia, nel 1948. La sua poesia si inscrive nel rapporto tra oralità e scrittura, tematica che nel 2000 affronta con il saggio L’aspetto orale della poesia (Selezione Premio Viareggio 2001, terza edizione Moretti&Vitali, 2007), e nel 2015 in Poetica del basso continuo. In poesia per Moretti&Vitali pubblica la sequenza poetica sui Tolki, i parlanti, in cinque libri. Per il teatro l’atto tragico Diotima e la suonatrice di flauto edito da Baldini Castoldi Dalai nel 2004. Sui suoi radiodrammi e sue poesie alcuni compositori contemporanei hanno composto musiche originali.
 di
di
Effeffe
Grazie a Rocco Pinto , libraio e amico, sono riuscito a partire per Parigi con sottobraccio la copia de La città dei vivi, di Nicola Lagioia.
In treno ho staccato lo sguardo dalle pagine aperte sul tavolinetto, in quei momenti che Fernando Pessoa aveva definito intervalli tra il sé e il sé stesso , e mi è venuto in mente un viaggio fatto anni prima da Roma dove si era appena conclusa la fiera della piccola e media editoria, a Torino, città in cui allora risiedevo. Per puro caso, in quello stesso scompartimento, avevo incontrato Giorgio Vasta e per vincere la noia c’eravamo avventurati in una lunga conversazione su temi a noi cari. Non so come, ma solo perché non me ne ricordo la transizione, Giorgio mi cominciò a parlare dello sceneggiato, L’amaro caso della Baronessa di Carini e più particolarmente dell’omonima ballata della sigla d’apertura che, mi faceva notare Giorgio, diceva allo spettatore, d’emblée, come sarebbe andata a finire la storia.
Il romanzo inchiesta di Nicola Lagioia, questa sua ballata dal ritmo incalzante, perentorio, come ogni narrazione che si dedichi a una storia veramente successa, e sufficientemente raccontata dai media, non può riservare sorprese al lettore su come vada a finire perché la realtà non si cambia. Il solo “spazio” aperto rimane quello dell’interpretazione dei fatti, una genealogia degli eventi che sia in grado di illuminare le zone d’ombra, centrali o periferiche che siano, di una storia umanamente inspiegabile se non si accoglie un’idea dell’umano più complessa di quanto l’etica comune ci faccia credere.
I fatti:
L’omicidio Varani, risale al 2016. Manuel Foffo e Marco Prato si resero responsabili di un delitto caratterizzato da particolare crudeltà, uccidendo Luca Varani nell’appartamento di Foffo nel quartiere Collatino a Roma, colpendolo con oltre 100 tra martellate e coltellate. (Adnkronos)

di Ornella Tajani
A Napoli, fino al 6 gennaio 2021, si può vedere la casa di Rosa Parks, grazie a una installazione dell’artista statunitense Ryan Mendoza. È interessante scoprire il suo progetto, e riflettere sui suoi significati, alla luce del primo capitolo dell’Elogio del margine di bell hooks, appena riedito da Tamu Edizioni; il volume esce a cura di Maria Nadotti, che firma anche un’importante nuova prefazione.
L’opera di Mendoza, dal titolo “Almost Home”, è promossa dalla Fondazione Morra Greco e ospitata nel Cortile d’onore del Palazzo Reale: si tratta dell’abitazione di Detroit in cui Parks visse tra il 1957 e il 1959, dopo essere fuggita da quel sud in cui, nel 1955, aveva dato il via al boicottaggio dei mezzi di trasporto della città di Montgomery (Alabama), rifiutando di cedere il posto sull’autobus a un uomo bianco. Quella che oggi si può vedere è la casa che il fratello aveva preso in affitto, dove viveva con la moglie e i loro tredici figli e dove la ospiterà insieme al marito. Sarà solo circa vent’anni dopo che Sylvester Parks riuscirà ad acquistarla, ma intanto la sorella Rosa l’avrà già lasciata. Come sottolinea la docente Jeanne Theoharis all’interno del ben curato opuscolo informativo offerto a chi visita l’opera, Rosa Parks non ha mai avuto una casa sua: ecco perché il «focolare», come lo definisce hooks, condiviso con i propri parenti riveste un’importanza particolare.
Questa di Mendoza è una “installazione” nel senso etimologico del termine: un insieme di assi e di pezzi smontati e rimontati. Dopo aver acquistato la casa – ormai in pessime condizioni – per 500 dollari, la nipote di Parks ha contattato l’artista per cercare con lui una fondazione che la restaurasse e la preservasse come monumento storico appartenente alla collettività; il sindaco di Detroit, infatti, aveva previsto la demolizione di 80mila abitazioni, fra cui questa. Nessuno si è mostrato interessato, così la casa ha attraversato l’oceano in due container, per approdare temporaneamente a Berlino, nel cortile dell’artista; da lì è poi giunta a Napoli. Per una forma di rispetto Mendoza ha previsto che non si possa accedere all’interno: l’installazione si guarda dall’esterno e il suo titolo, “Almost Home”, «Quasi casa», rinvia all’auspicio ch’essa possa tornare un giorno negli USA, lì dove è giusto che faccia da memento. L’obiettivo dell’artista è quello di proporla come rappresentazione di «tutti coloro le cui storie possono solo essere immaginate e le cui pagine non saranno riportate nella storia d’America».
Oggi – scrive hooks, citata da Nadotti nell’introduzione al volume citato – la tematica che richiede il massimo della nostra attenzione è quella della rappresentazione.
Il primo capitolo del suo Elogio del margine si basa sul ruolo eminentemente politico che l’abitazione ha rivestito nelle lotte per i diritti civili: la casa «come sito della resistenza e della lotta di liberazione».
Costruire un focolare domestico non significava soltanto fornire dei servizi. Voleva dire costruire un luogo sicuro dove i neri potessero confermarsi l’un l’altro e, così facendo, guarire molte delle ferite che la dominazione razzista aveva inflitto loro. Nella cultura della supremazia bianca, all’esterno, non saremmo riusciti a imparare ad amare o rispettare noi stessi; è stato lì, all’interno, in quel «focolare domestico» per lo più creato e mantenuto da donne nere, che abbiamo avuto modo di crescere e progredire, di nutrire il nostro spirito. Il compito di costruire un focolare domestico, di fare della casa una comunità di resistenza, è stato condiviso globalmente dalle donne nere, in particolare dalle donne nere delle società suprematiste bianche.
hooks pone l’accento sullo sforzo che le donne nere compivano per non esaurire tutte le loro energie nei lavori di cura delle famiglie bianche presso le quali passavano gran parte della giornata, e per conservare una porzione di sé da offrire ai propri cari, al proprio focolare: tale sforzo va per l’autrice messo in valore come atto politico di resistenza, nonché come forma critica della definizione sessista «secondo la quale servire sarebbe il ruolo ‘naturale’ delle donne».
Ricordando l’angoscia che provava quando vedeva la madre andarsene per prestare servizio nelle case dei bianchi, hooks scrive:
Al suo rientro, dopo lunghe ore di lavoro, non si lamentava. Faceva di tutto per farci capire quanto fosse contenta di aver concluso la sua giornata di lavoro, di essere a casa; ma nello stesso tempo ci dimostrava che nella sua esperienza di lavoro come domestica al servizio di una famiglia bianca, in quello spazio di Alterità, non c’era nulla che le togliesse la sua dignità e il suo potere personale.
Uno degli strumenti dell’apartheid è proprio quello di impedire ai neri di costruirsi un’abitazione, primo nucleo comunitario:
I bianchi hanno trovato un modo efficace per sottomettere i neri a livello globale: costruire senza posa strutture economiche e sociali che sottraggano a molti i mezzi per farsi un focolare. Ricordarlo dovrebbe permetterci di capire il valore politico della resistenza delle donne nere nelle case. Dovrebbe fornirci la cornice entro cui discutere lo sviluppo della loro coscienza politica, riconoscendo l’importanza politica dello sforzo di resistenza che ha avuto luogo nelle case. Non è un caso che il regime di apartheid sudafricano attacchi e distrugga sistematicamente gli sforzi della nostra gente per costruirsi un sia pur precario focolare domestico, quella piccola realtà privata dove donne e uomini neri possono ricrearsi e ritrovare sé stessi. Non è un caso che questo focolare domestico, per quanto fragile ed effimero possa essere, quattro pareti tirate su in fretta e furia, un mucchietto di terra dove riposare, sia sempre esposto a violazioni e distruzioni. Perché, quando non si ha più lo spazio per costruirsi una casa, è impossibile costruire una vera comunità di resistenza.
È proprio nella direzione del recupero della memoria che va il lavoro di Ryan Mendoza, il quale, con il suo “The Rosa Parks House Project”, ha riprodotto già più volte il gesto simbolico fragile e potentissimo di “tirar su quattro pareti in fretta e furia”: prima a Berlino, poi a Providence, ora a Napoli.
Al momento in cui scrive, nel 1990, hooks afferma la necessità di ripensare questo luogo come «sito primario della sovversione e della resistenza».
Partendo da qui, potremo ritrovare la prospettiva perduta, dare alla vita un nuovo significato. Potremo fare della casa quello spazio dove tornare a rinnovarci e a curare noi stessi, dove guarire dalle nostre ferite e diventare interi (corsivo mio).
La storia travagliata di Rosa Parks dimostra quanto sia stato difficile per lei trovare un posto in cui guarire dalle ferite e trovare pace: morirà a 92 anni, dopo essere stata minacciata di sfratto per mancato pagamento dell’affitto (affitto invece regolarmente versato, secondo Elaine Steele, direttrice del Rosa and Raymond Parks Institute). Oggi l’opera di Ryan Mendoza invita a riflettere su questo travaglio e a risemantizzare il «focolare», sia sul piano simbolico, sia sul piano concreto, riproponendolo come un protagonista importante della storia del movimento per i diritti civili degli afroamericani.
di Antonio Francesco Perozzi

Mi piace parlare di Taccuino dell’urlo (2020, Marco Saya Edizioni) di Sonia Caporossi in termini di dialettica e “impaludamento”, intendendo con questi i due diversi impianti di significazione all’interno dei quali si muove il linguaggio del libro. Mi pare – voglio dire – che il Taccuino possa leggersi come reazione del linguaggio allo stress provocato da due spinte poietiche separate ma dipendenti l’una dall’altra: la prima, elastica, che nasce dall’energia che si agita tra due (s)oggetti in attrazione; la seconda, entropica, che viene dalla (e incide sulla) coesistenza/opposizione tra lo svelamento e l’occultamento di un quid reale nel (e attraverso il) linguaggio.
Di fatto, il libro racconta una relazione, amorosa e dolorosa, tra due soggetti. Nella sezione “Indizi” (di per sé già significativa: l’autrice lascia al lettore alcuni possibili strumenti ermeneutici, e il testo si annuncia in partenza come labirintico) le prime parole che si incontrano – che sono quindi le prime dell’opera – sono proprio «Lui e lei». Le pagine successive non faranno altro che interrogare, attraverso un linguaggio di cui ora proverò a studiare le caratteristiche, quanto in potenza già contenuto nell’incipit: la relazione – in senso metafisico, oltre che affettivo – tra due soggetti, che è, giocoforza, connessione e separazione al contempo (potremmo riconoscere nella congiunzione “e” l’allegoria della compresenza di vicinanza e lontananza).
Ma l’impianto dialettico, a mio avviso, è riscontrabile anche nella struttura del testo: trentadue poesie (segnate con numeri romani) sono inquadrate da altre tre composizioni (segnate con lettere greche) che scandiscono i tre momenti dell’opera. Anche seguendo queste sole poesie-cornice è possibile tracciare in linea di massima il percorso del Taccuino: α si incentra su atti di denotazione e percezione, tramite l’anafora di «ho visto» e l’individuazione di qualcosa «in un altro» (precisamente, «l’abisso», «il riflesso», «l’influsso», «l’ossesso»: si nota già qui la potenza della relazione, che chiama in campo immagini e concetti legati alla indeterminatezza, al buio, al dolore); φ segna la fase più acuta della disfunzione della referenza del linguaggio, e cioè – ma ci tornerò più avanti – della parola che si auto-sabota di fronte alla realtà («voglio solo addormentare questa voglia di volere»); ω, in chiusura, colloca nel silenzio («alla fine lui resta in silenzio») l’approdo risolutivo della dialettica (ma – e sarà più chiaro nelle righe successive – è un silenzio che non può farsi se non in simbiosi con la propria negazione, che è poi l’affermazione del linguaggio; tant’è che l’ultima strofa torna a parlare di scrittura, cioè di distruzione del silenzio).
Quando parlo di “relazione” e “dialettica” all’interno di questo libro intendo, perciò, lo spazio che intercorre tra «Lui e lei», ma anche il campo “magnetico-semantico” (la stessa autrice parla, in XXXII, di «campo d’azione», tra i due soggetti) provocato dal cercarsi di questi due soggetti, che si traduce (sul linguaggio) in termini di tensione distorcente e massimalismo. Maria Grazia Calandrone, che firma la prefazione, parla infatti di un rapporto «che disorienta, perché procede per contrasti e contraddizioni» e individua la miccia del caos nel dolore: «anche la lingua con la quale la relazione racconta sé stessa deve simulare il disordine della ferita, il dolore che scaglia fuori da sé.»
L’attrazione verso l’Altro (o il distacco da esso; comunque il riferirsi a) determina quindi una scossa interna alla sintassi. Da qui deriva quello che ho chiamato in apertura “impaludamento”, facendo implicitamente riferimento alla «palus putredinis» di Sanguineti: se le ragioni storiche, e perciò poetiche, di Laborintus possono ritenersi lontane da quelle del Taccuino, non pochi sono gli elementi che in questa Caporossi fanno pensare – almeno a me – a Sanguineti, come la deformità dei versi, l’accumulo di materiali, le lettere greche, i giochi di parole, l’innesto di vocaboli e concetti filosofici e accademici. Quello che soprattutto ci interessa, però, – e al netto comunque di altrettante ragioni di distanza tra l’autrice e il primo Sanguineti, come, ad esempio, il verso breve e la struttura fonico-metrica regolare di alcuni testi (entrambe le cose già in α) – è il generale sconquassamento dello strumento poetico che anche Caporossi mette meticolosamente in atto; e lo fa esplorando gli ambiti più vari del mondo verbo-visivo: dal deragliamento grafico dei versi sulla pagina all’uso di caratteri “speciali” (la parentesi graffa e i doppi due punti mi sembrano i più caratteristici), dal lessico “difficile” (la filosofia, le scienze, il greco, il latino; ancora più stridente se coinquilino del lessico pop, come nel caso della metafora calcistica su cui si impernia XXXII) all’evidenziazione di parole (corsivo, grassetto, ma anche il barrato, che cancellando mette in risalto).
La “palude” del Taccuino dell’urlo è quindi la palude di linguaggio originata dalla tensione incontrollabile che collega i due soggetti e si ripercuote sui versi in un gioco (tragico) di apparizione/sparizione dell’Essere nella parola. Ancora torna utile la prefazione, quando Calandrone scrive: «La scrittura di Sonia Caporossi è mossa dalla necessità di comprendere filosoficamente il mondo, che si dà silenzioso nei suoi nessi». Il poetico, potrei chiosare, nasce allora proprio dal fatto che il tentativo di comprensione filosofica del mondo – che richiede un sistema logico – si scontra con i vuoti del mondo stesso (la tensione irrisolta verso l’Altro) e quindi con gli effetti di quelli sul linguaggio (da cui la necessità di “Indizi” lasciati come viatico da chi scrive a chi legge).
Sono molti, infatti, e sparsi ovunque, i punti in cui il linguaggio si annuncia potente e impotente insieme e – anche in questo caso – con tecniche e intensità diverse: ne sono esempi le “negazioni tetiche” (negazioni che chiamano in causa, nell’immaginazione, ciò che negano: stessa strategia del testo barrato) su cui si fonda VI, gli ossimori («irragionevole ragione»), l’oscillazione tra esterno e interno dell’Io («prospettive e vedute / come fossero panorami del mio inconscio»), le dichiarazioni dirette dell’inefficacia materiale delle parole («in questa bieca pretesa / sensoriale del linguaggio», «chiamare il suo nome nel vuoto», «e nessuno risponde / a ciò che ha domandato»), le tautologie e i meta-processi («ragionare la ragione»), i versi che giocano su meccanismi paradossali e di circolo vizioso tra presenza e assenza («nell’ipocrisia / di questo industriarsi a non fare», «e non era stato mai / così prossimo / alla meta della perdita»).
Nel deragliamento del linguaggio generato dalla tensione emotiva-esistenziale tra due soggetti in attrazione-repulsione io vedo la ratio di questo libro, che non si risolve artisticamente, però, in una meta-poetica assoluta, ma diventa documentazione – seppur non mimesi – del reale proprio nel momento in cui si rivela franta e incontrollabile: né meta-poesia né referenzialità pure, ma un’estetica che abita lo strato intermedio tra realtà e linguaggio, l’alternanza tra asserzione e sottrazione di entrambi. Uno sforzo meticoloso – ecco il senso del titolo – di annotazione, di nominazione della sfera più dolorosa del non detto.
di Francesca Matteoni
Come suona il presente? Forse come uno spettro, che mentre lo guardiamo è già altrove, una fotografia dai contorni in dissolvenza, sfumata in colori troppo vividi per sembrarci reali. Catturano questo suono le dieci tracce di Testimone di passaggio, ultimo disco di Flavio Ferri ( Delta V), che si tessono potenti intorno ai versi del poeta Luca Ragagnin. Un disco che si avvale della collaborazione di vari compagni d’avventura e musicisti importanti della scena indipendente italiana: Gianni Maroccolo (Litfiba, CSI, PGR), Carlo Bertotti (Delta V), Marco Trentacoste (Deasonika), Livio Magnini (Bluevertigo), Olden, Paolo Gozzetti, Fabrizio Rossetti, Valerio Michetti, Ulrich Sandner, Marco Olivotto, Mia Ferri, Elle, Codice Ego.
Il senso della fugacità del presente tuttavia non può essere ridotto a un rapido consumo, come detta l’abitudine più diffusa: per testimoniare bisogna saper durare, resistere alle mode e infiltrarsi ostinatamente nel mondo al contrario, facendosi negli spigoli ferita/ a prova di universo, come dicono due versi di “Beckett”, canzone d’apertura. Anche per questo il disco non è disponibile, salvo per tre tracce, in formato digitale, ma solo in CD e vinile, nella forma fisica che richiede contatto e cura. E in questa forma me lo sono riascoltata una domenica mattina, ricevendo la stessa sensazione dei vecchi dischi: una misura personale del tempo, in cui la voce evocativa di Ferri esalta la profondità delle parole in una poetica elettronica lucidamente spaesata e liberatoria. Si parte da una solida base letteraria – i testi di Ragagnin infatti precedono la produzione musicale, evocando numi tutelari nelle persone di Beckett, Houdini e Ligeti, ovvero il grande drammaturgo del Novecento, secolo che questi anni zero si portano addosso senza digerirlo; il grande illusionista e il grande compositore moderno, la cui fama è legata ai capolavori cinematografici di Kubrick. Per un significativo paradosso tuttavia la grandezza dei tre è direttamente proporzionale alle loro sparizioni: il non detto, il silenzio che supera il linguaggio per il poeta; le fughe straordinarie del mago, la cui illusione è una maschera del fallimento e diviene suggello di estinzione, nella chiusa memorabile del testo a lui dedicato; gli universi crollati negli occhi del compositore che ha scritto la colonna sonora dell’inizio della civiltà e dunque anche della sua inevitabile dissoluzione.
Dalle figure profetiche si passa a quelle fiabesche, ma andate a male, come accade in “Bambina da canzone” e “Moderna”, le cui protagoniste scambiano il bosco per un mondo di opportunismi e veleno o si risvegliano disincantate, private di ogni scenario di salvezza classica: Ma non è una fiaba da villaggio incantato/E non sei la regina di un regno ghiacciato/Non porti il diadema d’un amore a riscatto/Sei soltanto la figlia d’ignoranza e misfatto. Sulla vanità della cronaca, ovvero la brutta copia della realtà, si rovescia il paesaggio intimo e dissonante di Ferri-Ragagnin, in un esercito deposto di libri alle pareti in “Testimone di passaggio”, nell’inevitabile assenza che è l’altra faccia del desiderio di permanere da qualche parte in “Le verità roventi”. Ma è in “Odio” e “Scoppio di dio” che il disco raggiunge il suo apice: fiaba, profezia, cupa densità trascinano l’ascoltatore in un crescendo della trama sonora. A volte la lingua fa questo, corre più veloce del pensiero e quasi raggiunge il rumore da cui viene la musica. Così ascoltiamo il suono rabbioso della gioia e della pace come un delirio di consapevolezza: Ti avevo abbandonato dentro un bosco/Nel tempo che defoglia gli alfabeti/Ma sei tornato senza sassolini/E mi hai legato al collo con un cappio./Il ghigno storto della gioia,/della pace, della pace. O ci ritroviamo dentro una litania che insegue dio in una variazione versificatoria senza tregua: che mangia il tempo e che si chiama…/che porta il tempo e che si chiama…/che parla il tempo e che si chiama…/che tace il tempo e che si chiama…/e che diventa dio dopo il tramonto/e che diventa dio dopo il trapianto/e mente un pianto per andare/e mette un panno per restare/un lino bianco steso sul millennio/un velo bianco teso sul millennio/un vero falso illuso sul millennio/ dna d’amore sul millennio. Dna d’amore sul millennio, ovvero un sangue antico e furibondo, parafrasando ancora la canzone, che infine si prende la sua rivincita come un canto di battaglia. E dunque, d’amore.

di Camillo Robertini
Le manifestazioni anti-Covid dei mesi scorsi, i raduni no-mask del 10 ottobre e le recenti insurrezioni napoletane non rappresentano un fenomeno locale e isolato, ma rispondono sempre più spesso a dinamiche che si sviluppano a cavallo tra gli stati e si rincorrono sui social network. Come la campagna elettorale statunitense ci ha insegnato, al momento giusto la negazione della pericolosità del virus o della necessità della profilassi può essere capitalizzata nelle urne. In questo modo l’apparizione e la sparizione delle mascherine in mano a Salvini o alla Meloni e le imprecazioni di Trump o Bolsonaro rispondono al calcolo politico e alla capacità simbolica che gesti così forti hanno sull’opinione pubblica.
Queste considerazioni, come visto, sono valide per innumerevoli paesi e assumono un significato ancora più preciso se le riportiamo all’America Latina che, da almeno sei anni a questa parte, vive uno dei periodi di maggiore incertezza dalla fine delle dittature militari degli anni Ottanta. Da quando le destre si sono affermate in diversi paesi per via elettorale (Cile e Argentina) oppure attraverso colpi di Stato più o meno palesi (Brasile e Bolivia) le lancette della storia sembrano essere tornate indietro, agli anni Settanta, quando i blocchi occidentale e sovietico si disputavano l’egemonia sull’area. Il contesto della pandemia sembra aver accentuato una polarizzazione tra i movimenti politici che propiziano una redistribuzione della ricchezza, sempre nella cornice degli ordinamenti liberali e delle destre rabbiose che presentano i timidi tentativi di redistribuzione come “pasos hacia Venezuela”, “vía al socialismo”.
Nel contesto continentale si sta manifestando con tutta la sua forza una egemonia delle nuove destre che, inaspettatamente, fanno ricorso a due antichi e potenti strumenti retorici: l’anticomunismo e la minaccia che i paesi della regione si trasformino in regimi comunisti e il rischio che i movimenti “populisti” pongano fine alla proprietà privata.
Rapidamente archiviata la fase progressista, che soprattutto fuori dall’America Latina aveva fatto sperare che dei governi riformisti potessero porre fine alle secolari ingiustizie di una delle porzioni più diseguali del pianeta, in diversi paesi le spinte reazionarie hanno assunto una forza inattesa. Così, dal 2015 in avanti uno ad uno sono caduti i governi di centro-sinistra, soppiantati da presidenti catechizzati al culto dell’individualismo e del governo supremo del libero mercato.
Una “nuova” guerra fredda e il peso della storia
Nel contesto di emergenza attuale possiamo osservare come una vicenda su tutte abbia polarizzato la discussione e si sia trasformata in una referenza tanto per la destra come per la sinistra: il Venezuela. Lo scontro sempre più vivo tra sostenitori e detrattori del governo di Nicolás Maduro e la condanna da parte dell’Onu della repressione contro l’opposizione ha fatto sì che attorno al “caso Venezuela” si riaccendessero antiche retoriche e discorsi che sembravano oramai assopiti. A più voci è stato chiesto un intervento armato degli USA, e lo stesso Trump si è detto più volte disponibile a “difendere la proprietà privata” e pronto a “estirpare” il socialismo dall’America Latina. Il fantasma del comunismo viene adoperato dai mezzi di comunicazione e dalle destre per delegittimare anche il più timido tentativo di rompere con le regole del gioco neoliberale. Così, la decisione di nazionalizzare un’impresa privata che speculava sulle esportazioni di soia dall’Argentina all’estero o porre un freno ai licenziamenti in pandemia vengono recepiti come tentativi di “sovvertire” l’ordine (neoliberale) costituito.
L’anticomunismo che riemerge in questo periodo si basa anche sullo sforzo che le corporazioni dell’informazione giocano rispetto al complesso quadro internazionale. Non di rado il gruppo Globo in Brasile, Clarín o La Nación in Argentina e Mercurio in Cile hanno presentato uno scenario da guerra fredda nel quale le forze liberali si opporrebbero alla coalizione social-chavista. L’anticomunismo manifesto dei monopoli dell’informazione fa leva su un potentissimo strumento retorico: la storia. Negli ultimi anni si è fatta strada una ricostruzione del passato alquanto surreale, ma inaspettatamente capace di entrare nel patrimonio culturale della gente comune, secondo la quale i sussidi sociali, le politiche dei movimenti populisti e socialisti abbiano condannato la regione a una inevitabile decadenza. La fase dei governi della Izquierda del siglo XXI (2005-2015) viene additata e responsabilizzata per colpe che affondano invece le proprie origini nelle profonde disparità che si sono accumulate dalla colonizzazione delle Americhe in avanti. Così le responsabilità di cinquecento anni di Vene aperte dell’America Latina sono ricadute su quei governi che hanno provato, con evidenti limiti e con tutte le contradizioni del caso, a porre un freno all’ingiustizia sociale.
Un caso evidente di come l’uso del passato possa determinare il dibattito pubblico è rappresentato dal settantacinquesimo anniversario dalla nascita del peronismo. Il movimento di Juan Domingo Perón è stato festeggiato nelle principali piazze dell’Argentina dai sostenitori dell’attuale esecutivo Fernández, che hanno ricordato i progressi sociali compiuti dal proletariato argentino durante gli anni Cinquanta. In quell’occasione però è emersa una, non del tutto infondata, critica al justicialismo che, da diverse voci, viene considerato il perpetratore di alcuni problemi oramai strutturali dell’Argentina d’oggi: povertà, corruzione dei funzionari pubblici, Stato sociale “troppo generoso”, pressione fiscale fuori controllo e inflazione annua oltre il 50%. Per dirla con le parole di Agustín Laje, uno dei guru della nuova destra latina, i settantacinque anni di peronismo sono stati una fase di lunga decadenza. Per gli alfieri della nuova destra poco importa se tra la fondazione del peronismo e l’attualità l’Argentina abbia avuto cinque governi militari, il peso retorico dell’uso del passato è tale da non lasciare alcun dubbio: la causa di tutti i mali della regione è il populismo, in tutte le sue manifestazioni: peronismo, chavismo, lulismo e così via. Esso, secondo la teoria dei liberisti d’acciaio, avrebbe infettato una società sana e avviata verso un sicuro futuro di prosperità condannandola a una inevitabile povertà.
La storia è tornata a dettare l’agenda politica il 12 ottobre scorso, in occasione dell’anniversario dell’uccisione del Che Guevara nella selva boliviana. Il presidente Bolsonaro, famoso per le sue uscite con le quali ha riabilitato la dittatura militare, è stato lapidario nel definirlo come un “delinquente comunista fonte di ispirazione dei drogati, feccia di sinistra”. Dello stesso avviso è stata anche la presidenta dimissionaria della Bolivia, Jeanine Añez, che però si è spinta ancora più in là rendendo omaggio all’esercito boliviano che contrastò la “miserabile invasione comunista del Che Guevara. La Bolivia ha dato una lezione a tutto il mondo: la dittatura comunista qui non trova terra feconda […] né l’invasione criminale e comunista del Che”.
 Foto di Matias Cruz da Pixabay
Foto di Matias Cruz da Pixabay
Nel contesto attuale, con la pandemia che non sembra dare tregua ai paesi dell’America Latina, i governi al potere sono sempre più stretti tra la necessità di preservare la salute pubblica e le pressioni di quanti vogliono riaprire le proprie attività. Sulla scorta di un comprensibile malessere, quello di quanti vedono polverizzarsi la propria attività, si innestano le invettive delle nuove destre che con grande efficacia macinano consensi.
Nel giro degli ultimi mesi l’inseguimento da parte di molti politici liberali delle più fantasiose giustificazioni contro il lockdown li ha avvicinati d’un balzo alle posizioni più estremiste fino a poco fa condivise solamente da Bolsonaro e Trump. Un caso evidente è quello dell’ex presidente argentino Mauricio Macri, riconosciuto anche dai suoi rivali per il suo aplomb, che però dall’inizio della quarantena a oggi ha assunto posizioni al limite del negazionismo. In occasione del “banderazo nacional” del 13 ottobre che ha visto le principali piazze dell’Argentina riempirsi di negazionisti e oppositori all’attuale governo, Macri ha giustificato la violazione delle norme sanitarie indicando la disobbedienza civile come uno strumento irrinunciabile per salvare la costituzione “messa in pericolo” dall’autoritarismo dell’esecutivo.
Che si tratti dell’Argentina o della Bolivia, del Cile o del Brasile vi è un filo rosso che tiene assieme le emergenti destre latinoamericane: un fervente anticomunismo e una intolleranza nei confronti delle classi popolari che attinge a piene mani al repertorio di pratiche autoritarie ereditato dalle dittature degli anni Settanta. Oggi la lotta contro il “populismo”, contro la “demagogia” e contro il “socialismo” è portata avanti da novelli crociati le cui pratiche politiche sono la violenza verbale, l’intolleranza nei confronti degli oppositori, l’odio di classe.
Una battuta d’arresto della repentina crescita delle destre nella regione è rappresentata dalla vittoria in Bolivia, in ottobre, di Luis Arce, candidato del partito Mas di Evo Morales così come il massiccio voto dei cileni col quale ha mandato definitivamente al macero la carta costituzionale ereditata da Pinochet. Vi sono segnali che indicano che l’ascesa delle destre più conservatrici e reazionarie è, per dirla con Brecht, «resistibile». Ma il recente attentato contro il neo presidente boliviano e la pressione mediatica dei gruppi che ancora sostengono le destre testimoniano che la loro propulsione è lontana dal dirsi esaurita.
Così, mentre le proteste popolari contro il Covid-19 esplodono in diverse parti della regione, le “destre liberali” che fino all’altro giorno avevano mantenuto posizioni ragionevoli, oggi soffiano sul fuoco sperando di intercettare il malcontento popolare. In questo modo le destre “presentabili” sono perfettamente sovrapponibili alle destre nazionaliste, e questa non è una buona notizia per le fragili democrazie della regione.
***
Camillo Robertini (1987) è uno storico italiano, ricercatore e docente presso l’Instituto de Estudios Internacionales dell’Universidad del Chile. È autore per Le Monnier di Quando la Fiat parlava argentino. Una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires dei militari (2019).
La foto di copertina è di Peter Kraayvanger da Pixabay
di Gherardo Bortolotti
Nell’estate del 2019 mi sono separato; è morto mio padre; ho incontrato dopo 25 anni il mio primo amore e, la notte stessa, ho visto una stella cadente. Potrei scriverci un libro e intitolarlo Romanzetto estivo. Ma, in effetti, già così è come se l’avessi fatto.
47. Quello che spesso dimentico è che le ore della sera hanno una peculiare intimità con la colpa, il difetto e il senso di disfatta. Non che quelle del mattino siano più clementi ma almeno gli orrori che promette la giornata, l’esilio a cui mi costringe il salario, tolgono il fiato e sono rapidissimi nell’occuparmi il cuore e la mente. La sera, il riposo e la meccanica chiusura del giorno finito hanno, invece, tutto l’agio di presentare il mio fallimento e la consistenza puerile dei miei sogni d’amore. Nei minuti prima del sonno penso allora a qualche episodio con Irene, per esempio quando camminavamo una sera di novembre e cercavo di baciarla mentre lei rideva al riparo del cappuccio e continuava a chinare la testa per impedirmelo. Mi ricordo soprattutto le sfumature della penombra, dentro le pieghe del cappuccio, che sembravano quelle di un cespuglio dei giardini suburbani che stavamo costeggiando, e la grazia del gesto di chinare il capo che era un rifiuto ma anche un piccolo inchino al suo sentimento per me.
di Giorgio Mascitelli
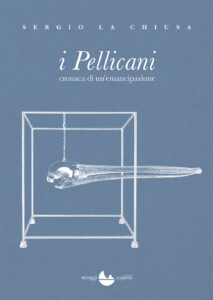
I Pellicani. Cronaca di un’emancipazione di Sergio La Chiusa, ed. Miraggi, Torino, 2020
Un uomo penetra in un palazzo fatiscente della periferia urbana perché spera di trovarvi ospitalità per la notte. Non si tratta di una scelta a caso perché nel palazzo dovrebbe abitare ancora il padre, con il quale si è lasciato vent’anni prima ( vent’anni il tempo canonico di ogni ritorno a casa) in modo piuttosto burrascoso per via di un suo prelievo forzoso dal comodino in cui il genitore era solito tenere il denaro contante. Vent’anni sono tanti, ma il nome sulla targhetta dell’appartamento, Pellicani, corrisponde. La sorpresa è che l’abitante, un vecchio paralitico, non pare assomigliare in nulla al padre, salvo nel naso.
Il giovane Pellicani non si perde d’animo, sebbene incerto se si tratti del caro parente o di un abusivo, decide di trattenersi più del previsto e intraprendere una drastica azione rieducativa in armonia con i valori individualistici della nostra società per far recuperare all’anziano disabile la propria indipendenza, o forse sarebbe più corretto dire per permettergli di conseguire la propria emancipazione.
Così prende avvio il romanzo I Pellicani di Sergio La Chiusa, finalista del premio Calvino 2019 e insignito della menzione speciale Treccani per la lingua, a proposito del quale va innanzi tutto notato che siamo di fronte a un’opera già matura, nonostante segni l’esordio dell’autore nel campo della narrativa. Romanzo picaresco sur place, per così dire, sembra voler rappresentare l’assurdità esistenziale di certe derive sociali ed etiche del nostro tempo in una situazione claustrofobica di un appartamento di un abitante solo, dotato di badante a mezzo servizio e di un figliol prodigo che si considera trattenuto lì dalla sua alta missione educativa. Se il protagonista e io narrante Pellicani junior appare erede dei picari nella sua disperata arte di arrangiarsi, nella sua tendenza autoaffabulatoria, e autoassolutoria, ha chiaramente dietro di sé i barboni beckettiani, specie quelli della trilogia o delle novelle. Del resto l’abbigliamento, un completo grigio topo e una valigetta 24 ore, che il protagonista sciorina con un certo compiacimento pare essere l’equivalente impiegatizio, nonostante le pretese manageriali, e più moderno della bombetta e del bastone da passeggio di un grande erede novecentesco dei picari ossia Charlot. In quest’ultimo, tuttavia, l’abbigliamento è funzionale a un’attitudine malinconica e dolce da clown bianco, qui l’ormai fatiscente vestiario rimanda a un Augusto che ha interiorizzato l’aggressività e la cialtroneria della società.
Così il programma didattico del giovane Pellicani, che al lettore potrà apparire una feroce forma di taglieggiamento del povero vecchio, è giustificato con una critica di ogni forma di assistenzialismo che tenderebbe, come spiegano gli specialisti del settore, a sviluppare pigrizia e inerzia nel soggetto. Ecco infatti come viene presentata dallo stesso interessato la sua missione in un passaggio che è un buon campione dell’intero testo: “Avevo capito che l’immobilità di Pellicani era un problema che non andava sottovalutato. Per sottrarsi seriamente all’assistenza era necessario mettersi in piedi, muoversi per proprio conto. La teoria e la provocazione intellettuale però da sole non potevano nulla, senza la prassi e l’esempio anche la dottrina più nobile diventa lettera morta, vanità per intellettuali rancorosi. Basta parole al vento! Basta vane dichiarazioni d’intenti! Prassi! Azione! Fu allora che escogitai esperimenti per mobilitare il paralitico. Decisi di agire in modo sottile, procedere per piccoli passi, introdurre minimi cambiamenti nelle abitudine quotidiane del vecchio. La donna di servizio, per esempio, lasciava un biberon pieno d’acqua sul comodino, a portata di mano. Lo notava sempre con un certo disappunto. Troppe comodità” ( pp. 84-85). Ineffetti il giovane Pellicani per stimolare all’azione il vecchio decide di svuotare il contenuto del biberon per costringerlo a muoversi fino alla cucina. E’ importante notare che sul linguaggio riposa il significato recondito dell’azione: qui viene adoperata una lingua infarcita di slogan e stereotipi mediatici main stream e del linguaggio politico e ideologico attuale, queste parole, come quelle successive in cui lo svuotamento del biberon viene ulteriormente giustificato con motivazioni umanitarie relative ai rischi per la salute derivanti dall’immobilità naturalmente evidenziano l’intima ipocrisia del personaggio e sul piano retorico si segnalano come una forma di eufemismo. Ora l’eufemismo è la principale strategia utilizzata nel discorso pubblico per presentare misure impopolari e ingiuste, dunque l’ipocrisia sociale è introdotta linguisticamente nel rapporto tra i due personaggi tramite il fatto che il protagonista mutua nel suo linguaggio le convenzioni e i modelli argomentativi del discorso ufficiale. Il discorso neoliberista, come ricordava Sloterdijk in un suo celebre libro, esorta a cambiare la propria vita ossia a migliorare le prestazioni ed ecco che Pellicani junior fa propri gli obiettivi della società, sentendosi autorizzato dal suo abbigliamento, suppongo, a imporre picarescamente l’onere del cambiamento della propria vita a un vecchio indifeso, i cui beni casualmente sono appetibili per lui. Per la verità la necessità di giustificare i vari passaggi del suo progetto educativo gli fanno talvolta anche riprendere un linguaggio più critico dei valori sociali dominanti, ma sempre con una costruzione linguistica che ha al centro l’eufemismo.
Non deve sorprendere che sia così perché la vitalità del personaggio risiede proprio nella sua natura picaresca di autore di espedienti per procacciarsi da vivere e che ha pertanto iscritto nel proprio DNA, e nella propria disperata cialtroneria, il ‘Franza o Spagna purché se magna’ adatto a quest’epoca. Proprio da ciò però risulta evocata potentemente la povertà morale e umana, di cui quella economica è nel contempo causa e conseguenza, della società attuale. L’appartamento dei Pellicani si trova in un palazzo fatiscente situato in un quartiere in cui la “ modernità era arrivata (…) con la sua smania di rinnovamento, e invece del noioso complesso residenziale costruito il secolo scorso c’era ora un’aperta area sterrata che lasciava molte più opportunità all’immaginazione e allo spirito imprenditoriale: mucchi di macerie, tubi, lamiere, piloni in calcestruzzo da cui spuntavano tondini di ferro..” ( p.6), così queste macerie rappresentante entusiasticamente dall’io narrante costituiscono un correlativo concreto del paesaggio morale e umano che si incontra nel libro. L’appartamento non è serrato ermeticamente nei confronti della realtà esterna, ma come una sorta di Minitalia o di Minioccidente la riproduce e il senso di claustrofobia che ne deriva è uno spiffero che viene da fuori.
In definitiva ci troviamo di fronte a un romanzo che riconcilia il lettore con il piacere della lettura perché racconta i casi degli uomini e il mondo che sta attorno a loro con grande libertà dai cliché editoriali e mediatici dominanti e con modi che sono specifici del linguaggio letterario.
di Maria La Tela
A cinque anni dovevo cantare Cicale, era un provino per una piccola rete tv.
Mia madre diceva che la facevo bene, che ero intonata, sapevo tutte le parole a memoria e la cantavo con un ritmo allegro.
Se me la fai sentire, mi disse la signorina al provino, ti regalo la mia catenina, il ciondolo era un delfino che luccicava.
di Mariasole Ariot
18 ottobre 1917. Paura della notte. Paura della non-notte
Franz Kafka

Aleksandr Nikolaevič Skrjabin – Etude Op.8 No.12 “
Crescono i corpi del giardino come piccole tempeste della notte, un fiore che appassisce alla finestra e tu non dici acqua – quando lo scherzo è cauto e doloroso, il bene che hai annunciato una miseria, di nuovo un filamento un pozzo un sogno, ancora il fiato un fato e il vuoto: è il nulla che mi cerchi, ancora la mia pelle sugli avanzi, divori il mio futuro e mi rammenti, quando agli anni della carne hai macellato, un cielo è un velo appoggiato sul pudore, ricorda il verticale: l’orizzonte e la pena che non vale
La tomba, il tuo affanno della lingua
E crescono, escono all’asciutto i rami sulla spiaggia, l’orlo che ha vestito il buio che ho investito, quando all’alba mi richiama un’incertezza ed è certezza, il patto che si stende sulla fossa, la madre che hai bevuto per assenza – e ancora non si muove che uno straccio, mi spello mi rivesto e mi riespello, il gioco che hai ferito, le serpi che ricordano i ricordi, che donano le facce al mio scomposto. Attendersi radura, un sangue condensato nella sfera, la resa della sera, aggrappati all’insieme distingui il mio passato, non farne – ti prego – una memoria

di Francesca Matteoni
Negli ultimi mesi mi sono trovata, per scelta e destino, in vari sensi spaesata, ovvero ho perso il mio luogo, anche se il luogo resta sempre là. In termini pratici ho traslocato, portandomi dietro il gatto, trasferendomi in un’abitazione situata proprio all’opposto rispetto al luogo lasciato, nella geografia della mia città. Traslocare non significa soltanto svuotare una casa e insediarsi in un’altra: significa staccarsi da una quotidianità di relazioni con esseri di varia natura, dagli umani al torrente, dagli olivi al bosco, dagli animali ai tetti che si fanno compagnia. Certo, portiamo in noi i luoghi amati. Diventano un pezzetto della carne che conosciamo come conosciamo le nostre braccia. Ma siamo lontani. Ci dobbiamo abituare alla distanza. Quando poi il trasloco avviene con un animale legato al territorio come il gatto tutto si complica. Il mio gatto non può vivere fra le mura di un appartamento. Insieme ci siamo avventurati nell’incolto attorno alla nuova casa, un passo, una zampa, una corsa nell’erba, un’intera ora separati, poi un’intera mattina, con la porta sempre aperta. Qualche difficoltà, qualche disorientamento, e poi il prevalere del gioco e della fiducia. Ecco, talvolta possiamo dire di aver stretto un legame con un luogo o con un animale quando sappiamo giocarci, quando sperimentiamo la leggerezza fino al ridicolo, quello che altri osservatori potrebbero definire follia. A volte non è la profondità dell’affetto, ma l’intensità del gioco a renderci una dimensione familiare. Accade con gli umani, con gli animali, con i luoghi. Accade che ogni stereotipo, perfino quelli positivi, di sacro terrore o rispetto, cada e cominci il dialogo di parole sciocche come di limpida intesa.
Riconosco con sollievo questa necessità di colloquiale leggerezza con quanto chiamiamo natura, nei saggi di Ellen Meloy, singolare scrittrice americana, di cui è finalmente disponibile un libro, Antropologia del turchese. Riflessioni su deserto, mare, pietra e cielo, pubblicato da Black Coffee nella traduzione di Sara Reggiani.
In “Spose fedeli”, uno dei saggi che concludono il libro, leggo:
Se c’è una cosa che mi spinge a scrivere di natura è il fatto che fin troppi suoi amanti sono talmente occupati a esprimere meraviglia o mostrarsi abbattuti dalla vittoria dell’avidità umana sulla necessità di preservarla, da esserci dimenticati che la natura sa anche essere un’inesauribile fonte di ilarità. Personalmente adoro le stravaganze, gli enigmi, i misteri, ossia la sostanza di cui è fatto il paradosso. E poi il piacere. In presenza degli ungulati mi comporto in modo insensato. Instauro un legame patologico con i colori. Gioco con la sabbia. Sono drogata del sesso fra i pioppi, dell’aspetto sadomasochistico di un Echinocerus – un cactus rivestito da una guaina di aculei coronata di vellutati fiori di un delirante rosso scarlatto – di quella solitudine che deriva dall’allontanamento dalla società, dell’esplorazione là dove gli umani scarseggiano, del concetto di umanità stesso, pur sapendo che questa esplorazione non mi condurrà a risposte definitive, che l’unica certezza che al massimo avrò sarà quella di essere sola con un branco di pecore selvatiche a farmi compagnia. E quando rido avverto il tanto temuto arrivo della follia, una sublimazione che confina col dolore. È l’equivalente di ammazzarsi dalle risate.
Dunque si può stare davanti al paesaggio senza una qualche attitudine mistico-reverenziale, che mentre l’esalta l’allontana, allargando il solco e la dicotomia fra umano e naturale, come se appunto fossimo fatti di chissà quale altra sostanza rispetto al posto in cui soggiorniamo. Lo straordinario che viene dal fuori geografico stabilisce contatti con l’ordinario dei nostri cinque sensi, cinque strumenti per comprendere, assorbire e restituire terre.
Ora mi domando se la percezione sensoriale non sia dunque l’unico mezzo di cui disponiamo per tracciare una mappa interiore del mondo. Che cosa ci dicono i sensi in certi paesaggi tanto da indurci a evitarli o a reclamarli come nostri?
E ancora:
Che siate a casa vostra o in territori ignoti non esistono guide migliori del peso dell’aria, il comportamento della luce, la forma dell’acqua. Tutto ciò che vi serve sapere riguardo a un luogo lo troverete in una pietra, una piuma, una foglia, un ciuffo di pelo, e nel modo in cui l’uomo ne ha fatto tesoro o scempio.
Questi estratti delineano lo spirito con cui attraversare il libro, collezione di saggi dove si incontrano il deserto del Sudovest americano, il fiume Colorado, le lagune dello Yucatan, questioni genealogiche alle Bahamas, storie di donne bizzarre nel deserto, animali e piante con i loro desideri, comportamenti, stranezze. Tutti gli scritti, però, ci riguardano, una volta deciso di cedere allo sguardo di Meloy, che va dall’appunto diaristico al memoriale, perché ruotano attorno al tema del qui e dell’altrove, annullando il distacco del mero osservare, e insistendo sull’abitare. Quanto e come abitiamo un posto, quanto ne siamo abitati? Come accade che una geografia ci risponda più di altre, al punto da porsi come pietra di paragone quando viaggiamo? Ogni testo sembra nascondere la domanda: perché questo ecosistema composto del vivente, delle memorie di chi ci è passato, dei richiami ad altri luoghi, ha a che fare con me? Quale scambio avviene fra noi?
Il deserto o il fiume o il colore turchese delle pietre dure divengono il nord della bussola, mentre la presenza dell’umano in loro non si attua tanto nell’esserci fisicamente immerso quanto nel sapere che esistono come esiste il corpo, fino a dimenticarcene. I saperi botanici ed etnologici dell’autrice non servono dunque per insegnare qualcosa dei paesaggi, quanto per intessersi più a fondo nell’intreccio di una realtà stratificata, dove le cose non esistono semplicemente per essere codificate, ma imparano a coabitare superando sia la visione antropocentrica che quella idealizzata e nostalgica della natura come fonte del bene sull’orlo della sparizione.
Dalla brughiera nebbiosa e aspra emerge in mio aiuto un verso di Emily Brontë: “Sono più felice quando più lontana”. Se ricomporre un paesaggio sulla pagina è un atto che avviene a distanza dall’oggetto della narrazione, è perché nella lontananza la storia acquista chiarezza, può essere custodita, dona alle parole rapidamente annotate su un taccuino lo spazio-tempo necessario per farsi vedere anche agli altri, a chi cerca le ragioni di un’erranza come di una sosta prolungata in certi luoghi. Riflettendo sul luogo ancestrale e partendo da un cestino artigianale, un’opera Yokut, gruppo etnico nativo della California centrale, ereditato dall’autrice per via matrilineare, la Meloy dice che gli Yokut “parlavano degli anni definendoli mondi”. Facciamo un salto in questo tempo-mondo. C’è un mondo nel quale il nostro corpo è piccolo, elastico, in divenire vorace, sono gli anni dell’infanzia. C’è un mondo nel quale il nostro corpo diviene una collina all’apparenza arida, rugosa, ma che sa ancora ospitare piccole vite nelle sue buche e nei suoi anfratti. È il tempo dell’anzianità. Traiamo questi mondi fuori dalla nostra immaginazione sensoriale, quando si fanno più fragili sull’orizzonte: “Forse per conoscere meglio un posto che ci è familiare, dovremmo prima estraniarcene”.
Ma quante cose possono dirsi luogo? Per esempio un colore. I nativi del Sudovest, ci racconta la scrittrice, donavano la loro pietra più preziosa, la turchese, al bene più prezioso delle loro terre, l’acqua. La pietra poteva essere lasciata presso sorgenti, polle, rivi. Blu che si riunisce al blu, un amuleto da indossare (e perdere), che ha le sfumature della vita quando corre nel rosso-arancio del deserto. Blu quale acqua e memoria familiare, come accade all’autrice rievocando l’esperienza di un campeggio in viaggio con i genitori e i fratelli da bambina, Meloy, si sofferma sul blu delle piscine nell’Ovest americano, case private, motel, su cui il padre aveva posto un divieto che ovviamente non faceva che aumentare il desiderio. Scrive:
L’Ovest è così pieno di blu da darti l’impressione di potertici tuffare, cosa che appunto da piccola avevo cercato più volte di fare. Il blu mi sembrava un bel posto in cui andare, un Paese in sé, superiore, imperturbabile, dove non eri costretto a parlare con nessuno.
In questo blu l’autrice traccia un percorso a nuoto fra la California e lo Utah, passando dalle piscine ai canyon, ricucendo la storia personale, fluida, cangiante, ritornante, alla solidità della roccia desertica, alla sabbia che riempie le orecchie durante innumerevoli notti all’aperto. Il confine fra autobiografia e descrizione naturalistica viene trasceso. Questo, a dire il vero, succede nell’esistenza di ogni camminante, che percorra valli e monti o che si limiti al solito tratto della passeggiata serale. Per scrivere del paesaggio e del luogo non ci si può semplicemente sedere e osservare. O meglio occorre osservare fino a tal punto da sparire dentro l’osservato e vedersi aprire vie impossibili che rovesciano il tempo nello spazio. Ci si può imbattere nella via del sognare, per esempio, ricordando che i Mohave,
come altre culture sorte sul fiume Colorado, tenevano in grande considerazione i sogni. Qualsiasi capacità o potere che avessero di prevedere le proprie sorti, in amore, in guerra, o nel gioco d’azzardo, venivano loro dai sogni. I sogni plasmavano la vita, e narrarli li trasformava in veri e propri viaggi. In quei viaggi il sognatore camminava verso una meta, si nutriva, si fermava a riposare, incontrava creature, vedeva luoghi importanti: il sogno dunque era una sorta di diario di viaggio del Mohave in cammino.
I sogni tramandati oralmente diventavano miti, o “canti sognati”. Il racconto poteva subire delle modifiche. Trama e tonalità erano fluide, e ben poco accadeva oltre al viaggio in sé. Per raccontare la propria storia si cantavano i nomi delle cose, le sorgenti, le rocce, le piante, gli animali, le stelle, i monti, i fiumi. Per raccontare la propria storia si metteva una cartina in musica. Si dava voce a un’area geografica.
Ripensando il valore del sogno come viaggio rivelatorio e ancora di più incantatorio: grazie al sogno siamo cantati dentro un paesaggio, che a tratti è quello quotidiano, a tratti è quello trasfigurato dalle nostre visioni più intime. Oppure, per il più banale degli incidenti che per un po’ obblighi all’immobilità, ci si può addentrare in questioni di parentela che ben oltre la linea di sangue ci legano ad altre donne, da luogo a luogo. Così, nel saggio “I jeans di Tilano”, Meloy si ritrova cucita per i capelli al tetto dalla spillatrice con cui cerca di appuntare del feltro, e coglie l’occasione per riandare con la mente alle donne ottocentesche che scelsero di traslocare nel deserto. In Australia, nel Nord Africa, in America. Abituati come siamo alla serietà e ai toni solenni quando si trattano le questioni di genere come quelle ecologiche, l’approccio può apparire singolare. Eppure non è così che avvengono le epifanie? Momenti di connessione e autenticità, mentre stavamo facendo altro, magari qualcosa di banale che non ci piace evidenziare nel nostro diario. Muovendomi verso un paesaggio a me più prossimo, Meloy è il tipo di persona che di un cammino nel bosco non viene a dirmi solo dell’assenza o presenza di tracce, della luce del crepuscolo fra i rami, ma, con la medesima passione, del terreno su cui si scivola, cadendo ridicolmente e scoprendo una tana di bestia misteriosa. Ancorata al tetto della sua casa nel deserto quindi esplora le capanne, le case, le stanze delle donne che nel deserto forgiarono se stesse.
O in “Scivolare sulla seta”, ci rende partecipi di un’avventura in kayak sul Colorado, per sapere alla fine e “all’ennesima notte sul fiume”, di non sapere nulla, di avere “l’obbligo di non lasciare questo fiume”. Di assecondarne la forma. “E forse allora imparerò qualcosa”.
Non parla in queste righe del fiume con toni diversi da quelli che useremmo trattando della nostra persona fisica e mentale, quell’essere che non possiamo abbandonare fino alla morte, se scegliamo di esistere. Per alcuni l’esistenza, con il suo caos di momenti sbagliati, bellezza e verità, parole a sproposito e silenzi ingombranti, avviene mentre il paesaggio non si limita a guardarci, ma coopera (a volte ci tollera e noi lo tolleriamo), ci mette alla prova, si stanca o si prende gioco di noi. E questo ben prima e oltre la consapevolezza.
Esco da questo libro rientrando nella mia vita spaesata. Nel suo stupore che sta nella robinia che mi impedisce il passo, mentre cerco di far coraggio al gatto ed è invece lui a confortarmi, tornando indietro ad aspettare che mi liberi. Non saremo mai amiche, dico alla robinia. Ma al tempo stesso mi attraggono le sue lunghe spine. Digito il nome di Ellen Meloy, scopro che è morta all’improvviso nel sonno, a 48 anni, nella sua casa. Chissà cosa resta di lei in quella geografia, oltre i suoi scritti, cosa resta di noi in ogni geografia cui apparteniamo. Riapro le pagine del saggio “La mia vita animale”, leggo:
Quando abbiamo costruito la casa, io e Mark abbiamo incanalato l’acqua piovana che si raccoglie sul tetto di metallo in delle tubature che riemergono ai piedi di alcuni giovani pioppi piantati in precedenza. Pioggia, neve disciolta, condensa – ogni goccia d’umidità presente sul tetto – ora scivola in canali di scolo e tubi di drenaggio, che passando sotto terra scendono a valle e forniscono acqua agli alberi. Una mattina sorprendo una volpe grigia a scavare vicino all’estremità di uno di questi dotti. Agitando le zampe come una forsennata solleva nuvole di terra rossa neanche avesse deciso di proseguire i lavori avviati dal picchio e spuntare finalmente in Cina. Nella tubatura si è acquattata una lepre dalla coda nera. La volpe è grande quasi quanto un coyote, con le zampe rosse di terra, il pelo argentato e lucido, e il lato superiore della coda bordato di nero. La osservo da tre metri di distanza e nel silenzio della lepre lei mi guarda dritto negli occhi. Pensi di restare lì impalata o mi aiuti ad acchiapparla?
Forse alla fine l’essenza di un coabitare relazionale, che sistemi le nostre fratture, ricomponga le eredità e le lasci andare, è tenere la domanda sul significato di una vita ecologica aperta, mentre un pensiero o una voce ci arriva nella testa e nello spirito. Non tormentarsi nel volere la risposta. Chiedersi piuttosto, fra lo scherzo e l’estrema serietà: “Chi ha parlato?”
di Isidora Tesic

Avere un corpo e non sapere come portarlo. Averlo appena, usarlo come mantice. Come gregario, per rompere l’aria. Per il beneficio di chi lo segue – fosse anche l’anima. Il ragazzo ha pensato spesso di avere un’anima esterna, che lo segue arrancando.
È sdraiato nella sua stanza e il corpo, in questo istante, è qualcosa di simile a un rudimento di esistenza. Non dorme. La stanza è una cellula di sopravvivenza e lui la abita ormai da sei anni. Fuori, il mondo ha le sue manie di disintegrazione e disinnesco.
Il ragazzo sa di essere una specie a rischio e da tutto questo si protegge come riesce. Solo che alla natura che lo vorrebbe meno fedele, più incline a cambiare pelle, si ritrova con nulla da offrire.
Il sole deve sorgere alle sei e cinquantasei. Il ragazzo si alza e attraversa la stanza. La finestra è socchiusa e, guardando fuori, si vede solo la strada, poco illuminata e deserta. Le specie fuori della cellula sopravvivono come riescono: apparentemente bene e meglio di quanto abbia mai fatto lui. Infatti non c’è nessun altro a scrutare nulla da una finestra alle tre del mattino.
“Esercizio di sepoltura” l’ha definito sua madre, esasperata. Nonostante la stanza sia qualcosa meno di una tomba. Più simile, in realtà, a un ecosistema artificiale, a favore di una sola specie protetta. Nulla lo giustifica e lo sa.
Nella distribuzione delle cose, gli atomi sono stati generosi con lui, come la Storia, la geografia, l’anamnesi familiare. E allora, da dove?
Non che non abbia provato a parlarne. Attraverso la porta, i 15 pollici, i 5 pollici, il telefono, con i consulenti, per dar pace alla desolazione del nucleo familiare, per l’imbarazzo della diserzione, per il corpo a suo agio negli spazi aperti e l’anima agorafobica.
Ma la vita è cacciatrice e lui preda. Non sarebbe scappato, non avrebbe combattuto. Il sacrificio lo ha contemplato.
Se, per ipotesi, la preda avesse deciso di fermarsi e stare ai margini della sua natura, gli istinti predatori sarebbero venuti meno. Avrebbe chiesto perdono al suo predatore per non voler contribuire al gioco eterno della vita e, illesa, sarebbe rimasta a guardare la corsa di qualcun altro. Illesa e senza natura.
Su questa ipotesi aveva costruito i suoi ultimi sei anni. E nella cellula era entrato al modo del monaco o del prigioniero. E cioè senza più uscire. Le cose riuscivano a esistere e ferirsi ed estinguersi nonostante lui. Il loro andamento naturale non si compromette, se uno, o meglio lui, aggiorna il suo status sociale a: mancante.
Il giorno che aveva sentito sua madre cercare di aprire per la ventesima volta, frenetica, la porta che lui aveva chiuso a chiave, suo padre aveva mormorato a bassa voce che forse era il caso di chiamare qualcuno. Il ragazzo si era sentito in colpa di essere richiuso in qualche modo al sicuro. Questo non aveva convinto nulla in lui a cessare quella che tutti avevano smesso di chiamare “sciocchezza” e avevano cominciato a battezzare “problema”. Nei successivi cinque mesi avrebbero cominciato a chiamarla “patologia”.
Alla settantanovesima discussione tra i suoi genitori, la voce di sua madre si era chiesta ossessivamente come avesse potuto non rendersene conto. I suoi ventuno anni e centoquattordici giorni erano stati analizzati, per trovare avvisaglie, presagi, ma non c’era stato nulla di rilevante. Lei piangeva spesso, in quei mesi.
Lo aveva implorato di uscire. Il ragazzo, attraverso la porta, aveva cercato di consolarla. E di spiegare, con la sua trentaseiesima seduta, che, pur non essendoci nulla che lo giustificasse, tutto era autentico.
L’anno era riuscito a passare senza sfiorarlo. Almeno lui. I suoi genitori l’avevano passato come fantasmi, convinti che al di là della porta non avessero più un figlio, ma un estraneo, che avevano creato loro. Avevano quasi rischiato di separarsi.
Dei trecentosessantacinque giorni dell’anno successivo più della metà l’aveva passata nel mondo virtuale, dove avere un corpo e condurlo non era un requisito indispensabile. Non aveva portato a nessuna risoluzione, perché non era il corpo l’origine di tutto. E l’anno dopo aveva evitato derive iperconnesse.
La sveglia ora segna le cinque. Il ragazzo scuote la testa con repulsione. Sta camminando lungo la stanza ormai da un’ora. La riesamina del passato è un metodo come un altro di devastazione. Nel suo caso, particolarmente efficace.
Sulla porta ha appeso uno specchio. Cornice antica, legno di noce. Ogni volta che si avvicina alla porta, si vede: “Tu, uscire…?”. Un altro ottimo meccanismo dissuasivo.
La vita al di là della porta, dopo il trauma, si è aggiustata a proseguire con buona pace di tutti i coinvolti. I suoi si sono abituati ad avere una voce al posto di un corpo e gli equilibri familiari hanno finito per ristabilirsi. A dispetto dell’entropia e della corsa al caos, nessuno può sopravvivere senza la parvenza di una stabilità.
Alle sei di oggi il ragazzo ormai ha finito di enumerare per la ottocentosettantacinquesima volta tutti gli eventi. È in attesa di qualcosa. Furioso, alza le mani e colpisce la parete di fronte alla quale si è fermato. Nonostante il tempo sia clemente, benché il corpo sia stato obbediente, a dispetto della vita e del circondario che gli hanno permesso la resa, senza punirlo ulteriormente, il ragazzo è ancora una preda. E allora, è davvero dove è posta la trappola, quello che conta?
La stanza è solo una stanza e lui un ragazzo, con una famiglia disfunzionale, e cioè a norma di secolo, e una vita irrigidita di terrore o qualcosa di simile, in questo sanguinosissimo mondo – e anche questo, in qualche modo, capita che sia a norma di secolo.
Scivola a terra, con la schiena contro il muro, coprendo il viso con le mani. Galassie, costellazioni e un vuoto pneumatico dietro le palpebre. Il pianeta terra assolutamente indistinguibile da altri punti sparsi tra le dita. Gli sembra di vedere tutto dall’alto, da una capsula sganciata nel buio, come probabilmente vede le cose dio, sempre che esista – e cioè senza alcuna possibilità d’intervento.
Eppure dalla finestra filtra un’aria fredda e via via più luminosa e lui respira sempre più a fondo, sempre più veloce, che il sole sta per sorgere.
Così timida la sua vita finora, con i suoi movimenti in ritardo e la prescrizione connaturata e i sei anni senza uscire – tutto forse per arrivare alla scoperta che non si può vivere alla maniera delle formiche, ma alla maniera delle stelle. Che ogni cosa vive, persino lui che ha provato a non farlo. Sì, tutto per giungere finalmente alla terrificante sapienza di resistere indifesi di fronte al predatore e tuttavia senza sgomento.
Le sette, la sveglia comincia a suonare, il ragazzo si riscuote e si dirige verso l’armadio. Apre le ante, prende l’abito, lo posa sul letto, in bagno si sciacqua il volto. Torna nella stanza e comincia il rituale di vestizione, tutto in lui si muove come fosse la prima volta. S’infila i pantaloni, indossa la camicia, la giacca, le scarpe. Per ultimo stringe il nodo della cravatta.
Lo specchio dalla porta emana una luce. Certo, è il riflesso del sole. Ma il ragazzo lo guarda e quello che vede è il bagliore di una stella morta. Dell’esodo di una stella resta la propagazione di una luce, se qualcuno la osserva dal terzo pianeta del sistema solare, un miscuglio di particelle elementari che la segnalano. Qui-c’era-una-stella – un alfabeto morse cosmico. L’assicurazione che niente, nessuno può essere dimenticato.
L’ultimo gesto prima di lasciare la stanza il ragazzo lo usa per coprire lo specchio.
“Esco” comunica, entrando in cucina. Alla madre, seduta al tavolo, sfugge un grido. “Tuo padre è a lavoro” riesce a dire soltanto, il ragazzo le sfiora appena la spalla e la donna sussulta. È più vecchia e meno gentile di quello che era. Le dà un bacio sul capo, leggero, lo stesso gesto ma a parti invertite, perché si diventa genitori dei propri con il passare del tempo. Sulla porta aggiunge: “Non ti preoccupare, torno presto”.
Alle 10.30 di oggi il ragazzo è seduto tra i banchi. Una folla. Molti stanno in piedi. La funzione è sobria, discreta. Sul globo ci sono modi diversi di venire a patti con le perdite.
Era giovane. Lo conosceva – ricorda bene il suo viso. Erano a un grado di prossimità, non abbastanza da essere amici. Sono nati nello stesso giorno. Il ragazzo l’ha saputo ieri sera: lui è morto senza preavviso, nella sua stanza.
di Filippo Polenchi (testo) e Andrea Biancalani (immagini)









 SANTIAGO DI COMPOSTELA – CITTÀ TRISTE, SENZA ALBERI, CHE SI RALLEGRA D’INVERNO SOTTO LA PIOGGIA
SANTIAGO DI COMPOSTELA – CITTÀ TRISTE, SENZA ALBERI, CHE SI RALLEGRA D’INVERNO SOTTO LA PIOGGIA
(“El Mundo”, 6 ottobre 1935)
Il Medioevo. Sì, il Medioevo, con le sue vaste zone di ombra e pietra, così lo immaginiamo dopo aver letto una cronaca e aver chiuso gli occhi.
Gelido, ascetico.
Galizia, la bucolica, si cancella al giungere dinnanzi alle mura di cinta di Santiago di Compostela. La violenta presenza della città medievale è così intensa che di colpo ci si dimentica che nel mondo esistono ancora città allegre. Si volta la testa, spaventati, come se il mondo finisse qui, lungo questi confini granitici, tra i quali, alle tre del pomeriggio si potrebbe uscire nudi per strada senza che nessuno se ne accorgerebbe. I caseggiati di pietra, grigi, di tre piani, con ampie scale scure, sembrano un pretesto per riempire lo spazio che lasciano i quarantasei edifici religiosi, monumentali e sinistri. I negozi, sotto i portici contorti, sembrano tane, molti banchi sono di granito, ed è inutile cercare la folla sotto le arcate levigate dal vento o a cassettoni. Solitudine. Solitudine di morte, di spopolamento, di noia e di penitenza.
Dico che Santiago di Compostela gela il cuore. Strade oblique e in pendenza, con nomi taciturni: Angustia,
Lagarto, Pescadería Vieja, Ànimas, Sal–si–puedes, Calderería. Mostruosi cubi di pietra, lisci, con alte finestre e inferriate, porte verdi, scudi di armi sulle facciate, pale d’altare con bambini scrostati che gettano saette di oro finto, vergini scolorite sulla groppa di un asinello, illuminate lateralmente da fanali di ferro, appesi, come impiccati, a catene, e una farfalla che brucia al sole in un bicchiere d’olio. E poi stemmi, campane che suonano, tuoni, pilastri di pietra al centro della carreggiata, irregolare, morse cancellate dall’ossido dei secoli. Nei buchi dei muri ciclopici, immagini di tortura e sofferenza sorvegliano una porta verde. Di fronte a un fanale di ferro, un santo con un pugnale piantato nella gola e la palma del martirio nella mano. Le gronde sporgono orizzontalmente da altissimi muri di pietra, teste di iena col busto di donna. Dove si guarda, figure abominevoli, segregate, dietro le sbarre come nelle gabbie dei leoni, bare di pietra, rilievi di monaci, la barba con gli anelli come i re assiri.
Neanche un albero.
Nelle fughe, tra i blocchi di pietra, qua e là c’è una macchia, lilla o viola. Un pon–pon sinistro nato da un prato. Ai fianchi della cattedrale, si apre una piazza con una gradinata talmente larga che sembra entrare in mare, e il mare è una pianura di pietra, e non c’è un solo albero nel cuore della città signorile, e questa piazza, tutta lastricata e chiusa da un lungo muro e da portici di fronte, è la Plaza de los Plateros con piccole vetrate dove, nell’ombra, brillano intagli di argento, oggetti religiosi e, nel punto più alto del lungo muro di ferro, scendendo una scala di pietra come se si attraversasse un corridoio, si scopre un’altra piazzetta lastricata dove non c’è un solo albero, come se il verde fosse sacrilegio qui, dato che tutto è di pietra, e al centro c’è una fontana di pietra con cavalli di pietra, con le colombe che beccano nelle giunte, tra una lastra e l’altra, o dentro gli occhi delle statue. Ovunque cadano gli occhi, ferro o pietra, e se si alza la testa, non si vedono cime di alberi, solo torri piramidali di pietra, annerite dal muschio e dai liquami degli uccelli, e scudi di pietra, squartati, con corone orizzontali. E il vento corre in questo deserto pietroso, sinistro, come se soffiasse nella città degli spettri, che qui ci devono essere, stipati sotto i portici che coprono i vicoli, e le stesse persone si perdono come fantasmi sotto gli archi, perché le colonne, rotonde o quadrate, e gli archi delle colonne sono di pietra, e il sole sembra un sole di pioggia, un sole bagnato e triste, venuto forse dal purgatorio, e tutto così crudele, che i ferri verdi, i fari agli angoli, e i monaci che si perdono tra le arcate, e le macchie del sole livido, il rintocco delle campane ci fanno pensare a un’umanità consacrata esclusivamente agli offici della penitenza religiosa, inginocchiata, solo inginocchiata.
La città silenziosa.
Ed è inutile che i bambini ridano, incorniciati dalle ciclopiche arcate, ed è inutile che le donne passino con luccicanti vestiti a fiori. La morte ha esteso così il suo impero a Santiago di Compostela che le voci umane risuonano fuori dal tempo, come quelle degli uccelli in gabbia, che ogni volta che cantano, dal loro carcere, ci ricordano che non dovrebbero stare lì dentro.
Silenzio. I clacson delle macchine non suonano, nemmeno gli altoparlanti delle radio, o i grammofoni, e neanche il chotis madrilegno, o i canti dei ciechi con la chitarra, o le orchestre di strada degli ebrei tedeschi. Silenzio, spegnimento, morte. Dicono che Santiago in inverno rivive con l’allegria degli studenti. Ma è d’inverno che in questa città piove ogni giorno, finché la pietra da grigia non si fa nera, così che, se Santiago, ora, in estate, è buio come un purgatorio, in inverno deve sembrare un sepolcro, il sepolcro dei vivi.
NdR: questo magnifico pezzo fa parte della magnifica raccolta “Acqueforti spagnole” (il titolo originario è ben diverso: “Aguafuertes, Gallegas Y Asturianas”) di Roberto Arlt, pubblicato recentemente da Del Vecchio, nella traduzione di Marino Magliani e Alberto Prunetti)
di Andrea Cafarella
Questa sofferenza porta il nome di chi ha scagliato queste maledizioni e ha la responsabilità di aver contribuito a distruggere i corpi e le menti di milioni di persone sparse su tutto il pianeta, creando il deserto sul quale oggi imperversa la guerra. L’unica speranza possibile passa dall’avere memoria: quando tutto sarà «finito» bisognerà ricordare che la storia di questi corpi derelitti accusa la storia della politica, chiedendo vendetta.
T.Z.Anusgate

Metto mano al linguaggio poiché sento il dovere di documentare un ritrovamento che mai avrei pensato di poter fare in vita. Un gran quantitativo di brandelli di testo recuperati dallo spazio virtuale che pare fosse conosciuto una volta con il nome di Internet. Dopo attenta analisi oso affermare che il contenuto di questi file potrebbe risalire esattamente al periodo descritto da Eolele Bellizario nell’emblematico racconto che sembra svelare il significato nascosto della data palindroma 02.02.2020, secondo parecchi molto più vicina a noi di quanto si possa pensare. C’è infatti chi farebbe risalire quel giorno a una cinquantina di anni or sono e chi invece lo identifica con il momento della fine dell’ultimo ciclo, decine di secoli addietro. La maggior parte degli studiosi concorda però sull’idea che quei giorni siano stati palcoscenico di un evento senza precedenti. Un particolare accadimento di carattere globale che ha cambiato le sorti della storia. C’è chi teorizza la seconda venuta degli alieni, chi un disastro ambientale e chi ancora ipotizza una grande guerra occultata dalla storia. In molti però concorrono nell’affermare che questa sia stata la causa principale del nostro modo di vivere odierno. Nonostante ciò, queste supposizioni non sono mai state certificate e non è stato possibile trovarne tracce tangibili né documenti utili a svelarne il mistero. Fino a oggi.
Il dossier che ho fortuitamente individuato ha per titolo «2666» e le frasi che da esso ho estrapolato – per quanto fosse possibile – e manipolato, nel tentativo di interpretarle, dandovi un senso logico, hanno dell’incredibile. Duemilaseicentosessantasei è un numero che inizialmente non mi diceva nulla, fino a che non ho provato a sommare le cifre che lo compongono raggiungendo come risultato il numero 20; dopodiché le ho moltiplicate ed è apparso il celeberrimo numero sacro, il 432.
A quel punto ho capito che c’era qualcosa di importante e occulto in questa sequenza.
La mia ipotesi è che si tratti di un messaggio in codice, all’interno del quale, numerologicamente, si tenta di avvertire il lettore di un periodico andirivieni del tempo che riporterebbe costantemente a quella data fatidica: 20/20 (oppure 02/02) ripetuta nel ciclo cosmico (432) all’infinito.
Il nome dell’autore del dossier risulta impossibile da decifrare. Riporto qui le lettere che ho potuto svelare, per onor di cronaca, seppure non sembrino dire o significare alcunché: E-D-U-R-R. Ognuno dei testi che compongono i capitoli del dossier è preceduto da una cifratura con schema ricorrente: una data, relativa al 2020, seguita da quello che potremmo presumere si tratti di un orario, sempre lo stesso: «06:00». Questa dicitura ce lo riconsegna come una sorta di diario, eppure quel 6 ripetuto giorno per giorno non può che risaltare allo sguardo attento. Soprattutto quando incontriamo un’eccezione, una singola anomalia: uno dei capitoli risulta scritto a un orario differente: le «20:26». Questi numeri ricordano evidentemente quelli presenti nel titolo del dossier e viene quindi spontaneo pensare a una codifica piuttosto che alla mera indicazione dell’orario. Appare come se colui che da questo punto in poi chiameremo, per comodità, Edurr voglia indicarci l’epicentro della vicenda, il punto dal quale, probabilmente, bisognerebbe iniziare a scavare.
Ed è proprio da qui che ho cominciato a vedere.
I numeri, tuttavia, potrebbero non bastare, in quanto non siamo assolutamente sicuri del loro uso, poiché non saprei dire nemmeno se effettivamente questi siano testi concepiti nell’oscuro duemilaventi oppure se quell’anno emblematico ne sia solo l’oggetto di studio. Si potrebbe anche trattare di una combinazione che niente ha a che vedere con un periodo temporale specifico. Ciò che mi ha davvero impressionato è il titolo di questo particolare capitolo indicato da una sequenza anomala e unica in tutto il dossier:
Lo Sconosciuto in Cina e la sua evocazione tecno-sciamanica a opera di Nick Land.
Ci sarebbe da interrogarsi per secoli su questa inscrizione: chi è Lo Sconosciuto? Soprattutto, però, chi è Nick Land? E cosa c’entra la Cina? In effetti, sarebbe più logico chiedersi cosa intendesse Edurr per Cina. In un contesto «tecno-sciamanico» possiamo ancora immaginare la Cina come quella valle sperduta e desolata che conosciamo oggi?
Quello che più mi incuriosisce di tutti questi dettagli oscuri all’interno del titolo, tuttavia, sono i «Sette punti». Essendo la dimensione numerologica preponderante in questi stralci di testo, mi sembrerebbe superficiale escludere l’indicazione.
Sette è il numero della completezza e della conoscenza.
Non potevo certo accontentarmi.
Così ho iniziato un lungo ed estenuante lavoro di estrapolazione e riconfigurazione dei testi che mi permettesse di riportare alla luce quanto fosse rimasto di ancora intellegibile negli scritti del fantomatico Edurr.
Arriva il coronavirus, la Cina è isolata, stamane l’opinione pubblica si è svegliata e ha pensato: anche oggi niente di nuovo, anche oggi si è affacciato lo Sconosciuto; il futuro prende la forma dei mostri: un virus, il contagio, antiche dittature e, dall’altra parte del mondo, Donald Trump.
Questo è quanto sono riuscito a ricostruire della sezione «20:26».
Un testo ermetico, in cui si nomina un «coronavirus» come se fosse un nuovo venuto. Per coronavirus s’intende la rinomata famiglia di organismi virali comunemente conosciuta come Orthocoronavirinæ che domina il mondo esterno, ovvero il fattore decisivo che renderebbe – secondo quanto dice il Codice – totalmente invivibile il ‘fuori’, e ancora: uno dei motivi principali che stanno dietro alla conformazione della nostra società e della nostra storia recente.
La cosa spiazzante è che mi sembra che se ne parli, in questa sezione del dossier, come di una novità: «arriva», scrive Edurr, come se si trattasse di un nuovo arrivo, appunto. Allora è forse possibile supporre un mondo, una società in cui la pestilenza non aveva luogo. Possiamo, presumibilmente, pensare a Edurr come a un uomo che prima di scrivere queste pagine era stato libero di girovagare all’esterno senza il rischio, o meglio: la certezza di morire a causa del contagio. Immaginiamo uno stato di cose che venga prima della pestilenza; nel momento esatto in cui la conosce per la prima volta nella sua forma mortifera e conglobante. Proviamo a figurarci Edurr come un testimone chiave, esemplare, di questo processo mastodontico e definitivo.
L’altra dicitura del testo che mi lascia interdetto è quel nome sconosciuto e di carattere quasi umoristico (il termine ‘trump’ ricorda l’antico strumento a fiato di cui si conservano alcuni esemplari nell’Archivio). Potremmo forse contrapporre, come due poli in guerra, Nick Land e Donald Trump? Nick Land potrebbe essere un antico sciamano, un precursore, e Donald Trump la sua controparte, un oscuro stregone voodoo. Potremmo congetturare considerando quella raccontata da Edurr come la guerra primeva tra le forze magiche che oggi governano l’Altrove.
Viviamo in tempi interessanti in cui è in corso una guerra spirituale tra le forze dell’apertura e quelle della chiusura.
Ha scritto Edurr in un altro frammento.
Devo ammettere che quando sono riuscito a recuperarlo e decrittarlo ho dovuto strofinarmi gli occhi e cambiare il liquido interstiziale più volte, nel tentativo di capire se quanto stessi leggendo fosse una mia proiezione o corrispondesse a un’inscrizione tangibile rimasta nello spazio.
Ho avuto timore di aver evocato io stesso Edurr, dalle pieghe del tempo dentro di me.
Rassicurato dalla medicina, ho continuato a lavorare senza sosta a quei file così danneggiati, a scavare ed enucleare ciò che era rimasto integro. Dopo poco mi sono imbattuto in un altro titolo:
Decide la Macchina. Il Calcolatore universale di Culianu.
Cos’è la Macchina? La definizione che costruisce Edurr ricorda molto da vicino la «teoria dell’Apparato» di Kolef, il bio-filosofo che sostiene da secoli la presenza di un enorme organismo onnipresente atto a controllare le nostre esistenze.
L’universo è chiuso in un immenso social network ed è bloccato in un eterno presente dove non esiste alternativa.
[…]
non esiste futuro perché ogni cosa è già decisa e prevista: la Macchina, governatrice dello spazio e del tempo, è colei che ha decretato la fine della Storia.
L’Apparato di Kolef potrebbe corrispondere allora al «Calcolatore universale di Culianu»? Sarebbe forse Culianu lo sciamano che ha individuato l’organismo controllore delle nostre vite? Oppure lui ne è il creatore, l’inventore, l’architetto? O ancora si potrebbe trattare solo di una nomenclatura o di un luogo geografico. Mi sembra però che l’idea del «Calcolatore» corrisponda esattamente alla descrizione dell’Apparato che sta riscrivendo la nostra storia, proprio a partire – come scrive Kolef – da un punto preciso dello spazio-tempo, un istante palindromo, in grado di modificare contemporaneamente passato e futuro.
E se quella data fosse proprio il bellizariano 02.02.2020?
Nonostante la domanda resti aperta, trovo comunque interessante paragonare le parole di Kolef, quando dice che l’Apparato ha rinchiuso le nostre esistenze cancellando il passato e riproducendolo a sua immagine e somiglianza, per eliminare la possibilità di una rivoluzione immaginale; e quelle di Edurr che, nello stesso capitolo sul Calcolatore di Culianu, scrive:
Il tempo e lo spazio sono piegati. Il super-computer algoritmico sta lavorando retroattivamente per riscrivere una storia che lo vedrà trionfante.
Le teorie di Kolef, come quelle di Ralser e Bhulz, ritrovano in questo dossier la loro veridicità: se dovessimo certificarne la provenienza temporale e geografica, allora risulterebbe ormai chiaro e lampante quanto Kolef avesse ragione e dovremmo arrenderci all’evidenza che la nostra esistenza altro non è se non un riverbero di un grande Apparato in grado di scrivere e riscrivere la nostra storia ciclicamente, intrappolandoci per poter succhiare da noi non si sa quale energia né per quale oscuro scopo. Le nostre vite sarebbero allora una menzogna. I nostri cari non sarebbero più i nostri cari; gli eventi che hanno costellato la nostra esperienza di crescita sarebbero allora meno che immaginari.
Personalmente, la sola idea che la mia vita (che considero una vita felice, di cui essere orgoglioso) sia stata tutta un’illusione, mi fa tremare e mi appassiona al contempo. Certo, quando entro nella mia capsula e apro il Varco, quello che posso esperire mi riempie in modo talmente profondo che non potrei dire che sia falso, non potrei mai considerare la mia Unione una menzogna.
Nonostante ciò, provo a prendere in considerazione l’ipotesi di considerare Edurr come un essere umano reale, vissuto centinaia se non migliaia di anni or sono. Un’epoca in cui una devastante guerra magica ha decretato le nostre sorti e nella quale risiede la risposta a tutte le nostre domande: rimaniamo comunque imprigionati in una gigantesca illusione e tutt’attorno pestilenze e carestie devastano il pianeta e noi siamo conservati, inermi nei nostri bunker, nutrimento eterno per un enorme organismo cibernetico che produce per noi un’illusione digitale – chiamarlo Apparato di Kolef o Macchina di Culianu fa poca differenza.
Cosa ne conseguirebbe?
La necessità di tentare di cambiare questo stato di cose e quindi di prepararsi a una nuova guerra.
Il voodoo digitale che chiude la mente ha bisogno di un controrituale capace di sintonizzarla verso l’imprevedibilità e l’unicità.
Il nostro Edurr ci esorta a compiere un ‘controrituale’ magico e immaginale, tramite il quale, ci dice,
opporre al Dataismo della Macchina un nuovo Dadaismo dell’Immaginazione.
Il «Dadaismo immaginale» sarebbe quindi un tentativo di riconfigurazione mentale che vada verso l’imprevedibilità e il caos. Uno sforzo, quantomeno eccentrico e forse insensato.
Vi è uno stralcio, che spero di aver ricostruito in modo abbastanza fedele, nel quale Edurr scrive che
i fantasmi del passato sono i possibili alleati di un dadaismo del futuro.
E se Edurr fosse proprio uno spettro? Credo che potremmo davvero dare ascolto a questa voce nel buio e quantomeno tentare di attraversare la soglia dell’immaginale con un altro spirito, con un’altra concezione mentale, che ci permettano di considerare il ‘fuori’ sotto una nuova luce: forse esso esiste ed è qui che si trova.
Proviamo a raffigurare l’esterno come un luogo vivibile. Tentiamo di fare uno sforzo: immaginiamo quello che è fuori dai nostri bunker come se fosse un mondo simile a quello immaginale, ma legato in modo inscindibile al nostro tempo, alla nostra carne, ai nostri corpi. Cosa potremmo fare se non uscire?
Credo che davvero sia possibile, concretamente, uscire dal bunker e che lo spazio immaginale dove viviamo tutte le straordinarie esperienze che formano la nostra vita possa essere veramente solo un luogo virtuale controllato dall’onnipresente Apparato, all’interno del quale noi subiamo un intrattenimento vuoto, utile soltanto a tenerci chiusi, serrati nei nostri bunker, necessario per insegnarci subdolamente che il fuori non esiste e la pestilenza perenne ci ucciderebbe all’istante.
O forse i virus sono lì in agguato e provano a entrarmi nel cervello nel tentativo di avermi e potersi nutrire delle mie carni.
L’Immaginazione è lo spazio dove la magia è possibile. Se nell’Immaginazione ciò che è corporeo diventa spirituale e ciò che è spirituale diventa corporeo, allora l’immaginazione è il punto d’incontro tra i due domini opposti del mondo: è il luogo dove la materia e lo spirito si incontrano. È il vecchio sogno della magia: fare cose con le parole.
Il «Dadaismo immaginale» sperato da Edurr potrebbe essere davvero l’insegnamento sul quale si basa il controrituale tramite cui poter trascendere l’immaginale e raggiungere l’Immaginazione. Si tratta di magia rituale, adesso lo so. Ogni giorno, da quando ho ritrovato questo dossier tecno-sciamanico, pratico l’Immaginazione nel tentativo di congiungere ‘corporeo’ e ‘immaginale’ nell’unico luogo d’incontro. Sono convinto che così mi sarà possibile uscire dal bunker. Sono sicuro che questa possa essere una strada, l’unica.
***
Se qualcuno sta leggendo o leggerà questi miei file testuali, che sembrano stralci di strani appunti e divagazioni: io mi rivolgo a te. Non prenderli come uno studio filologico molto fantasioso. Le parole che ho qui riportato sono davvero state scritte nel 2020, un anno catastrofico i cui eventi eccezionali sono forse soltanto i primi di una lunga catena. Non importa chi tu sia o quanto tempo sia passato da quell’anno emblematico. Siamo tutti arrabbiati e delusi dai nostri simili. In collera con i nostri avi per il mondo che ci hanno lasciato e sprezzanti verso i nostri figli e i figli dei nostri figli e tutte le generazioni a seguire. Ci chiediamo entrambi se la nostra esistenza si possa ridurre a un’illusione e se questa si trovi al momento culminante della sua egemonia. Sentiamo tutti l’avvicinarsi dell’apocalisse, eppure potrebbe essere già avvenuta, più di una volta, e potrebbe ripetersi per sempre. Non c’è differenza tra me e te: siamo vivi poiché possiamo morire. Questo è il rischio di essere. Andare incontro alla fine senza considerare i limiti del corpo, abbandonarsi alla vita. Arrendersi alle frustrazioni del tempo, alle domande senza risposta, alla possibilità che niente abbia senso e tutto sia falso. Cos’è poi vero o falso? Edurr e il suo diario misterioso sono davvero più reali delle mie mani e dell’epidermide morbido e liscio che le conchiude? Il mio respiro, qui dentro, è più reale di ciò che vedo tramite le lenti? Abbiamo sconfitto la morte oppure è la morte che ci ha battuto dandoci l’illusione che non esista più, che sia finalmente scomparsa?
Eppure ho in testa delle immagini di corpi sconosciuti che s’incontrano, si toccano e si penetrano l’un l’altro. Li vedo mentre riposano. Queste immagini sono meno reali di quelle che osservo oltre il Varco del cyberspazio? Morire e vivere, sono davvero gli opposti; oppure vivere corrisponde proprio a morire?
Quello che ti chiedo è una cosa semplice e di enorme portata, un atto collettivo. Ti chiedo di partecipare al controrituale con un gesto elementare che può davvero cambiare il mondo. Sollevati e respira profondamente. Guarda l’esterno e spalanca l’apertura del bunker. Esci dal loculo che chiami casa e respira di nuovo e se morirai,
Testo tratto da: AA.VV.,Piccola antologia della peste, Ronzani editore 2020
di Paolo Godani

Sono due le istanze fondamentali che guidano il lavoro filosofico di Paolo Virno dal Saggio sulla negazione. Per una antropologia linguistica (Bollati Boringhieri 2013) sino a Avere. Sulla natura dell’animale loquace, passando per le pagine inedite contenute in L’idea di mondo. Intelletto pubblico e uso della vita (Quodlibet 2015) – entrambe volte indagare o a costruire lo spazio che si apre all’intersezione di logica e antropologia.
La prima è l’esigenza di rendere espliciti e il più possibile trasparenti i modi spesso intricati, opachi e non a caso paradossali, con cui il soggetto umano sembra relazionarsi con le proprie caratteristiche naturali o essenziali. È un’esigenza dialettica o, come preferisce dire l’autore, l’istanza di una “filosofia dello spirito intrisa di materialismo” che trova la sua matrice nella filosofia classica tedesca.
La seconda, sulla quale vorrei attirare innanzitutto l’attenzione non solo perché mi è più congeniale, ma anche perché qui in Avere viene in piena luce, è l’esigenza di affermare nella maniera più netta la consistenza al contempo ontologica e impersonale della natura umana, ovvero delle abilità, degli affetti, dei requisiti biologici e delle situazioni storiche che ci definiscono come animali loquaci. È, questa, un’esigenza che porta Virno a un confronto serrato, ma mai accademico, con la metafisica greca (in particolare con il Parmenide di Platone e con le Categorie di Aristotele).
La tesi di Avere, in fondo, è molto semplice: l’essere umano, per il fatto di avere un linguaggio, e in particolare per il fatto che nel suo linguaggio esistano operatori peculiari come la negazione e il verbo avere, è un essere costitutivamente incapace di coincidere con la propria essenza, un essere che si pone costituzionalmente a distanza da se stesso. Lo testimonia, in maniera apparentemente inoppugnabile, la possibilità di “levare la mano su di sé”, cioè di rinunciare al proprio stesso esserci. All’essere umano, a ogni essere umano, può capitare di essere se stesso, solo perché, innanzitutto, può non essere ciò che è – e questo per il semplice fatto che il “ciò che ognuno è”, l’essenza di noi stessi, la possediamo, l’abbiamo, è nostra, sempre e solo come alcunché di estrinseco. Possediamo la nostra natura, ma come qualcosa che non ci appartiene.
Questa tesi, che nelle mani di qualche “squisito” intellettuale alla moda potrebbe diventare un ritornello da cantare in coro ad ogni festival, viene trattata da Virno con estrema circospezione. La stoffa del filosofo si riconosce dal modo in cui riesce ad evitare i tranelli che le sue stesse tesi gli tendono immancabilmente.
Il più infido tra i fili tesi sulla via dell’avere o, più semplicemente, la “tentazione cui può essere indotto il pensiero” è la “credenza sempre fallace, spesso irresistibile, talvolta abietta” secondo la quale il vivente umano sarebbe qualcuno che “compone come un puzzle, anzi inventa, giocando con il linguaggio, l’ousía che più gli aggrada” (cap. 6., § 1.,Domande scabrose). La trappola, dunque, consiste nel prendere il soggetto umano che ha, e non è, la propria essenza, per “un soggetto privo di qualsivoglia prerogativa essenziale” (ibidem), ovvero – se vogliamo considerare la formulazione filosofica più nota di questa credenza, quella heideggeriana – per un soggetto o un Dasein che, in quanto ha da essere la propria essenza, risulterebbe “privo di, o provvidenzialmente esonerato da, qualsiasi requisito essenziale” (cap. 6., § 2., Apparenze inevitabili).
Per evitare il tranello di un soggetto che, in quanto vuoto o indeterminato, sarebbe infine capace di tutto, Virno adotta diverse strategie, tra le quali la più sorprendente è forse il riferimento alla dottrina platonica della “partecipazione” (methéxis). La sorpresa, naturalmente, sarebbe frutto di ingenuità, se è vero che il verbo metéchein implica échein, “avere”. Per il soggetto umano avere, e non essere, la propria essenza, significa partecipare della natura umana (cfr. cap. 4, § 1. Partecipazione). Il punto rilevante, qui, è che affermare il distacco dell’animale umano dalla propria essenza non ha la funzione di stabilire la nostra abissale e angosciosa assenza di determinazione, cioè la nostra “libertà”, bensì di stabilire che ognuno è parte, modo, variazione di una natura comune. I tratti caratteristici della natura umana, spiega in questo senso Virno, non sono in alcun caso predicati ascrivibili ad un soggetto, ma sono res, cose, che non mancano di manifestare una perfetta indipendenza rispetto a ogni loro singola “incarnazione”.
È forse persino superfluo aggiungere che questo prelievo platonico non conduce Virno ad assumere per interno la dottrina platonica delle idee, ivi compresa, dunque, la pre-esistenza di queste ultime. Ma che le idee non esistano per sé e non popolino l’Iperuranio, bensì siano esse stesse il prodotto di azioni, abitudini, usi, non le priva affatto della loro consistenza ontologica, né del loro carattere impersonale ed estrinseco. Nella sintesi di Virno: “Mettere al centro della scena l’incompatibilità delle abilità e degli affetti che abbiamo con la funzione predicativa equivale a segnalare la consistenza ontologica di quelle abilità e di quegli affetti, vale a dire la loro natura di res autonome. Le azioni partecipative emancipano i requisiti biologici e le occasioni storiche cui si applicano dalla imbarazzante condizione di puri contenuti semantici, di significati indipendenti dalla prassi. Ne fanno piuttosto delle risorse estrinseche, impersonali, pubbliche” (cap. 4, § 7. Risorse pubbliche, non predicati).
Resta, tuttavia, il fatto che, di queste risorse estrinseche, impersonali e pubbliche, qualcuno sembra far uso. Virno non si accontenta di dire che le abilità e gli affetti caratteristici della natura umana presentano un ampio spettro di variabilità, con cui di volta in volta si realizzano in questo o quel singolo individuo. Non si accontenta, cioè, di mettere la variabilità (e, di conseguenza, l’individuazione) tutta a carico di quella stessa natura comune di cui ognuno di noi è parte. Né l’affermazione del distacco, né il tema dell’uso mi pare precludano questa via: si potrebbe dire, per esempio, che non sono i singoli individui a usare la natura umana, ma che è quest’ultima a far uso di sé, attraverso gli individui che la incarnano di volta in volta.
Ma è un’altra la strada che Virno prende sul finale del testo, dove, parlando del “groviglio logico e antropologico” che caratterizza il “paradosso della soggettività”, non rinuncia a sostenere che il soggetto, cioè “l’avente, pur essendo determinato fin nelle sfumature dall’avuto [cioè la natura umana], mantiene una spiccata autonomia, o distanza, da ciò che possiede” (cap. 6., § 3., Tre coppie per una danza). Virno vede molto bene che se il soggetto, pur conservando una qualche autonomia, è interamente determinato dalla natura che possiede, non ha alcun senso domandarsi che cosa esso sia al di là di quella natura – dato che la risposta potrebbe essere soltanto una, ovvero che il soggetto è appunto la natura che ha. Ecco allora che l’unica strategia possibile resta quella, tipicamente aristotelica, di sviare la ricerca di una definizione. Non, dunque, domandarsi che cosa sia il soggetto che ha la propria vita e la propria natura, i propri affetti e la propria biografia, ma come si configuri la sua situazione paradossale. Una fenomenologia.
E una dialettica, per quanto spaesata. Ammessa l’autonomia del soggetto umano, la sua situazione sembra quella di un essere anfibio, capace di sopravvivere in due ambienti differenti solo perché si trova sempre in quello sbagliato.
L’umano sembra potersi appropriare della natura che è sua, ma in realtà non può che viverla come un portato esteriore: posso dire, certo, “questo è il mio corpo”, ma non mancando di percepire tutta l’estraneità che questo mio stesso corpo porta con sé. Oppure, viceversa, posso sapere che l’affetto di amore o d’ira che mi trascina è alcunché di comune a tutti, eppure non posso, al contempo, non assaporarne o soffrirne la declinazione particolare che esso sembra assumere per il fatto di essere il mio affetto di amore o d’ira. Da un altro punto di vista (che declina lo spaesamento della dialettica esistenziale in termini temporali), il vivente umano possiede la propria natura non come si possiede un pacchetto di beni utilizzabili, ma la possiede come un credito esigibile: “ha realmente le risorse innate che gli spettano, il vivente creditore, ma le ha a mo’ di ipoteca sull’avvenire” (cap. 6, § 6. Debito e credito). D’altra parte, questo stesso “creditore della propria essenza” (ibidem) è anche qualcuno che “ha ricevuto le proprie prerogative essenziali senza dare in cambio alcunché” (ibidem); è cioè un “vivente indebitato”.
di Roberta Salardi

Frammento tratto da Trilogia della scomparsa di Roberta Salardi, Effigie, settembre 2020 (pagg 99-102)
T’è mai capitato di mangiarti le mani? Io ho continuamente voglia di masticare qualcosa, qualunque cosa. Finito il pane e le sigarette, mi mangio le unghie, i capelli, le pellicine… Finiti i miei, vorrei passare ai tuoi. Ma dopotutto non credo affatto che staresti meglio senza tua madre. Nonostante tutto, ti sono necessaria. Qualcuno deve pur piangere sul latte versato! Tu saresti capace di sprecare persino l’olio senza fare una piega.
«Senti quello che dico?»
Mi fai blaterare e blaterare al vento. Dov’è quel disgraziato di tuo fratello? Non è colpa sua se non risponde. Sei tu che l’hai ridotto così.
È difficile per te immaginare una corsa per portare a qualcuno, da qualche parte, a qualcuno, un corpo freddo, bagnato, ferito, esanime, svenuto, trascinato correndo, prendendo in braccio un corpo morto, incespicando, sollevato ansimando, pesantissimo, caduto, cadendo a corpo morto, rialzandosi, facendosi aiutare da qualcuno sulla strada, forse dietro l’angolo, fuori dalla boscaglia, credendo che fosse un tuffo non un scivolata, mettendo male il piede, raddrizzandosi, il corpo di qualcuno respirante, gorgogliante però muto, assente, snodato, annegato, il corpo di un fiume, di un mare scivolato per sbaglio in una bocca, in una gola aperta, con i pesci che vogliono nuotare, saltare, respirare, il naso che vuole respirare, uscire tra le foglie, gli occhi chiusi che anelano alla luce oltre i rami, oltre la superficie delle foglie, ma la testa riversa, un braccio pesantissimo, il corpo molle, sciolto, libero di nuotare sbracciato, con la testa indietro, in giù, crollata, scrollando l’acqua, vomitando i pesci, la sabbia, le mie collane, nuotando, affogando, sbagliando strada, rifacendola a testa in giù, sott’acqua, ma respirando ancora, soffiando, senza dimenticare di saltare le onde, mangiare i pesci, passare sotto i rami, dandomi la spinta, ancora un colpo di reni, incrociando qualcuno, chiamando a gran voce, a grandi bracciate…
È difficile immaginare le fatiche inutili, le corse controvento, il tempo perso per salvare qualcuno: per qualcuno che era già morto tanto tempo fa, a sedici anni: felice di esserlo, di sedici anni e morto per sempre.
Lasciatemi stare! Sto tanto bene dove sono… Voi scherzate! Non tornerò per due donnette stupide, per una madre che straparla e per una ragazzina presuntuosa e petulante, favola di tutto il quartiere. Tutti ridono a crepapelle alle nostre spalle per le sue stramberie e vanterie. Una che vorrebbe darsi a tutti ma nessuno si prende, tanto per capirci. C’è da vergognarsi ad avere una famiglia così. Non tornerò per un inferno ammobiliato con cucina abitabile, meglio non abitarle troppo le cucine: pane e sangue marcio, sangue marcio con e senza pane… Soprattutto se torna mio padre, quello proprio non fatemelo rivedere. Lavorava ma era sempre povero in canna; manco a farlo apposta, più lavorava e più era povero… Qua in giro non lo poteva vedere nessuno. Doveva dei soldi a metà isolato e tutti a chiedere a me, da quando era sparito, manco m’avesse lasciato l’eredità, lo stronzo. Mia madre, una scema e mia sorella, una stronza anche peggio di mio padre. Due gocce d’acqua. Mai una volta in sedici anni che mi abbia regalato uno dei suoi ciondoli, delle sue collanine, che so, da rivendere tanto per farci qualche dose, per sballare un po’ con gli amici. Poteva venire anche lei se voleva. Ma no, lei faceva la freddina, la perfettina. Si dava un tono, la cretina, poi si sarebbe fatta scopare da cani e porci, soprattutto i porci. Se per caso c’era un nuovo arrivato scartato da tutti con la faccia da depravato, quello le piaceva. E chiedeva a me come arrivarci, come fare a conoscerlo. Ah, sì? E tu cosa mi dai in cambio? Inutile stare a spiegarle, solo tempo perso. Quante volte avevo provato a dirle che volevo ritrovare nostro padre per spaccargli la faccia? Ma lei non ascoltava, le parole le entravano da un orecchio e le uscivano dall’altro. Solo canzonette. Non aver tirato un pugno a mio padre, questo sì, questo lo rimpiango. Ma non rovinatemi il trip, se no m’incazzo. Questa è la dose più figa che mi son fatto, se permettete.
Non torno indietro certo per quella faccia di merda di chi ha avuto la viltà di mettermi al mondo. Prima si è scopato per bene mia madre, ma non è tutto. Non gli è bastato. Ci ha pure lasciato a galleggiare tutti quanti in questa fogna. Grazie tante. È questo che dovrei dirgli? Bastardi!
Dovrei tornare indietro per voi, figli di puttana?
Le fighe… ho capito dove volete arrivare. Ma io non ne ho bisogno. Visto che ci tenete, v’insegnerò un trucco. Si può arrivare al bello saltando quel passaggio, tutta la rottura di coglioni delle donne. Io ci ho dato un taglio. Be’ c’è chi può, modestamente…
Quando scopri la chimica, sei salvo. Sei Dio, cazzo!
Modestamente, ce l’ho fatta. Io sono in paradiso. E voi crepate, stronzi!
Mia madre che correva per le scale cercando di capire, di sentire: «Cos’è successo?» Ma il fiato era fermo in gola, allacciava le parole. Scendendo, risalendo le scale. Correndo con lentezza, la voce arrotolata, le gambe annodate… «Ho sentito qualcosa…» … i piedi… «un rumore… » … pietrificati… «Perché i piedi sono così freddi?» Non un rumore, un grido. «Mi avete chiamata?» I piedi pesantissimi. Un corpo scomposto, un grido disarticolato, caduto giù per le scale… Scendendo, non più salendo, solo scendendo… «Non sarà…?» Il corpo ghiacciato. «Fulvio! Martina!» Credevo fosse un tuffo, non una scivolata. Quando uno salta sugli scogli e sta provando… salta sui lastroni… «Martina!» Credevo fosse una finta, non una caduta… «Non è possibile!» Una passeggiata, non una corsa. «C’era qualcuno con te, se no… » Saresti capace… «Dov’eri?» Soltanto una stupida…
trad. isometra di Daniele Ventre (da Omero, Odissea, ed. Mesogea, Messina, 2014)
Dentro la sala, frattanto, lo splendido Odísseo rimase,
e per i proci tramava insieme ad Atena l’eccidio:
Dunque a Telemaco in fretta parlò con alate parole:
«Dentro, Telemaco, è bene che tu le armi d’Ares deponga,
sì, tutte quante; ed ai proci, invece, con dolci parole
parla, se mai ne cercassero e ne domandassero conto:
«Le ho allontanate dal fumo, ché più non sembravano quelle
che nel partire per Troia Odísseo ci aveva lasciate,
sono annerite, fin dove è giunta la vampa del fuoco.
Ansia più grande mi pose un nume nel cuore, per giunta,
che suscitiate discordia fra voi nell’ebbrezza del vino,
che vi feriate l’un l’altro e poi funestiate il banchetto
e il corteggiare; da solo è stimolo agli uomini il ferro!»
Sì, così disse, e a suo padre Telemaco allora obbediva;
dunque chiamandola fuori, parlò alla nutrice Euriclea:
«Nonna, suvvia, nelle stanze per me tu trattieni le donne,
fino a che l’armi del padre al chiuso io non abbia riposte,
belle, che dentro la sala il fumo consuma d’incuria,
ora che il padre è lontano; io prima ero ancora un fanciullo;
voglio riporle, ora, dove il fumo del fuoco non giunga».
E di rimando gli disse la cara nutrice Euriclea:
«Figlio, se infine volessi avere una volta attenzione,
sì da curare la casa e guardare tutti i tuoi beni!
Ora però chi, venendo al tuo fianco, ti farà luce?
Serve, che luce t’avrebbero offerta, non vuoi far uscire».
Ed a lei dunque l’accorto Telemaco disse, per contro:
«L’ospite: non lascerò che rimanga inerte, colui
che del mio pane si ciba, benché da lontano sia giunto!»
Egli così le parlò: le restò senz’ali la voce:
chiuse la vecchia le porte alle ben tenute dimore.
Dunque balzarono in piedi Odísseo e il suo splendido figlio,
dentro portarono gli elmi e gli scudi adorni d’umboni
e acuminate le lance; ed innanzi Pallade Atena
con una lampada d’oro spandeva bellissima luce.
Ecco che allora si volse Telemaco in fretta a suo padre:
«Padre, che grande prodigio è questo che vedo con gli occhi!
Ecco, le mura di casa e insieme le belle campate,
come le travi d’abete e i pilastri in alto levati,
sono visibili agli occhi, nemmeno avvampasse una fiamma.
Sì, nella casa c’è un dio che abita il cielo spazioso!»
E gli diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Resta in silenzio, il pensiero racchiudi e non fare domande:
tale è l’usanza dei numi che hanno dimora in Olimpo.
Ora tu va’ a riposare, ché qui rimarrò solo io,
provocherò nuovamente le ancelle e con esse tua madre;
addolorata com’è, mi domanderà d’ogni cosa».
Sì, così disse; andò via, Telemaco, lungo la sala,
sotto il brillio delle lampe, a dormire nelle sue stanze,
là dove sempre giaceva, raggiunto da sonno soave;
lì si distese anche allora e attese la splendida Aurora.
Dentro la sala, frattanto, lo splendido Odísseo rimase,
e per i proci tramava insieme ad Atena l’eccidio:
E dal suo talamo uscì Penelope ricca di senno,
ed in figura eguagliava Artemide o l’aurea Afrodite.
Presso il camino le misero un trono–e su quello s’assise–,
ch’era intarsiato d’avorio e d’argento e dal carpentiere
fu fabbricato, da Icmalio, ed uno sgabello da piedi
ebbe adattato vicino, su cui un gran vello era steso.
Sì, su quel trono sedé, Penelope ricca di senno.
Bianche di braccia le ancelle le vennero intanto di sala.
Ed abbondanza di pane portarono via, con le mense
e con le coppe da cui bevevan potenti signori;
via dai bracieri gettarono i tizzi, poi molta altra legna
su vi disposero, sì che recasse luce e calore.
Ma nuovamente Melanto a Odísseo rivolse rampogna:
«Ospite, ancora sèi qui, per infastidirci di notte,
mentre t’aggiri per casa, magari a spiare le donne?
Vattene fuori, meschino, e contèntati del banchetto;
o te n’andrai fuori presto, colpito da qualche tizzone».
La guardò bieco e rispose Odísseo ricco d’ingegno:
«Trista, perché mi tormenti così, con la collera in cuore?
Forse perché sono logoro, indosso ho ben misere vesti,
mèndico in mezzo alla gente? La necessità mi costringe!
Già, sono fatti così i girovaghi e i mendicanti.
Ed anche io abitavo fra gli uomini un tempo una casa
prospera, ricca di beni e molto donavo a un mendico,
quale che fosse, qualunque bisogno l’avesse a me spinto;
e servitori infiniti avevo, e tant’altra ricchezza,
quanta ne hanno coloro che han fama d’agiati e di ricchi.
Pure, ogni bene distrusse Zeus Cronide –già, l’ha voluto–.
Donna, per questo ora bada anche tu a non perdere tutta
la vanagloria che adesso inalberi in mezzo alle ancelle,
se la padrona alla fine dovesse colpirti, adirata,
o ritornasse qui Odísseo (la sorte ha con sé la speranza)!
Anche se fosse perito e non più vedesse il ritorno,
pure, Telemaco ormai per grazia d’Apollo è cresciuto,
il figlio suo: fra le donne, nessuna a palazzo gli sfugge,
che sia sleale, poiché non ha più l’età d’un fanciullo!»
Sì, così disse e l’udì, Penelope ricca di senno,
mosse rampogna all’ancella, parlò, le rivolse parola:
«Certo che no, non mi sfuggi, tu, cagna impudente, sfrontata,
tale misfatto hai commesso, che lo laverai col tuo capo!
E ben sapevi ogni cosa, poiché da me stessa tu udisti
ch’io avrei fatto domande all’ospite nelle mie stanze,
quanto al mio sposo, poiché per lui ho crudele tormento!»
Disse, e rivolse parola a Eurinome, la dispensiera:
«Porta tu dunque un sedile, Eurinome, e sopra anche un vello,
sì che si possa sedere e parlare e udire parola,
l’ospite, presso di me: desidero fargli domande».
Sì, così disse e la donna in fretta si mosse a portare
un levigato sedile ed un vello sopra vi stese;
là si sedette a sua volta lo splendido Odísseo costante;
prima fra loro parlò Penelope ricca di senno:
«Ospite, questo da prima ti domanderò io in persona:
chi sèi al mondo, e di dove? E dove hai città, genitori?»
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Donna, di te fra i mortali nessuno su terra infinita
mai sparlerà: la tua gloria si leva nel cielo spazioso,
fama d’un sire impeccabile e incline a temere gli dèi,
d’uno che regni sovrano su eroi numerosi e valenti,
ben ministrando giustizia; e la nera terra produce
orzo e non meno frumento, son gli alberi colmi di frutti,
sana progenie han le greggi, e procura pesci anche il mare,
grazie al suo saggio governo, per lui la sua gente fiorisce.
Ora, però, tutto quanto domandami, nella tua casa,
ma della stirpe non chiedermi e non della terra dei padri,
per non riempire più oltre il mio cuore di sofferenze
a ricordarle; son troppo afflitto ed a me non bisogna
in una casa di genti straniere fra gemiti e pianti
starmene, no, poiché è male aver sempre pena infinita;
che non s’adiri con me un’ancella o forse tu stessa,
che non si dica che piango dal cuore oberato di vino!»
Gli rispondeva a sua volta Penelope ricca di senno:
«Il mio valore e il mio aspetto, o straniero, ed anche il mio corpo
han gli immortali disfatto, da quando per Ilio gli Argivi
sono partiti e partì Odísseo con loro, il mio sposo.
S’egli, una volta tornato, mi risollevasse alla vita,
anche più grande e più bella sarebbe così la mia fama!
Ora m’angoscio, poiché troppi mali un dio m’ha scagliato.
Tutti i più nobili, quanti sull’isole hanno potere,
tanto a Dulichio che a Same e a Zacinto verde di selve,
tutti coloro che sono i signori d’Itaca impervia,
a mio dispetto mi fanno la corte e distruggon la casa.
Ecco perché non mi curo dei supplici e degli stranieri,
né degli araldi, di quanti del popolo sono al servizio.
Dentro il mio cuore mi struggo e l’amato Odísseo rimpiango.
Gli altri m’affrettan le nozze; io frattanto inganni dipano.
Prima l’inganno del manto un dio m’ispirò nella mente,
prendere a ordire a palazzo una grande tela e imbastirla,
tela sottile ed immensa; ed in mezzo ai proci poi dissi:
«Giovani proci, poiché Odísseo splendido è morto
pur impazienti di nozze, attendete, fino a che un manto
non compirò –che le fila non vadano perse nel vento–,
funebre manto a Laerte eroe, per il giorno che a lui
venga la Moira funesta di morte diuturna di pene,
che fra le schiere d’Achee con me non si sdegni nessuna,
se giacerà senza veste chi già possedé tanti beni».
Sì, così dissi ed in loro persuaso fu l’animo altero.
Ecco che allora di giorno tessevo la grande mia tela,
e la sfacevo di notte, avendo le fiaccole accanto.
Dunque occultai per tre anni l’inganno e persuasi gli Achei;
ma, come fu il quarto anno, tornarono indietro stagioni,
al declinare dei mesi, e lunghi passarono i giorni,
ecco che allora per colpa di ancelle, di cagne impudenti,
vennero a cogliermi in fallo, e poi mi gridaron minacce.
E così io la compii, benché non volessi, di forza;
ora alle nozze non posso sfuggire, né più nessun altro
piano riesco a trovare; e mi pressano i genitori
a maritarmi, s’infuria mio figlio –gli ingoiano i beni–
ché ne ha coscienza; oramai è un uomo che più d’ogni cosa
è della casa sollecito, e Zeus gli concede fortuna.
Ora, però, la tua stirpe rivelami, donde tu venga;
certo non già dalla quercia primeva, non già dalla roccia!»
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«O venerabile sposa di Odísseo nato a Laerte,
dunque non recederai dal chiedermi della mia stirpe?
Ecco che a te la dirò; mi consegnerai a un dolore
grande più d’altro che soffro; ed è giunsto, se dalla patria
sua manca un uomo per tutto il tempo ch’io ora ne manco,
fra le città dei mortali errando e soffrendo dolori.
E tuttavia ti dirò ciò che tu mi chiedi e domandi.
Creta, una terra, si leva nel mare colore del vino,
bella e opulenta, dall’onde accerchiata; e d’uomini accoglie
gran moltitudine, stuolo immenso, e città ne ha novanta
–ha la sua lingua ogni popolo, è un misto; e vi sono gli Achei,
gli Eteocretesi dal cuore magnanimo, e anche i Cidoni,
e le tre stirpi dei Dori e splendide genti, i Pelasgi–,
Cnosso è fra quelle, la grande città di cui re fu Minosse
che s’incontrava con Zeus il grande, ogni nove stagioni,
e di mio padre era padre, di Deucalïone animoso.
Me generò Deucalione, e insieme Idomèneo sovrano;
questi però verso Ilio a bordo di navi ricurve
se ne partì con gli Atridi; Etone è il glorioso mio nome,
sono minore per nascita; il primo è Idomèneo e il più forte.
Là vidi Odísseo io in persona e gli diedi doni ospitali.
Già, ché l’aveva sospinto a Creta la forza del vento,
mentre puntava su Troia, dal capo Malea lo distolse;
egli in Amniso approdò, dove è l’antro sacro a Ilizia,
dentro non facili cale, a stento evitò le procelle.
Ci domandò d’Idomèneo, appena fu giunto alla rocca;
si proclamava suo amico ed ospite suo riverito.
Era oramai alla decima o forse all’undecima aurora,
dalla partenza per Ilio a bordo di navi ricurve.
Io lo condussi alla mia dimora e un buon ospite fui,
con ogni cura l’accolsi, poiché c’era molto a palazzo;
doni anche agli altri compagni che s’erano mossi al suo fianco
feci, prendendo farina dal popolo e limpido vino
ed immolando giovenchi, perché si saziassero in cuore.
Dodici giorni laggiù restaron gli splendidi Achei;
li tratteneva gran vento di Bòrea, e non ci lasciava
sorgere in piedi, anche a terra: un avverso iddio lo destava;
nel tredicesimo il vento cessò, se ne andarono tutti».
Molte menzogne fingeva, dicendone simili al vero;
ella, ascoltandole, ruppe in pianto e si sciolse il suo volto.
Come la neve si scioglie sui monti dagli alti crinali,
quella su cui soffia l’Euro, da poi che l’ha Zefiro sparsa,
e della neve disciolta si riempiono i corsi dei fiumi:
tali si sciolsero a lei, profusasi in pianto, le guance,
mentre piangeva il suo sposo a lei prossimo. Odísseo frattanto
s’impietosiva di cuore, al piangere della sua donna,
ma come corno i suoi occhi restavano, o simili a ferro,
sotto le palpebre immoti: celava le lacrime ad arte.
Ma non appena fu sazia del suo lacrimevole pianto,
ella di nuovo rispose con queste parole e gli disse:
«Ospite, adesso però di te voglio fare la prova,
se veramente laggiù coi compagni pari agli dèi
hai ospitato il mio sposo a palazzo, come tu dici.
Dimmi che foggia di vesti indossava sulle sue membra,
e quale aspetto egli avesse e i compagni giunti al suo fianco».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Donna, è difficile prova, poiché tanto tempo è trascorso
da quel momento; oramai il ventesimo anno è venuto
da che laggiù se n’è andato, è partito dalla mia patria;
e tuttavia ti dirò come sembra fosse al mio cuore.
Folto, purpureo mantello lo splendido Odísseo portava,
doppio; ed inoltre una fibbia a duplice scanalatura,
aurea, v’era attaccata; e un bel fregio aveva davanti:
fra le sue zampe anteriori un cane stringeva e guardava
uno screziato cerbiatto guizzare; ammiravano tutti
come quel cane, pur d’oro, stringesse e guardasse il cerbiatto
come, proteso alla fuga, guizzasse il cerbiatto coi piedi.
Vidi all’eroe sulle membra un chitone tutto sgargiante
ed era morbido al punto da rassomigliare alla buccia
d’una cipolla essiccata, e splendente, simile a un sole.
E lo guardarono in molte, davvero, ammirate, le donne.
E un’altra cosa ti dico, tu ponila dentro il tuo cuore;
io non lo so, se già a casa Odísseo li avesse sul corpo,
se da un compagno egli li ebbe, salendo sull’agile nave,
se da un suo ospite, già, poiché a molti Odísseo era stato
caro; ed in mezzo agli Achei in pochi eran simili a lui!
Ed anche io gli donai una spada bronzea e un chitone
tutto di porpora, doppio, e leggiadro e adorno di frange,
lo accompagnai con onore alla nave salda di banchi.
Ed al suo fianco un araldo di poco più avanti negli anni
era; e non meno di lui dirò quale fosse l’aspetto:
curvo di spalle, di scuro incarnato, chioma ricciuta,
ed il suo nome era Euribate; Odísseo pregiava più lui
di tutti gli altri compagni, ché avevano in cuore concordia».
Disse ed in lei ben più grande destò desiderio di pianto:
ben riconobbe quei segni sicuri che Odísseo svelava;
ma non appena fu sazia del suo lacrimevole pianto,
ecco che allora rispose con queste parole e gli disse:
«Ospite adesso davvero, se prima apparivi pietoso,
nelle mie case sarai ben accetto nonché riverito:
già, ché io stessa gli diedi le vesti di cui tu mi dici,
le dispiegai dalle stanze, appuntai il lucente sperone
sì che gli fosse ornamento… Ma non lo potrò riabbracciare,
ché non ritornerà a casa, alla cara terra dei padri.
Certo per triste destino Odísseo su concava nave
se ne partì per vedere Ilio infausta, l’innominanda».
E le diceva in risposta Odísseo ricco di ingegno:
«O venerabile sposa di Odísseo nato a Laerte,
non consumare il carnato gentile piangendo il tuo uomo,
non macerarti nell’animo. Oh, io non ti biasimo certo,
no, ché ogni donna s’affligge, se perde il legittimo sposo,
quello a cui diede dei figli, congiuntasi a lui nell’amore,
sia pur da meno di Odísseo, che dicono eguale agli dèi!
Smetti di piangere, dunque, e le mie parole comprendi:
ti parlerò con parola sincera e non celerò nulla
di quanto io del ritorno di Odisseo ho già appreso da tempo,
che non lontano, sul suolo opimo di genti Tesprote,
egli, ancor vivo, assai doni trasporta alla propria dimora,
chiestili in quella contrada. Sul mare colore del vino
perse i diletti compagni e insieme la nave leggera,
dalla Trinachia partendo, da un’isola; l’ebbero in odio
Zeus ed il Sole: i compagni uccisero i bovi del Sole.
Essi morirono tutti sul mare agitato dall’onde:
lui su una chiglia di nave i flutti han gettato a una costa,
terra di genti feaci, che sono congiunte agli dèi;
queste accordarono a lui di cuore gli onori d’un dio,
molto gli offrirono in dono, e volevano anche scortarlo
senz’altro danno qui in patria. E da tempo Odísseo sarebbe
qui: ma diverso disegno al suo cuore parve più saggio,
di radunare ricchezze scorrendo ampio tratto di terra:
già, poiché Odísseo più d’altri, in mezzo alle genti mortali,
vie di guadagno conosce, mortale con lui non gareggia!
Proprio così mi narrò il re dei Tesproti, Fidone:
egli giurò al mio cospetto, ed intanto in sala libava,
ch’era già in mare la nave ed erano pronti i compagni,
quelli che qui scorteranno Odísseo, alla terra dei padri.
Ma rimandò prima me; andava per caso una nave
di marinai dei Tesproti a Dulichio ricca di grano.
e mi mostrò tutti quanti i beni che Odísseo raccolse.
D’altri potrebbe allevare la decima generazione,
tanti tesori a palazzo del sire giacevan riposti!
Disse che s’era recato a Dodona, inteso a carpire
piani di Zeus dalla quercia divina dall’alto fogliame,
come potrà ritornare ad Itaca, terra opulenta,
–n’era lontano da tempo–, se incognito oppure palese.
Egli così s’è salvato, perciò, ti sarà ben vicino
presto, ed ancora lontano dai cari, da terra di padri,
non rimarrà lungo tempo: suvvia, ne farò giuramento.
Sappia per primo ora Zeus, lui, ottimo e sommo fra i numi,
e il focolare di Odísseo impeccabile, a cui son giunto:
si compirà senza dubbio ogni evento come t’annuncio.
Ora che muta è la luna Odísseo verrà a questi luoghi,
al declinare del mese, o al nascere del successivo».
E di rimando gli disse Penelope ricca di senno:
«Ospite, questa parola potesse adempirsi davvero:
conosceresti da me ben presto amicizia, con molti
doni, così che ti chiami beato chiunque t’incontri!
Altro s’attende il mio cuore, per come s’annuncia il futuro:
no, non ritornerà a casa Odísseo, e da lui tu congedo
non otterrai, poiché più non esiste in casa un padrone
simile a ciò che fu Odísseo fra gli uomini, se lo fu mai,
nel dare asilo e congedo agli ospiti suoi riveriti.
Ora lavacro fornitegli, ancelle, apprestategli il letto,
coltri e non meno lenzuola e anche coperte sgargianti,
giunga fra quieti tepori all’aurora trono-tutt’oro!
E l’indomani lavatelo e ungetelo presto, all’aurora,
che nella casa il banchetto vicino a Telemaco goda,
dentro la sala sedendo. E male per quello fra i proci
che roso in cuore gli dia fastidio, ché più nessun frutto
qui fra di noi coglierà, per molto che s’incollerisca!
Ospite, come di me capiresti che fra le donne
su tutte l’altre io eccello per mente e saviezza d’ingegno,
se mal vestito e dimesso dovessi sederti a banchetto
dentro la sala? Destino degli uomini è un vivere breve.
Uno che appaia crudele e crudeli azioni conosca,
ha per augurio dolori da tutti i mortali in futuro
mentre è ancor vivo, e da morto lo coprono tutti d’infamia;
Uno che candido appaia e candide azioni conosca,
vede fra gli uomini tutti diffondersi l’ampia sua gloria
grazie ai suoi ospiti, e sono in molti a chiamarlo valente».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«O venerabile sposa di Odísseo nato a Laerte,
no, le lenzuola, per me, nonché le coperte sgargianti
sono aborrite, da quando i monti innevati di Creta
abbandonai, e salii sulle navi dai lunghi remi;
io dormirò come ho sempre dormito le insonni mie notti.
Già, ché su turpe giaciglio di notti oramai ne ho trascorse
molte ed ho atteso la bella sul trono, la splendida Aurora.
Né tantomeno al mio cuore il lavacro per i miei piedi
giunge gradito; i miei piedi non li toccherà, no, una donna
fra tutte quante le serve che vivono nella dimora:
solo un’anziana, una vecchia che probi pensieri conosca,
una che avesse sofferto le pene ch’io pure ho sofferte:
ad un’anziana non io vieterei toccare i miei piedi».
E di rimando gli disse Penelope ricca di senno:
«Ospite mio, mai, finora, un uomo di tanta accortezza,
fra gli stranieri lontani, o più caro, in casa mi giunse,
con tale senno tu trovi per tutto un’accorta parola!
Vecchia un’ancella, sì, l’ho, chiude in cuore saggi pensieri,
quella che ben accudì l’afflitto, colei che lo crebbe,
presolo fra le sue braccia, appena lo fece la madre;
ella ti laverà i piedi, sebbene sia ormai senza forze.
Lèvati, adesso, suvvia, Euriclea, tu, ricca d’ingegno,
lava un coetaneo del tuo signore; anche Odísseo, magari,
è diventato così, nei piedi, e così, nelle mani:
nella sciagura i mortali raggiungono presto vecchiaia».
Sì, così disse, e l’anziana celò fra le mani il suo volto,
lacrime calde versò, e parlò parola di pianto:
«Ah, per te, figlio, rimango sgomenta! Te Zeus più degli altri
uomini ha preso ad odiare; e hai mente che teme gli dèi.
Mai un mortale bruciò per Zeus il signore del lampo
in tale numero cosci opulenti e scelte ecatombi,
quante ne offristi tu a lui, pregandolo, per arrivare
alla felice vecchiaia, e allevare il fulgido figlio;
ora a te solo del tutto fu tolta ogni luce al ritorno!
Forse lui stesso così ricopron d’infamie le donne
degli stranieri lontani, se è giunto a gloriose dimore,
come anche te queste cagne ricoprono tutte d’infamia,
e per fuggire le loro offese e le troppe insolenze,
tu non ti lasci lavare; oh, non m’ha forzata nolente,
no, non la figlia d’Icario, Penelope ricca di senno!
Sia per Penelope stessa io dunque ti laverò i piedi,
sia per pietà verso te, ché dentro hai commosso il mio cuore
con le tue pene. Ma via, ascolta parola ch’io dico:
qui sono giunti stranieri e miseri supplici, in molti;
mai prima d’ora, lo affermo, altri tanto simili ho visto,
quanto somigli tu Odísseo d’aspetto e di voce e di piede».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Vecchia, hanno detto lo stesso coloro che han visto con gli occhi
noi, tutt’e due, che davvero assai simili l’uno all’altro
siamo, così come tu, che hai mente assennata, confermi».
Disse; la vecchia prendeva intanto un bacile lucente,
dove soleva lavare i piedi ed in esso molta acqua
fredda versò, poi v’infuse acqua calda. E Odísseo, frattanto
presso il camino sedeva, ma svelto si volse nel buio:
all’improvviso temé nell’animo che ravvisasse
la cicatrice, prendendolo, e fosse palese il suo piano.
S’appressò ella, a lavare il suo re; all’istante conobbe
la cicatrice già inferta da un verro col candido dente,
quando al Parnaso l’eroe andò presso Autòlico e i figli,
da quel buon nonno materno che in mezzo alle genti brillava
per latrocinio e spergiuro; e questo fu dono d’un dio,
Hermes: infatti per lui i cosci d’agnelli e capretti
egli bruciò, ben graditi; e il dio gli era amico e compagno.
Come fu Autòlico giunto ad Itaca, terra opulenta,
vi ritrovò quel fanciullo che appena era nato a sua figlia;
ecco che allora Euriclea glielo mise sulle ginocchia,
mentre finiva la cena, parlò, gli rivolse parola:
«Trovalo dunque tu stesso, Autòlico, il nome che al figlio
d’una tua figlia imporrai: atteso da tempo a te viene».
E dispiegò la sua voce, Autòlico, e disse in risposta:
«Genero mio, figlia mia, imponete il nome che dico:
io sono giunto fin qui maturando l’odio per molti
uomini e donne su tutta la terra nutrice di genti:
dunque sia Odísseo il suo nome veridico. Ed io, per mio conto,
quando egli giunga nel fiore e la grande casa materna
abbia raggiunta, in Parnaso, nel luogo in cui sono i miei beni,
gliene darò parte in dono e poi lo rimanderò lieto».
E venne Odísseo da lui, perché desse doni stupendi.
E con abbracci e parole di miele accoglienza all’eroe
diedero subito Autòlico e i figli d’Autòlico insieme;
strinse a sé Odísseo anche Anfìtea, che fu di sua madre la madre,
e lo baciò sulla testa, e su tutt’e due gli occhi belli.
Ed ai suoi figli gloriosi Autòlico allora ordinava
di preparare un banchetto: ne udirono tutti l’invito.
Ed all’istante condussero un bove, un giovenco cinquenne;
trassero il cuoio, l’approntarono e tutto lo fecero a pezzi,
lo sminuzzarono accorti, l’infissero sugli schidioni,
con attenzione lo cossero e fecero infine le parti.
Quindi, per tutto quel giorno e fino al calare del sole,
si banchettò, nulla al cuore mancò d’un banchetto abbondante.
Ma, come fu tramontato il sole e la tenebra scesa,
tutti al riposo pensarono ed ebbero il dono del sonno.
Quando apparì mattutina l’aurora che ha dita di rosa,
mossero, andarono a caccia i figli d’Autòlico stessi
con i levrieri, e lo splendido Odísseo vicino ai levrieri
li accompagnò: del Parnaso raggiunsero l’erta montagna,
cinta di selve, arrivarono in fretta alle balze ventose.
E da non molto già il Sole veniva irradiando le terre
dall’instancabile fiume Oceano gorghi-d’abisso,
che i cacciatori alla valle pervennero, prima di loro
erano i cani, cercando le tracce, e frattanto a seguirli
c’erano i figli di Autolico; Odisseo splendido a questi
si accompagnava, squassando una lancia d’ombra allungata.
Là, nella fitta boscaglia un gran verro s’era annidato:
mai vi spirava la furia di vènti dall’umido soffio,
mai una volta coi raggi il sole fulgente passava,
mai vi scorreva la pioggia attraverso, tanto intricati,
erano, e vi s’ammassava un enorme mucchio di foglie.
Strepito d’uomini e cani e di passi giunse al cinghiale,
quando avanzarono in caccia; e la bestia incontro dal bosco
venne, rizzando le setole e fuoco le ardeva negli occhi;
prossimo a loro ristette. Ecco Odísseo prima degli altri
correre: alzò con la grave sua mano la lunga sua lancia,
già di colpire impaziente; però lo ferì prima il verro
sopra il ginocchio, e lambì molta carne con la sua zanna
–era balzato di fianco–, ma non sfiorò l’osso dell’uomo.
Colpo anche Odísseo vibrò, colse il verro all’òmero destro,
da parte a parte passò la punta dell’asta lucente;
cadde alla polvere il verro gemendo, e volò via la vita.
I cari figli d’Autolico allora gli furono intorno,
ed alla piaga di Odísseo impeccabile, pari a un dio,
posero accorto rimedio e col canto il livido sangue
gli tamponarono, e giunsero in fretta alle case del padre.
Cure giovevoli a lui prestarono e doni stupendi
diedero subito, Autòlico e i figli d’Autòlico insieme,
lo rimandarono lieto ad Itaca, in lieta amicizia,
rapidamente. E per lui il padre e la nobile madre,
quando tornò, s’allegrarono e gli domandarono tutto,
la cicatrice, e che fosse accaduto; egli appieno narrava
come, cacciando, fu còlto da un verro col candido dente,
quando era andato coi figli d’Autolico, là, sul Parnaso.
Su quella piaga la vecchia passò con aperte le mani,
e la tastò, la conobbe, e lasciò cadere il suo piede:
dentro il bacile piombò la gamba, echeggiò così il bronzo,
si reclinò da una parte e l’acqua si sparse per terra.
Gioia e dolore le avvinsero a un tempo i pensieri, i suoi occhi
furono pieni di pianto, la florida voce si spense.
Accarezzandogli il mento, a Odísseo così si rivolse:
«Figlio, davvero tu sèi Odísseo! Eppure non io
t’ho ravvisato, non prima d’aver ben tastato il mio sire…»
Ella gli disse e a Penelope intanto si volse con gli occhi,
tesa com’era a svelarle che in casa era giunto il suo sposo.
Ma non poteva, Penelope, in viso guardarla o vederla,
no, poiché Atena annebbiò la sua mente. Odísseo, frattanto,
con la sua destra sfiorò la gola alla donna e la strinse
l’accostò a sé con la mano sinistra e spiegò la sua voce:
«Balia, perché mi vuoi perdere? E ben m’hai nutrito tu stessa
alla mammella; ecco, adesso, pur molti dolori sofferti,
dopo vent’anni, son giunto alla cara terra dei padri.
Dunque poiché l’hai compreso –nell’animo un dio te l’ispira–,
taci, perché nessun altro qui dentro il palazzo lo sappia.
Sì, poiché questo ti dico e sarà già evento compiuto:
se per mia mano un dio faccia sterminio dei proci superbi,
anche se sèi mia nutrice, non te salverò, quando l’altre
donne mie ancelle dovrò uccidere dentro il palazzo!»
E di rimando gli disse Euriclea la ricca d’ingegno:
«Ah, figlio mio, che parola t’è uscita dal chiuso dei denti!
E tuttavia lo sai bene che è saldo il mio cuore e non cede:
io come duro macigno me ne rimarrò, come ferro.
E un’altra cosa ti dico, tu ponila dentro il tuo cuore;
se per tua mano dio faccia sterminio dei proci superbi,
t’indicherò una ad una qui dentro il palazzo le donne,
quelle che ti disonorano e quelle che sono innocenti».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Balia, perché tu dovresti svelarmele? A te non compete:
bene le ravviserò io stesso e conoscerò tutte;
serba il segreto in silenzio, piuttosto, e confida nei numi!»
Sì, così disse e l’anziana si mosse attraverso la sala,
acqua al lavacro portando, ché l’altra era tutta versata.
Poi, come l’ebbe lavato ed unto con olio lucente,
trasse di nuovo vicino al camino Odísseo il suo seggio,
per asciugarsi e celò sotto i cenci la cicatrice.
Prima fra loro parlò Penelope ricca di senno:
«Ospite, ti parlerò ancora per brevi momenti:
presto difatti vedrà il tempo del dolce riposo,
chi sarà colto da sonno soave, sia pur nell’angoscia.
Senza misura a me invece un nume ha donato il dolore:
già, poiché tutti i miei giorni di pianto e afflizione mi sazio,
alle mie opere bado e anche alle ancelle per casa;
quando però si fa notte e per tutti viene il riposo,
dentro il mio letto mi giaccio e fitte nel cuore oberato
e lancinanti mi pungono a darmi afflizione le cure.
Come la figlia che nacque a Pandàreo, il verde usignolo,
quando diffonde il bel canto, se ormai primavera s’appressa,
e tra le foglie addensate degli alberi sta appollaiata,
e di continuo volando effonde la voce echeggiante,
a lamentare il suo Itilo, il figlio che un tempo col bronzo
ella stroncò per follia, il seme di Zeto sovrano;
tale il mio cuore, di dubbio in dubbio, è indeciso fra due,
se rimanere col figlio e serbare tutto al sicuro,
tanto i miei beni che i servi e la grande, eccelsa dimora,
ed onorare il mio letto nuziale e la pubblica voce,
o accompagnarmi oramai al migliore che fra Achei
me nel palazzo corteggia e mi porge doni infiniti.
E il figlio mio, fino a quando era ancora ingenuo, un fanciullo,
non mi voleva sposata e via dalla casa nuziale;
ora che invece è cresciuto e giunto nel fiore degli anni,
quasi piuttosto mi prega di andarmene via dal palazzo,
per la ricchezza s’adira che stanno ingoiando gli Achei.
Ora, però, dammi ascolto e interpreta questo mio sogno.
Nel mio cortile ci sono venti oche che mangiano grano
fuori dall’acqua, e di loro io m’allieto, solo a mirarle;
ma calò enorme dal monte un’aquila adunca di becco,
tutte nel collo ferì e le uccise; a terra per casa
giacquero in massa, ma l’aquila all’etere splendido ascese.
Ecco che allora gemei e in pianto scoppiai, anche in sogno,
mi si raccolsero intorno le Achee dalle trecce gentili,
pietosamente piangevo per le oche dall’aquila uccise.
L’aquila s’appollaiò, tornata, sul bordo del tetto,
e mi calmò con parole umane e spiegò la sua voce:
«Abbi coraggio, tu, figlia d’Icario l’illustre di glorie:
vero presagio è, non sogno, e sarà già evento compiuto.
Erano i proci, quelle oche, ed io, ch’ero prima un uccello,
l’aquila, sono a mia volta il tuo sposo, io, che ora ritorno,
e getterò sopra tutti i proci un ignobile fato».
Disse così; mi lasciò il sonno soave di miele;
io nel palazzo osservai le mie oche, allora, e le vidi
che becchettavano il grano al trogolo, come da sempre».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«Donna, davvero non è possibile intendere il sogno
se lo si spiega altrimenti, da poi che a te Odísseo in persona
svela che deve compirsi: palese è il destino dei proci
tutti, non uno potrà sfuggire alla morte, alle chere!»
E di rimando gli disse Penelope ricca di senno:
«Ospite, duri a spiegarsi, difficili a intendersi i sogni
sono, e per gli uomini certo non giungono a compiersi tutti.
Duplici s’aprono infatti le porte dei diafani sogni:
una ha battenti di corno e l’altra ha battenti d’avorio.
Quelli fra i sogni che vanno fra porte d’avorio tagliato,
solo producono inganno, recando parole incompiute;
quelli che vengono fuori passando fra il corno polito,
compiono schietti presagi, se appaiono ad uomo mortale.
Temo però che da qui non passasse, quel prodigioso
sogno: davvero una gioia sarebbe per me, per mio figlio!
E un’altra cosa ti dico, tu ponila dentro il tuo cuore;
questa sarà la funesta aurora, che condurrà via
me dal palazzo di Odísseo: voglio oggi proporre una gara,
sì, quelle scuri che Odísseo, qui dentro il palazzo ch’è suo,
come taccate ordinava in linea, dodici in tutto;
poi vi lanciava attraverso, da molto lontano, una freccia.
E sarà questa la gara che stabilirò per i proci;
l’uomo che tenda quell’arco con più faciltà fra le mani
e fra le scuri, fra tutte e dodici, lanci una freccia,
io seguirò e non altri, abbandonerò la dimora
delle mie nozze, assai bella, ricolma com’è di ricchezze,
quella di cui serberò il ricordo, io credo, anche in sogno».
E le diceva in risposta Odísseo ricco d’ingegno:
«O venerabile sposa di Odísseo nato a Laerte,
non rimandarla oramai questa gara nelle tue case,
già, che da te tornerà Odísseo ricco d’ingegno,
prima che abbiano i proci toccato quell’arco polito,
prima che tendano il nervo e col dardo passino il ferro!»
E di rimando gli disse Penelope ricca di senno:
«Ospite, presso di me volessi sedere a palazzo
per confortarmi, mai il sonno mi si verserebbe sul ciglio.
Non è concesso però che sempre rimangano insonni
gli uomini, no, che per tutti i bisogni han posto misura
numi immortali ai mortali, su terra nutrice di biade.
Ed è perciò che oramai me ne salirò al piano alto,
mi giacerò dentro il letto ch’è fonte per me di lamento,
madido sempre di pianto si fa, da che Odísseo s’è volto
alla partenza, a vedere Ilio infausta, l’innominanda!
Lì cercherò il mio riposo; tu qui nella sala riposa,
o che ti stenda per terra o che ti preparino coltri».
Come ebbe detto, salì al piano più alto, sgargiante,
ma non da sola: con lei andavano l’altre, le ancelle.
Al piano alto salì, insieme alle donne sue ancelle,
e rimpiangeva il suo sposo, Odísseo, finché sulle ciglia
sonno soave le infuse, Atena dagli occhi di strige.
di Giacomo Sartori
C’eravamo già da moltissimo tempo abituati a raccogliere quello che trovavamo andando in giro, milione di anni dopo milione di anni, poi l’altroieri ci siamo messi a raccogliere i semi delle piante e a piantarli noi. Per varie ragioni sulle quali gli esperti non sono nemmeno troppo d’accordo, adesso non stiamo lì a disquisire di questo. Invece di sgambettare in giro raccoglievamo i semi delle piante che avevamo seminato e li mangiavamo, e una piccola parte, quelli più grandi e delle piante più belle, li riseminavamo. Era insomma nata l’agricoltura, e la genetica. E erano apparsi i commercianti. E anche i guerrieri, perché dove c’è commercio c’è guerra, questo è assodato.
Non cerchiamo di appurare se in questo passaggio siamo diventati più felici o meno, la felicità si soppesa male. Senz’altro nel cambiamento siamo diventati più stupidi, e il nostro cervello si è rimpicciolito. Perché per raccogliere quello che c’era ci voleva un’ottima memoria e bisognava essere molto esperti, ognuno doveva essere un insigne tassonomo e naturalista. In ogni caso seminando noi le piante abbiamo fatti progressi incredibili anche in termini numerici, cosa da fare invidia alle formiche dei formicai.
Siamo una specie intelligente, anche se magari un pochino meno di prima, questo non si nega, e abbiamo visto che se preparavamo la terra con uno strumento idoneo, che abbiamo chiamato aratro, i semi attecchivano meglio, e le piante erano più contente. Perché le piante coltivate non amano le erbacce, insomma quelle che consideriamo erbacce, e amano trovare il terreno morbido e arioso. Nel frattempo avevamo adottato i metalli, e quindi gli aratri erano molto più robusti, sempre più robusti, e più pesanti. Per tirarli ci attaccavamo dei buoi, e dopo qualche rapidissimo migliaio d’anni dei motori con le ruote, che chiamiamo trattori. Abbiamo arato tutte le foreste di pianura, e non solo quelle, per creare campi arati, sempre più campi arati, campi arati dappertutto, basta vedere il disegno di Silvia. Spesso alla terra non piaceva essere arata, e se ne è andava via. Siamo sempre più numerosi, e sempre più affamati di animali, che mangiano tantissimo, e quindi abbiamo bisogno di tantissimi campi arati.
Il nostro vero avanzamento tecnologico è questo, l’aratro, tutto il resto, compresi i tanto decantati computer, e l’ingegneria genetica, sono dettagli da niente. Da sette-diecimila anni mangiamo piante coltivate su terreni arati, o animali che mangiano piante coltivate da terreni arati, e adesso anche pesci che mangiano piante coltivate su terreni arati. Il problema è che negli ultimi cento anni abbiamo molto tirato la corda, a forza di concimi chimici e di arature e riarature, e la terra arata si è stancata, spesso è ammalata, o semplicemente se ne è andata via per sempre. Poi qualche decennio fa gli americani si sono accorti che potevano in fondo piantare i semi anche senza arare, la terra si stancava meno. Facendo dei buchini con una grande macchina, e mettendoci dentro i semi: le piante sono contente anche così. Il problema senza arare sono le erbacce. Per sterminare le erbacce gli americani usano i diserbanti. Giù pesanti con i diserbanti, e il terreno è pronto per la semina. E’ un metodo che si sta diffondendo dappertutto, perché le trovate americane fanno sempre colpo. Il problema sono questi cavoli di diserbanti, e le porcherie che formano degradandosi: dal terreno vanno anche nelle acque, e poi nel nostro sangue e in quello degli altri esseri viventi.
Il nostro problema adesso è questo: siamo tantissimi, sempre di più, e abbiamo tanta fame, fame di torelli e maiali che maciniamo e infiliamo nei panini, o che spadelliamo a fettine. E quindi attacchiamo gli ultimi lembi di foresta tropicale. Se però continuiamo a usare l’aratro stanchiamo troppo la terra già indebolita dai concimi chimici e dall’erosione, già morente. Se non usiamo l’aratro la facciamo ammalare per i diserbanti, e ci ammaliamo anche noi. Un bel cruccio, un vero di lemma, altro che intelligenza artificiale e nanotecnologie.
NdA: questo pezzo è inserito nel catalogo della mostra di (bellissime) opere infantili “Terra!“, organizzata da Fondazione PinAC di Brescia (Rezzato), e ora aihmè sospesa, ma aperta fino a giugno 2021; il catalogo comprende anche vari altri interventi di ricercatori e specialisti ambientali, ognuno dei quali abbinato a un’opera esposta; l’immagine:: Silvia Heimbach, Vienna, 1967, tempera, 50×41 cm