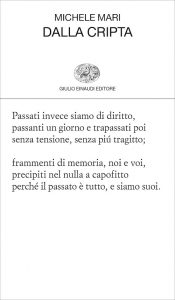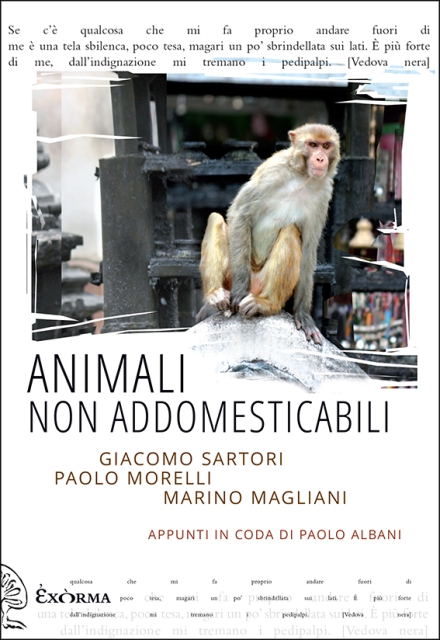di Luca Baldoni

Mi prendesti da parte una sera per propormi
un’avventura. I ragazzi di sopra avevano quell’acido che
ci avrebbero fraternamente regalato. Io non l’avevo ancora
mai provato, ma me lo chiedesti con timore soprattutto
perché volevi farne un rituale, un’impresa comune di coscienza che
sconfinasse nell’umano. Accettai e iniziarono i preparativi.
Perché decidemmo di lasciar perdere i locali e di allestire
un’epifania in casa ad uso del sesso e dell’amore, inventando
insieme l’attesa per l’apertura di orizzonti dentro
ai nostri cuori. Devo ammettere che ormai non ricordo quasi
niente se non che la notte grazie al cielo sembrava non volere
più finire, e le parole sgorgavano dalle nostre bocche senza
esitazione, e ai primi bagliori grigi dell’alba sulle pietre della strada
mi dicesti che ti stava venendo freddo e io andai su di sopra a
prenderti la coperta verde da mettere sulle spalle.
E se non ricostruisco gli atti, le parole, la sequenza, ricordo che intenso
piacere era guardare, toccare, ascoltare, raccontare,
vederti di fronte a me per ore, scopare, confessare, annusare come se
tutto nella vita potesse veramente essere eccezionale, e allora
non potevi che desiderarne il prolungamento, che non avesse mai
fine, che la luce non scacciasse più la luce
e il giorno e la notte potessero incontrarsi.
***
VII.
Sotto cielo e vigore hai imparato a giocare con corpi e traiettorie, girando gli astri dentro al culo del tuo amore. Svagato tripudio inviso al tempo, offesa cercata e non voluta da trip evanescente azzardato tra isole mitiche e natanti. Senza ormeggi in dotazione, né una palma alla cui ombra partorire.
Taci dell’invocazione al figlio del delfino. Della forza della pinna che batte contro l’onda, del fianco che s’impenna e vola, del dorso levigato che inanella miglia dopo miglia, da sponda a sponda. Astri e delfini in un gioco da bambini, svagata diversione riversata sul mondo come pace, forza, affermazione.
Hai fuso gli elementi in un fiotto di bagliore, sciolto i corpi dalle loro vessazioni – per una breve stagione senza cuore. Tu stesso ne hai consacrato i rituali, le danze sfrenate sotto il sole.
A te, maestro-principiante, la lezione.
***
il fine settimana in riva a un lago,
dove lui e amici possedevano
un terreno con alcune semplici
casette di legno.
con altri uomini seduti intorno al fuoco;
quasi mi addormento, il tedesco diventa
imponderabile, guardo in alto le fronde
il vento che le scuote
l’oscurità illuminata dalle stelle.
Forse mi addormento… ma c’è un risveglio
in mezzo ad un racconto:
da uno dei più anziani una crepa nella voce
parole e pause in successione, un gesto:
scoprirsi l’avambraccio, battere la mano
sul tatuaggio.
Un brivido così forte –
un ricciolo rosa sfugge dalle braci,
rovinosamente
viene risucchiato verso l’alto.
***
Secondo movimento: Culmine
L’ultima notte del millennio eravamo a Londra. Se l’avessi
saputo quando ero adolescente – e mi immaginavo adulto
cosa avrei fatto dove sarei stato con chi proprio in quel
frangente – mi sarebbe sembrato eccezionale. Mentre di
quella sera non ricordo quasi niente perché troppa era
la stanchezza, l’umiliazione, ricadute su entrambi armati
l’uno contro l’altro per dar fuoco alle nostre frustrazioni.
So che eravamo con amici tra la folla vicino al ponte
in ferro di Hammersmith, e allo scadere della mezzanotte
guardammo tutti verso est per veder partire
dall’altro capo del Tamigi una scia di fuoco che
doveva solcare il cielo come un arco teso.
Ci fu qualcosa… che tra le urla della gente mi sembrò lontano,
inconcludente, come visto in un cannocchiale
rovesciato. Il giorno dopo si seppe dai giornali
che c’era stato un errore colossale:
i fuochi erano scoppiati solo in parte, il serpente
luminoso dopo un volo sregolato
si era spento vicino al Parlamento.
Avevo già chinato la testa
al passaggio del tempo, pestato la polvere
su un altare spento.
***
VIII.
sottratto al nemico ridacchiante
e messo rapidamente in saccoccia
come un dono inaspettato.
la poesia è come l’arte dell’arciere:
mira al cuore, sfonda il tuo piacere.
**********
dalla prefazione di Pierre Lepori
La poesia di Luca Baldoni – per addentellati biografici ma anche interessi di studioso (che lo hanno portato a firmare una corposa antologia della poesia omosessuale italiana del Novecento) – si ricollega chiaramente alla grande tradizione dell’autobiografia in versi, del romanzo intimo che esplora senza peli sulla lingua l’omoerotismo. Ma non deve per questo essere limitata a un puro esercizio militante, tali e tante sono le stratificazioni e le inflessioni di questo nuovo volume di versi.
Nella breve nota iniziale, l’autore sembra quasi scusarsi della lontananza temporale da cui ritornano queste poesie (parte di una trilogia conclusa da anni) – e rivela una battaglia editoriale tanto più assurda giacché il libro, diciamolo subito, è splendido. Parla di queste poesie come di Juvenilia, ma varrà subito la pena di relativizzare l’excusatio non petita: se questo può essere valido (forse) per la primissima sezione, la gioventù non è qui una questione di stile, ma di emozione. L’emozione acerba di questi versi è percorsa dal sudore giovanile, dal rimpianto che inizia già prima di essere pensato; dalla nostalgia con cui le parole inevitabilmente toccano il tempo.
Questa prima parte (Riverrun) è in realtà d’una bellezza stregante, per panorami, libertà delle emozioni, per voluttà timbrica. Vi si coglie una voce intatta e forte, capace di denuncia e di rivendicazione, ma anche di sublimare una tradizione culturale poco italiana (l’autore è anglista e traduttore) che va da Auden a Dylan (torna alla mente la voce calda di Under Milk Wood, nell’ultima di queste poesie irlandesi, nonostante la realtà cittadina che descrive); certi affondi più scabrosi possono far pensare a Ferlinghetti o Ginsberg, sia per tematiche, sia per la forza liquida della lingua. Questa prima sezione riesce a farci percepire la nitidezza del tempo e al contempo il luccichio sfasato del reale; oscilla continuamente tra autobiografia e flusso disperato delle immagini, nella città straniera. Ritroviamo l’autore dimenticato dall’amante, febbricitante in una stanza; romanticamente abbracciato su una spiaggia; ma anche capace dell’emozione delle battaglie, della gioia di una vita coraggiosa e disinibita. È una poesia che racconta il singolo e la sua epoca, una poesia che è città, nebbia, confusione di voci, pedinamento del reale (per rubare una citazione a Zavattini).
Per chi ha vissuto quella temperie e quelle lotte, l’immedesimazione è possibile (anzi quasi auspicata); ma non è indispensabile, perché la versificazione tersa e metricamente generosa permette a ognuno di metterci del suo: il lettore vi leggerà le sue notti, la sua gioventù, la sensazione che il tempo – perduto e ritrovato – ha una consistenza materiale. È questo il “sale del ricordo”, che ci prende alle spalle e resta come un’infinita adolescenza negli occhi.
Il secondo capitolo prende il largo, sull’isola di Mikonos (classica destinazione turistica gay), e il tono si fa penniano nel suo “lasciarsi possedere dal sole”, nel suo “paradiso altissimo e confuso”: il rischio del cliché mediterraneo e gaudente è superato con impeto, grazie a un linguaggio di corpi e vento. In queste vacanze erotiche tutto è caldo, melanconico, magari dolcemente ironico: come la scena in cui il ragazzo “di vita”, ritrovato l’estate seguente, rimbrotta il poeta che torna (“Sei proprio innamorato, anche tu hai preso a ritornare”). E poi cielo, mare, corpi, traiettorie; e poi le intermittenze del cuore, dell’attimo bello ma già perso, del Kairos. Senza temere il ridicolo, questa sezione porta quasi il titolo di canzone cantata a squarciagola: Summers of Love, come se, per contrappasso epocale, la pop melensa dei Frankie Goes to Hollywood fosse la quintessenza della poesia: è il suono magico e avvolgente di viandanti gatti amanti. Sole e adorazione.
La sezione seguente ci porta a Berlino, che dopo la caduta del muro divenne quasi un luogo di pellegrinaggio (in particolare nei quartieri di Schöneberg e Kreuzberg); e dove l’autore non riconosce – come molti altri prima di lui – la mitica Alexanderplatz di Döblin e Fassbinder; è la Berlino della libertà scabra (anche omosessuale), in cui risuonano gli echi della storia, nella Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche o nel portale della Anhalterbanhof, susù fino agli amori tumultuosi di Erika e Klaus Mann, ai Cabaret di Weimar, all’Istituto di sessuologia di Hirschfeld. Baldoni si commuove visitando un approssimativo museo di storia omosessuale (lo Schwules Museum sulla Lützowstrasse), ben diverso dagli altari con madonnine dell’Italia meridionale. La città diventa uno specchio utopico, ma anche un vortice, in cui l’individuo viene risucchiato dalla storia: come in una serata di chiacchiere dolci sulle rive del Wannsee, in cui il ricordo dei campi di concentramento fa capolino come una coltellata; o più semplicemente, come un “ricciolo di brace rosa” (riferimento ai triangoli rosa della Germania nazista).
Quello che ci aspetta, tuttavia, nell’Anno Duemila (il capitolo seguente) è un disinganno crudele, senza scampo. Come uno sberleffo all’utopia, nemmeno i fuochi d’artificio di Londra mantengono le loro promesse, sono pétards mouillés; e il disincanto di un’epoca crassa e iperliberista sgretola i furori dell’utopia. La prosodia si distende, tende quasi alla prosa, e le immagini sono vivide e sarcastiche. Fino al culmine tremendo, la scena in cui un giovane padre già completamente conquistato dal marketing cerca di convincere l’autore della necessità di passare ad altro, di metter su pancia, moralmente parlando. Parole vuote di un’epoca vuota, che sono però un muro di gomma contro cui l’intimità ferita dell’io-poetante non può che rimbalzare. Con il dandismo di un Wilde frastornato, Baldoni sceglie la sua strada di vagabondaggio senza tante storie, coi ginocchi bagnati di nostalgia. Ma, per l’appunto, in questo la prima parte è essenziale per capire la caduta: non era una gioventù fine a se stessa, ma una cifra di fedeltà…
La conclusione è elegante e laconica, disperata e dolce. I versi si asciugano, le mani si cercano in vano, la fuga su un’isola di foscoliana memoria sembra l’unico orizzonte pagano ancora possibile. Occorre lasciare alle spalle ogni esibizione di cultura e censo, ogni appartenenza e identità, ma restare fedeli e continuare a correre “col cuore stretto nel palmo della mano”. Un cuore strappato con un gesto violento e necessario. Anche se sono ormai così lontani, quella gioventù, quegli ideali spingono a un nuovo viaggio. Sembra di sentire, sornione, dietro le spalle, il buon vecchio Penna sussurrare “felice chi è diverso / essendo egli diverso / Ma guai a chi è diverso / essendo egli comune”… Il percorso di questa raccolta, tutt’altro che giovanile, si conclude così, con la promessa di una fedeltà, con la consapevolezza che la poesia può ancora salvare il mondo (come afferma Jean-Pierre Siméon), ma soprattutto il mondo interiore. L’unico che abbiamo.
da Luca Baldoni: Sale del ricordo (Lietocolle, 2018)





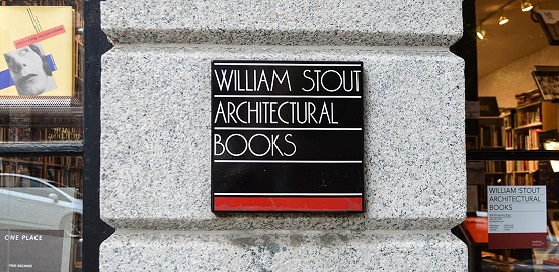 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo
 Non è un problema di stile. Non è perché le case del Movimento Moderno, pensate come macchine da abitare (a detta di Le Corbusier), non sappiano essere emozionanti. Lo si capisce quando il progettista e il committente si incontrano nella stessa persona. Come nel caso più unico che raro di Casa Cattaneo a Cernobbio. L’edificio fu progettato nelle migliori delle condizioni di libertà creativa per il giovane progettista. Cesare Cattaneo, appena laureato, aveva ricevuto in regalo il terreno dove poter edificare senza alcun vincolo quello che più desiderava. La casa fu pensata fin nei suoi più intimi particolari, con una meticolosità fanatica. Una sorta di modello in scala 1:1, un enorme prototipo che doveva dimostrare la forza poetica del linguaggio moderno, la sua realizzabilità (siamo negli anni trenta del secolo scorso), la sua intrinseca qualità. Nulla fu lasciato al caso, ogni tema sviscerato: il negozio a doppia altezza al piano terra, quello che si apre sulla città, gli appartamenti ai piani superiori, la terrazza all’ultimo piano affacciata sul panorama lacustre. Progetto libero da condizionamenti perché non tenuto, come ebbe a dire Cattaneo stesso, a “soggiacere alla volontà tirannica dei clienti”. Un capolavoro che purtroppo non ha avuto seguito essendo Cattaneo morto giovanissimo. (Mi sono accorto che gli architetti o muoiono molto giovani, vedi Sant’Elia o Terragni, oppure vecchissimi, come il quasi centenario Giovanni Michelucci o l’ultracentenario Oscar Niemeyer. Avendo io superato da bel po’ la giovinezza mi auguro sempre più convintamente di appartenere alla seconda categoria).
Non è un problema di stile. Non è perché le case del Movimento Moderno, pensate come macchine da abitare (a detta di Le Corbusier), non sappiano essere emozionanti. Lo si capisce quando il progettista e il committente si incontrano nella stessa persona. Come nel caso più unico che raro di Casa Cattaneo a Cernobbio. L’edificio fu progettato nelle migliori delle condizioni di libertà creativa per il giovane progettista. Cesare Cattaneo, appena laureato, aveva ricevuto in regalo il terreno dove poter edificare senza alcun vincolo quello che più desiderava. La casa fu pensata fin nei suoi più intimi particolari, con una meticolosità fanatica. Una sorta di modello in scala 1:1, un enorme prototipo che doveva dimostrare la forza poetica del linguaggio moderno, la sua realizzabilità (siamo negli anni trenta del secolo scorso), la sua intrinseca qualità. Nulla fu lasciato al caso, ogni tema sviscerato: il negozio a doppia altezza al piano terra, quello che si apre sulla città, gli appartamenti ai piani superiori, la terrazza all’ultimo piano affacciata sul panorama lacustre. Progetto libero da condizionamenti perché non tenuto, come ebbe a dire Cattaneo stesso, a “soggiacere alla volontà tirannica dei clienti”. Un capolavoro che purtroppo non ha avuto seguito essendo Cattaneo morto giovanissimo. (Mi sono accorto che gli architetti o muoiono molto giovani, vedi Sant’Elia o Terragni, oppure vecchissimi, come il quasi centenario Giovanni Michelucci o l’ultracentenario Oscar Niemeyer. Avendo io superato da bel po’ la giovinezza mi auguro sempre più convintamente di appartenere alla seconda categoria). Ogni casa, insomma, porta con sé una storia, un mondo. Spesso mi accorgo quanto un appartamento mi dica molte cose di chi lo vive. Gli oggetti quotidiani, gli arredi, i quadri o le fotografie ai muri, ci vestono, ci rappresentano, esattamente come quando indossiamo un abito. Perché ogni casa, dal ricco maniero al monolocale in affitto, assomiglia alla persona che la abita. Anche qui il gioco delle etimologie può tornare utile. “Persona” deriva da Per Sonar, la maschera in legno che serviva a rafforzare il suono della voce nel teatro antico. La casa è innanzitutto la creazione di un ambiente ideale. Ma “ambiente” viene da Ambire, cioè andare attorno come l’aria, o come le persone attorno alle quali si vive. Quindi quando si abita una casa si indossa una maschera che dà un’idea di sé a se stessi e al mondo circostante. Oggi, in un mondo di risorse scarse, abitare significa stare in una casa sostenibile, ecologica. Inevitabilmente, mi viene da chiosare, dato che “Ecologia” deriva dal greco Oikos logos, “discorso sulla casa”: lo studio delle relazioni fra l’umano e il mondo vivente.
Ogni casa, insomma, porta con sé una storia, un mondo. Spesso mi accorgo quanto un appartamento mi dica molte cose di chi lo vive. Gli oggetti quotidiani, gli arredi, i quadri o le fotografie ai muri, ci vestono, ci rappresentano, esattamente come quando indossiamo un abito. Perché ogni casa, dal ricco maniero al monolocale in affitto, assomiglia alla persona che la abita. Anche qui il gioco delle etimologie può tornare utile. “Persona” deriva da Per Sonar, la maschera in legno che serviva a rafforzare il suono della voce nel teatro antico. La casa è innanzitutto la creazione di un ambiente ideale. Ma “ambiente” viene da Ambire, cioè andare attorno come l’aria, o come le persone attorno alle quali si vive. Quindi quando si abita una casa si indossa una maschera che dà un’idea di sé a se stessi e al mondo circostante. Oggi, in un mondo di risorse scarse, abitare significa stare in una casa sostenibile, ecologica. Inevitabilmente, mi viene da chiosare, dato che “Ecologia” deriva dal greco Oikos logos, “discorso sulla casa”: lo studio delle relazioni fra l’umano e il mondo vivente. Stiamo domesticizzando lo spazio pubblico. Alcuni oggetti di culto della casa moderna, novecentesca e borghese, sono perfettamente inutili per le nuove generazioni. Fate un test (io l’ho fatto con le mie figlie): fra televisore e computer vince il computer. Fra computer e smartphone vince lo smartphone. Tutto si miniaturizza, diventa etereo. Oggi l’infrastruttura necessaria, indispensabile, in ogni casa, in ogni città anzi, è il Wi-Fi.
Stiamo domesticizzando lo spazio pubblico. Alcuni oggetti di culto della casa moderna, novecentesca e borghese, sono perfettamente inutili per le nuove generazioni. Fate un test (io l’ho fatto con le mie figlie): fra televisore e computer vince il computer. Fra computer e smartphone vince lo smartphone. Tutto si miniaturizza, diventa etereo. Oggi l’infrastruttura necessaria, indispensabile, in ogni casa, in ogni città anzi, è il Wi-Fi.