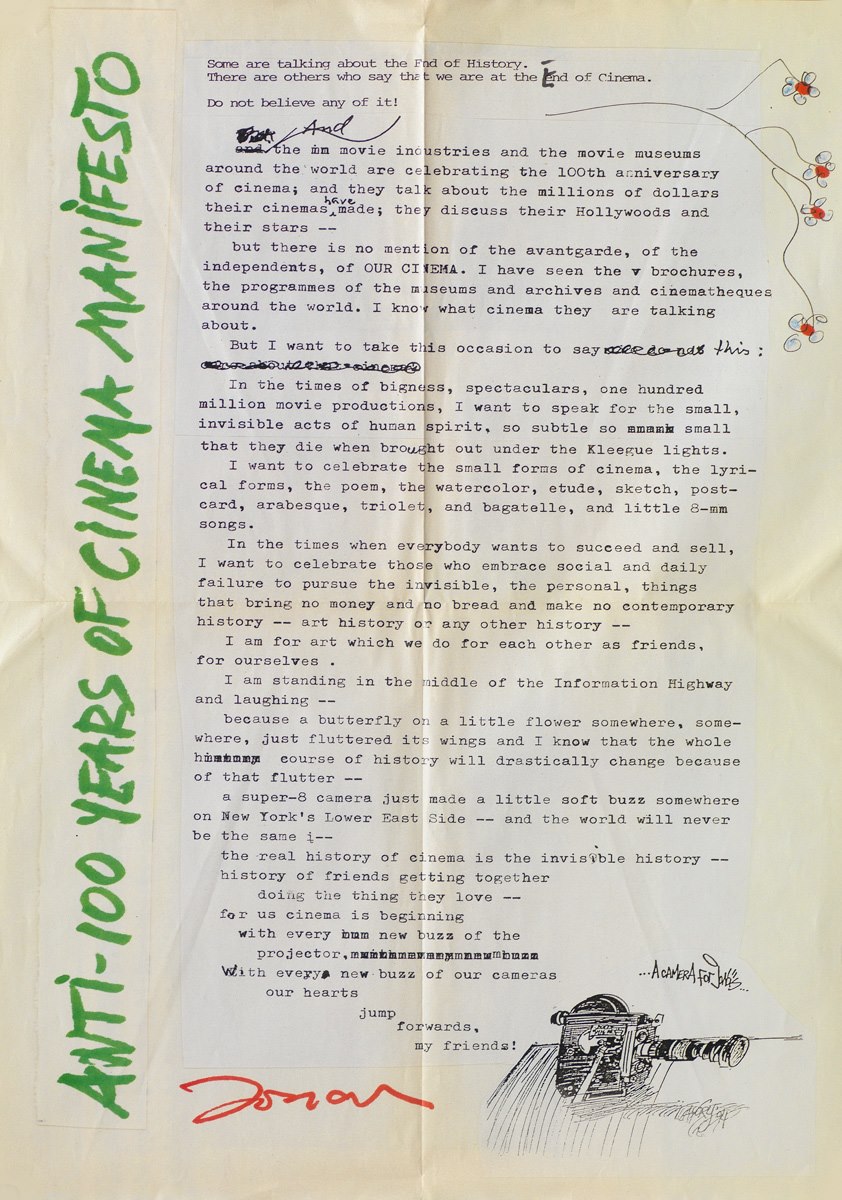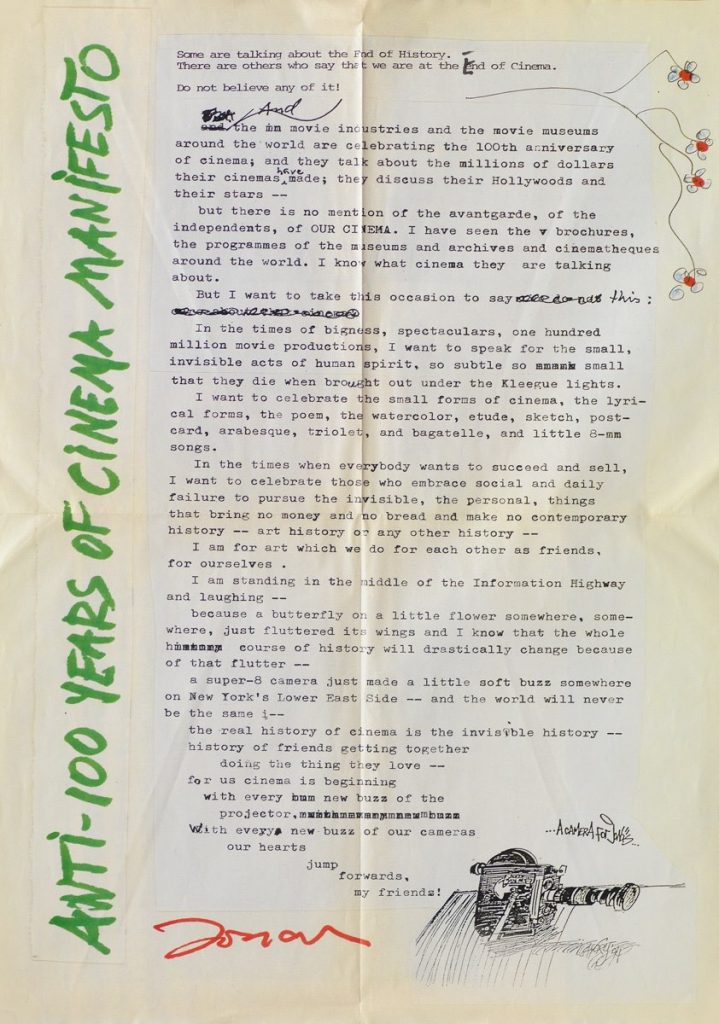di Marco Zonch
[Spoiler Alert – lo scambio che segue contiene informazioni sulla trama di alcuni dei romanzi dell’autore, tra cui Terra ignota 1 e 2, L’impero del sogno e La stanza profonda]
Questa intervista si colloca all’interno di un più ampio progetto di ricerca che ha per oggetto la produzione letteraria italiana, in prosa, del periodo che va dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso a oggi. Il tentativo è quello di affrontare i problemi connessi al cosiddetto “ritorno alla realtà” e, più in generale, le trasformazioni avvenute in questi vent’anni da una prospettiva ontologica e non, come è stato spesso proposto, attraverso l’impiego di categorie epistemologiche.
In questo senso, centrale appare essere la questione della spiritualità, pensata all’incrocio tra la riflessione di Michel Foucault e i risultati della riflessione sociologica contemporanea a proposito delle trasformazioni del panorama religioso occidentale. L’impressione, che questa intervista sembra supportare, è che molti dei più noti scrittori oggi attivi non si pongano problemi nell’ordine della possibile (o impossibile) corrispondenza tra parole e cose, tra mondo scritto e mondo non scritto, ma al contrario riflettano sulla possibilità di entrare in possesso di una verità di ordine spirituale.
Nelle risposte alle domande che, qui di seguito, l’autore mi ha cortesemente concesso, sembra inoltre possibile individuare una qualche forma di relazione tra “impegno” e spiritualità.[1]
Vanni Santoni (1978), esordisce con Personaggi precari nel 2007. Ha poi pubblicato, Gli interessi in comune (2008), Se fossi fuoco arderei Firenze (2011) Terra ignota e Terra ignota 2 (Mondadori 2013 e 2014), Muro di casse (2015), La stanza profonda (2017), finalista al Premio Strega e L’impero del sogno (2018). Scrive per il “Corriere della Sera” e dirige la collana narrativa di Tunué.
L’intervista si è svolta attraverso uno scambio di mail che ha avuto luogo tra il 30 ottobre e il 5 novembre del 2018. L’autore non è stato messo a parte della prospettiva di lavoro nella quale l’intervista si sarebbe inserita al fine di evitare l’influenza di questa sulle sue risposte. Ho tuttavia premesso che l’oggetto del mio interesse sarebbe stato di natura ontologica, e avrebbe avuto l’obbiettivo di chiarire alcuni punti problematici del lavoro che sto svolgendo.
Glossario:
RPG: Role Playing Game (gioco di ruolo), gioco “da tavolo” o videogioco in cui il singolo partecipante interpreta un personaggio, di sua invenzione o scelto tra quelli proposti dal gioco stesso. L’esempio più noto di gioco di ruolo è forse quello di Dungeons&Dragons.
Nelle versioni classiche di questi giochi i personaggi vengono abitualmente creati a partire da fattori quali: razza (umano, elfo, nano…), classe (mago, guerriero…), livello (il grado di forza del personaggio, che aumenta sconfiggendo mostri o completando specifiche missioni), allineamento (buono, caotico, malvagio, neutrale…) e da statistiche, espresse in valore numerico, quali: intelligenza, forza, destrezza ecc..
Il risultato delle interazioni tra personaggi, scontri ecc. è, in molti giochi di questo tipo, determinato dal lancio di dadi, all’incrocio con le scelte del giocatore e con le caratteristiche del personaggio interpretato.
MMORPG: acronimo di Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Videogiochi come, ad esempio, World of Warcraft, in cui il giocatore guida le azioni di un singolo personaggio collaborando o scontrandosi con altri giocatori al fine di raggiungere alcuni obbiettivi proposti dal gioco stesso. Anche in questo caso, le caratteristiche del personaggio sono abitualmente espresse numericamente. Per esempio, un personaggio, prima di essere sconfitto, deve subire un ammontare di danni uguale o superiore ai propri punti vita.
Cyberpunk [Cyberpunk, Cyberpunk 2020]: gioco di ruolo di ambientazione distopica.
Vorrei partire da una cosa di cui, nei tuoi lavori, si parla sempre o quasi: le sostanze psicotrope. Indipendentemente dal genere testuale, che il mondo sia d’invenzione o no, mi pare tu attribuisca ad esse un medesimo ruolo assiale. Le droghe sono cioè asse, a un tempo, della narrazione e del mondo (nel senso che rimandano alla sua vera essenza). Per essere concreti, intendo dire che più di una volta l’assunzione di soma, in Terra ignota, mette in moto gli eventi e accade lo stesso, anche se certo con delle differenze, nell’Impero del sogno. Se questo è possibile, è perché i tuoi personaggi usano queste sostanze come mezzo – necessario? – a cui ricorrere per entrare in relazione con qualcosa che esiste ma che non è altrimenti percepibile, a cui non si può altrimenti avere accesso?
In Terra ignota è senz’altro vero quanto affermi, a patto che si stia parlando di psichedelici, e non di “droghe” in generale, categoria alla quale sarebbe peraltro una forzatura ascriverli. La protagonista Ailis ottiene uno stato superiore di coscienza – e anche un grado superiore di capacità magica – attraverso l’assunzione di una pozione che ricorda il soma dei Veda, e ne porta del resto il nome. Si noterà anche che il Cerchio d’Acciaio, l’ordine deviato di cavalieri che nel primo volume ha il ruolo di antagonista, sta cercando di eradicarne l’uso dal mondo, onde riservarlo a una sola casta di eletti.
Questa mia scelta deriva da una semplice aderenza storico-antropologica, sia pure virata in chiave fantasy: il soma vedico era con ogni probabilità una sostanza psicotropa – si dibatte sul suo essere stato la canapa, l’amanita muscaria, la psilocibina o un qualche decotto delle molte piante contenenti DMT – e anche nelle altre maggiori tradizioni mistiche, all’origine della comunione con gli dei (o col mondo spirituale) c’è l’incontro più o meno deliberato con qualche molecola di questo tipo. Senza arrivare alla “stoned ape theory”, che vuole l’intera spiritualità umana discendere dall’incontro degli ominidi con i funghi psichedelici, o alle teorie sul loro uso da parte dei paleocristiani, è noto che le due colonne intorno a cui si è sviluppato il nostro pensiero – quella greca e quella ebraico-cristiana – hanno avuto, nella loro componente più squisitamente spirituale, influenze di questo tipo: il ciceone dei misteri eleusini (che segnavano il massimo momento iniziatico per i cittadini) conteneva ergot, claviceps purpurea, la muffa da cui si estrae l’LSD, mentre secondo diversi antropologi il “cespuglio in fiamme” e in generale i primi contatti col divino raccontati nell’Antico Testamento avevano avuto come tramite fattuale piante quali la syrian rue, contenente DMT. Non c’è da stupirsi di tutto questo: basta guardare alla riscoperta della spiritualità avuta negli anni ’60 dalla materialista società occidentale in seguito alla diffusione di massa dell’acido lisergico. Allo stesso modo, non c’è da stupirsi del fatto che le religioni, una volta strutturate, tendano ad abbandonare il “fatto noetico” delle origini: nel momento in cui la religione è organizzata e amministra un potere anche politico, la possibilità dell’esperienza mistica non solo diventa inutile, ma addirittura pericolosa, dato che l’esposizione dei semplici fedeli al sapere iniziatico apre alla messa in discussione del ruolo di mediatore tra umano e divino assunto dal sacerdote.
Essendo Terra ignota una saga che si basa da un lato sull’intertestualità rispetto al canone fantastico e dall’altro sulla nostra tradizione mistica ed esoterica, è venuto logico inserire tali dispositivi, specie considerando che, nelle civiltà che hanno utilizzato o utilizzano psichedelici nei loro riti, questi in genere svolgono anche una funzione di iniziazione all’età adulta, che è poi ciò che capita alla protagonista Ailis con gli eventi del primo volume.
Per quanto riguarda invece L’impero del sogno, non è così. I soli agenti psicoattivi assunti dal protagonista Melani sono sonniferi e narcotici – quando realizza che per continuare il sogno che fa da “portale” per il mondo fantastico in cui è chiamato ad agire, deve dormire più ore possibile.
Si capisce dunque che tali sostanze non hanno in alcun modo la funzione di catalizzatori (non ne hanno del resto la possibilità chimica) ma sono utilizzate semplicemente per la loro funzione meccanica: far addormentare prima e più a lungo.
Nell’Impero del sogno la porta per l’altro mondo è appunto il sogno, e non si tratta di un percorso di accesso spirituale a dimensioni più elevate dell’essere, bensì di un vero e proprio passaggio, secondo una tradizione più popolare e “bassa” del fantastico. Il sogno di Melani non è in questo diverso dall’armadio delle Cronache di Narnia, serve solo ad “andare dall’altra parte”, ed ha del resto luogo anche quando il protagonista non è costretto dagli eventi a sedarsi.
Per quanto perseguita con mezzi meccanici, la volontà di sapere che cosa ci sia oltre “l’armadio”, che cosa sia il sogno, viene alla fine ripagata con un’esperienza che è, esplicitamente, descritta facendo ricorso al vocabolario della mistica (p. 102, Impero). Messo da parte l’armamentario psicoanalitico con il quale il protagonista tenta di spiegarsi, inizialmente, la natura del proprio sogno, e che nella nota conclusiva sembra assumere il ruolo dello strumento per dare ragione dell’intertestualità, la vera natura del percorso compiuto dal Mella sembra essere quella del viaggio iniziatico (p. 14, 111). Al centro, un’esperienza mistica. Mi riferisco al volto della bambina che incontra nel sogno per la cui descrizione, appunto, «Servono emblemi da mistico » (p. 102).
Una cosa è quanto accade nel romanzo, un’alta il modo in cui è descritto, e i dispositivi a cui si ricorre per farlo in modo efficace. Che L’impero del sogno abbia anche una chiave lettura esoterica, non c’è dubbio. Detto questo, è necessario considerare che la teofania di Melani non avviene a fine romanzo, come culmine e risoluzione di un percorso, ma a metà di esso, come inizio di un percorso invece nuovo e differente. Allo stesso modo, il lettore per così dire “introdotto” noterà che un percorso iniziatico completo avviene già nei prodromi del suo sogno, quella parte che non viene neanche narrata direttamente, ma raccontata da Melani all’amico studente di psicologia Iacopo Gori.
Quel dialogo iniziale ha pertanto una doppia funzione: da un lato permette, appunto, di archiviare le letture psicanalitiche per lasciare campo libero al fantastico; dall’altro suggerisce che già l’arrivo in quello spazio che Melani vede come un palacongressi è il compimento di un primo, e completo, percorso iniziatico. La teofania giunge poco dopo, e non è “guadagnata sul campo” – né pienamente compresa: non c’è infatti integrazione, per dirla con Jung. Per quanto il suo voto al congresso, e quindi la sua assunzione di responsabilità, risulti in ultima istanza decisivo, Federico Melani si vedrà assegnata la bimba-dea per via di una sorta di complotto: alcune delle delegazioni scelgono lui per evitare di farla finire nelle mani di altri dai quali sarebbe più difficile poi strapparla. Ne consegue che la visione delle pp.102-104 non è tanto portatrice di un valore simbolico quanto, paradossalmente, di uno realistico: siamo di fronte a un ragazzo che per la prima volta guarda in faccia una dea. Come descrivere ciò che esperisce? Servono, appunto, “emblemi da mistico”, e dunque per rappresentarla in modo efficace ho attinto al mio bagaglio conoscitivo ed esperienziale in quest’ambito. Lo scopo finale del viaggio di Melani – che di fatto comincia lì – è del resto di altro registro: dopo aver compreso che gli immaginarî che ha frequentato possono aiutarlo a sopravvivere nella sua inattesa avventura, successivamente capirà anche che per diventare “davvero adulto” dovrà anche smantellarli, anzi distruggerli uno per uno, come ben mostrava Pintarelli in questa recensione uscita su Esquire. Per questo, credo, L’impero del sogno è stato visto da alcuni anche come la storia di un ritorno alla realtà.
Aiutami quindi a capire: se l’intertestualità, che va da Berserker di Kentaro Miura ai manuali di Cyberpunk, viene spiegata come “accidentale”, come riuso di figure per la costruzione del sogno, al contrario l’esperienza mistica (o spirituale) è qualcosa a cui l’essere umano può avere accesso; sia attraverso l’aiuto di psichedelici sia senza. Come dire, se i mondi che racconti sono d’invenzione, non esistono davvero, l’esperienza mistica al contrario esiste, è reale ed è inoltre portatrice di una certa carica anti-istituzionale.
Sono contento che all’Impero del sogno venga riconosciuta questa natura intertestuale, del resto qui molto visibile (non ve ne è tuttavia meno, ancorché più nascosta, in altri miei lavori di altro tenore, come Muro di casse o La stanza profonda: è una modalità che mi interessa sia perché qualunque espressione testuale è in ultima istanza intertestuale, sia perché il crollo ormai definitivo delle barriere tra generi (per non parlare di quelle tra le forme) apre nuove possibilità e pone nuove questioni in tal senso. La natura intertestuale di questo romanzo nasce però da esigenze del tutto pratiche, che poco hanno a che fare con l’omaggio a immaginarî che pure ho amato. Come è noto, per quanto evolutosi in modo autonomo, e per quanto accostato da molti, per il modo in cui affronta il nostro rapporto con gli immaginarî, a due miei romanzi realistici quali appunto Muro di casse e La stanza profonda, L’impero del sogno nasce come prequel dei due Terra ignota, romanzi fantasy usciti per Mondadori nel 2013 e 2014. Quella saga era invece pensata proprio come un omaggio al fantasy che avevo praticato, da lettore di romanzi e fumetti, spettatore di film, cartoni animati e serie, videogiocatore e giocatore di ruolo: mi interessava in particolare ripercorrere tutte le suggestioni di quelle opere, ritrovando però un collegamento forte – che mai era svanito, ma che molti facevano finta non esistesse, per via di un diffuso, e oggi in via di dissipazione, pregiudizio nei confronti del fantastico – con il canone fantastico “alto”, dal mito arturiano all’Ariosto, fino al Calvino delle Città invisibili. Tutto questo, che bene esplicita lo storico del fantasy Edoardo Rialti in questi due pezzi, è stato apprezzato e dibattuto, ma mi lasciava con un problema di ordine ontologico: perché quel mondo, il mondo di Terra ignota era così? Dal punto di vista del lettore – della nostra realtà se vogliamo –, la risposta era pacifica: perché l’autore di quei libri aveva letto determinati romanzi e fumetti, aveva guardato determinati film, serie e cartoni, aveva giocato a determinati giochi; ma da dentro, la domanda restava senza risposta. Ho lavorato allora alla costruzione delle premesse cosmologiche di quel mondo: il suo seme, l’Imperatrice che emana il mondo di Terra ignota sognandolo, altri non è che la bimba dell’Impero del sogno, che sogna quel mondo là (e non un altro) perché, nel periodo passato “presso di noi”, quando Federico Melani e Livia Bressan – ecco una sorta di sacra famiglia postmoderna, come ha notato di nuovo Rialti – dovevano difenderla dagli assalti delle varie delegazioni, ha avuto accesso alle “cose da nerd” di Melani e ai libri di esoterismo, storia e filosofia di Bressan.
Circa la carica anti-istituzionale dell’esperienza mistica, premesso che non liquiderei come “inesistenti” i mondi creati dalla letteratura, da altri medium o anche soltanto dall’immaginazione – Plotino, Śaṅkara e Schopenhauer possono dirci qualcosa in tal senso – parlerei più di una sua extra-istituzionalità o sovra-istituzionalià: nel momento in cui la questione si sposta fuori dall’esperienza sensibile comune e la trascende verso un senso ulteriore, è inevitabile che gli affari degli uomini – o, peggio, le catene e. i gioghi che incessantemente creano e affibbiano a se stessi e a i loro simili – appaiano risibili.
Visto quello che mi dici, più che di un ritorno alla realtà parlerei di un ritorno alla città: nel senso che l’accesso al vero, l’esperienza di iniziazione, è ciò che in qualche modo premette la presa in carico di compiti che sono, in senso ampio, politici. Il percorso di Melani, dopo la sua “vittoria” ai voti e dopo aver visto il volto della dea-bambina, è un percorso di lotta. Combatte contro coloro che vorrebbero impadronirsi della bambina e usarne il potere per i propri scopi. Melani non sceglie, però, una delle parti e, anzi, alla fine si trova a combattere con la società stessa (p. 270, Impero).
È vero quello che dici, ed è altrettanto vero che Melani – spero che questa intervista abbia dei doverosi “spoiler alert”! – alla fine trova nell’Uomo in camicia, capo di quella che si rivela essere la delegazione più insidiosa, un possibile specchio del sé futuro. Una incarnazione, o se vogliamo allegoria, del minimo di compromessi necessario ad avere una qualche posizione nella società. E Melani, nello sconfiggerlo, sì, ma con un seppuku, esprime un rifiuto anche rispetto a questo, e non solo ad aspetti della società più facilmente condannabili, rappresentati dagli altri delegati. Anche per questa ragione non volevo che quello di Federico Melani fosse un tradizionale percorso di illuminazione: il suo è un percorso di rifiuto assolutamente radicale. Non etichettabile, anzi, come nichilista, solo in virtù del fatto che a partire da tale sacrificio, Gemma potrà generare un mondo. Che questo derivi dall’appartenenza di Melani a una generazione a cui è stata negata qualunque possibilità rivoluzionaria? È possibile. Daniele Giglioli ha scritto che Muro di casse e La stanza profonda raccontano le nicchie dove è andato a nascondersi il desiderio utopico contemporaneo, altrove bandito: dato allora che, come si è detto, per i suoi temi (e, credo, anche per ragioni puramente cronologiche, da cui l’autore non riesce mai a prescindere del tutto) L’impero del sogno finisce per costituire una involontaria trilogia con questi due romanzi, più che con quelli a cui è narrativamente legato, non escluderei questa lettura.
Vorrei fare un passo indietro e ritornare alla questione dell’intertestualità, del worldbuilding. Se, da un lato, i mondi di Terra ignota e dell’impero del sogno, assomigliano a quella degli isekai – un genere nipponico in cui uno o più personaggi si ritrovano ad abitare il mondo di un videogioco, un mondo fantastico ecc. fattosi in qualche modo reale ma che spesso ha regole “fisiche” e sociali da mmorpg https://en.wikipedia.org/wiki/Isekai – dall’altro tu accosti a questa “giocosità ontologica” (B. McHale) tutta una serie di problemi, anche questi ontologici, nient’affatto playful. Faccio riferimento a una cosa che hai detto prima, sull’impossibilità di liquidare come inesistenti i mondi dell’immaginazione. Ma anche ad una certa idea che si ritrova nella Stanza profonda, di parallelismo tra dungeon, tra stanza profonda, appunto, e inconscio, al gioco come rito (p. 108, 109 stanza): qual è il rapporto tra il fantastico e il nostro quotidiano? In che rapporto stanno, tra loro, i mondi creati dalla letteratura, i mondi del gioco ecc. e le esperienze spirituali che racconti?
In Terra ignota sono presenti elementi che possono ricordare un videogioco o un gioco di ruolo anzitutto per ragioni di influenze transmediali, che nel fantasy si fanno anche più pressanti. È chiaro che quando si portano elementi da un altro medium, sia esso ludico, video o di altro tipo, in un testo scritto, si tratta, sempre, di un lavoro di “traduzione”, non di semplice riporto. Questo è quello che ho cercato di fare in quei due romanzi, dove la gamma delle influenze è davvero molto ampia: c’è Ariosto come Dragon ball, c’è il Mahabarata come il cinema di Milius e Boorman, e appunto videogiochi come Ultima o Zelda. Tale lavoro di traduzione richiede un’azione su tutti gli elementi, tale che possano stare assieme in modo armonico: per questo, ad esempio, Ailis, Brigid e le altre figlie del rito a volte appaiono tridimensionali, vive, altre più simili a personaggi di un manga che a persone vere, altre “larger than life”, come eroine del mito, e altre ancora più – diciamo così – “pixelate”, come fossero sprite di Final fantasy IV o Chrono trigger: hanno questa capacità di fluttuazione proprio per poter reggere una parallela varianza delle modalità operative e di rappresentazione del mondo in cui si muovono.
Nell’Impero del sogno, più specificamente nella seconda metà (ma non dimenticherei che, nella prima, il sogno di Melani, pur rifacendosi a tutt’altri immaginarî, ha caratteristiche strutturali simili a quelle di un MMORPG), l’influenza videoludica è più netta e deliberata: anche per questa sua centralità non volevo che fossero semplici omaggi, così ho rifuggito il citazionismo, per provare, piuttosto, a creare scene che assomigliassero a un videogioco anzitutto nella loro impostazione strutturale.
È vero che nella Stanza profonda e in Muro di casse si mette l’accento sulla dimensione rituale insita in fenomeni apparentemente molto diversi quali i giochi di ruolo e i rave party: per quanto in entrambi i casi si tratti di espressioni di liberà, anzi di vere e proprie epitomi della libertà, non si può non notare come alla base ci sia comunque un sistema codificato di regole e apparati rituali, che vengono liberamente scelte e accettate dai partecipanti, non imposte, ma che comunque organizzano l’entropia della “pura” libera espressione del sé entro forme simbolicamente coerenti, innalzando così la portata esplorativa, introspettiva e sperimentale dell’esperienza, e portandola dal semplice intrattenimento verso altri e più significativi ambiti dell’esperire umano.
Credo che sulla funzione salvifica dell’immaginazione, e sul modo in cui determinati medium e determinate esperienze possono attivarla, dica molto, e in modo molto acuto, questo pezzo di Antonella Francini scritto per Alfabeta2 proprio a partire dalla Stanza profonda e dall’opera intertestuale per antonomasia, La terra desolata di T.S. Eliot.
L’immaginazione, indipendentemente dalla forma – romanzo, film, videogioco ecc. –, ha insomma qualcosa a che fare con la salvezza, personale, prima, e collettiva poi?
Quello del potere salvifico dell’immaginazione è un tema classico della narrativa fantastica e non solo. Come detto, rimando all’articolo linkato poco sopra chi volesse approfondire questo aspetto dei miei lavori. Vale la pena però dire che quando si passa a una dimensione collettiva, non tutti gli immaginarî – e, soprattutto, non tutte le modalità di produzione di immaginario – sono uguali: nel momento in cui non si è soli con la nostra mente (o la nostra anima), ma sono in ballo interazioni con altri, risulta più significativo ciò che, come i giochi di ruolo o i free party, aiuta a disegnare nuove modalità di relazione umana attraverso logiche cooperative e inclusive, piuttosto che competitive e divisive.
È questo uno degli obbiettivi della tua scrittura? Intendo dire: pensi alla scrittura come a un modo per produrre comunità, o per offrire esempi di modi di essere alternativi a quelli della competizione?
È fondamentale per me sottolineare come queste considerazioni siano tutte fatte a posteriori, e in buona parte derivanti da riflessioni che altri hanno fatto sui miei libri. Non credo che l’arte debba avere obiettivi programmatici. Cerco di scrivere quello che voglio, nel modo che voglio, a partire da temi che mi interessano, esperienze che ho vissuto e altri libri che ho letto, e di farlo nel miglior modo possibile, secondo le mie capacità e le esigenze della vicenda. Al massimo, in alcuni casi, come quelli di Muro di casse e della Stanza profonda c’è la volontà di storicizzare un certo fenomeno e rifletterci sopra. Solo quando il libro è finito, è opportuno – e a dire il vero neanche necessario – che l’autore rifletta sui significati che quello cela: nelle arti, pensare prima a possibili obiettivi o messaggi da far pervenire, peggio che mai se politici (anche se positivi e/o in buona fede), è dannoso.
[1] Ho pubblicato alcuni dei risultati di questa ricerca, a cui mi permetto di rimandare, qui: M. Zonch, Il testimone di fede: verità e spiritualità nella narrativa di Saviano, in «Incontri. Rivista europea di studi italiani», 32(1), 2017. DOI: https://doi.org/10.18352/incontri.10206

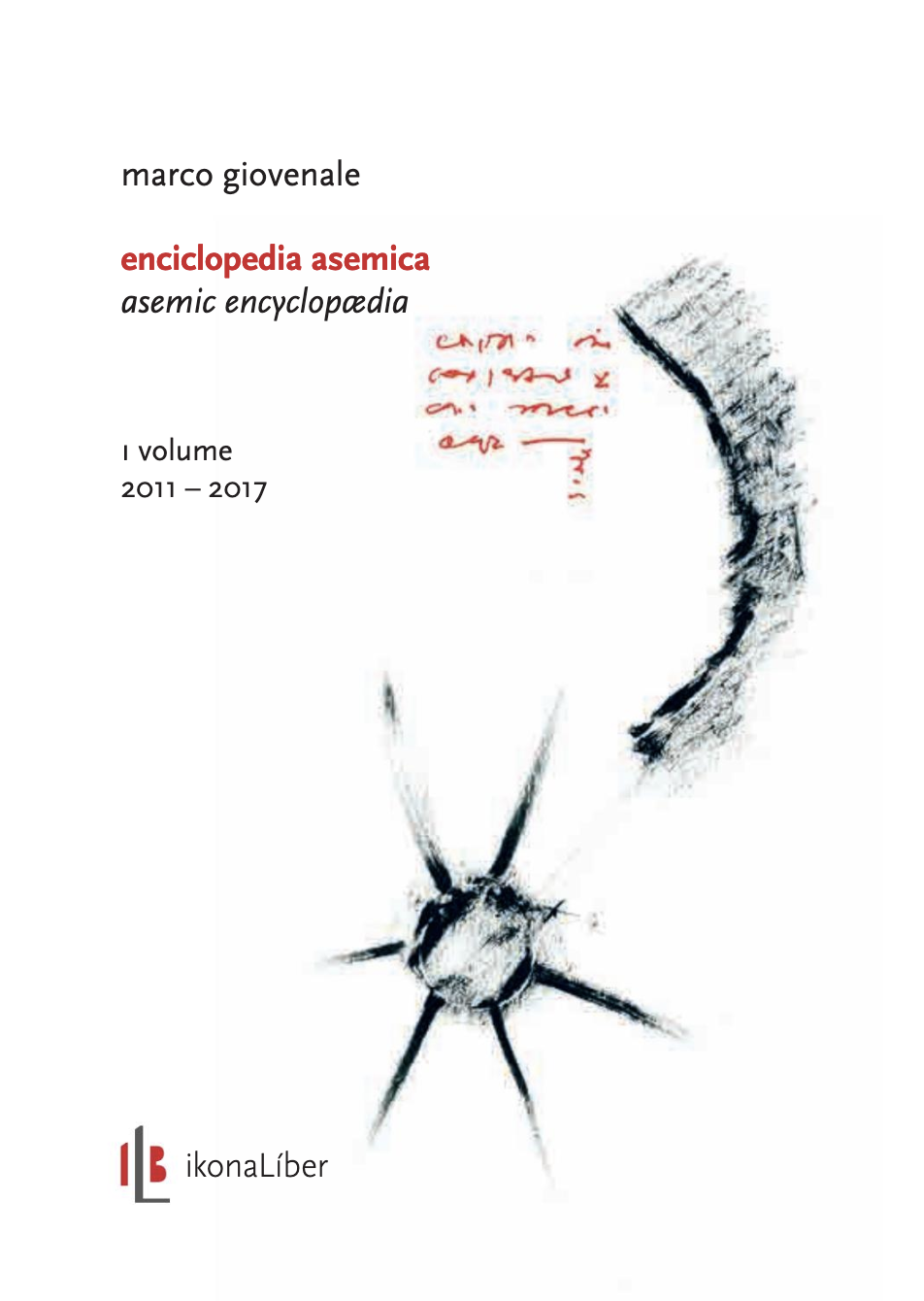
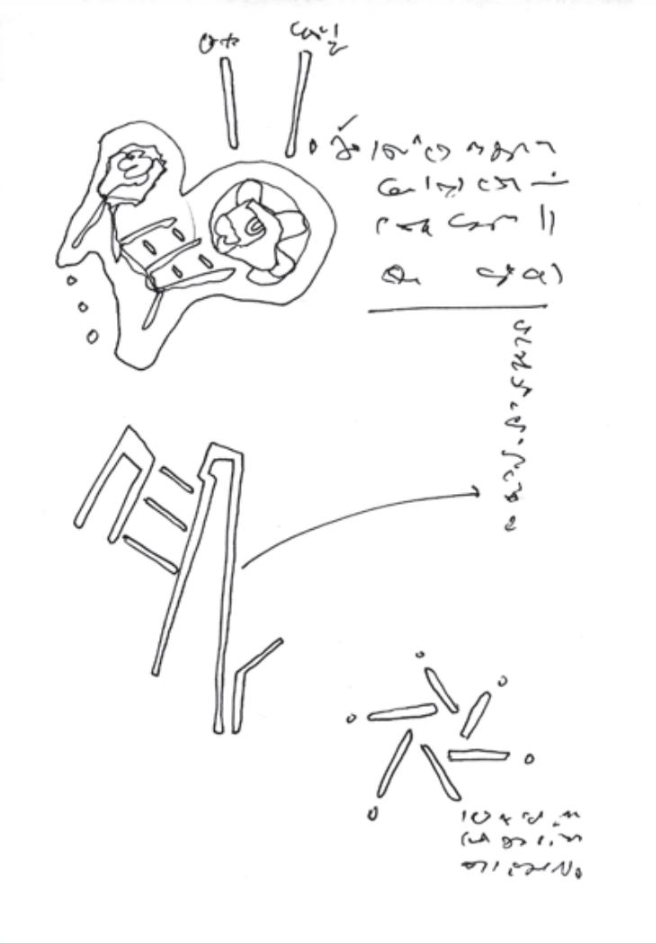
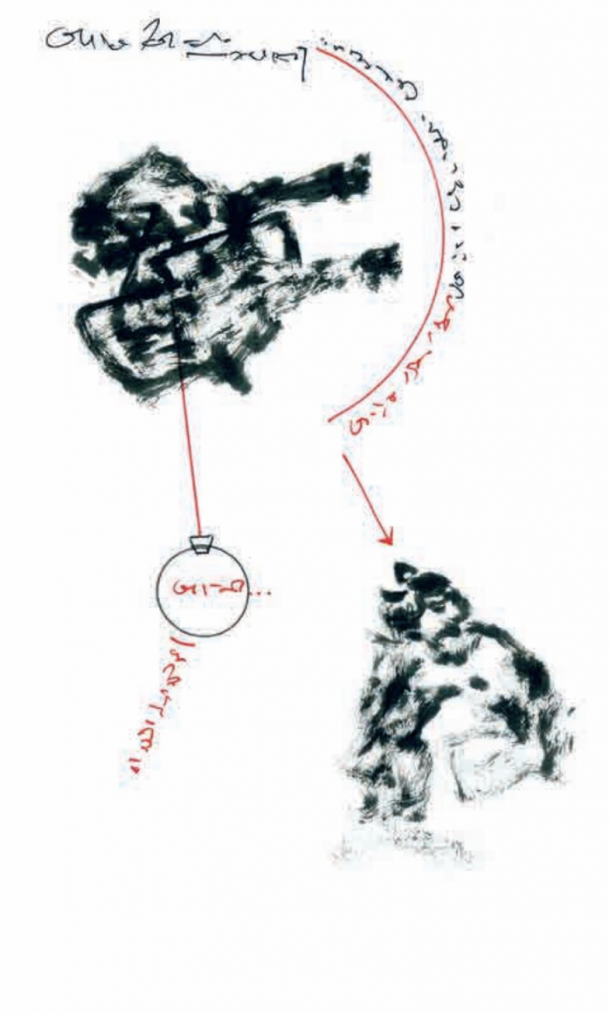
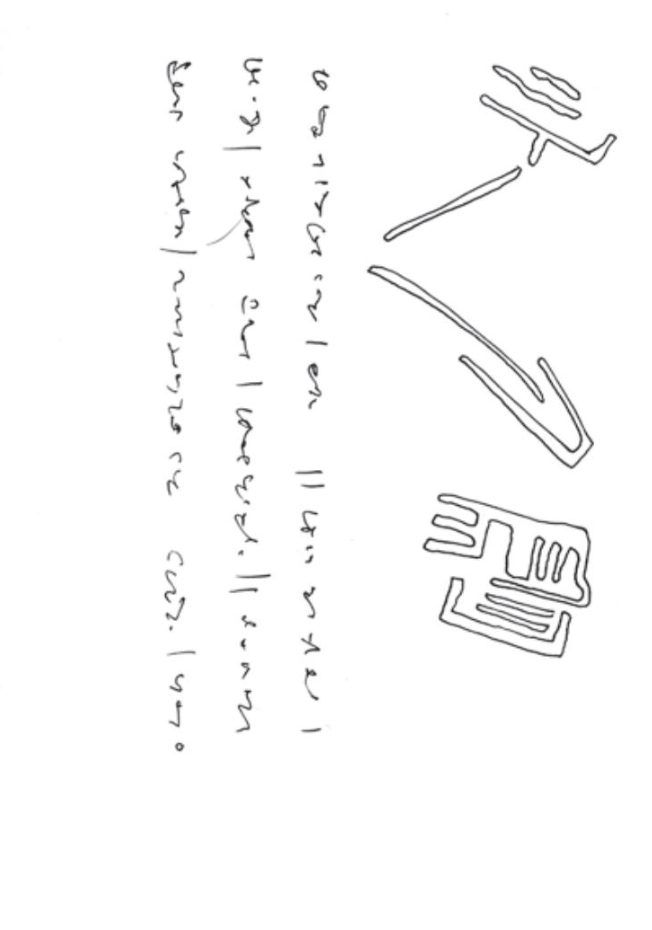
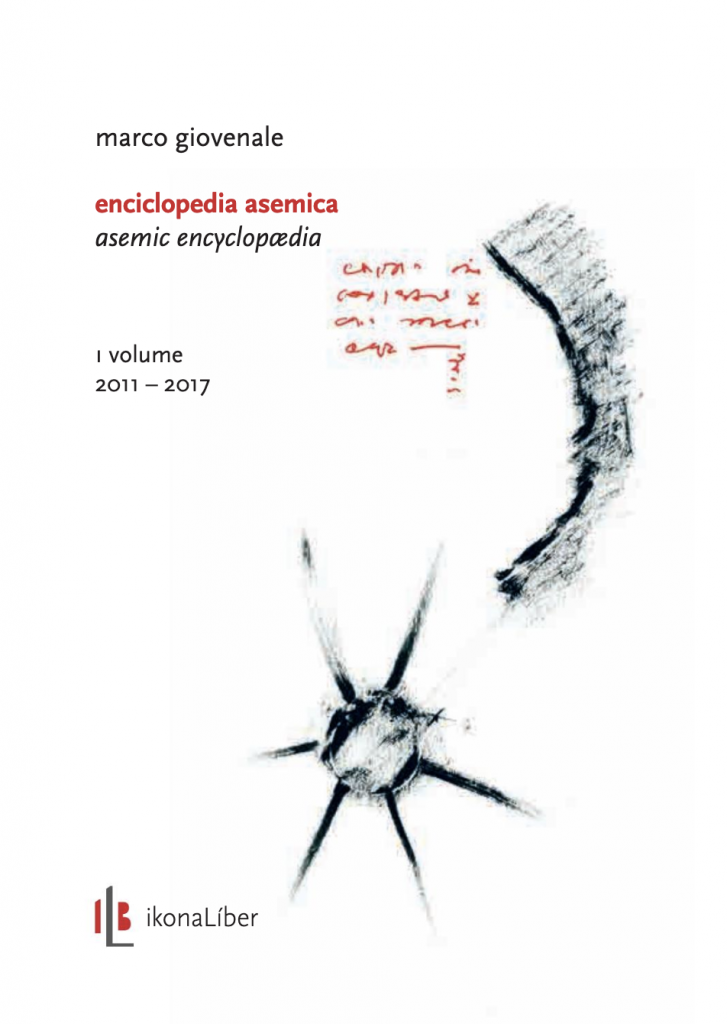

 trad. isometra di Daniele Ventre
trad. isometra di Daniele Ventre

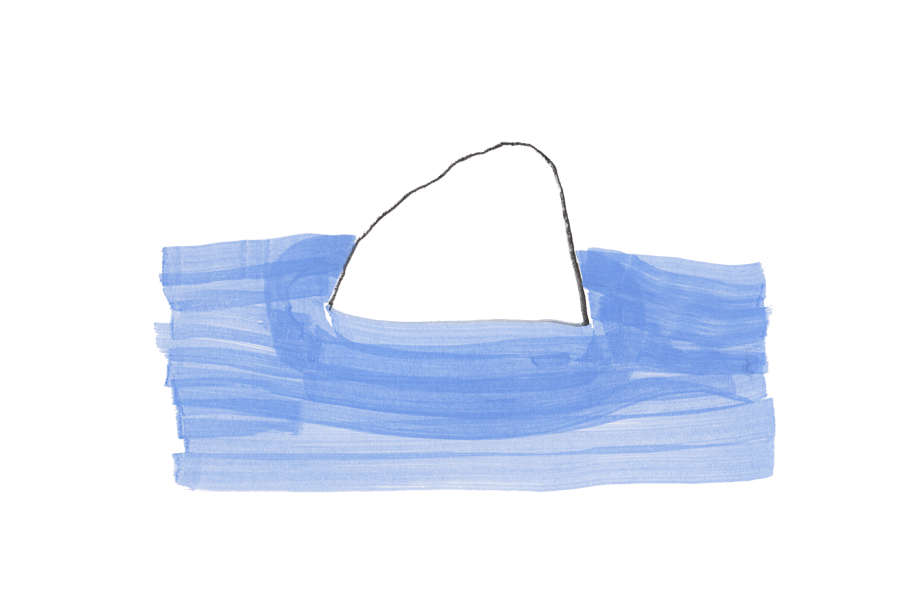
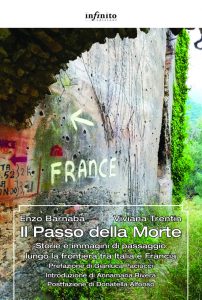



 L’ultimo testo pubblicato di Villa.
L’ultimo testo pubblicato di Villa.