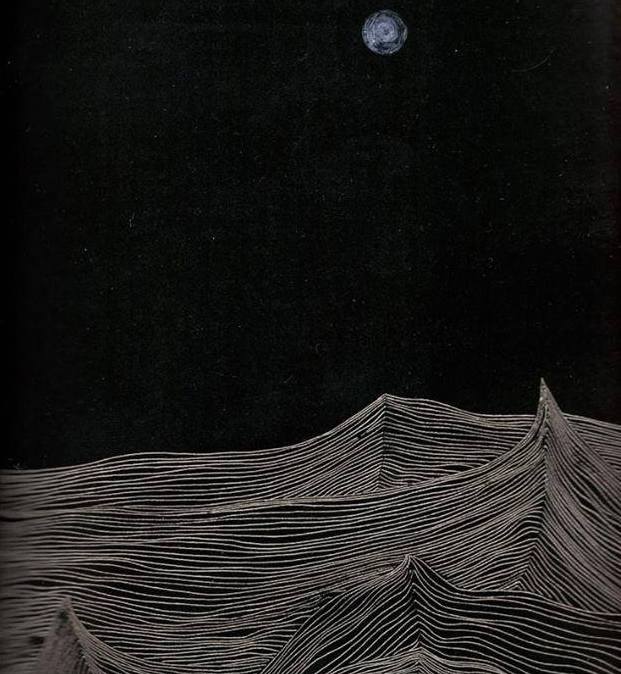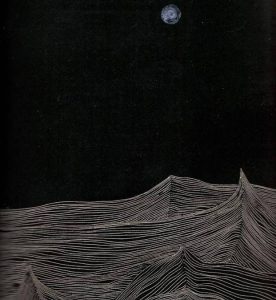di Daniele Ventre
Polesía, il nuovo numero di Trivio, il quarto dalla nascita della rivista, patrocinata dalla casa editrice Oèdipus di Francesco Forte e curata dal poeta Ferdinando Tricarico, si presenta eccezionalmente come un volume monotematico sulla “democrazia”, volume che coinvolge un ampio numero di poeti. La scelta nasce dalla considerazione del direttore scientifico Antonio Pietropaoli (si veda la sua breve Premessa al volume, a p. 5), secondo cui se una rivista culturale deve “da un lato godere della più ampia libertà di movimento” deve anche, “dall’altro, … lasciarsi incalzare dagli eventi della realtà esterna”: una realtà di profondo degrado politico, nella quale “non solo il sistema democratico mostra evidenti crepe, ma il concetto stesso di democrazia viene revocato in dubbio, è entrato in crisi … ultimo effetto perverso della globalizzazione, che ha inoculato in tanti, in troppi, la convinzione che la democrazia fosse solo quella degli integrati, degli inclusi, degli (ad) agiati, e si fosse dunque trasformata in odiosa oligarchia”.
In relazione oppositiva a questa realtà, “nell’epoca della perdita dell’utopia”, per riprendere le parole di Francesco Muzzioli (nella sua introduzione Per una poesia democratica a p. 9), la paralisi dell’immaginazione politica attua un vero e proprio rovesciamento del principio speranza di blochiana memoria in un fine della disperazione, di contemplazione della catastrofe, il che “chiama in causa proprio quelle facoltà tradizionalmente connesse alla letteratura”, come sede elettiva della contemplazione di futuri possibili, o quanto meno di demistificazione dei fondamenti assurdi, deteriori e deterioranti, dell’impossibile presente. Tale è lo scopo ultimo di questa antologia tematica, con cui, al di là delle differenze di poetica e di orientamento, si cerca di lanciare, come apertis verbis dichiara il curatore Ferdinando Tricarico “il sasso nello stagno della disillusione politica”, attuando, pur fra mille incertezze e ripensamenti, questa crasi fra Polis e Poesia -e si tratta, ovviamente, di una crasi paradossale, visto che al presente si realizza, forse per la prima volta nella storia, il caso di una forma di organizzazione del potere che non ha bisogno di sanzione estetica o culturale.
Le esperienze poetiche raccolte in Polesía, alla quale anche chi scrive è stato chiamato a fornire il suo modesto (e per quanto possibile onesto) contributo, sono assai eterogenee, potendovisi riconoscere un panorama abbastanza ampio e sfaccettato, benché per forza di cose non completo, dei vari linguaggi della poesia italiana attuale. Nella visione di insieme fornita da Francesco Muzzioli, si possono ravvisare qui in vario modo tre elementi tradizionalmente specifici di quei testi che si concepiscono, e si percepiscono, come politicamente orientati, o fortemente impegnati verso la comunità: 1) l’invettiva, come vis polemica d’attacco; 2) la satira, come prassi dissacratoria; 3) l’ironia, come habitus mentale e stilistico di entrambe. Più che di tipologie atte a classificare il materiale antologizzato, questa terna di connotati tipici fornisce un quadro generale della sua ἰαμβικὴ ἰδέα, vale a dire, del suo tono di fondo, che è aggressione linguistica, stilistica, immaginativa, cognitiva ed etica al problema, oltre che agli obbiettivi comuni dei testi raccolti: la globalizzazione selvaggia, il modello di governance tecnocratica senza controllo della finanza, la sindrome cinese dell’ingegneria sociale neo-liberista estrema, che coniuga dittatura militar-burocratica e far west economico, ma anche il contraltare glocalistico, xenofobo, neo-conservatore, populista, francamente neofascista, rappresentato da forze ademocratiche solo in apparenza ribelli al sistema, ma in realtà perfettamente organiche alle sue reti di comando liquide, o spesso semplicemente liquefatte.
Così, in una carrellata cursoria, ma si spera non troppo superficiale, si susseguono in ordine di apparizione: lo stile franto, misto fra allusione storica e intimismo, dei versi liberi di Luca Ariano; la riflessione lucida di Mariano Bàino, articolata in due tempi pentastici, che sembrano riecheggiare una sorta di trompe-l’oreille esametroide e decostruiscono con ironia sottile e corrosiva le parole chiave del gergo dei tecnocrati, e la loro filosofia da platonismo aziendale raffazzonato, fra i week-end plebiscitari dei politicanti della domenica, i fludi talk-show delle narrazione liquide, entrambi indifferenti al black out definitivo della biosfera e dei suoi abitanti; la tecnica versolibera di Domenico Brancale, per cui prende invece vita una sorta di spontaneismo dell’etica del viandante, del diverso, dell’altro; il linguaggio compassato e nitido, da university wit, di Franco Buffoni, che consegna al lettore un finissimo e stringato scavo poetico dell’archaiología della costituzione come base della democrazia in quanto spazio in cui tendere, nelle parole del diritto, all’utopia possibile; il messaggio di Enzo Campi,che si dipana invece in una estrema frammentazione dei nessi tonali elementari dei sintagmi, arrivando all’enjambement in piena elisione, all’episinalefe, e trasformando in balbettio disintegrato la rottamazione dell’umano derivante dalla disgregazione neoliberista dell’istituzione democratica; la lunga catena di lasse atonali tratte dall’inedito di Purgatorius, di Guido Caserza, che è portatore di un forte messaggio di demistificazione dei tic politici comuni al tempo attuale e riesuma in un nuovo contesto elementi e tratti stilistici propri dei novissimi, che a volte sembrano riprendere, ora in oppositione ora in consonanza, i toni di Laborintus, o dei passaggi apertamente politici della produzione di Pagliarani; seguono i lunghissimi stichi di prosa di Nadia Cavalera, che attutiscono il classico impatto che ci si aspetterebbe dall’esercizio della funzione poetica, diluendolo in una catena discorsiva semi-colloquiale; con spazi ritmico visuali più compatti si dipana il discorso poetico, pur esso fondato sul verso atonale, di Domenico Cipriano, nel cui testo si riflette l’implosione dell’individuo a pulsioni sociali e affettive primarie, di fronte al crollo dell’ideologia come progetto e orizzonte condiviso; la parodia della democratura come fiaba dell’orrore, fra parole magiche di tono anglizzante, ambiguità e volgarismo televisivo ironizzato, connotano la monostrofa monologica di Floriana Coppola; il blocco di prosa, degré zéro della forma di fronte alla deformazione e all’informe del mondo pubblico, caratterizzano il testo, anch’esso parodico, di Vera d’Atri, che (de-)costruisce un discorso politico, frantumando il senso delle sillabe nella gragnuola dei tecnicismi politologici affastellati; da prima decisamente virato sul nonsensical, sul gingle, poi sulla Betrachtung prosastica con giochi fonetici immersi in una sintassi frammentata, l’irruzione linguistica di Chiara Daino nel càosmo della democrazia in delirio di impotenza; sempre sul piano del ludus verbale, organizzato però in una sorta di psico-dramma a soggetto (de-soggettivato), il testo di Carmine De Falco, orchestrato sulla mimica del silenzio e del basso profilo in tempi di controlli totalizzanti e onnipervasivi; estremamente concentrata la tempra stilistica di Francesco Filia, il cui dettato, con la sua assoluta immediatezza, richiama l’idea di una dimensione politica in cui l’uomo sia presente nella sua pienezza, al di là di ogni finzionismo e di ogni costruzione artificiale del nemico di turno; altrettanto immediato, ma di tono contestativo, con andamento da filastrocca e da slogan, da corteo, il breve sistema di quattro strofe di Claudio Finelli, il cui tono da marcia traccia il perimetro del diritto ad esercitare il dissenso dalle fila di una minoranza, che si trasforma a questo punto in una sorta di anti-élite; una complessa alternanza fra prosa ritmica e verso atonale nel testo di Giovanna Frene, determina una sorta di dialettica fra discours razionalizzato, storicizzato, e un recit versale dal tono gnomico, universalizzato; una riflessione sul potere politico che si struttura come forma della divisione/distinzione/discriminazione, e di una antropologia dell’opposizione amici-nemici, si definisce nelle quattro strofe versolibere di Vincenzo Frungillo; la parodia e l’altergiunzione dominano la prosa ritmica intervallata di stichi atonali di Francesca Genti, che con il suo poemetto-novella surreale/iperreale in prosa/verso delinea la società attuale, avviata a diventare postdemocratica, come un collage di tribù insulari e isolate più o meno conformiste al loro interno; toni quasi neo-oracolari, al limite del messianico, si rinvengono nelle due brevi lasse versolibere di Federica Giordano; una raffinata ironizzazione dei tradizionali simboli della modernità (uno fra tutti, l’albero della libertà, di giovanil-hegeliana memoria) si legge nel demo di Marco Giovenale, che già nel titolo allude alla forma di una struttura tecnicamente ancora in prova, imperfetta, inconclusa, sub iudice, da esperimento ancora da consegnarsi al pubblico, e che demistifica, con la sua sintassi franta, tramata di omissioni, rimandi intratestuali sbozzati, pseudo-reticenze e pseudo-preterizioni i toni e il linguaggio ordinario, da imbonitore propagandistico, dell’opinionista maggioritario tipo, e della sua orchestrazione di insignificanze condivise e tic sintattici da pubblicità-regresso; un linguaggio molto più tradizionale, tramato dall’evocazione dell’albero d’ulivo come proto-albero della libertà (e di fatto totem della democrazia attica, incunabolo improprio di tutte le democrazie) si rinviene nei versi di Mimmo Grasso; la prosa in prosa di Andrea Inglese fa da integrazione antifonale e risposta a distanza al testo di Giovenale, in una distesa e tecnicizzante ironizzazione della trama comunicativa e mediale delle democrazie, che decostruiscono dall’interno il loro pluralismo attraverso un discorso ridotto a sloganistico “messaggio”, di fatto unilaterale, che genera malinteso più che intesa e non-sensi più che razionali dissensi e consensi argomentati, finendo in sostanza per essere, in modo strisciante, totalitario, e sfuggente rispetto ai suoi stessi destinatari annidati in una post-ideologica massa parcellizzata; diverso ancora il senso allusivo dei versi di Maria Grazia Insigna, connotati, nell’esordio, da una sorta di contemplazione delle macerie, e dell’assenza degli uomini, in uno spazio (tanto esistenziale, quanto politico) nullificato e annebbiato da una chenosi non mistica; tutt’altra forma assume la lassa di prosa ritmica di Costanzo Ioni, che come da sua cifra stilistica inconfondibile, crea uno spazio nuovo, intrecciato di dialetto, latino, anglismi deformi e difformi, facendo aderire al cafarnao sociale generalizzato delle comunità disgregate su un pianeta abbandonato alla deriva economica e climatica, il suo personale cafarnao linguistico, sermo impossibile che si configura come l’unico possibile codice di decifrazione del caos; i versi lunghi, quasi versi neo-narrativi, di Carmine Lubrano tessono il referto autoptico di una non-narrazione, centrata sui giochi allitterativi e paronomasici che fanno della democrazia degratata la figlia impropria della demenza e del demerito; centrati lato sensu sulla forma della Pace, gli endecasillabi sciolti, neo-leopardiani in più di un’accezione, di Eugenio Lucrezi, per converso tramano con il loro andamento discorsivo, quotidiano, una sorta di giambo attutito, in cui i richiami a una certa tradizione lirica si dissimulano e si fondono con la colloquialità spontanea che descrive il business as usual no matter what nel tempo della crisi definitiva; per converso, estremamente concentrati appaiono i versi di Franca Mancinelli, a evocare per speculum et enigmate, in modo decisamente neo-ermetico, una trama della memoria come fondazione (ossimorica) di una ucronia concreta della società civile; il tono sloganistico, quasi da refrain contestativo, da striscione, ritorna a gola spiegata nei versi liberi a cadenza più o meno ternaria, anapestica, tramata di rime facili, di Anna Marchitelli; di altra natura il tono contestativo di Giovanna Marmo, che impronta alla negazione il suo discorso poetico sulla polis degradata a piccola patria particolaristica, dominata dalla massificazione e dalla disintegrazione in automatico, tramite una medialità inquinata e degenere, della parola e della voce ragionante; lucido e feroce, nella sua revulsione dei sintagmi, il messaggio di Renata Morresi, in cui i topoi e i cliché del pensiero progressista-democratico andati a male dopo la fallita fine della storia, franano progessivamente verso la singolarità di una adesione esitante; una nicchia a sé occupa, in questo ambiente variegato, Lamassu, la prosa di Paola Nasti, surreale dialogo lucianeo con un totem mesopotamico, quasi una operetta morale, o un conte philosophique drammatizzato, sull’intraducibilità (e sulla necessità di tradursi) della democrazia nell’umano, essendo questa effettivamente realizzabile, come da rousseauiana citazione, solo in un utopico popolo di dèi; nei versi di Lucio Pacifico si presenta invece all’occhio, in apparente focalizzazione esterna, un paesaggio deragliato di esperienze standardizzate dall’ingranaggio produzione-consumo, in cui di fatto nessuna parola ideologicamente marcabile e nessun concetto specificamente politico trovano più luogo e cittadinanza; la maniera breve, neolirica, di Melania Panico si articola in due momenti ritmici, fra il prima e il dopo l’instaurazione della democrazia, con riduzione degli individui a elementi mansueti di un gregge, come a suggerire per allusione la natura intimamente gregaristica, non partecipativa, delle democrazie industriali; nei suoi versi serpeggianti nel vuoto dello spazio bianco come spago da ricucire cicatrici, Marisa Papa Ruggiero definisce lo stato di nomadismo esistenziale dell’uomo contemporaneo, lanciato verso una quest non eroica, una cerca, senza definizione dell’oggetto; più personale e intimistica la riflessione di Maria Concetta Petrollo, che evoca la dimensione incerta della democrazia come dinamica di organizzazione sociopolitica debole, perché non radicata nella longue durée (nell’urna elettorale,”prima di me/ passò/ solo mia madre”); una struttura narrativa, da virulento e spietato racconto allegorico, ha invece il poemetto di cronaca nera di Antonio Pietropaoli, i cui versi liberi cadenzati, quasi pavesiani, fra l’endecasillabo dattilico e l’esametroide, fanno da colonna sonora in sordina alla brutale dinamica di uno stupro con delitto in due tempi, in un testo che può essere letto a più livelli come immagine del disordine costituito; la forma poematica, stavolta per lasse di endecasillabi e settenari, a volte regolari, a volte segnati da anacrusi che li rendono ipermetri o ipometri, connota con altre dinamiche anche la scelta stilistica ed espressiva di Ugo Piscopo, che riprende, ironizzandola, la forma del contrasto e della cobla di canzone; richiami evidenti, ricontestualizzati e risemantizzati, ai novissimi, in particolare a stilemi sanguinetiani (“…le grandi idee …saranno messe/ in prigione…”), nel trittico di lasse di versi atonali il selfie è uguale per tutti, di Gilda Policastro, che delinea lo scenario disgregato di una medio-crazia dell’autoscatto, dominio del narcisismo mediale dei mediocri nel tempo della banalità del mare; centrato sull’immagine incipitaria del “fiero pasto universale” che costituisce il mutuo sbranamento assicurato della lavorazione della storia è invece il tessuto ritmico implicito delle lasse in cui si articola il discorso poetico di Lidia Riviello, nel cui verso/prosa ritorna, insistito, il tema harrisiano (da cannibali e re) della sicurezza/insicurezza alimentare come trama pulsionale profonda della politica; la forma della democrazia neo-imperiale, in transizione verso forme più o meno ambigue di principatus e dominatio, o democratura, si accampa nei versi di Gianluca Rizzo, il cui trilinguismo (latino, italiano, inglese) è finalizzato a ricreare le tensioni del campo semantico dell’egemonia nei suoi slittamenti epocali; una sorta di teologia negativa della democrazia (“demo… che?”) si ritrova nelle strofe tristiche versolibere di Anna Santoro, il cui tono graffiante si stende sul quadro desolato di un mondo “bastonato da dittature amiche”; decomposizione e ricomposizione del linguaggio politico mediale della dittatura tecnocratica cinese, modello improprio del capitalismo occidentale in cerca di nuovi erramenti ed orrori, nei lunghi stichi atonali di Ivan Schiavone, il cui tema centrale è la possibilità di una guerra commerciale che è per definizione senza vincitori né vinti, così che le parole di XI JinPing, il capo di tale dittatura, finisce per offrire una sorta di lezione storica indiretta al capo della più grande democrazia occidentale, il Trump creatore di barriere doganali e sbarramenti; quasi eracliteo il correlativo oggettivo costituito dall’immagine del cercatore d’oro nei versi di Giulia Scuro, nei cui versi la ricerca dell’Eldorado dell’utopia, nascosta dietro la forma astratta della democrazia, viene adombrata in un tessuto iconico che è al limite dell’orfismo; nei versi a prevalente cadenza anapestico-ternaria (decasillabi, novenari, settenari con battuta di terza, trisillabi, quaternari), l’acquaforte di Ada Sirente procede a tratti con il ductus ritmico di un embaterion, mimando nell’inceppamento del ritmo finale, l’inceppamento dell’ideale; nella poesia di Rossella Tempesta si tratteggia il deragliamento del rapporto fra istituzione e bisogni, nel luogo dove maggiormente esso si avverte, su quella frontiera del palazzo che l’ente locale rappresenta, quella membrana permeabile e invalicabile fuori dalla cui immunitas sono respinte le aspirazioni comuni degli individui comuni; peculiare, e fondata su una riflessione metapoetica che incrocia potere (guerra) e poesia, è invece il breve esquisse di Christian Tito, in cui l’onnipervasività della potestas devota al bellum, trova un muro nel poeta devoto in qualche modo al “bello”, e travestito da dipendente della potestas, in un duello verbale ed esistenziale esplicito in cui è il poeta, in definitiva, a fornire il suggello (“non importa se non leggete le poesie/ sarà la poesia a leggervi tutti”); sul filo della memoria storica e della mancata fine della storia (come la storia è finita, per i personaggi che la subiscono, e non è mai, fukuyamamente parlando, finita), è la qinah in morte e in vita di Falcone e Borsellino, di Anna Toscano; una struttura da monologo tucidideo di Pericle satanicamente rovesciato, l’immaginario discorso di Trump sullo stato dell’Unione, nelle lasse di stichi atonali di Ferdinando Tricarico, che si presenta come ghost writer dipendente ribelle del sistema e destinato al firing (termine che può indicare tanto il licenziamento quanto l’eliminazione fisica a cura di un plotone di esecuzione), e si configura come l’autore di un logos votato a disvelare e demistificare, dall’interno, lo stesso inganno semantico latente nel termine democrazia; per blocchi semantici ripetuti all’interno di nodi paralogici, o paraetimologici, o demistificatori di pseudo-logiche, procede, come suo uso, la lunga sezione/session poematica di Silvia Tripodi, che illustra l’insensatezza di una macchina perfettamente oliata per alimentare in modo automatico la propria autoreferenziale gestione e governance, così che di fatto la dimensione della democrazia in senso moderno viene essenzialmente esclusa, messa in parentesi; struttura poematica ha anche la lassa di versi lunghi (di un endecasillabo e un settenario accostati, à la Bernardino Baldi) che il sottoscritto, Daniele Ventre, penultimo tra cotanto senno (così sono costretto, con riluttanza estrema, ad autonominarmi e autoclassificarmi, come da completo referto), ha incentrato sull’immagine della Statua della Libertà, parodiando in negativo (piaccia o meno) Emma Lazarus e il suo New colossus, con i suoi proclami politici svuotati di credibilità da decenni di occidentale, euro-americana e democratica non accoglienza classista e razzista del viandante; rapido ed essenziale, epigrammatico, il madrigale muto di Lello Voce, il quale, nella sua brevitas, condensa il nodo della crisi della democrazia nell’insensatezza del suo linguaggio quotidiano, balbettio di politici sgrammaticati, di pubblicità e di vuoti d’anima, sprigionati come sminuzzamenti del senso dal tritacarne del pensiero unico, che riversa sul mondo frammenti di suono, voci chiocce, suole usurate, mani vuote, cielo senza stelle, a restituire all’uomo tardo-moderno l’immagine dell’assemblea pluralistica dominata dalle armi e dal mercato alla fine della decadenza.
Un panorama così apparentemente variegato ed eterogeneo permette, di primo acchito, di delineare, sia pur con qualche approssimazione, un quadro generale di questo spaccato, per forza provvisorio, di una nuova poesia politica possibile. Alcune esperienze e dinamiche sembrano, in tale orizzonte, più centrali (nel senso linguistico, chomskyano, del termine), centrate come sono sul nodo della vita associata in una società complessa, vale a dire il linguaggio come nucleo primario della medialità. In tal senso si muovono, a vario titolo e da differenti approcci e poetiche (ma sono indicazioni di massima, ampiamente rivedibili e gravide forse di eccesso di semplificazione), sia forme espressive, tipiche ad esempio di Marco Giovenale, di Andrea Inglese, Renata Morresi o di Silvia Tripodi, in apparenza lontane dalla forma tradizionale del plurilinguismo comico-realistico dissacratorio, sia la lingua artificiale di Costanzo Ioni, che questo plurilinguismo conduce alle estreme conseguenze. Altri esperimenti, altrettanto centrali, conducono verso la destrutturazione delle dinamiche effettive della comunicazione frontale/mediatica del politico (come individuo storico e come categoria) rispetto alla massa interlocutrice passiva: è il caso, ad esempio, del monologo di Pericle rovesciato di Ferdinando Tricarico, e in responsione inversa, del discorso di Xi JinPing reinventato da Ivan Schiavone, o per altri aspetti del Purgatorius di Guido Caserza; un tono peculiare hanno quei poeti che hanno in varia maniera impresso ai loro versi uno stile contestativo, da corteo apparente, da Claudio Finelli, ad Anna Marchitelli, a Giovanna Marmo; uno statuto particolare va riconosciuto a testi, come quelli di Franco Buffoni, Francesco Filia, Antonio Pietropaoli, Lidia Riviello, Rossella Tempesta o Lello Voce, che aggrediscono da vari punti di vista le metacondizioni sociali e le soluzioni al contorno del discorso della democrazia, tematica di fondo a cui si accostano anche le prese di posizione dei due testi espressamente neometrici presenti nella raccolta, quello di Eugenio Lucrezi e il mio modesto contributo. Una linea a parte è rappresentata dai testi di tempra apertamente neo-lirica, come accade in ordine sparso per Melania Panico, Ada Sirente e Giulia Scuro, le quali affrontano il problema con il loro codice espressivo volutamente decentrato, battendo una via che stigmatizza il degrado del linguaggio della comunità annegandolo nel silenzio, nella non nominazione, più che riecheggiandone la vuota stereotipia. Come si può notare, si tratta di classificazioni che prescindono del tutto dalle diverse poetiche e dalle appartenenze dei vari autori, puntando più che altro a mettere in evidenza gli effetti concreti delle diverse soluzioni espressive adottate.
Ne risulta, fra quelli involti nel caos dell’agorà e quelli che si sono consegnati al romitaggio, una sorta di anti-epos collettivo del declino della communitas ad opera degli immunes, in cui le varie forme in campo definiscono non tanto soluzioni -impossibili e incredibili da parte di chi non detiene alcun potere concreto- quanto ipotesi di lotta per un popolo che manca, sia al momento di aggregazione politica e difesa dei propri diritti, sia al momento di costruzione estetica della propria narrazione come identità dialogante.
.

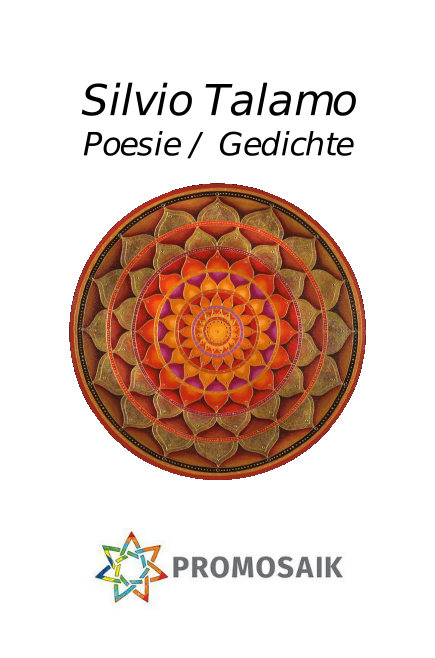













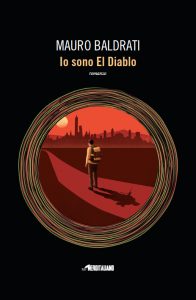


 «… devo riprendere dall’inizio? Quale inizio? Quando ho lasciato l’appartamento? È vero, se non avessi deciso di andarmene non sarei qui. Sembrava così semplice, cambiare casa, cambiare vita, semplice, vendere l’appartamento e via, d’un colpo tutto dietro le spalle. Ho deciso quest’inverno, un mattino, su due piedi. Faceva molto freddo, me lo ricordo perché avevo tirato fuori dalla canfora il pellicciotto, l’odore mi aveva dato nausea e ho pensato che mi sarei dovuta comprare un cappotto nuovo. Era un lunedì. Sono sicura. Perché era il giorno dopo, cioè il giorno prima era successa la cosa di Mathias. La data esatta? Non la sa? Una domenica d’inverno. Io, il lunedì mattina, quando mi sono guardata attorno, sono tornata indietro negli anni, quando siamo arrivate, la mamma e io, avevamo improvvisato una festicciola, sul terrazzo, noi due, in mezzo agli scatoloni, c’era un bel sole, le bibite si scaldavano e la crema delle pastine si scioglieva, ma le ho mangiate tutte, e ho bevuto l’aranciata, avevo sette anni e la mamma sembrava allegra. I gerani c’erano già, rosa e rossi, piantati in vasi di terracotta a bassorilievi, lungo due lati; le aiuole le ho fatte molti anni dopo, quando ne ho avuto bisogno. Glielo racconto poi, mi ascolti ora, è importante, quel lunedì mattina, quando ho deciso che non potevo più restare. Non pensavo al pericolo, non pensavo a niente, non volevo né nascondere né svelare, volevo solo andare via, per sempre. Facevo colazione in veranda e guardavo Mimì, dietro la vetrata, giocare con i gerani, grattare la terra. Frugava con le zampe e con il muso nelle ultime piantine, un ossicino è spuntato e un rigurgito di caffelatte mi ha dato un gusto acido in bocca: era ora di andarmene. Trentacinque anni in quell’appartamento, trentacinque anni in quel terrazzo, quindici anni da sola. Ho messo il pellicciotto che sapeva di canfora e sono scesa a comprare il giornale, però il giornalaio sotto casa era ancora chiuso per lutto, il figlio era morto la settimana prima, no, io non c’entro, un incidente stradale. Sono andata in piazza e non avevo i guanti né il cappello. Un dettaglio insignificante? No. Tutto quello che racconto ha un senso, almeno per me. Camminavo con le guance sferzate dal vento glaciale, con le mani livide sprofondate nelle tasche e sorridevo, sì, mi rallegravo del fatto che con quelle temperature avrei potuto rimandare il lavoro di giardinaggio. D’estate invece bisogna sbrigarsi, quando fa troppo caldo è dura. Estate come inverno comunque è un’operazione lunga che richiede applicazione. E una grande calma. La prima volta sporcai dappertutto, non pensavo che un corpo potesse contenere tanto sangue. E tanta carne, e viscere, budella, ossa, muscoli. Ci misi due giorni per tagliare, spezzare, triturare, bollire, gettare, sotterrare. La testa, la volli lasciare intera, tutta intera sotto un albero. Il terzo pino sulla destra, prima del ponte. Non c’è più? È passato tanto tempo! Forse era il quarto pino, forse dopo il ponte. Quella prima volta, fu una fatica, zoppa come sono, si immagini trascinare un bauletto. Il peggio è stato scavare. Dopo un’ora la cavità era ancora piccola e già avevo le mani coperte di piaghe e di vesciche, non ce la facevo più a tenere la pala, allora ficcai dentro le mani nude. Il buco a poco a poco si fece più profondo, abbastanza profondo. All’ospedale mi fecero tante domande. Piangevo, ma non per il dolore alle mani. Mio padre, mio amore, mio adorato, mio tutto, mio troppo, troppo amore, il primo uomo che ho amato, pazzamente, e non era bello, era vecchio ed era stanco. Appoggiavo la faccia sulla sua pancia rotonda, accarezzavo il pelo grigio del petto, e il mondo si esauriva in un’estasi infinita. Aveva la forza e l’ingegno di un animale selvatico, un odore aspro inebriante, le labbra tumide, le mani calde. Mi prendeva senza una parola, senza un bacio, il desiderio era il suo modo di amarmi. Forse. Avrei voluto essere piccola piccola e vivere dentro di lui. Mi mancava, sempre, crudelmente, anche quando c’era. Troppo amore, e lui aveva una moglie e due figli già grandi, e un lavoro importante, e sessant’anni, e io avevo lui, il gatto, i gerani e non ancora trent’anni. Quel lunedì mattina, mentre andavo in piazza a cercare il giornale, ho ripensato a Giovanni e ho pianto. Dovevo ucciderlo per non soffrire. Lei è una donna, mi capisce, vero? Ho pianto, ripensando al cuscino che lo soffocava nella letargia del sonnifero, poi mi sono calmata e mi è venuto in mente che dopo, quando sono riuscita a sistemare tutto, un po’ nei vasi un po’ altrove, a ripulire, a far tornare le cose e la casa nell’ordine che avevano avuto nei vent’anni passati con mamma, dopo, con le mani fasciate e la morte nel cuore, sono andata in un negozio specializzato e mi sono fatta spiegare come piantare le grandi aiuole lungo i bordi del terrazzo… »
«… devo riprendere dall’inizio? Quale inizio? Quando ho lasciato l’appartamento? È vero, se non avessi deciso di andarmene non sarei qui. Sembrava così semplice, cambiare casa, cambiare vita, semplice, vendere l’appartamento e via, d’un colpo tutto dietro le spalle. Ho deciso quest’inverno, un mattino, su due piedi. Faceva molto freddo, me lo ricordo perché avevo tirato fuori dalla canfora il pellicciotto, l’odore mi aveva dato nausea e ho pensato che mi sarei dovuta comprare un cappotto nuovo. Era un lunedì. Sono sicura. Perché era il giorno dopo, cioè il giorno prima era successa la cosa di Mathias. La data esatta? Non la sa? Una domenica d’inverno. Io, il lunedì mattina, quando mi sono guardata attorno, sono tornata indietro negli anni, quando siamo arrivate, la mamma e io, avevamo improvvisato una festicciola, sul terrazzo, noi due, in mezzo agli scatoloni, c’era un bel sole, le bibite si scaldavano e la crema delle pastine si scioglieva, ma le ho mangiate tutte, e ho bevuto l’aranciata, avevo sette anni e la mamma sembrava allegra. I gerani c’erano già, rosa e rossi, piantati in vasi di terracotta a bassorilievi, lungo due lati; le aiuole le ho fatte molti anni dopo, quando ne ho avuto bisogno. Glielo racconto poi, mi ascolti ora, è importante, quel lunedì mattina, quando ho deciso che non potevo più restare. Non pensavo al pericolo, non pensavo a niente, non volevo né nascondere né svelare, volevo solo andare via, per sempre. Facevo colazione in veranda e guardavo Mimì, dietro la vetrata, giocare con i gerani, grattare la terra. Frugava con le zampe e con il muso nelle ultime piantine, un ossicino è spuntato e un rigurgito di caffelatte mi ha dato un gusto acido in bocca: era ora di andarmene. Trentacinque anni in quell’appartamento, trentacinque anni in quel terrazzo, quindici anni da sola. Ho messo il pellicciotto che sapeva di canfora e sono scesa a comprare il giornale, però il giornalaio sotto casa era ancora chiuso per lutto, il figlio era morto la settimana prima, no, io non c’entro, un incidente stradale. Sono andata in piazza e non avevo i guanti né il cappello. Un dettaglio insignificante? No. Tutto quello che racconto ha un senso, almeno per me. Camminavo con le guance sferzate dal vento glaciale, con le mani livide sprofondate nelle tasche e sorridevo, sì, mi rallegravo del fatto che con quelle temperature avrei potuto rimandare il lavoro di giardinaggio. D’estate invece bisogna sbrigarsi, quando fa troppo caldo è dura. Estate come inverno comunque è un’operazione lunga che richiede applicazione. E una grande calma. La prima volta sporcai dappertutto, non pensavo che un corpo potesse contenere tanto sangue. E tanta carne, e viscere, budella, ossa, muscoli. Ci misi due giorni per tagliare, spezzare, triturare, bollire, gettare, sotterrare. La testa, la volli lasciare intera, tutta intera sotto un albero. Il terzo pino sulla destra, prima del ponte. Non c’è più? È passato tanto tempo! Forse era il quarto pino, forse dopo il ponte. Quella prima volta, fu una fatica, zoppa come sono, si immagini trascinare un bauletto. Il peggio è stato scavare. Dopo un’ora la cavità era ancora piccola e già avevo le mani coperte di piaghe e di vesciche, non ce la facevo più a tenere la pala, allora ficcai dentro le mani nude. Il buco a poco a poco si fece più profondo, abbastanza profondo. All’ospedale mi fecero tante domande. Piangevo, ma non per il dolore alle mani. Mio padre, mio amore, mio adorato, mio tutto, mio troppo, troppo amore, il primo uomo che ho amato, pazzamente, e non era bello, era vecchio ed era stanco. Appoggiavo la faccia sulla sua pancia rotonda, accarezzavo il pelo grigio del petto, e il mondo si esauriva in un’estasi infinita. Aveva la forza e l’ingegno di un animale selvatico, un odore aspro inebriante, le labbra tumide, le mani calde. Mi prendeva senza una parola, senza un bacio, il desiderio era il suo modo di amarmi. Forse. Avrei voluto essere piccola piccola e vivere dentro di lui. Mi mancava, sempre, crudelmente, anche quando c’era. Troppo amore, e lui aveva una moglie e due figli già grandi, e un lavoro importante, e sessant’anni, e io avevo lui, il gatto, i gerani e non ancora trent’anni. Quel lunedì mattina, mentre andavo in piazza a cercare il giornale, ho ripensato a Giovanni e ho pianto. Dovevo ucciderlo per non soffrire. Lei è una donna, mi capisce, vero? Ho pianto, ripensando al cuscino che lo soffocava nella letargia del sonnifero, poi mi sono calmata e mi è venuto in mente che dopo, quando sono riuscita a sistemare tutto, un po’ nei vasi un po’ altrove, a ripulire, a far tornare le cose e la casa nell’ordine che avevano avuto nei vent’anni passati con mamma, dopo, con le mani fasciate e la morte nel cuore, sono andata in un negozio specializzato e mi sono fatta spiegare come piantare le grandi aiuole lungo i bordi del terrazzo… »