
di Gaia Benzi
Siamo messi più o meno così: negli scorsi anni di fascismo si parlava come di una cosa morta e sepolta, l’antifascismo sembrava essere superfluo e fuori moda, e dominava la retorica degli “opposti estremismi”; oggi le imprese fascioxenofobe dei militanti di estrema destra hanno conquistato le prime pagine dei giornali, con un effetto cassa di risonanza che non si capisce quanto sia voluto, e quindi criminale, e quanto sia solo incosciente idiozia. Il dibattito pubblico è schiacciato sugli ultimi eventi, che si pretende abbiano impresso il segno del paradigma. Tutto sembra essere, come al solito, un’emergenza: l’emergenza democratica, l’emergenza fascista, la conseguente emergenza antifascista. E noi scivoliamo, ancora una volta, lungo la china politica e comunicativa che ci impone il carosello elettorale, e che ormai dovremmo conoscere bene.
Ma il neofascismo non è mai stato un’emergenza: è un fenomeno presente da anni e da anni denunciato, con costanza, da pochi. Trattarlo come tale rischia solo di dare vita ad analisi sbagliate che, se da un lato ingigantiscono il problema, dall’altro non arrivano a comprendere come e dove esattamente il neofascismo stia davvero mettendo radici. Siamo stati chiamati a prendere parte, e ci siamo riscoperti partigiani; ma per costruire argini alla barbarie, forse, la prima cosa da fare è proprio rifiutare la logica emergenziale di questa chiamata, non accontentarci più di rispondere agli stimoli esterni e iniziare ad elaborare, invece, strategie di lungo corso.
Parto da me e dalla mia esperienza, mettendo sul piatto qualche spunto di riflessione. Sono nata e cresciuta e attualmente vivo in uno dei quartieri apparentemente più neri di Roma, l’Appio Latino, scenario che ha fatto da sfondo alla famosa, lugubre e annuale sfilata commemorativa di Acca Larentia il 7 gennaio, con tanto di saluto romano a congedo. Quando esco dal portone sono circondata da svastiche e celtiche e scritte in fasciofont, prodotto delle sezioni dei vari partitucoli neofascisti della zona. E ogni giorno provo, in questo scenario di svastiche e celtiche, a fare politica insieme ad altre e altri, parlando di accoglienza, mutualismo e solidarietà. Forse come curriculum non è granché, ma un paio di cose mi sento di dirle.
Innanzitutto, ci tengo a dire che, persino nelle loro roccaforti, i fascisti veri e propri, cioè i militanti delle sezioni dei partitini fascisti, sono ancora pochi. Sempre troppi, certo, ma ancora pochi. I loro asset principali sono i soldi e il tempo da perdere, oltre a una notevole dose di fanatismo. Se oggi vediamo aumentare i loro simpatizzanti è perché da almeno dieci anni stanno investendo con ampiezza di mezzi principalmente in due settori: la legittimazione culturale, e il reclutamento dei giovani. Un lavorio costante, sottotraccia, che ha saputo fiutare il vento nero dell’Europa di questi anni e spera ora di cavalcarlo, cosciente che la destra, anche estrema, è elemento appetibile soprattutto per le nuove generazioni: l’unica facile alternativa di ribellione in un panorama dove ogni alternativa sembra aver cessato di esistere. Un decennio – o forse di più: un ventennio, un trentennio – in cui nel frattempo la sinistra istituzionale scompariva e quella di movimento veniva massacrata in tutti i modi possibili e immaginabili, e ridotta a un lumicino.
E così, mentre l’antifascismo era sempre meno attrattivo, sempre più appannaggio di gruppi ristretti “ancorati al passato”, e veniva delegittimato nel discorso pubblico, il fascismo diventava cool, e al giorno d’oggi può capitare di sentirsi dire da uomini e donne di sedicente sinistra (intellettuali, giornalisti, persino scrittori) che “questa cosa se la fanno i centri sociali non mi interessa, se la fa CasaPound sì”. Ormai il fascismo è “di moda”, come scrive giustamente Raimo su Internazionale.
Ma anche se apparentemente ripuliti, anche se ancora attualmente pochi, i fascisti restano comunque pericolosi. Non sto qui a fare l’elenco delle aggressioni degli ultimi anni, che fortunatamente sta circolando da giorni nella mediosfera italiana – e che ogni tanto sarebbe carino fosse ripreso pure dai giornalisti che ospitano questi “democratici figuri” nei loro studi. Mi limito, ancora una volta, a ciò che conosco, all’Appio Latino, dal quale partivano le macchine cariche di minorenni dirette verso i quartieri multietnici di Roma per i cosiddetti banglatour, veri e propri riti di iniziazione fascista. I banglatour sarebbero i pestaggi collettivi, avvenuti a partire dal 2013, di immigrati provenienti dal Bangladesh, individuati sulla base di criteri etnici, scelti in quanto poco robusti e poco inclini alla reazione fisica e alla denuncia. A dimostrazione del fatto che le aggressioni su base etnica non sono cosa recente, e anzi vanno avanti indisturbate da tempo: la punta di un iceberg fatto di intimidazioni quotidiane, in particolare tra le studentesse e gli studenti delle medie superiori, tra le straniere, i neri, le trans, i “diversi” di ogni sorta.
A un quadro siffatto va aggiunto il clima del paese, dove il lessico e la postura fasciste sono ormai sfacciatamente sdoganate, e la xenofobia è diventata senso comune. Un clima alimentato ad arte dai nostri governanti, che nel fomentare le destre e i loro argomenti trovano un facile espediente per deviare la rabbia sociale. Ed è in virtù di questo clima se ora i fascisti, noti vigliacchi, si sentono legittimati ad alzare la testa.
Un doppio binario che, pur con i suoi intrecci e la sua complessità, va tenuto ben presente da chi pratica l’antifascismo. Sorgono manifestazioni di protesta dopo anni di silenzio – e che si diffondano e si moltiplichino ogni giorno di più. Con la consapevolezza, però, che l’antifascismo tradizionalmente inteso come contrapposizione diretta e scontro frontale potrebbe non essere più sufficiente.
Me ne accorgo quando incontro le persone per strada, durante i banchetti o la distribuzione di volantini, e cerco di instaurare con loro un dialogo fatto in verità soprattutto d’ascolto. Ogni volta c’è chi si ferma a chiacchierare, a inveire, chi si lamenta, chi ti manda affanculo, ma comunque si finisce a parlare, e ogni volta mi rendo conto con rammarico che le parole d’ordine dell’antifascismo fanno riferimento a una tradizione politica che, per varie ragioni, non esiste più. Per questo anche le iniziative antifasciste all’apparenza più lodevoli e, diciamo così, “d’impatto”, se prive di un radicamento territoriale rischiano di essere percepite come “guerra tra bande”. E la contrapposizione sul piano chiamiamolo militare – di forza bruta, fatta di azioni che si concentrano principalmente sui partitini dichiaratamente fascisti, che vanno braccati e ostacolati e sfidati pubblicamente – risulta spesso incomprensibile nelle pratiche a una maggioranza silenziosa non fascista che pure potrebbe e dovrebbe essere inclusa nel discorso. Un antifascismo dal retrogusto machista, che rischia di essere indistinguibile a un occhio esterno.
In generale, il limite più grande sul quale sento di fare serena autocritica riguarda la natura stessa della risposta antifascista, che sempre più spesso si configura come rincorsa sui loro temi, presa di parola ex-post, viene cioè dopo qualcosa che i fascisti fanno, nel tentativo di recuperare il terreno perso mentre continuavamo a dividerci in micropartiti e aree politiche, indebolendo così le nostre stesse file. Tenendo a mente il doppio binario di cui sopra, e il fatto incontrovertibile che le manifestazioni prima o poi finiscono, e bisogna tornare a casa, mi sembra che oggi ci sia bisogno soprattutto di potenziare quei ragionamenti e quelle pratiche che si concentrano nell’attaccare il retroterra che gonfia le vele delle destre: ragionare, cioè, su come levare ai fascisti il terreno sotto i piedi.
Una volta ho sentito dire da un compagno molto più in gamba ed esperto di me che “se vuoi fare antifascismo nel quartiere, apri una palestra popolare”. Molte realtà nate dal basso riescono ad operare in contesti difficili (leggi: periferie abbandonate a se stesse, territori dell’estrema destra, territori di mafia) perché interpretano l’antifascismo su un piano sociale e culturale – che poi è lo stesso piano su cui stanno investendo loro. Le iniziative di piazza – e i pranzi meticci, gli incontri pubblici, le passeggiate della memoria, i forum partecipati, le assemblee aperte, e chi più ne ha più ne metta – hanno quasi sempre al centro i bisogni di chi abita il territorio in cui si svolgono, e aspirano a coinvolgere le persone normali, non politicizzate. L’obiettivo è quello, a partire dai problemi e dalle necessità comuni, di ribaltare il discorso delle destre, e individuare cause diverse da quelle propagandate solitamente (gli immigrati, ad esempio, come fonte di ogni male). In queste occasioni magari non ci si pone esplicitamente contro i fascisti, ma ci si batte per qualcos’altro, e si mettono in circolo anticorpi al fascismo dando spazio ad altri modi di vedere il mondo.
Soprattutto – e forse è questo l’aspetto più importante – sono momenti in cui si riprende parola apertamente e pubblicamente, e si fanno emergere le alternative al discorso culturale fascista o ur-fascista che già ci sono, esistono e operano quotidianamente. Alternative molto più presenti e diffuse delle strutture fasciste, e che a differenza di queste non trovano mai spazio sui mezzi d’informazione mainstream.
Sono un’intercapedine nel discorso pubblico razzista e frammentato, spesso allergico a qualunque proposta portata avanti su base identitaria di contrapposizione frontale al fascismo e alle destre. Sono tentativi di parlare alle persone e di far parlare le persone tra loro, costringendole a incontrarsi per strada, coinvolgendo anche chi crede che i migranti ci levino il lavoro e i soldi, chi pensa che siano un problema concreto, chi straparla di degrado e sicurezza ed è completamente imbevuto della retorica dominante – in una parola: chi non la pensa come noi. È una zona grigia dove ci si sporcano le mani spesso e volentieri, e pezzo dopo pezzo si prova a erodere, come la goccia che scava la roccia, il consenso culturale delle destre.
Credo che, di fronte ai recenti fatti, sia ancora più impellente la necessità di allargare il fronte dell’antifascismo ed elaborare nuove strategie per arginare la barbarie. È un lavoro ancora tutto da fare, e da estendere a quelle categorie – le studentesse e gli studenti, gli uomini e le donne immigrate – che oggi sono vittime privilegiate delle azioni fasciste, per strappare pezzo a pezzo, territorio dopo territorio, con un processo costante e capillare di ricostruzione del tessuto sociale, il terreno culturale imbevuto di solitudine, disagio e intolleranza in cui le destre e i fascisti scorrazzano indisturbati. Costruire, più che distruggere, sembra essere oggi la sfida dell’antifascismo.
PS: Nell’Appio Latino, quartier generale di Forza Nuova, ultimamente colonizzato anche da Blocco Studentesco – propaggine giovanile di Casa Pound, negli ultimi trent’anni la destra ha sempre perso le elezioni. Giusto per dire che le apparenze a volte ingannano, e i margini per costruire una resistenza alla barbarie ancora ci sono. Solo, non vanno sprecati.
*
Gaia Benzi è dottoressa di ricerca in Italianistica e attivista di Scup – Sport e Cultura Popolare. Ha scritto per Micromega, CheFare e Dinamopress.
[Foto: stella in onore del partigiano Paolo Morettini, situata sul Monte Tancia in Sabina, luogo della sua ultima battaglia.]
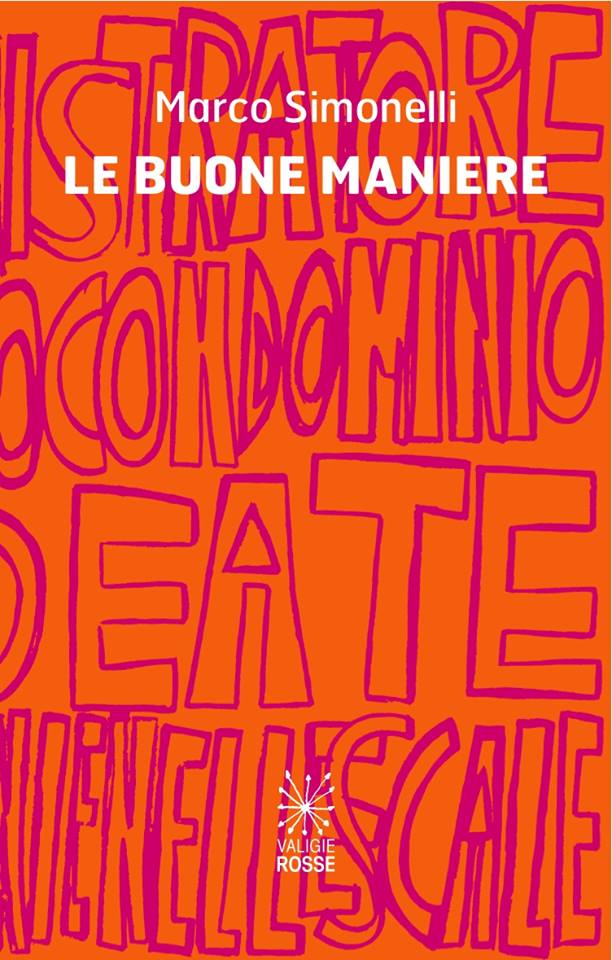





 Nota
Nota 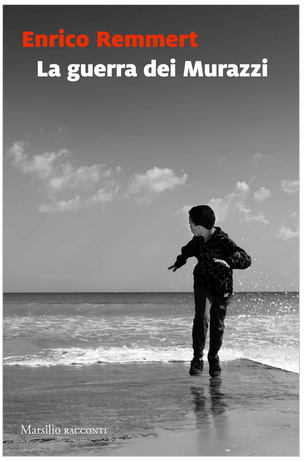 Questo si chiede Manu, barista di uno dei luoghi in cui si sta rifacendo la storia delle notti torinesi, protagonista del primo racconto, ma anche di quell’ incredibile epoca dei murazzi a Torino. Quello che non riusciamo a capire è se la ragazza questa domanda la stia facendo all’io narrante, al proprio creatore e dunque come ascoltatrice o a sé stessa. Certo è che la descrizione nelle prime pagine dello scontro tra hooligans e una banda di quartiere magrebina, superiore per numero ma non addestrata, ti coinvolge nella minuziosa descrizione del campo di battaglia- quei famosi controviali di Torino che nessun italiano al mondo potrà mai capire. E ti immedesimi a a tal punto in quella prospettiva, le due ragazze assistono da un balcone agli eventi, che la visuale da cui tutto si genera si sovrappone all’occhio del lettore come se si fosse dentro a una pagina dell’arte della guerra o di certe riproduzioni della battaglia di Waterloo che si possono vedere al Musée de l’Armée a Parigi. Non aveva forse scritto. Sun Tzu che “Fondamentale in tutte le guerre è lo stratagemma”? Senza voler qui rivelare i dettagli di ogni singola storia dove la trama è un semplice incidente di percorso nello svelamento del senso che il lettore compirà davvero solo alla lettura, quello che colpisce è la leggerezza con cui i giochi si fanno attraverso l’elemento tattico e dunque razionale, in tutte e quattro le storie. Se c’è una traccia che potrebbe servire nella comprensione dell’estetica di Remmert questa va sicuramente trovata tra le lezioni americane di Italo Calvino e in particolare la prima, dedicata alla leggerezza. Come non mettere in relazione infatti questa prima immagine degli hooligans, rapidi, impercettibili, con una delle ultime, l’annegamento nel Po davanti ai Murazzi di Abdellah? Come non scorgervi infatti l’opposizione tra leggerezza dei gesti e delle fughe nel primo, e pesantezza di un corpo che annega in mezzo a una festa in grado di annientare ogni residuo di razionalità, di umanità e permettere ai tanti testimoni di assistere alla morte di un uomo senza coglierne la gravità, il peso, appunto.
Questo si chiede Manu, barista di uno dei luoghi in cui si sta rifacendo la storia delle notti torinesi, protagonista del primo racconto, ma anche di quell’ incredibile epoca dei murazzi a Torino. Quello che non riusciamo a capire è se la ragazza questa domanda la stia facendo all’io narrante, al proprio creatore e dunque come ascoltatrice o a sé stessa. Certo è che la descrizione nelle prime pagine dello scontro tra hooligans e una banda di quartiere magrebina, superiore per numero ma non addestrata, ti coinvolge nella minuziosa descrizione del campo di battaglia- quei famosi controviali di Torino che nessun italiano al mondo potrà mai capire. E ti immedesimi a a tal punto in quella prospettiva, le due ragazze assistono da un balcone agli eventi, che la visuale da cui tutto si genera si sovrappone all’occhio del lettore come se si fosse dentro a una pagina dell’arte della guerra o di certe riproduzioni della battaglia di Waterloo che si possono vedere al Musée de l’Armée a Parigi. Non aveva forse scritto. Sun Tzu che “Fondamentale in tutte le guerre è lo stratagemma”? Senza voler qui rivelare i dettagli di ogni singola storia dove la trama è un semplice incidente di percorso nello svelamento del senso che il lettore compirà davvero solo alla lettura, quello che colpisce è la leggerezza con cui i giochi si fanno attraverso l’elemento tattico e dunque razionale, in tutte e quattro le storie. Se c’è una traccia che potrebbe servire nella comprensione dell’estetica di Remmert questa va sicuramente trovata tra le lezioni americane di Italo Calvino e in particolare la prima, dedicata alla leggerezza. Come non mettere in relazione infatti questa prima immagine degli hooligans, rapidi, impercettibili, con una delle ultime, l’annegamento nel Po davanti ai Murazzi di Abdellah? Come non scorgervi infatti l’opposizione tra leggerezza dei gesti e delle fughe nel primo, e pesantezza di un corpo che annega in mezzo a una festa in grado di annientare ogni residuo di razionalità, di umanità e permettere ai tanti testimoni di assistere alla morte di un uomo senza coglierne la gravità, il peso, appunto.


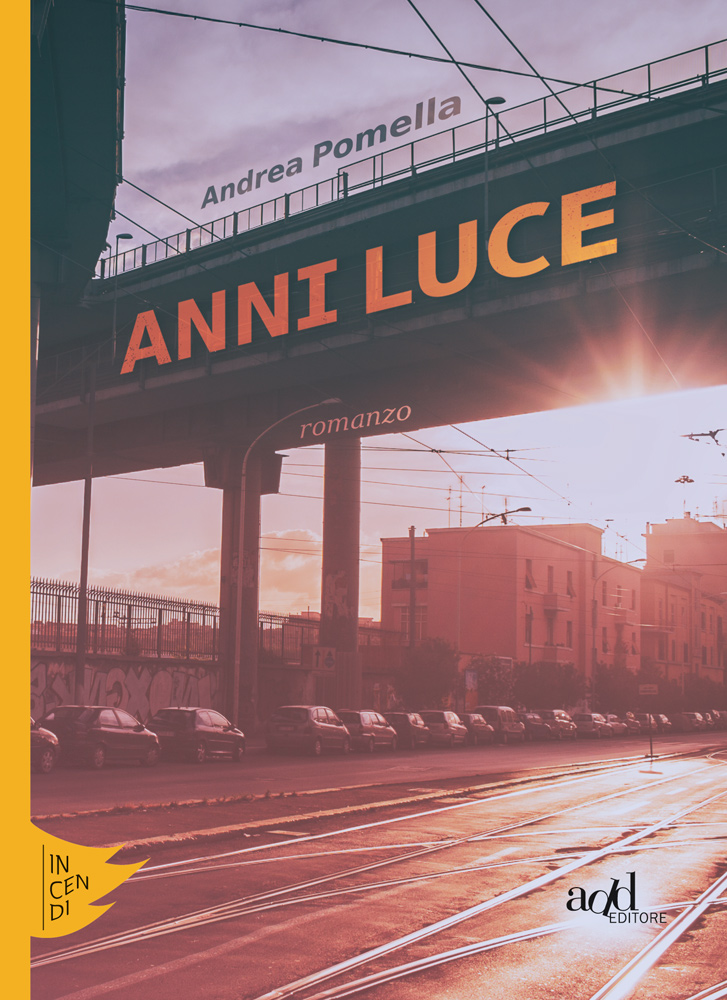
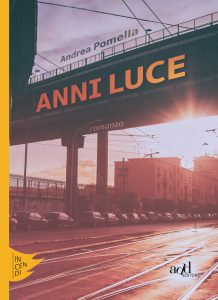 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta



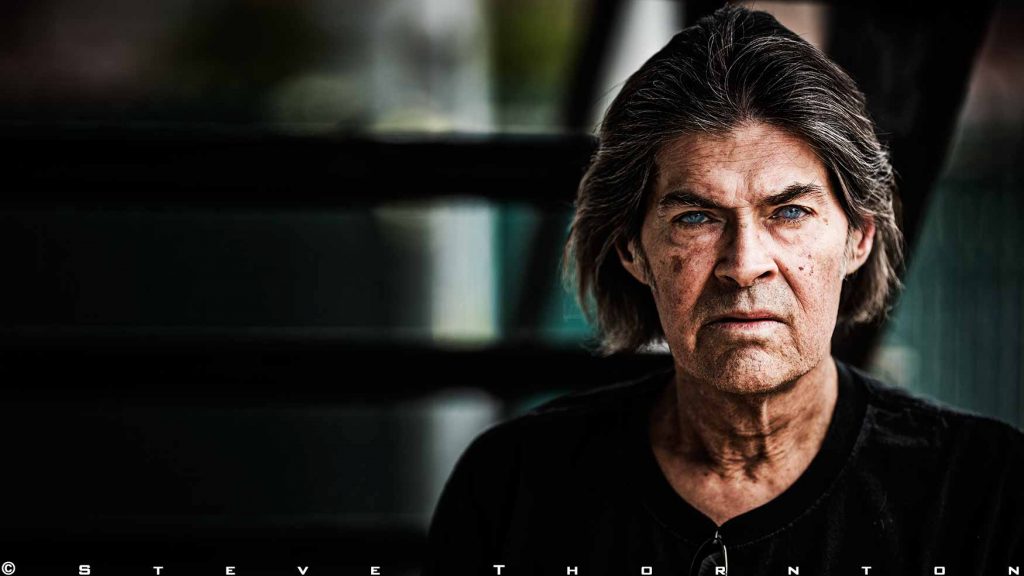




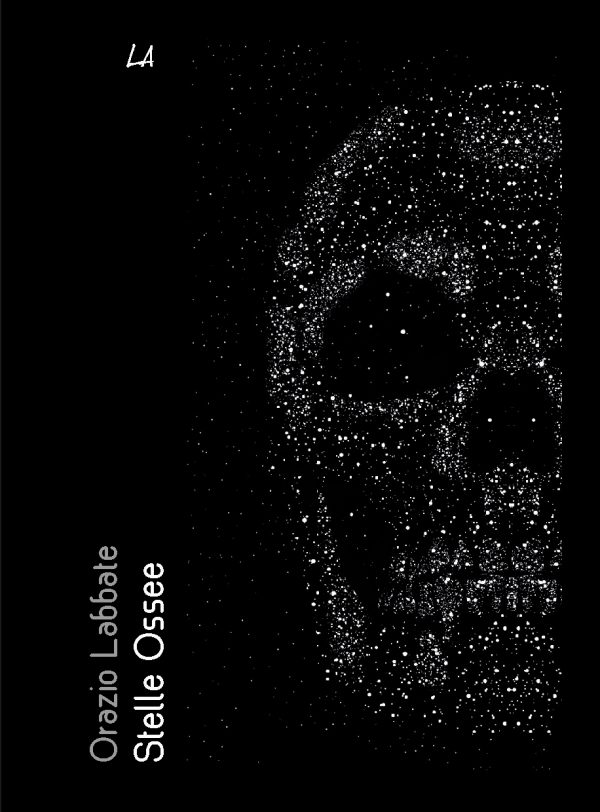


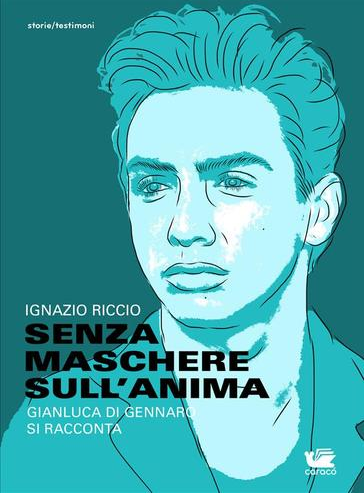 di
di La storia di Gianluca Di Gennaro però non è solo la storia di un giovane attore che riesce a “cogliere” il momento giusto, a giocarsi le sue chance, il debutto a quattordici anni in
La storia di Gianluca Di Gennaro però non è solo la storia di un giovane attore che riesce a “cogliere” il momento giusto, a giocarsi le sue chance, il debutto a quattordici anni in