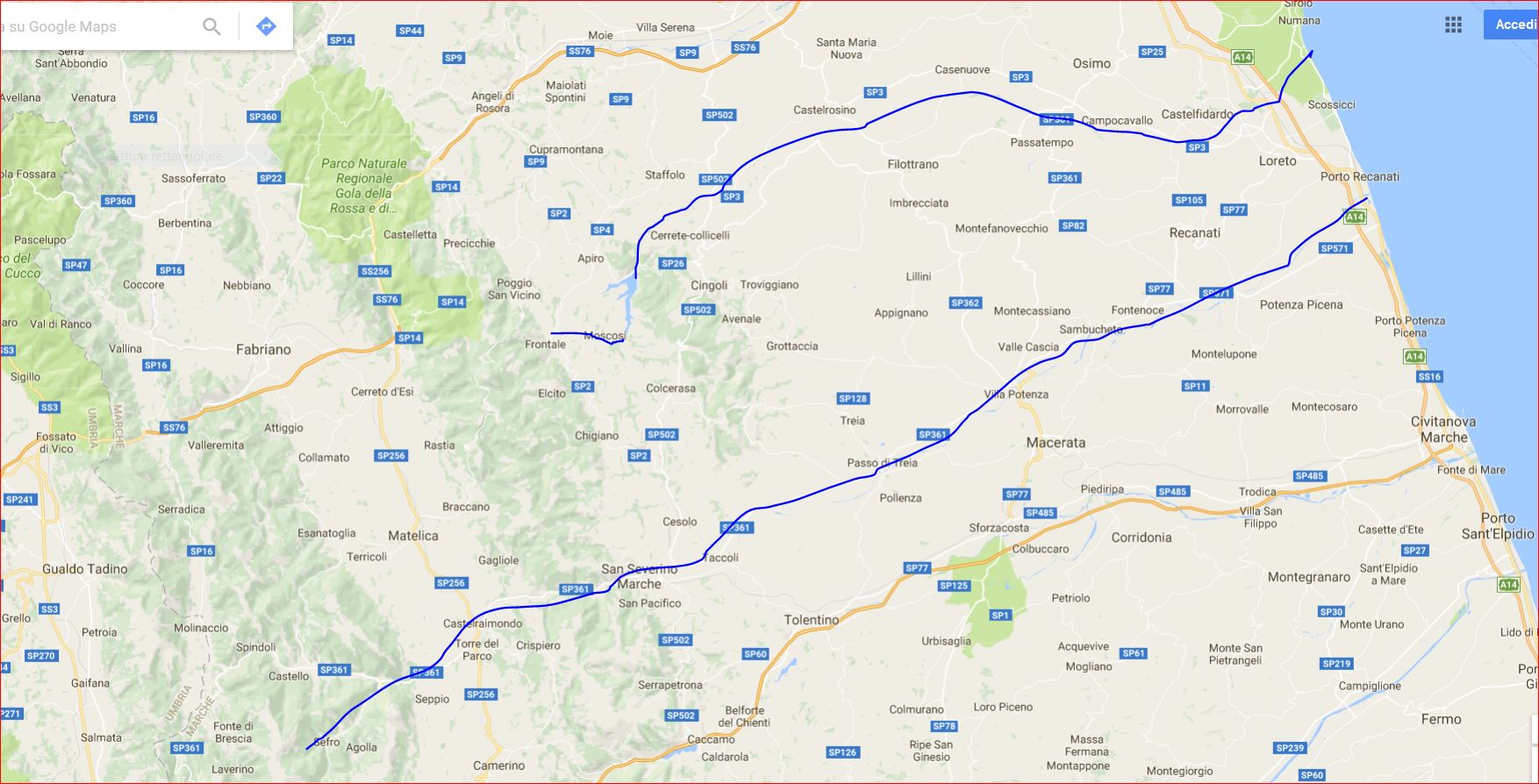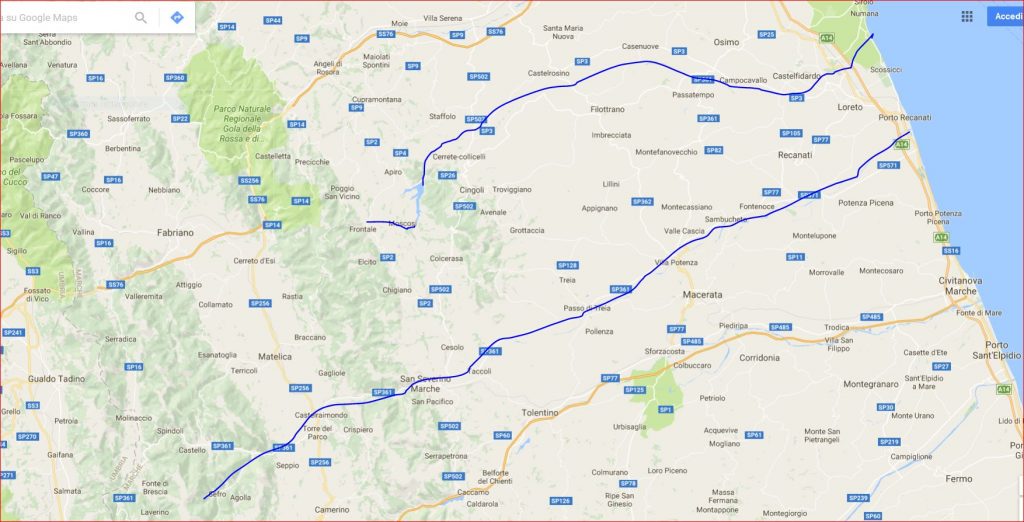di Francesca Matteoni
Questo articolo è apparso lunedì 11 ottobre sul quotidiano online ReportPistoia, a cui si deve il titolo, che mi sembra appropriato. Lo rilancio su Nazione Indiana perché penso che possa essere utile a chiunque sia interessato al volontariato culturale, specialmente negli spazi Arci, sempre più in abbandono. Ho aggiunto link a eventi e blog locali per ulteriori informazioni – il link cui rimando per la Casa in Piazzetta è in realtà un archivio blog di un laboratorio tenutosi lì nel 2014 (fm).
Dopo i recenti fatti che hanno messo il Circolo delle Fornaci sotto riflettori di cui si farebbe volentieri a meno, ho pensato che era il momento di raccontare un’esperienza diversa in quel luogo di cui sono stata parte attiva. Ho pensato, soprattutto, che in un lungo periodo di crisi dell’Arci, che difetta riguardo l’offerta culturale e il dibattito politico, serve più che mai il racconto, perché i fatti non parlano da soli: anzi, se lasciate soli, cadono nell’oblio. No, non è ammissibile che Casa Pound provocatoriamente pretenda di fare raccolte di beneficenza in un luogo fondante della sinistra sociale. Non è nemmeno corretto etichettare tutta la beneficenza come buona: buono è ciò che aiuta l’emancipazione dalla povertà di ogni tipo – economica, spirituale, intellettuale; buona è la ricerca del benessere di tutti, aldilà di etnia, credo, classe, non ciò che crea dipendenza verso un gruppo ideologico che avversa concetti di uguaglianza, rimarca assurdi confini identitari e preferisce la paura alla conoscenza. Ma quando i luoghi restano vuoti e le formule non corrispondono alle pratiche reali, il minimo che può succedere è che altri subentrino, sostituendo i loro scopi ai valori che dovrebbero resistere oltre personalismi e lotte di potere. Sono cresciuta a un campo di distanza da dove sorge l’attuale circolo delle Fornaci. Allora c’era una pista irregolare di pattinaggio e una struttura messa su alla meglio per le iniziative estive del circolo, che si trovava in Via di Sant’Alessio. Una catapecchia in confronto all’edificio moderno che vediamo oggi, eppure quella catapecchia era piena di vita e si animava ancora di più durante la Festa dell’Unità, mentre le sale dell’attuale circolo fanno un po’ tristezza al confronto. Ho passato le estati dall’infanzia all’adolescenza in quella pista, a litigare, fare comunella, a rifugiarmi sotto la fornace per starmene in pace fra le sterpaglie e il casottino dei pattini di Tiberio, Artemio Balli, il presidente della società di pattinaggio. Sono diventata più o meno adulta, ho lavorato e studiato all’estero, sono tornata. E al mio ritorno c’era il circolo fresco di inaugurazione.

Nell’autunno del 2013 ho iniziato a proporre iniziative, per poi entrare nel consiglio qualche mese dopo: era novembre ed eravamo reduci da una delle tragedie in mare che aveva colpito i profughi a Lampedusa. L’assessore alla sanità dell’isola aveva lanciato un appello per una raccolta fondi e pensai che potevamo raccoglierlo, con un concerto di solidarietà. C’era da una parte da rispondere a un’emergenza vera; dall’altra da fare musica – e se nei circoli non si fanno suonare i ragazzi, si contribuisce a togliere loro spazi, a rendere l’aria cattiva, a fermare quel meraviglioso senso di libertà e sovversione che vive nelle migliori esperienze musicali. Il punk rock è libertà, citando Kurt Cobain. I ragazzi devono poter suonare, anche stonando, andando fuori tempo, trovando il loro tempo. All’evento parteciparono vari gruppi – rap, punk, dream pop, rock. Tantissima gente. Iniziò la collaborazione con Lorenzo Fedi, il giovane fonico dell’Arci, che al circolo Garibaldi organizzava concerti, intercettando gruppi italiani ed europei e dando voce ai giovanissimi della provincia, molti dei quali frequentavano la sala prove della Casa in Piazzetta. Grazie all’aiuto di Lorenzo abbiamo dato vita a concerti, ospitando emergenti, gruppi di varia provenienza, perfino parigini, esperimenti giovanili, animando serate, pomeriggi e nel gennaio 2015 la Notte Rossa dell’Arci alle Fornaci.
Era bello ed era vero – esisteva un filo connettore con il Circolo Garibaldi e Casa in Piazzetta, memori che le Fornaci erano già la scena di un importante evento sociale legato alla musica: lo S’concerto di Quartiere, esperienza decennale di radicamento sul territorio e spazio per le espressioni giovanili. Poi, convinta che volere è potere, ho ideato alle Fornaci un festival di poesie, “Perché tale è la mia natura”, fratello minore del festival L’importanza di essere piccoli, promosso dall’Associazione Arci Sassiscritti di Porretta Terme, che da anni porta poeti e cantautori nei borghi dell’Appennino emiliano e che tra il 2014 e il 2017, durante la scorsa amministrazione, ha coinvolto anche il comune di Pistoia. Poeti di caratura nazionale, autofinanziamento, interazione con operatori e artisti locali. Quando dissi che volevo fare un festival di poesia alle Fornaci, qualcuno sgranò gli occhi, come se fossi pazza. Ma questo accade perché da una parte spesso la gente ignora che l’anima della poesia non è roba da salotto: sta nei margini, si nutre del contatto con il molteplice e il diverso; dall’altra ha un pregiudizio sciocco verso questo quartiere e dimentica che l’unico modo per cambiare le cose è osare avere una visione. Tantissimo lavoro e bellezza e, in negativo, molta solitudine nel fare. L’anno dopo il festival ha avuto la sua seconda edizione in due diversi momenti: uno primaverile gestito dai ragazzi di Piazzetta e aperto agli adolescenti con le loro poesie e la loro musica; e quello estivo, per cui grazie all’interessamento di Arci provinciale e la mediazione di alcuni del consiglio, arrivò anche un finanziamento per coprire le spese.

Ad aggiungere impegno a maggio il circolo aveva ospitato la festa annuale di Nazione Indiana, realtà intellettuale della rete, il più antico dei blog letterari della cui redazione faccio parte, insieme a scrittori e poeti del nostro panorama. Incontri sull’educazione di genere, sull’Islam, sui libri di recente pubblicazione dal fumetto al reportage, al cinema e al video, coinvolgendo educatori e operatori del territorio come l’insegnante Pina Caporaso e Michele Galardini, direttore del festival Presente Italiano e attivo al circolo con un programma di cineforum. Ero tuttavia stanca e abbandonata a me stessa – non riuscivo più a reggere tutto da sola. Così dopo il festival me ne sono venuta via, salutando un’ultima buona iniziativa del Circolo – una festa Arcobaleno realizzata insieme ad Arcigay di Pistoia. Era il 2015 e io già mi stavo impegnando per il paese dove risiedo, Santomoro, collaborando con il Centro Sociale di cui ora sono la presidente. Venendo via ho portato con me alcune cose, adattandole e migliorandole: Zucche Vuote! i laboratori per bambini di Halloween, diventati qui una piccola tradizione; e la poesia, che si è trasformata in esperienza laboratoriale e itinerante nella Valle delle Buri, con il progetto Il Viaggio dell’Eroe. La musica è rimasta indietro, con mio grande rammarico: si agisce a seconda dello spazio in cui siamo, delle esigenze del territorio in cui ci muoviamo – cose che imparo quotidianamente in questo paese alle pendici dell’Appennino. Cosa mi resta? Amici, esperienza, il valore dell’impegno. E cosa vuol dire tutto questo? Prima di tutto che spesso c’è un modo errato di intendere il volontariato sociale. Questo significa seguire e attuare un immaginario vivo e sociale, non donare semplicemente un po’ del proprio tempo, ma far sì che ci sia posto per le idee, mettendosi in discussione perché sappiamo che il risultato sarà gratificante, che la gioia sta nel condividere. Secondo, che nei circoli non basta mettere vagamente a disposizione delle stanze. Bisogna accompagnare chi viene, servono figure di bravi mediatori, che creino legami con il mondo urbano, riconoscendo “chi ci è” da “chi ci fa”. Queste sono responsabilità precise che chiunque voglia attivarsi nell’Arci dovrebbe considerare: volontariato non significa fare alla meno, significa che c’è qualcosa che conta più dello stipendio nella nostra scala di valori e per cui, magari, lo stipendio è funzionale. Significa offrire luoghi per la diversità di espressione e comportarsi da buon ospite quando qualcuno arriva: farlo sentire a casa. Perché questo erano, talvolta ancora sono, i circoli: le case di tutti, la Casa del Popolo. Una casa dove la sinistra dovrebbe mostrare la sua faccia migliore e comunitaria. Le case se non si curano crollano. Le porte non vanno soltanto aperte – bisogna uscire a cercare l’altro, sempre, come scriveva il poeta Hölderlin, e infine invitarlo, lasciarlo entrare.



 [Di seguito, un estratto del romanzo “Il perturbante”, Autori riuniti 2017, finalista e menzione speciale al Premio Calvino 2016]
[Di seguito, un estratto del romanzo “Il perturbante”, Autori riuniti 2017, finalista e menzione speciale al Premio Calvino 2016]
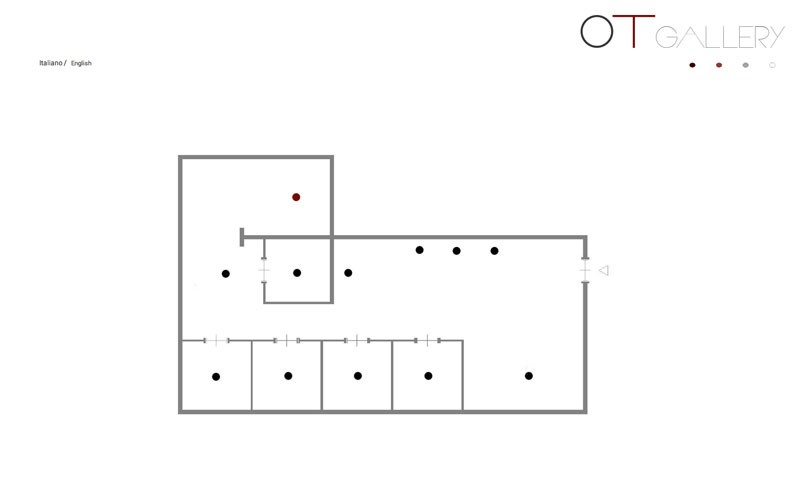
 Di seguito, un racconto sul sesso, le aspettative e le prime volte.
Di seguito, un racconto sul sesso, le aspettative e le prime volte.


 Scrivendo di sé nei sei mesi che aveva impiegato per terminare il suo breve libro di centocinquantasette pagine Ferguson si era ritrovato dentro un nuovo rapporto con se stesso. Sentiva un legame più intimo con i suoi sentimenti e allo stesso tempo si sentiva più lontano, quasi distaccato, indifferente, come se durante la stesura del libro fosse diventato paradossalmente una persona più calda e più fredda, più calda perché si era aperto e aveva mostrato le sue viscere al mondo, più fredda perché poteva guardare quelle viscere come se appartenessero a un altro, un estraneo, uno senza nome, e non sapeva dire se quella nuova relazione col suo io di scrittore fosse positiva o negativa, migliore o peggiore. Sapeva solo che il libro lo aveva sfinito, e non era sicuro che gli sarebbe tornato il coraggio di parlare di sé.
Scrivendo di sé nei sei mesi che aveva impiegato per terminare il suo breve libro di centocinquantasette pagine Ferguson si era ritrovato dentro un nuovo rapporto con se stesso. Sentiva un legame più intimo con i suoi sentimenti e allo stesso tempo si sentiva più lontano, quasi distaccato, indifferente, come se durante la stesura del libro fosse diventato paradossalmente una persona più calda e più fredda, più calda perché si era aperto e aveva mostrato le sue viscere al mondo, più fredda perché poteva guardare quelle viscere come se appartenessero a un altro, un estraneo, uno senza nome, e non sapeva dire se quella nuova relazione col suo io di scrittore fosse positiva o negativa, migliore o peggiore. Sapeva solo che il libro lo aveva sfinito, e non era sicuro che gli sarebbe tornato il coraggio di parlare di sé.  lta, lei, entrando in bagno, l’aveva trovato dentro. Non aveva bussato, né si era sincerata in altro modo se ci fosse qualcuno. Ma adesso lui era davanti a lei, seduto sulla tazza, i jeans e le mutande alle ginocchia. Non che ci fosse niente di male o che non fosse capitato altre volte. I due erano parecchio intimi, avevano passato ore a perlustrare l’uno i pori dell’altra, i difetti fisici e le irregolarità corporali non erano più tabù, in alcune occasioni potevano toccare quegli argomenti senza provocare ferite o ritorsioni. Eppure, trovarsi così, sotto lo sguardo di lei, mentre era concentrato sui propri intestini – il viso contratto e gli occhi persi sulle mattonelle – lo aveva messo pazzescamente a disagio, come se lei fosse entrata in una sfera di verità assoluta, la sfera in cui lui si conservava vero ma per se stesso, dove lei non avrebbe mai dovuto mettere piede.
lta, lei, entrando in bagno, l’aveva trovato dentro. Non aveva bussato, né si era sincerata in altro modo se ci fosse qualcuno. Ma adesso lui era davanti a lei, seduto sulla tazza, i jeans e le mutande alle ginocchia. Non che ci fosse niente di male o che non fosse capitato altre volte. I due erano parecchio intimi, avevano passato ore a perlustrare l’uno i pori dell’altra, i difetti fisici e le irregolarità corporali non erano più tabù, in alcune occasioni potevano toccare quegli argomenti senza provocare ferite o ritorsioni. Eppure, trovarsi così, sotto lo sguardo di lei, mentre era concentrato sui propri intestini – il viso contratto e gli occhi persi sulle mattonelle – lo aveva messo pazzescamente a disagio, come se lei fosse entrata in una sfera di verità assoluta, la sfera in cui lui si conservava vero ma per se stesso, dove lei non avrebbe mai dovuto mettere piede.







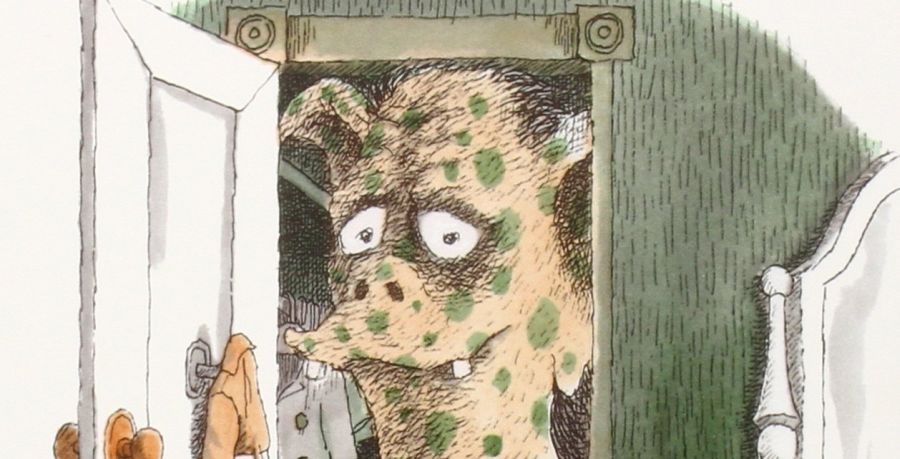
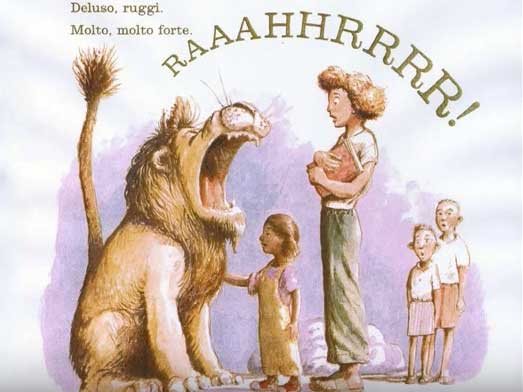




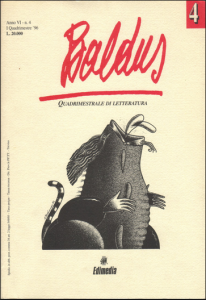 A proposito di Nazione Indiana tra noi redattori si è sempre detto che quella che a molti appariva come una debolezza- la mancanza di una gerarchia redazionale, di una parola d’ordine diktat condivisa da tutti, un’estetica e un pensiero unici e trionfanti – e perché no anche un po’ tronfi- costituiva il punto più saldo e solido, insieme alla stima e all’amicizia che hanno reso il nostro sito longevo e vivace. Eppure uno degli elementi che ci accomuna va a mio avviso identificato in quella parola di cui si diceva all’inizio: le riviste. La maggior parte di noi si è formato sulle riviste e per alcuni addirittura nelle stesse, come è stato prima il caso di Baldus, poi Paso Doble, Sud, Alfabeta e l’Atelier du Roman. L’elenco va chiaramente completato ed è proprio questo che chiederò agli altri collaboratori o lettori di Nazione Indiana: segnalate nei commenti la rivista in cui vi siete formati. Ma formati a cosa? ci si potrebbe chiedere. A stare con gli altri? A crescere insieme? A farsi le ossa? A scoprire da subito che la qualità letteraria non va affatto a braccetto con “l’argent”? Che non si è pagati per fare cultura ma appagati dal desiderio di farne parte? Che il conflitto può essere foriero di scoperte e non solo di spaccature? O più semplicemente si impara con le riviste che le cose possono finire e ricominciare, che nulla è più duraturo dell’effimero.
A proposito di Nazione Indiana tra noi redattori si è sempre detto che quella che a molti appariva come una debolezza- la mancanza di una gerarchia redazionale, di una parola d’ordine diktat condivisa da tutti, un’estetica e un pensiero unici e trionfanti – e perché no anche un po’ tronfi- costituiva il punto più saldo e solido, insieme alla stima e all’amicizia che hanno reso il nostro sito longevo e vivace. Eppure uno degli elementi che ci accomuna va a mio avviso identificato in quella parola di cui si diceva all’inizio: le riviste. La maggior parte di noi si è formato sulle riviste e per alcuni addirittura nelle stesse, come è stato prima il caso di Baldus, poi Paso Doble, Sud, Alfabeta e l’Atelier du Roman. L’elenco va chiaramente completato ed è proprio questo che chiederò agli altri collaboratori o lettori di Nazione Indiana: segnalate nei commenti la rivista in cui vi siete formati. Ma formati a cosa? ci si potrebbe chiedere. A stare con gli altri? A crescere insieme? A farsi le ossa? A scoprire da subito che la qualità letteraria non va affatto a braccetto con “l’argent”? Che non si è pagati per fare cultura ma appagati dal desiderio di farne parte? Che il conflitto può essere foriero di scoperte e non solo di spaccature? O più semplicemente si impara con le riviste che le cose possono finire e ricominciare, che nulla è più duraturo dell’effimero. Ma tornando da dove eravamo partiti, ovvero dalle dodici bellissime gambe, una cosa mi ha sempre incuriosito, come strani misteri che ci si porta dietro dall’adolescenza ed è il fatto che un numero di avanspettacolo e quello di un dossier monografico portassero lo stesso nome: rivista!! La risposta è semplice. Entrambe portano lo stesso nome perché le caratterizza la periodicità, il suo ripetersi almeno nella cornice che ospita contenuti diversi. In realtà anche altro, ancora più essenziale, unisce queste due rappresentazioni, ed è il loro mettere insieme generi diversi, gusti differenti, proponendo una mescla di alto e basso, elitario e popolare. Avanspettacolo e avanguardia hanno calcato per decenni lo stesso palco a cominciare dalla grande lezione di Tzara e Compagni, inventori di quel Cabaret Voltaire a cui è ispirato il titolo delle nostra serata. Ci saranno performance, musica improvvisata, reading, convivialità, conversations, preferendo questo termine, civile, a quello di dibattito generalmente stantio come l’acqua nelle caraffe posate sul tavolo dei relatori. Le feste di Nazione Indiana sono state e saranno questo. A Fano faremo come a Milano, Mesagne, Pistoia, Torino, Parigi, Fos’di Novo, Bolzano, dunque non mancate.
Ma tornando da dove eravamo partiti, ovvero dalle dodici bellissime gambe, una cosa mi ha sempre incuriosito, come strani misteri che ci si porta dietro dall’adolescenza ed è il fatto che un numero di avanspettacolo e quello di un dossier monografico portassero lo stesso nome: rivista!! La risposta è semplice. Entrambe portano lo stesso nome perché le caratterizza la periodicità, il suo ripetersi almeno nella cornice che ospita contenuti diversi. In realtà anche altro, ancora più essenziale, unisce queste due rappresentazioni, ed è il loro mettere insieme generi diversi, gusti differenti, proponendo una mescla di alto e basso, elitario e popolare. Avanspettacolo e avanguardia hanno calcato per decenni lo stesso palco a cominciare dalla grande lezione di Tzara e Compagni, inventori di quel Cabaret Voltaire a cui è ispirato il titolo delle nostra serata. Ci saranno performance, musica improvvisata, reading, convivialità, conversations, preferendo questo termine, civile, a quello di dibattito generalmente stantio come l’acqua nelle caraffe posate sul tavolo dei relatori. Le feste di Nazione Indiana sono state e saranno questo. A Fano faremo come a Milano, Mesagne, Pistoia, Torino, Parigi, Fos’di Novo, Bolzano, dunque non mancate.