di Giacomo Sartori
ma dove vai
con quei passetti
cosa sgambetti
ancora ti alleni
con gravità di atleta
su e giù per il giardino
bimbina vecchia
(quasi un secolo
fascismo compreso!)
di Giacomo Sartori
ma dove vai
con quei passetti
cosa sgambetti
ancora ti alleni
con gravità di atleta
su e giù per il giardino
bimbina vecchia
(quasi un secolo
fascismo compreso!)

La Luna, forse
di
Maria Luisa Putti
C’è sabbia dappertutto. Negli occhi che appena riesco ad aprire, sulla pelle del viso. La sabbia è roccia che si sgretola. Pesa sul mio corpo sepolto, scricchiola sotto i denti. I capelli sciolti intrappolati nella terra mi tengono ancorata, immobile. Non mi posso alzare. Non posso liberare null’altro che i pensieri dalla duna bianca che mi avvolge. Sono sulla Luna forse, e attorno a me non c’è che uno spazio vuoto; organismi primordiali a cui ora assomiglio. Con le dita provo a scavare un tunnel. Non ho mai sopportato la sabbia sotto le unghie, nemmeno quand’ero bambina e mia madre mi lasciava giocare sulla riva: «Fai un bel castello!», mi diceva. Ed io me ne stavo lì, con il mio cappellino turchese – uno di quei cappelli da marinaio – e i secchielli di plastica pieni d’acqua, per liberare le mani dall’arsura della materia inerte che si essiccava al sole. Mi mancava l’aria, come adesso, che non so dove sono. Guardavo le conchiglie, gusci vuoti, saturi di polvere d’oro, e immaginavo che nascondessero labirinti segreti, stanze abitate dalle fate; minuscole bambine vestite di bianco, che si rincorrevano fino al mare. Avrei voluto tenerle sul palmo della mia mano, e pettinarle, come facevo con le bambole. Mi sembrava di sentire le loro vocine, il fruscio delle vesti che le coprivano fino alle caviglie, ai piedi.
Sì, i piedi. Li avverto ora come corpi estranei, divorati da milioni di microscopici insetti, lucertole, piccoli rettili e animali preistorici che credevo estinti. E le gambe: la sabbia le ha inghiottite fino a lasciarne solo il ghiaccio delle ossa vuote.
Il tunnel che ho scavato con le dita non basta a liberarmi le braccia dalla morsa che mi stringe. Mi sembra di sprofondare ancora più giù, come se le mie mani avessero aperto un varco sotterraneo che affaccia sull’abisso. Un mulinello d’aria di correnti sconosciute lambisce i miei fianchi. Ho freddo. D’un tratto, quasi animata da una forza estranea – o forse è solo l’istinto di sopravvivere – riesco a far leva sui gomiti e sento che una delle mie spalle è quasi fuori. Finalmente posso muovere il collo. Ecco, così. Ora anche l’altra spalla è libera. Mi faccio forza con i palmi delle mani sulla sabbia che mi circonda, emergo fino alla vita, e sento i granelli sottili muoversi sotto di me, lungo le gambe, sui piedi, tra le dita formicolanti e fredde, come filtrati dal foro sottile di una clessidra.
Posso respirare ora, un respiro profondo che odora di fiori, dei pollini dolci di aprile che riempiono l’aria da un finestrino abbassato, di un’auto ferma al rosso di un semaforo o nello slargo verde della strada che costeggia le mura, dove mi fermavo con le amiche a chiacchierare dei nostri segreti di ragazze.
Attorno a me le piccole creature primordiali si muovono operose in cerca di cibo. Raccolgono frammenti di alghe essiccate, petali, foglie, minuscole bacche colorate che sembrano le bocce di un biliardo, o le biglie che mi piacevano tanto quando ero bambina: le infilavo una ad una attraverso il collo di una bottiglia, fino a riempirla tutta quanta, e dopo cercavo di farle uscire, con le dita, per giocarci ancora. Una bacca celeste scivola sulla sabbia, ed io me la ritrovo in mano. D’un tratto dinanzi ai miei occhi le luci delle macchine abbagliano i miei ricordi: una bellissima ragazza bionda fa rotolare e saltare e scomparire e poi ricomparire ancora una pallina dello stesso colore. Dopo si avvicina ai finestrini per chiedere qualche spicciolo; ha gli occhi scuri, e porta un paio di occhialetti tondi da ragazzina delle scuole medie. Sorride, come se il suo lavoro di giocoliera nel traffico delle ore di punta bastasse a farla felice: è felice, è in vacanza, è a Roma!
Su un ramo che sporge dalle pareti di roccia a picco sulle dune c’è un alveare, lo vedo da lontano, lucente d’oro come il becco lungo degli uccelli che planano sulla riva. Le piccole bambine vestite di bianco si tengono per mano, come perline di una collana, una accanto all’altra, e adesso le sento cantare. Camminano tutte insieme, con i capelli sciolti, e le risate piccole dei loro giochi infantili. E loro giocano, e giocano, arrampicandosi sul dorso di animali giganteschi, gusci di tartarughe dalle strane teste, esseri preistorici impastati di sabbia, che si muovono lenti come il respiro di questo vento immobile. Senza paura, si avventurano nelle fauci aperte da uno sbadiglio torrido di un sonno antico. E tenendosi saldamente l’un l’altra per mano, come in un gioco di contrappesi, si lasciano pendere dall’alto di un’ala aperta in volo, catenella sottile di innocenza.

Guardare quelle creature minuscole mi porta lontano da me stessa, dal luogo in cui mi trovo ora, intrappolata, sepolta per metà in un mare di sabbia, la sabbia del tempo che mi fa prigioniera, che mi scorre accanto, lasciandosi sprecare nel suo fluire indifferente. Non contano gli orologi scolpiti nei fianchi ripidi delle montagne: le loro lancette giocano a rincorrersi, un minuto dietro l’altro, un’ora dietro l’altra, all’infinito. Le guardo senza più pensare che il tempo è la materia della vita, che plasma e disegna tutto attorno a sé, mutando le forme di ogni cosa. Me ne sto qui, ancora sepolta in questo paesaggio lunare, in questo mare che inciampa nelle sue stesse onde. È un lungo clacson che suona ininterrotto di auto incolonnate in disordine.
Una donna anziana attraversa la strada e porta per mano un bambino. I capelli grigi sciolti sulle spalle in una piega morbida, i vestiti colorati sul corpo sottile, l’azzurro della sciarpa, la fantasia lucente della giacca. Si volta verso il mare di macchine ferme; scatta il semaforo ma nessuno riparte, come se ogni cosa, gli appuntamenti, gli impegni, il ritardo, la fretta di correre chissà dove si fossero d’un tratto dissolti, al di là del tempo, che improvvisamente rallenta, e rallenta, fino a svanire: tutti guardano lei, il suo passo lieve, il suo essere ancora, sempre, bellissima.
di Giacomo Verri
In Metropoli, il nuovo romanzo di Massimiliano Santarossa, il racconto del futuro.
 Nel duemilatrentacinque la Terra potrà riconoscere sulla propria groppa una sola enorme città: Metropoli. Sarà essa il solo ganglio della poststoria, il solo confine alle lande desolate che s’apriranno maestose quando tutto sarà azzerato, quando nel cielo, perpetuamente crollante di piogge, starà crocefisso, come una misera “palla incolore”, “il sole artico del mondo pietrificato”.
Nel duemilatrentacinque la Terra potrà riconoscere sulla propria groppa una sola enorme città: Metropoli. Sarà essa il solo ganglio della poststoria, il solo confine alle lande desolate che s’apriranno maestose quando tutto sarà azzerato, quando nel cielo, perpetuamente crollante di piogge, starà crocefisso, come una misera “palla incolore”, “il sole artico del mondo pietrificato”.
Metropoli, mostruosa tromba apocalittica cantata da Massimiliano Santarossa (che ora torna in libreria per Baldini e Castoldi, dopo l’agghiacciante Il Male del 2013), è una città, calvinianamente cresciuta nelle menti di ognuno, ma con bibliche proporzioni da incubo, “nata tra mura infrangibili, alte ventisette metri e spesse cinque, che erano l’opera più poderosa e fondamentale costruita dal Crollo Produttivo in poi, e con esse le Industrie delle Zone Lavoro, i Palazzi del Popolo, le Zone Svago, le arterie viarie sopraelevate”.
Sembra un libro delle Cronache, Metropoli, sembra un testo sacro in cui potrebbe essere contenuta la sapienza del futuro. Ma Metropoli non sorge con le misure della saggezza, tanto è vero che è potenzialmente infinita, perennemente schiacciata sul presente, non ha centro e manca di un sancta sanctorum: nessuno la governa, né un dio né l’uomo, ma è un mostro che innalza labirintici patiboli in cui gli esseri umani sacrificano tutta intera la loro vita, è un aberrante incrocio tra un lager e una città chiusa dell’Unione Sovietica.
Reduce dalla vita, qui giunge, tra algidi bagliori, un uomo, un viandante del mondo perduto; varcate le porte di Metropoli diviene il cittadino numero 5.937.178. In qualità di Sopravvissuto al Crollo Produttivo, viene indirizzato al Ricovero Fisico Psichiatrico, dove è lavato sotto un getto di acqua bollente, vestito con abiti “grigi, leggeri, candidi, inodori”, nutrito e ospitato in una Stanza di Contenimento, la numero 111. Sebbene il primevo impatto cromatico sia a Metropoli con il puro colore bianco, presto si scopre che quella è la tinta della disperazione che tutto riempie e tutto annulla. Annulla, sì, i guasti della precedente democrazia travestita da capitalismo (o del capitalismo velato da un approccio egualitario che ricorda la critica alla democrazia americana di Alexis de Toqueville: “Nulla era stato mai pensato per il progresso generale, milioni e milioni di persone si erano mosse esclusivamente a fine privato, ombelicale: fare per godere, di continuo e di più”), annulla il male, ma anche il bene, annulla la malattia, la guerra, ma anche la pace, elimina lo sporco danaro e il peccato, ma anche la memoria, l’amore, la fede, il futuro e ogni senso di grazia. Metropoli è la realizzazione del nichilismo robotico che scarnifica i volti umani voltandoli in crani “rotti da fori neri occupati da pupille ormai bianche, levigate da una vita troppo lunga”.
Le parole dell’uomo sono sostituite dal chiasso della Produzione: tutto è produzione a Metropoli (una produzione che, tra l’altro, vorrebbe, miseramente scimmiottare la Creazione), tutto è corpo senza mente. “Il cemento, il ferro, il vetro, l’acciaio, l’asfalto, parevano annientare l’uomo”, la nobile materia cambiata in vile materiale realizzava l’inferno sulla Terra. Un inferno che coincide con la divinità che lo regge: Metropoli è il demonio, è il Dio sradicato dal cielo che al cielo cerca di tornare impietosamente colonizzandolo, come a Babele.
Nelle Città invisibili, Marco Polo spiegava a Gengis Khan, parlando a proposito di Despina, che “ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone”. Ma il deserto è ancora qualcosa, sicuramente è meno delle speranze che Despina nutre nella mente del cammelliere o del marinaio. Ma il deserto c’è ed è la durezza che esalta il premio, l’aridità necessaria per godere fino in fondo dell’ombra. Attorno a Metropoli, invece, s’apre “un niente smisurato”, tanto eccelso che anche gli sforzi che la città compie per propagarsi hanno il sapore dell’inanità. E verso quel nulla non c’è alcuna forma di interesse, nessuna scintilla di curiosità, non è l’affascinante buio dell’universo, non è il trepidante deserto dei Tartari. Non è, appunto, niente. O, almeno, il Dio Metropoli vuole che ciò che sta là fuori non sia Niente, fino a quando non verrà inglobato dalle mura della città, e gli stessi uomini, divenendo nutrimento per i loro simili, si voltino in carne della città medesima.
Marcus, questo il nome dell’internato, incontra Sofia. Loro due sono gli unici esseri che sembrano essere rimasti umani, sono i soli a riscoprire, abbracciando il dolore per allontanare il terrore, che l’anima ha un peso e che non può essere prostituita all’“infinitamente osceno” che sulla terra si sta manifestando sotto la specie del vuoto interiore. Insieme, Marcus e Sofia prendono le misure della salvezza, che non è la salvezza abominevole promessa da Metropoli, “luogo regredito nel tempo di millenni”, nel tempo che fu prima di Dio e che più niente ha della “dignità della morte”.
La salvezza sta fuori, nel nulla. Forse anche nella morte. Ma io credo che risieda soprattutto nella parola: nella parola che Marcus bisbiglia a Sofia, in quella che lei restituisce a lui. La parola di Santarossa è un antidoto all’asetticità di materiali sempre uguali a se stessi, è una cura contro la monotonia da clone alla quale forse, un domandi, saremo condannati. È infine una parola che, mentre intacca e zaffa la superficie apparentemente immodificabile del grande mostro, conduce alla speranza di poter adoperare quella medesima parola per riempire il nulla da cui siamo minacciati.
“La libertà inizia al principio del nulla”.
di Maria Grazia Calandrone
.
le spirali delle due ammoniti sul tuo petto
ripetono la forma delle galassie gemelle
PGC 9074 e PGC 9071
della costellazione del Triangolo
una (la 9074, di tipo Sa) mostra una sporgenza luminosa, l’intenzione di un’alba, ma porta i bracci avvolti strettamente intorno al proprio nucleo
l’altra, la galassia che si srotola più a Nord nel nero siderale (la 9071, di tipo Sb), ha allargato le braccia da un discreto numero di anni-luce.
il buio dell’universo è sottoposto a magnetismi incommensurabili. altrimenti, è cieco.
questa forma di abbraccio
disabitata, questa custode con le ali aperte nel silenzio profondo, reca un dolore alla spalla destra. è un oggetto celeste dai tendini infiammati, a Nord-Est del tuo cielo
le due galassie sono scientificamente inseparabili. cito, da un articolo di Eleonora Ferroni, in Notiziario dell’Istituto Nazionale di AstroFisica: “sono abbastanza vicine da sentire l’una la gravità dell’altra, ma non ci sono disturbi gravitazionali visibili”
entrambe hanno prodotto “giovani e calde stelle retrostanti”, mentre “formazioni stellari più antiche e fredde” pulsano, gialle del giallo bestiale della savana, accanto al loro nucleo
e un corteo di stelle ormai lontane le circonda, come una corona di detriti
le due astrali Signore delle porte accanto hanno lasciato scie di sangue e dolcezza, scorie di amori ormai assorbite dal rombo dei venti galattici. ma la forza di gravità di ciascuna nei confronti dell’altra le porterà a confondersi in un unico grande fenomeno, in un abbraccio pieno.
l’articolo chiude infatti così: “tra qualche centinaio di milioni di anni le due strutture si fonderanno, perché l’attrazione gravitazionale che già le vincola avrà definitivamente attirato le due ormai inseparabili gemelle”.
sacre stelle pazienti. oggetti che non forzate
la curvatura spaziotemporale, limpide forze che state
nell’intervallo naturale
che sulla terra viene detto rispetto.
le stelle hanno la calma delle stelle.
questa forma cretacica fossile ha un disegno terrestre: le sue spirali, formate da rigoni d’inchiostro organico, riproducono la rotazione delle due galassie. cose forse avvenute nello stesso momento in terra e in cielo. 180 milioni di anni fa. cose delle quali siamo il futuro. o l’utopia.
questa insiemistica fantascientifica, lo stadio fossile-astrale della materia, è il mio dono per te.
in attesa di formare l’insieme al quale sono destinate, le due vicine svolgono un’intensa attività interiore, che porta entrambe a uno sprigionamento di energie attive, utili alla creazione di pianeti. esse sono due splendide officine, due fervidi laboratori di stelle. esse irradiano luce.
l’osservatorio on-line del telescopio spaziale Hubble della NASA-ESA, che le ha individuate, ha pubblicato la notizia il 24.6.2013 (di quel pomeriggio, ricordo un allegrissimo braccio di ferro al bar, sotto una parete di grappoli di glicine. non ha vinto nessuno. le nostre forze sono strutture equivalenti e complesse)
la suggestiva scoperta ha subito rimbalzato sui siti astronomici internazionali, nei primi giorni del luglio 2013. di quei giorni ricordo un dialogo sull’ironia della natura: scoprivamo che gli alveoli polmonari e il meconio si formano nel medesimo stadio evolutivo del feto umano: pneuma e feci. come sempre. l’umano.
poi, ricordo la musica di un amore immortale sulla rovina di Massenzio: “e si ’na stella canta pe’ ammore rimmane ’n cielo mill’anne e nun more”. poi, ricordo un sorriso, così profondo da perdonare i morti, invincibile come la forza gravitazionale che sulla terra viene detta destino. e poi ricordo un suono di campane, semplice come il caldo della tua bocca
che dura qui, ben oltre la mia vita
16.11.14
°
.
[Mi sono innamorato di questa poesia, leggendola per caso, una mattina a Roma, luce solita che assolve tutte le malefatte cittadine, persino nazionali, luce stronza-belissima, e la leggevo, questa poesia sulle galassie, nell’ultimo libro di Maria Grazia Calandrone, Serie fossile, Crocetti, Milano, 2015. È il testo che chiude il libro. I poeti dovrebbero scrivere di stelle anche oggi, ma è difficilissimo, meglio non farlo, eppure qui, Maria Grazia Calandrone, ci è riuscita con estrema efficacia e disinvoltura. a. i.]
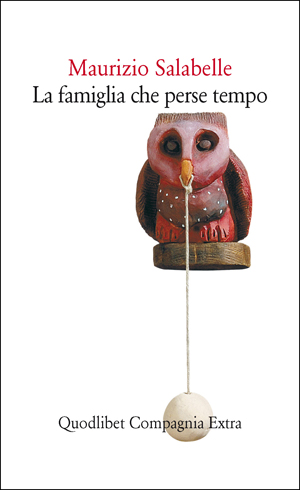 di Marisa Salabelle
di Marisa Salabelle
Di tutti i libri pazzi e strampalati che ha scritto mio fratello Maurizio, La famiglia che perse tempo è forse il più pazzo e strampalato. L’ha scritto che avrà avuto, quanto, ventott’anni? Non lo so con precisione perché a noi non diceva nulla e in famiglia, che scriveva, l’abbiamo saputo in due occasioni: quella volta che la mia amica Benedetta mi fece vedere un numero di una rivista, Erba d’Arno, dove era stata pubblicata una sua poesia, e poi la volta famosa che Giuseppe Pontiggia telefonò a casa e a rispondergli fu nostro padre, il quale non se lo sarebbe mai immaginato che Giuseppe Pontiggia potesse telefonare a casa per dire che aveva letto il manoscritto di Maurizio e che gli era piaciuto moltissimo. Quel manoscritto era, credo, La famiglia che perse tempo, che piacque a Pontiggia e a Ermanno Cavazzoni ma che per ragioni contingenti è rimasto inedito fino a ora.
La storia è quella di una famiglia di cinque persone, genitori e tre figli adulti, tutti nullafacenti, se si eccettua il figlio maggiore, che è medico, e occasionalmente riceve qualche paziente, e il narratore, che risponde all’improbabile nome di Phatrizio e per un periodo fa l’autista di autobus. Oltre a questo, la madre di tanto in tanto cucina e il padre fa misteriosi esperimenti chiuso nella sua camera: per il resto i cinque si trascinano dal divano al letto, si incrociano nell’andito, spilluzzicano i cibi imbanditi dalla madre, guardano vecchi film presi a noleggio. Oltre che svogliati e oziosi, i cinque sono affetti da stranissimi disturbi: perdono periodi di tempo, soffrono di letargia, attraversano momenti di grave depressione. Per capire l’origine dei loro mali analizzano gli oggetti che hanno in casa, orologi che diventano fuligginosi e che non segnano più l’ora, brandelli di stoffa infetti da strani germi, libri e opuscoli che cospargono il pavimento, provenienti da chissà dove. Scrivono memorie, si intervistano l’un l’altro, improvvisano conferenze al tavolo di cucina. Cambiano spesso casa, sperando così di risolvere i propri guai, ma i quartieri in cui vanno ad abitare si rivelano di volta in volta sempre più tetri, squallidi, al punto che neppure sono segnati nelle mappe della città.
Se paragono questo romanzo ai successivi, che però sono stati pubblicati prima, vedo analogie e differenze. Vedo innanzitutto che, rispetto alle altre opere, tutte caratterizzate da un’atmosfera surreale e da una trama fantastica, La famiglia che perse tempo è un romanzo ancora più rarefatto, astratto, paradossale. Non esiterei a definirlo un’opera altamente sperimentale. Vedo, però, anche le analogie con i romanzi successivi, in cui Maurizio mette in scena i suoi personaggi stralunati e le sue famiglie stravaganti. Padri sempre un po’ distratti, lontani dalla realtà, impegnati in attività bizzarre quali compiere esperimenti scientifici o consultare ossessivamente vocabolari; madri che svolgono in modo malcerto i loro compiti di accudimento, mettendo in tavola solo noccioline e patatine fritte, lavando le verdure col detersivo per i panni, inondando divani e poltrone di acqua saponata e così via. Fratelli e sorelle che vivono relazioni simbiotiche, uomini adulti stranamente impacciati con le donne o incapaci si svolgere lavori normali.
Ogni volta che leggo uno dei suoi libri, penso alla nostra famiglia, e riconosco alcuni particolari, alcuni comportamenti e modi di esprimersi, che mi fanno dire: siamo noi, eravamo così. Quindi penso che Maurizio abbia voluto raccontare, in chiave surreale, la nostra vita; altre volte invece penso che abbia creato i suoi romanzi e i suoi personaggi come in un gioco, un divertimento fantastico e bizzarro.
E poi, naturalmente, c’è il suo linguaggio. Un lessico semplice, accessibile ma ricercato, parole a volte un po’ desuete, che lui sceglieva principalmente in base alla sonorità, un fraseggio caratteristico, con una sua musica interna, un suo ritmo ben preciso. «Nello scrivere, seguo una musica o un ritmo interno che è del tutto indipendente da ciò che narro» affermava infatti in un memorabile articolo, Un romanzo è un apparecchio complicato: «È una musica poco appariscente e un po’ monocorde, che mi arriva non so da dove ma che sento di dover seguire e assecondare e che determina la lunghezza dei periodi, il numero di sillabe delle parole, la posizione dei segni di interpunzione.» E in effetti credo sia proprio questo senso rapsodico del linguaggio ciò che fa di Maurizio, veramente, uno scrittore. Che basta leggere una frase per dire, non c’è dubbio, è lui. Inconfondibile.
 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta
Guai a chi costruisce il suo mondo da solo.
[…]
Angelo Maria Ripellino
Il suono di queste parole mi riecheggia nella testa: Guai a chi costruisce il suo mondo da solo.
Il famoso verso di Ripellino è parte dell’epigrafe scelta da Diego Conticello, uno dei sette poeti presenti nel XII quaderno di poesia italiana contemporanea, curato da Franco Buffoni e pubblicato da poco per Marcos y Marcos.
Gli altri sei nomi presenti sono: Maddalena Bergamin, Maria Borio, Lorenzo Carlucci, Marco Corsi, Alessandro De Santis e Samir Galal Mohamed. Le prefazioni che accompagnano i testi di ciascuno di loro, sono curate da: Mario Benedetti, Stefano Dal Bianco, Gian Ruggero Manzoni, Fabio Pusterla, Niccolò Scaffai e Emmanuela Tandello.
 Scriviamolo sui muri, la resistenza è ancora possibile, l’urgenza delle parole si frapponga fra noi e il resto.
Scriviamolo sui muri, la resistenza è ancora possibile, l’urgenza delle parole si frapponga fra noi e il resto.
La sconfitta non è definitiva, la speranza è tutta nella nostra capacità di ridere.
L.Di Ruscio
NON POSSIAMO ABITUARCI A MORIRE
( Festa-tributo-incontro sull’opera di Luigi Di ruscio )
A partire dall’opera di questo grande scrittore e poeta, attraverso la proiezione di piccoli cortometraggi e frammenti video sulla sua figura e la lettura di suoi testi ad opera di poeti, scrittori e amici che l’hanno ammirato e conosciuto, questo evento vuole essere insieme un momento di festa e di riflessione. In questi tempi dove l’uomo, la poesia e la bellezza vengono continuamente offesi, aspira ad essere un’alternativa il più possibile concreta alla volgarità e all’ignoranza che tentano di soffocare la nostra vita di uomini liberi.
INTERVENGONO:
Fabrizio Bianchi
Luigi Cannillo
Biagio Cepollaro
Nino Iacovella
Rosemary Liedl Porta
Christian Tito
Adam Vaccaro
Programma
Nino Iacovella presenta e introduce la serata :
(Tutte le lettere saranno lette da Luigi Cannillo che leggerà le lettere di Di Ruscio e Christian Tito che leggerà le sue lettere.)
Intervallo
Concerto di chitarra classica con i musicisti Claudio Ballabio e Nicola Panzarino.
Venerdì, 10 aprile, ore 19.00.
Milano presso Spaziotu di Maschere Nere,
Fabbrica del Vapore, Via procaccini, 4.
[ Sono particolarmente legato a Luigi Di Ruscio. Sia per la sua opera che per l’amicizia che ho nutrito per lui a partire dai primi anni ’90. Un mio breve contributo alla comprensione della figura di Di Ruscio come poeta e come maestro, avvicinato pur nelle tante differenze a Elio Pagliarani e a Giancarlo Majorino, relativamente al tema del poema, si trova qui . B.C.]
 di Federico Pevere
di Federico Pevere
Heidi Krieger è stata campionessa europea di lancio del peso. Ha avuto seri problemi di salute dovuti principalmente a ciò che le veniva somministrato. Heidi negli anni è diventata Andreas e ama Ute. Ute Winter è stata una campionessa di nuoto. Ha avuto seri problemi di salute dovuti principalmente a ciò che le veniva somministrato. Ute è rimasta Ute, e ama Andreas.
(questo testo è tratto da “Il Molino a vento e altre prose”, bella antologia di racconti di Gabriel Miró (1879-1930), Benito Pérez Galdós e Vicente Blasco Ibáñez, tradotti da Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi, e curata da quest’ultimo, per Galaad Edizioni, 2015; nel mix di “desuetudine” e estrema potenza, a me ricorda da vicino il nostro Vincenzo Pardini; GS)
di Gabriel Miró
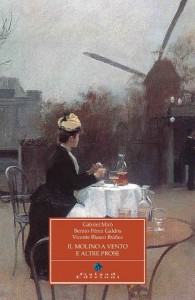 Un’aquila seguiva sempre il gregge. Il suo verso risuonava in tutta l’azzurra vastità del giorno, le pecore si fermavano e la guardavano. A volte volava così bassa che si sentiva il fischio delle piume e del becco e la sua ombra enorme passava sui dorsi lanosi delle bestie.
Un’aquila seguiva sempre il gregge. Il suo verso risuonava in tutta l’azzurra vastità del giorno, le pecore si fermavano e la guardavano. A volte volava così bassa che si sentiva il fischio delle piume e del becco e la sua ombra enorme passava sui dorsi lanosi delle bestie.
Nelle ore più calde il pastore si coricava sul prato di gramigna e le pecore si stringevano contro le rocce. Tutto il fondovalle era inondato dal sole: rossi campi coltivati, alberi in fiore, orti recintati, ruderi di casolari, sentieri
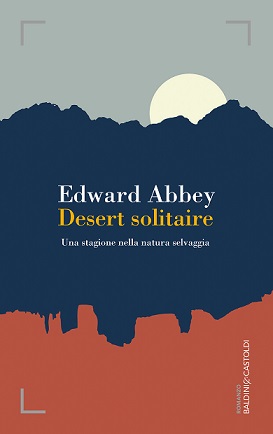 (torna in libreria Desert solitaire. Una stagione nella natura selvaggia. Attualissimo, non ostante gli anni. Ringraziamo l’editore per averci regalato un estratto del libro. G.B.)
(torna in libreria Desert solitaire. Una stagione nella natura selvaggia. Attualissimo, non ostante gli anni. Ringraziamo l’editore per averci regalato un estratto del libro. G.B.)
di Edward Abbey
Qui da solo, immerso nel silenzio, capisco il terrore che molti provano in presenza del deserto primordiale, la paura inconscia che li spinge a voler domare, alterare o distruggere ciò che non riescono a comprendere, a ridurre il selvatico e il preumano a dimensioni umane. Qualunque cosa piuttosto che confrontarsi direttamente con l’anteumano, con quell’altro mondo che ci spaventa non tanto perché sia pericoloso o ostile ma per qualcosa di molto peggiore: la sua implacabile indifferenza.
Via dall’ombra, nella calura. Procedo a passo pesante nella gola sinuosa, nel silenzio, severo ma fragile. In questa atmosfera così arida i suoni non svaniscono, non producono eco e neppure muoiono dolcemente ma si estinguono all’improvviso, bruscamente, senza il minimo riverbero. Il cozzare delle rocce l’una contro l’altra è come uno sparo: sordo, improvviso, eccessivo.
Dietro la curva successiva, eccolo, inaspettatamente, il ponte di pietra.
Inaspettatamente, scrivo. Perché? Avevo fiducia, sapevo che il ponte sarebbe stato qui, sfidando ogni probabilità. E sapevo anche abbastanza bene quale aspetto avrebbe avuto: tutti lo abbiamo visto in fotografia almeno un centinaio di volte. E non sono nemmeno deluso in quel modo vago che spesso proviamo quando ci troviamo di fronte a uno spettacolo che a lungo avevamo immaginato. Il Rainbow Bridge non sembra né più piccolo, né più grande di quanto avessi previsto.
Poi mi sento in colpa. Newcomb. Perché non ho insistito che venisse con me? Dovevo afferrarlo per i peli della sua lunga barba da selvaggio e trascinarlo per il sentiero, caricandomelo in spalla come San Cristoforo al momento di attraversare il torrente, inciampando sulle pietre e scaricandolo infine sotto il ponte, lasciandolo lì a marcire o a strisciare di nuovo verso il fiume. Nessuno avrebbe potuto desiderare una defenestrazione più incantevole.
Attraverso la finestra di Dio sull’eternità.
Oh, be’. Salgo ai piedi del contrafforte orientale e metto la mia firma e quella di Ralph nel registro dei visitatori. Lui è il numero 14.467 e io il successivo a firmare questo libro da quando i primi uomini bianchi raggiunsero il Rainbow Bridge nel 1909. Non molti per essere passato più di mezzo secolo, e soprattutto nell’era della pubblicità. Ma non è mai stato un viaggio semplice. Fino a oggi.
La nuova diga migliorerà le cose, ovviamente. Quando sarà piena, l’acqua arriverà fino al Bridge, trasformando un’avventura nella solita escursione in motoscafo. Per chi lo vedrà in futuro sarà impossibile capire che metà della bellezza del Rainbow Bridge risiedeva proprio nella sua lontananza, nella relativa difficoltà ad accedervi, nella natura selvaggia che lo circondava e di cui era parte integrante. Una volta rimossi questi aspetti, il Bridge non sarà nient’altro che un’isolata bizzarria geologica, un’ulteriore estensione di quel diorama museificato a cui il turismo industriale tende a ridurre il mondo naturale.
L’eccellenza è tanto difficile quanto rara, disse un uomo saggio. Se è così, che cosa accade all’eccellenza se eliminiamo la difficoltà e la rarità? Parole, parole… Il problema mi fa venire sete. C’è una sorgente sull’altro lato del canyon, proprio sotto una cengia alla base occidentale del Bridge.
Scendo giù, risalgo dall’altra parte e raccolgo l’acqua dal muschio gocciolante con l’aiuto di una lattina abbandonata lì da qualcuno.
Il caldo è impressionante. Mi riposo per un attimo all’ombra, mi addormento e sogno nella luce terribile del mezzogiorno. Quando il sole cala dietro l’orlo del canyon, mi alzo e ritorno da Newcomb e al nostro bivacco.
Ma vengo attirato dalla traccia di un sentiero che sembra condurre fuori dal canyon, passando sopra il Rainbow Bridge.
Tardo pomeriggio, il canyon si sta riempiendo di ombre, non dovrei tentare. Decido comunque di provarci: risalgo un ghiaione e traverso un lungo terrazzo inclinato che sbuca nell’aria sottile alla base di un alto dirupo. Impossibile proseguire.
Ma dall’alto penzola una corda, fissata a un punto invisibile. La provo, sembra ben ancorata, e aiutandomi con quella e qualche opportuno punto d’appoggio per i piedi e le mani mi faccio strada fino in cima. Da lì all’orlo del canyon la strada è lunga ma non impegnativa.
Sono di nuovo all’aperto, fuori dall’inframondo. Da quassù, il Rainbow Bridge, trecento metri più in basso, è solo una cresta di arenaria di non eccessiva importanza, un minuscolo oggetto perduto nell’intricata vastità del sistema dei canyon che si irradia dalla base della Navajo Mountain.
Più interessante è la vista verso nord, est e ovest, che rivela la struttura generale del territorio che abbiamo attraversato a bordo delle nostre piccole imbarcazioni.
Il sole, ormai in prossimità dell’orizzonte, splende nell’aria limpida sotto strati di nuvole, illuminando con tenui variazioni di rosa, vermiglio, terra d’ombra e ardesia, i complessi tratti e i dettagli, definiti in maniera netta dall’ombra, del paesaggio del Glen Canyon. Vedo la mesa dai bordi squadrati oltre la confluenza del San Juan e del Colorado, gli altopiani dello Utah centro-meridionale, e più in là, centocinquanta chilometri o anche più in linea d’aria, le cinque vette delle Henry Mountains, compreso il monte Ellsworth, vicino a Hite, da dove è cominciato il nostro viaggio.
A oriente una tempesta isolata ribolle sopra il deserto, una massa di nuvole color lavanda sta bombardando la terra di fulmini e pioggia. Ma è così lontana che non riesco nemmeno a sentire i tuoni. Tra qui e là, tra me e le montagne, si estende lo spazio selvaggio del canyon, il territorio magico di guglie, pilastri e pinnacoli dove non vive nessuno, e dove, non visto, nelle fosse neroblu della roccia, scorre il fiume.
Luce. Spazio. Luce e spazio senza tempo, perché in questo Paese le tracce della storia umana sono minime. Nella dottrina dei geologi, con il loro schema di ere, eoni ed epoche, tutto scorre, come insegnava Eraclito, ma dal punto di vista mortale dell’uomo il paesaggio del Colorado è come una sezione di eternità: senza tempo. In tutti i miei anni nel Paese dei canyon – a parte durante le inondazioni – non ho mai visto una roccia cadere di sua spontanea volontà, per così dire. Per convincermi dell’esistenza del cambiamento, e quindi del tempo, spingerò giù una pietra dalla cima di un dirupo, la osserverò scendere e aspetterò – fumando la pipa – di redigere il resoconto del suo impatto e della sua disintegrazione. Farò del mio meglio per aiutare i processi naturali e verificare le ipotesi della morfologia geologica. Ma non ne sono del tutto convinto.
Gli uomini vanno e vengono, le città nascono e muoiono, intere civiltà scompaiono; la terra resta, solo leggermente modificata. Restano la terra e la bellezza che strazia il cuore, dove non ci sono cuori da straziare. Capovolgendo Platone ed Hegel a volte penso, senz’altro in modo perverso, che l’uomo è un sogno, il pensiero un’illusione, e solo la roccia è reale. Roccia e sole.
Sotto il sole del deserto, nella sua dogmatica luminosità, le favole della teologia e i miti della filosofi a classica si dissolvono come nebbia. L’aria è limpida, la roccia intacca crudelmente la carne. Frantumate la roccia e l’odore della selce vi salirà alle narici, acre e pungente. Di giorno mulinelli di polvere danzano sulle pianure di sale; di notte i cespugli pieni di spine si incendiano. Che cosa significa? Non significa nulla. È come è, e non c’è bisogno di trovarvi alcun significato. Il deserto sta lì e svetta oltre ogni possibile qualifica umana. Per questo sublime.
Il sole sta per toccare gli altopiani traforati a occidente.
Per un attimo sembra sobbalzare, espandersi, poi all’improvviso tramonta. Mi metto in ascolto per un tempo lunghissimo.
Nel crepuscolo e alla luce della luna scendo verso la corda, verso la cengia, verso il fondo del canyon sotto il Rainbow Bridge. Nell’aria volteggiano i pipistrelli. Le lucciole volano vicino alle sorgenti e rospi piccolissimi ma dal vocione profondo cantano il loro gracidio verso di me mentre arranco oltre i loro stagni per il lungo sentiero che mi riporterà al fiume, al fuoco, alla compagnia e a una cena di mezzanotte.
Siamo alla fine del nostro viaggio. Al mattino, io e Ralph mettiamo via la nostra attrezzatura, la carichiamo sui gommoni e lanciamo un’ultima occhiata a questa scena che – lo sappiamo – non vedremo mai più come la vediamo ora: il fiume Colorado, maestoso, libero e selvaggio, che scorre
vicino alla base delle pareti torreggianti, che ruggisce tra i massi sotto l’imboccatura del Forbidden Canyon; il Navajo Point e il precipizio del Kaiparowits Plateau centinaia di metri sopra, oltre le pareti interne del canyon; e a oriente, banchi di nubi spinti dalla tempesta impilati l’uno sull’altro, bordati d’oro e scintillanti nell’alba.
Ralph fa una fotografia, rimette la macchina nella custodia waterproof che tiene a tracolla sul petto, e salta nella sua imbarcazione. Partiamo.
di Giorgio Mascitelli
Si sa che Matteo Renzi è molto abile nelle battute e anche nel caso della sua uscita sull’insegnamento dei Promessi Sposi che andrebbe vietato per legge si è mantenuto all’altezza della sua fama. Boutade perfettamente calcolata, anche nell’usare un’affermazione scherzosa di Umberto Eco fatta in un contesto diverso, ha il pregio di avere un sapore maledettamente antiestablishment colpendo un padre della patria senza dare fastidio a nessuno. E’ noto che ormai i padri non ci sono più ( questo l’ha detto lo stesso Renzi in un altro discorso) e quanto alla patria è chiaro come il sole che i soldi si fanno altrove. E poi a quale studente italiano non sta sulle scatole il romanzo di Manzoni?
Prendiamo a esempio quell’insopportabile Lucia perfettina e santarellina, un’autentica figa di legno si direbbe oggi nella città che dette i natali all’illustre scrittore: chi in tutta coscienza può dire di averla in simpatia? Lo stesso Manzoni aveva previsto che la sua protagonista non avrebbe destato i favori del pubblico e provvide a mettere in bocca a un personaggio del romanzo tutte le nostre perplessità. ’Madonnina infilzata’ la definisce Perpetua, che è una metafora pudica del fiorentino ottocentesco, il cui significato è molto simile a quello della più sboccata metonimia milanese del XXI secolo. Ma tutto questo a Manzoni non servirà a molto: ormai per lui sono definitivamente tramontati i tempi in cui campeggiava sereno sulla banconota da centomila lire.
In realtà non si può seriamente pensare che il presidente del consiglio abbia detto una cosa del genere solo per il gusto di impressionare i borghesi o di farsi notare. La sua dichiarazione segue una serie di prese di posizione di altri esponenti politici ( Tremonti, Monti, Profumo), economisti, commentatori preoccupati per il nostro futuro e sopracciò vari del neoliberismo nazionale e internazionale contro l’inutilità della cultura umanistica. Non si tratta soltanto di un riflesso di fastidio per tutto ciò che non crea, o non sembra creare, profitti, ma la polemica antiumanistica è consustanziale alla politica pedagogica del neoliberismo verso la popolazione, in particolare quella in età scolare. Visto che il progetto di preparare le persone alle esigenze del mercato si concretizza in “un’interiorizzazione delle norme di prestazione, in autosorveglianza costante per uniformarsi agli indicatori” ( Dordot-Laval La nuova ragione del mondo) e nello sviluppo fin dall’infanzia di quello spirito di competitività, che evidentemente non è così innato, è ovvio che ci sia una naturale diffidenza, se non ostilità, nei confronti di qualsiasi idea della vita altra rispetto al mercato come quelle veicolate dalle discipline umanistiche ( e anche da quelle scientifiche, se è per questo, quando queste educano a un comprensione critica della realtà e alla curiosità intellettuale). E’ chiaro altresì che nella scuola in particolare le idee sulla vita elaborate dalla tradizione culturale occidentale contrastano con l’instaurazione di quello specifico microclima ideologico che è necessario per inculcare quei tre valori o norme morali utili alla creazione di una cultura di mercato che ho elencato sopra.
A questo discorso neoliberista comune a tutto l’occidente si aggiunge l’invito specifico delle classi dirigenti italiane alla descolarizzazione e alla rivalutazione del lavoro manuale in considerazione del fatto che siamo un paese perdente nella guerra della globalizzazione: pertanto la maggior parte dei posti di lavoro che si troveranno in futuro sarà a bassa qualifica ed è considerato poco conveniente spendere molti soldi per la preparazione di gente che finirà all’estero. E l’elementare idea che un accrescimento del livello culturale può portare benefici, magari non prevedibili, anche a livello economico è perfettamente estranea a menti convinte che gli swap servano all’umanità e Manzoni no.
Proprio l’OCSE il 9 febbraio scorso nel suo rapporto sulla spinta alla crescita ( Going to Growth) raccomandava all’Italia di compiere le seguenti riforme dell’istruzione: istituire un sistema di valutazione degli insegnanti, sviluppare un sistema di istruzione professionale post diploma di secondaria, aumentare le tasse universitarie e creare un sistema di prestiti d’onore per gli studenti universitari. Si tratta di un progetto di educazione, contenuto in queste raccomandazioni, che tende a creare una scuola articolata intorno a un principio d’autorità nella formazione degli studenti, che rende difficile l’accesso all’università per le fasce più povere della popolazione e che immette sul mercato del lavoro qualificato manodopera facilmente ricattabile perché indebitata prima ancora di iniziare a lavorare.
Le raccomandazioni dell’OCSE non sono naturalmente semplici consigli disinteressati, ma al contrario sono indicazioni da recepire per tutti quei governi che vogliono riscuotere la fiducia dei mercati, come si suole dire oggi, oppure, se si preferisce usare le parole del Conte zio quando chiede al padre provinciale dei cappuccini il trasferimento di fra Cristoforo per aver osato ostacolare suo nipote don Rodrigo, sono gli amichevoli consigli di un’organizzazione che gode di attinenze cospicue nel mondo dei mercati finanziari. Del resto la prima di queste raccomandazioni è già stata recepita dalla Buona Scuola renziana.
Quanto alla Buona Scuola, è una riforma ( a quanto pare è una riforma, nel senso che in autunno era stato detto che non si trattava di una riforma, evidentemente con l’avvicinarsi della primavera lo è diventata) concepita in un quadro economico di diminuzione delle risorse pubbliche, in un quadro ideologico di aperta ostilità da parte delle élite nei confronti della cultura soprattutto per il suo valore critico ed emancipatorio e sotto la pressione di potenti organizzazioni internazionali che vogliono limitare l’accesso all’istruzione e subordinarla alle esigenze di un mercato del lavoro dal respiro breve, entro un progetto generale di riduzione di ogni aspetto della vita al mercato.
A questo proposito Matteo Renzi ha dichiarato, più o meno, che la Buona Scuola è una riforma importantissima perché definirà l’istruzione almeno per i prossimi cinquant’anni. A mio avviso, il presidente del consiglio ha peccato per eccesso di modestia: con premesse del genere c’è il caso che riesca a sistemarla per sempre.
 di Mariasole Ariot
di Mariasole Ariot
Di Roberto Dalmonego ci si ricorda la saliva : una bava lenta, trascinata, un prolungamento inutile di un residuo di umanità, la scia delle lumache che sono già passate. Di Roberto Dalmonego ci si ricorda la camminata, uguale a tutte le camminate della corsia, la camminata faticosa del farmaco. Trascinata, un prolungamento inutile di un residuo di umanità, la scia di un sé già passato. Di Roberto Dalmonego ci si ricorda un corpo steso a terra, un urlo nella notte. Di Roberto Dalmonego non ci si ricorda nulla.
Del piccolo L. si ricordano gli anni. La sua voce masticata dai farmaci, i calzini bianchi, i suoi capelli alla Elvis Presley, il sogno di diventare psicologo – o forse economista, diceva, o forse Legge. La sua dichiarazione nella camera oscura : sono qui perché non sapevo più riconoscere il male dal bene. Ci si ricorda la finta torta di compleanno, il barattolo della nutella e il pane secco, ci si ricorda la risata improvvisa sui racconti di Maddy :
– e allora ci addormentavamo con un po’ di benzina, e funzionava
ridevamo
– e i miei nipotini sui covoni si rotolavano, e allora un po’ di benzina funzionava
ridevamo
– ma io sono astemia, il vino no
ridevamo
– poi sono morti tutti i bambini
lui continuava a ridere
Di Roberto Dalmonego non si è saputo nulla. Non ci sono tracce fino al 28 marzo 2015. I giornali hanno taciuto, i poteri forti hanno taciuto : quel che conta è silenziare. Strangolato nella notte del 31 marzo di un anno fa. Il piccolo L. l’ha preso alla gola. Gli infermieri del turno notturno : nessun indagato : tutti dormivano. Li ho visti distesi come larve, il respiro profondo, la fotografia del tacere.
Fate silenzio, c’è chi dorme : noi che non siamo loro, che non siamo voi.
Di Roberto non si saprà nulla. E’ morto un disperato, è morto un già morto con la bava alla bocca. Una bava lenta, veloce nella fine, un prolungamento inutile di un residuo di umanità, la scia delle lumache che sono già passate.
Il piccolo L. ha i fiori in bocca, ha camminato nella casa con il sole dipinto sulla porta : territorializzazione spinta, riciclaggio dei malati. Quattro euro l’ora e due turni a settimana, con tutti i pazzi c’è un gran risparmio. Un riciclo : dimissioni e poi riutilizzo.
Il sistema psichiatrico trentino piace alla Cina – scrivono i giornali. Una conquista.
I piccoli L. a cucire borse, all’ex tossico un po’ di autolavaggio, un po’ di erba portata dai pazienti più esperti dai pazienti più datati, al ragazzo che cade nella paresi offrono un vecchio cesso su cui vomitare, qualche esperimento mattutino, la ragazzina senza corpo nella gabbia dei leoni, vediamo che succede, spingere per sottrazione, sottrarre per inclusione : venite tutti, tacete tutti.
Nessun commento, nessuna notizia. La stampa nazionale tace. Negli archivi della rete si trovano solo buchi : il niente di ciò che resta : un niente.
By definition, of course, we believe
the person with a stigma is not quite human
E.Goffman
In fondo si trattava di folli. Di chi vedeva demoni strangolando, e di chi sognava strangolatori e ed era già morto. Di chi dormiva strangolato.
Non saperne nulla : essere ciechi non per sciagura ma per godimento. Essere ragnatele trasparenti. Costruire una maglia sicura, allargarla, sperare che nessuno parli. Allargare il più possibile : escludere per inclusione. Fare della città un piccolo manicomio gentile, fareassieme per disfare. Quindici diagnosi a testa.
Ma l’importante è tacere. L’importante è tinteggiare i muri con la vernice trasparente. L’importante è verniciare, l’importante è svestire, l’importante è riciclare, l’importante è tacere.
Di Roberto Dalmonego nessuno sapeva nulla. Un solo articolo in un anno. Nessuno saprà nulla. Conta controllare questo nulla, fare del nulla il prestacorpo alle proprie zone morte, conta esportare il modello, dire superare Basaglia con una nuova legge che superi il superabile.
Conta superare per un apparente malinteso, conta scoprire i denti tenaci della novità a costo di distruggere per apparente forza contraria quel che di buono si era fatto.
Muore la 180 nelle zone interstiziali, muore nell’ombra, muore perché la parola non è contemplata, muore perché l’incompleto non si accetta, muore per desiderio di assoluto, muore per il totale, perché l’importante è che tutto funzioni : una macchina perfetta, ingranaggi ben oleati, il filo spinato sulle bocche.
Di Roberto Dalmonego resta l’ombra sulle piastrelle azzurre. Resta la sedazione come una bava, resta un volto senza faccia, resta un nome senza volto, resta un un corpo senza sepoltura.
Ma : i morti hanno bisogno di nomi, hanno bisogno che si dica, hanno bisogno che non si taccia, hanno bisogno del grave della parola, hanno bisogno di un peso, hanno bisogno del dire, hanno bisogno di vivi che smettano di allungare le spalle al cranio per dire semplicemente : càpita.
Fonti :
Il trentino non è un’isola felice
Il caso di Roberto Dalmonego
Il treno dei folli
Psichiatria democratica contro la proposta di legge 181
Un lapsus interessante nella proposta di legge 181 : “Sapere di ciascuno, sapere di lutti. Gli utenti è familiari esperti, un jolly prezioso”
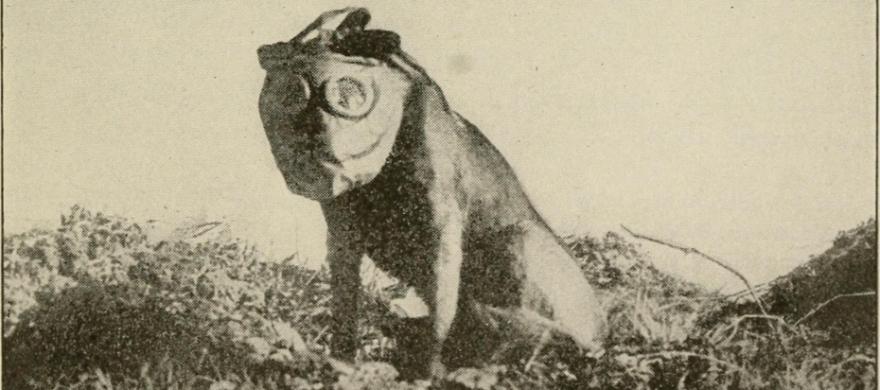
HANS CAROSSA
Kérdzi-Almàs, 25 novembre 1916
Pare che per i prossimi due giorni ancora saremo al sicuro da allarmi. Cerchiamo di sistemarci: molti tirano fuori libri e uniformi buone, qualcuno dispone sul tavolo una fotografia. Il mio alloggio è pieno d’irrequietezza; tutti i vicini entrano ed escono, poco fa è venuta qui una vecchia a mendicare acquavite. Oggi pomeriggio sono stato testimone d’una scena che, considerata in sé, non ha forse alcun significato, eppure ho la sensazione che mi riguardi, me e qualcun altro. Settimane fa vennero al mondo, in questa casa, molti gatti, che ora diventano molesti, tanto più che manca il latte per loro. Un ragazzotto di circa quindici anni, che è qui a servizio, sembra abbia avuto incarico di togliere di mezzo tutte quelle bestie. Mentre stavo scrivendo in camera, lo vidi portarle attraverso il cortile e prima che mi rendessi conto delle sue intenzioni, sbatterle con rapidità incredibile una dopo l’altra contro la parete del fienile, davanti a cui giacquero esanimi. Poi, fischiando e dimenando le braccia com’è il suo solito, il ragazzotto ritornò in cucina, dove appunto si stava portando in tavola, si sedette con gli altri e si mise a mangiare tranquillamente. Ma uno dei gattini giustiziati, grigio-azzurro, dal muso il petto e le zampe bianchi, e un bioccoletto argento chiaro sulla nuca, assolutamente diverso dagli altri, era rimasto soltanto tramortito e a poco a poco si riebbe. Solo allora notai che sanguinava al mento, per il resto sembrava incolume. Vacillando tentò piccoli passi, si fermò, si passò alcune volte la zampina sulle orecchie, come se ciò dovesse aiutarlo a riacquistare coscienza, e scivolò poi attraverso il cortile dentro la casa. Entrò esitando dalla porta della cucina e si guardò intorno. Quando vide la gente che banchettava, si sforzò di saltare sopra la panca, cosa che dopo alcuni tentativi gli riuscì; poi sedette per qualche istante immobile. Alla fine, venne a strofinarsi con fiduciosa preghiera contro il gomito del suo assassino, che masticava placidamente. Dal mio tavolino nascosto potevo osservarlo senza perderne un gesto. Quando s’avvide della bestiolina, quello seguitò ancora per un po’ a mangiare; a un tratto, sembrò lottare con la nausea, fu colto da una sorta di singhiozzo e respinse il cucchiaio. Non appena gli altri se ne furono andati, toccò con circospezione il gattino, come se ne avesse paura o dubitasse della sua presenza corporea. Finalmente, lo posò con tutta la delicatezza di cui era capace, quasi fosse un ninnolo di porcellana, sopra la tavola, e gli sbriciolò davanti i suoi resti di carne e pane. Quello ne mangiò un poco, e questo fatto rallegrò il ragazzo. (…) Il ragazzotto, da allora, ha ripreso il suo lavoro nel cortile. Ha raccolto i gatti morti con la cautela usata verso quello vivo, e li ha portati via. Mi sembra alquanto mutato nel suo contegno, il viso più sveglio, il passo più sicuro; inoltre da allora non l’ho più udito fischiare.
Domani arriva il principe ereditario austriaco, a passare in rivista la truppa presso Lemhény. Io mi dichiaro bisognoso di riposo e chiedo il permesso di restare a Kézdi-Almàs. Il tempo si fa molto ventoso e freddo.
STEFAN ŻEROMSKI
La guerra divenne l’elemento vitale del tenente Leszek Snica. Confessava a se stesso e agli amici che la guerra, da quando l’aveva conosciuta, era diventata nel suo intelletto quasi una prosecuzione, un ampliamento dell’attività artistica, un fiore che affondava le sue radici nella vita dell’uomo forte, dell’uomo creatore. Finalmente era caduto dalle sue possenti braccia creatrici tutto ciò che era meschino lavoro, preoccupazione di procurarsi cibi, bevande, indumenti, di sostenere famiglia. Era caduto come un inutile straccio. Tutto gli veniva consegnato in forma matematicamente perfetta, esatta, affascinante, ad una semplice richiesta: armi, indumenti, cibi, bevande, mantenimento della moglie e del figlio erano procurati con una puntualità al secondo da quella immane, complessa ed oltremodo possente macchina, che tutto pensava e tutto faceva ad un tempo, rispondente al nome di “Austria”. La sua vocazione di uomo, di marito, di creatore (la cui forza prorompente era guidata dalla saggezza) era diventata il valore, proprio il fine cui l’uomo creatore dovrebbe essere predestinato sulla terra. Quando il tenente Snica paragonava la sua vita precedente in Italia, una vita da furfante, da affamato, da vagabondo e da mezzo lazzarone, da “artista pittore”, con la sua attuale forza, tremava d’ira e vibrava di estasi. Là una nullità, qui un potentato. Potentato effettivo. La guerra aveva fatto sì che il mondo si spalancasse al suo sguardo intrepido e al suo pugno serrato. Si dischiudevano tutte le porte delle case, ogni scrigno fino ad allora inviolato, si infrangevano tutte le leggi che chiunque avesse mai scritto, si disperdeva in polvere il codardo cuore umano, proprio quello stesso che egli, oggi, un guerriero intrepido, sei settimane prima portava sotto l’abito borghese. Conosceva quella miseria e perciò gli piaceva ora guardarla come un oggetto estraneo. Lo affascinava la vita vagabonda della guerra, senza né data né ora prevedibile, fitta di esperienze travolgenti, di avventure e di eventi fantastici, che non riuscirebbe a sognare il poeta dalla fantasia più esuberante. All’avidità del suo animo insaziabile si offriva un mondo splendido e indicibilmente interessante. Dietro ad ogni collina, dietro ad ogni bosco attendevano delle nuove fantasmagoriche manifestazioni, che avanzavano continuamente, immagini irreali, dagli anfratti misteriosi del tempo e dello spazio. Poteva entrare in tutte le case, ispezionare palazzi e ville, conoscere persone e rapporti sempre nuovi, indagare all’interno dei casi più complessi, largheggiare in grazie e punizioni, reggere le vite e le sorti degli uomini, secondo l’interesse segreto della guerra, il che si poteva, a seconda delle circostanze, identificare col capriccio dell’individuo: tutto ciò era veramente attività artistica. La creazione di quest’arte non si esauriva mai, e non si era mai sazi di ammirarla.
ALFRED DÖBLIN
Le città renane erano in attesa dei reduci e adornavano le loro vie e i ponti. Padri, fratelli, figli ritornavano. Si voleva festeggiare chi era rimasto in vita, coloro che ritornavano dall’inferno, e festeggiare la fine della guerra. Coloro che avevano sognato grandi gesta di guerra e si aggiravano spauriti, erano lieti che il loro orgoglio, i reggimenti in marcia, i cannoni, i carri armati, le mitragliatrici, le fanfare e le bandiere, presto avrebbero riempito di nuovo le strade. Esisteva ancora la gioia, dunque, e non tutto era perduto. Altri s’attendevano un aiuto per le novità che sopravvenivano, perché non c’era più lo Stato, tutto pareva in dissoluzione, certi giorni pareva d’esser preda di bande brigantesche. Altri ancora attendevano i reduci per la rivoluzione, per la rivoluzione totale.
[…]
In mezzo ai soldati che bivaccavano, nelle scuole, ai posti di ristoro, s’affollavano persone con richieste molteplici. Infermiere e dame della buona società offrivano caffè, birra e piccole salsicce. Intorno ai pentoloni da campo dei soldati sulla piazza s’affollavano povere donne e molti bambini, uomini anziani che mendicavano pane e tendevano bicchieri. Davanti alle stazioni i comandanti cercavano di cacciar via i mendicanti.
[…]
– Mio caro figliuolo. Dopo ch’ebbe sparecchiato, lo trovò assorto, con lo sguardo chino. Egli disse: – Io sto qui disteso e seduto, rifletto e rievoco. Eccomi qui adesso. Qui ho vissuto e ho lavorato prima della guerra. Prima della guerra. È qualcosa più della guerra. Mamma, io so che non mi sono battuto per mesi con la morte e non sono ritornato a casa dalla guerra per continuare la mia vecchia vita. Non è questo il mio destino, me lo vedi in faccia. E anche se le mie membra fossero più forti, non mi sarebbe più concesso di farlo.
[…]
Egli incrociò le braccia e tacque a lungo. Poi toccò la mano della madre: – Di quale disfatta parli? – Di ora, del 1918. – La disfatta è più remota. Non intravedo ancora le sue radici. Si può essere vinti, ma non disfatti, e non è così. Questo è uno smascheramento. Non sapevano morire, temevano la morte come dei borghesi. Non possedevano il giusto rapporto con la morte e la vita – E dopo alcun tempo soggiunse: – Non erano autentici. – La madre stava seduta muta a contemplarlo. Era profondamente contenta di vederlo, di ascoltarlo e di averlo lì. Non lo capiva. Egli si tormentava. Oh, era malato, paralizzato. Tutto sarebbe migliorato lentamente. Amarezza, amarissima amarezza, quando sarai la mia cara sorella.
SCIPIO SLATAPER
Nella mia città facevano dimostrazione per l’università italiana a Trieste. Camminavano a braccetto, a otto a otto; gridavano: viva l’università italiana a Trieste, e strisciavano i piedi per dar noia alle guardie. Allora mi misi anch’io nelle prime file della colonna, e strisciai anch’io i piedi. S’andava cosí giú per l’Acquedotto. A un tratto la prima fila si fermò e dette indietro. Dal caffè Chiozza marciavano contro noi in doppia, larga fila i gendarmi, baionetta inastata. Marciavano come in piazza d’armi, a gambe rigide, con lunga cadenza, impassibili. Ognuno di noi sentí che nessun ostacolo poteva fermarli. Dovevano andare avanti finché l’Imperatore non avesse detto: halt! Dietro quei gendarmi c’era tutto l’impero austrungarico. C’era la forza che aveva tenuto nel suo pugno il mondo. C’era la volontà d’un’enorme monarchia dalla Polonia alla Grecia, dalla Russia all’Italia. C’era Carlo Quinto e Bismarck. Ognuno di noi sentí questo, e tutti scapparono via interroriti, pallidi, spingendo, urtando, perdendo bastoni e cappelli.
Io rimasi a guardarli con meraviglia. Marciavano dritti avanti, senza sorridere, senza ridere. La gente che scappava era per loro lo stesso che la compatta colonna che marciava per l’università italiana. Io rimasi fermo a guardarli, e fui arrestato.
Un gendarme mi prese per il polso sinistro e andammo. Era una cosa molto strana. Egli continuava a camminare del suo passo; io cercavo d’imitarglielo. Gli occhi della gente che passava mi percorrevan tutto come gocce fredde nella schiena, dandomi un brivido, tanto che il gendarme pensò: Der Kerl hat Furcht. Ma forse non pensò niente, e continuava a camminare del suo passo. Ricordo benissimo che un giovanotto passando estrasse la destra inguantata per arricciarsi il mostacchio destro, poi tirò fuori la sinistra per arricciarsi il mostacchio sinistro. Io avevo voltato la testa per vederlo, sí che, il gendarme procedendo, mi sentii tirare avanti. Una donna, con un bel boa, torse gli occhi, ma vidi che rideva. Perché mi lascio condurre da questo imbecille?
Ha le spalline grosse, giallonere. Perché non lasciarmi condurre da lui? Si va dove non so, ma non è necessario ch’io sappia. Mi conduce lui, svolta, scantona, e i miei piedi si pongono sempre paralleli ai suoi. La baionetta scintilla molto lucida. È carico il tuo schioppo?
Perché non mi risponde? E un garzone di beccaio, invece di far due passi di piú, salta oltre la panca di passeggio, e il grembiule macchiato di sangue vecchio si gonfia e sbatte svolazzando. Appena siamo passati ci guarda e urla: “Dèghe al giandarmo!”. Scappa.
Io vedo bene pulsare l’arteria nel collo di questo imbecille. E le mie mani sono molto lunghe, e sono come ossa ai polpastrelli. E non c’è gente. Alboino… Ma io sono piú che Alboino. Io sono piú che Bismarck.
Riferimenti
Hans Carossa, Rumänisches Tagebuch (Diario rumeno), in Sämtliche Werke, Frankfurt a.M., Insel-Verlag, 1962, in Mario Schettini (a cura di), La letteratura della Grande Guerra, Milano, Sansoni, 1968, pp. 989-991, traduzione di M.T. Mandalari. Stefan Żeromski, Charitas (Dalla trilogia Lotta con Satana, 1916-1919), III ed., Warszawa, Czytelnik, 1956, Schettini, cit., pp. 1107-108, traduzione di Andrzej Zielinski. Alfred Döblin, Teuere Heimat, sei gegrüsst (Ti saluto, patria diletta), in Bürger und Soldaten 1918 (Borghesi e soldati 1918), Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 1939, Schettini, cit., pp. 531-41, traduzione di M.T. Mandanari. Scipio Slataper, Il mio Carso (Libreria della Voce, Firenze 1912), il Saggiatore, Milano 1965, pp. 45-47.
L’immagine
Cane con maschera anti-gas. Da Internet Archive Book Images.

di Francesca Fiorletta
«Che ore sono?» disse Michèle sbadigliando.
«Insisti, dopo tutto quello che ti ho detto?» rispose Adam.
«Sì, che ore sono?».
«È l’ora in cui, chiara nella notte, vaga intorno alla terra errante con la sua luce altèra…»
[Il verbale, J.M.G. Clézio, :duepunti edizioni]
Il tempo non c’è, non avanza mai, s’è perduto, piano piano, il tempo.

di Giorgio Nisini
Margherita era stata una specie di “calamita dell’attenzione”, aveva ridato di colpo densità alle cose presenti, consentendomi di attraversare la fase finale della mia adolescenza senza perdere definitivamente il contatto con la realtà.
Jan Reister
Oggi è la giornata mondiale del backup, nota anche come la giornata del senno di poi. È dedicata alle persone che hanno perso per sempre i loro dati, non hanno mai fatto un backup e per soprammercato vengono redarguiti dai loro amici supponenti che hanno sempre un backup (due, tre) delle loro cose.
Ho visto capitare di tutto: il nonno a cui è stato rubato il laptop con tutte le foto dei nipotini, lo scrittore con una consegna tra un mese e l’hard disk rotto, la ricercatrice a cui un virus ha cancellato i documenti di due anni di lavoro, l’architetto che perde tutti i progetti, fatture e foto dei figli, e nessuno di loro aveva pensato a mettere al sicuro una copia dei dati.
Questo articolo è dedicato alle persone normali e ottimiste, che usano un computer senza essere esperte di informatica. A loro dico: fai un backup ora!
Chiudi gli occhi e immagina che il computer che usi scompaia nel nulla: rotto, rubato, cancellato per sbaglio da tuo figlio. Ne hai bisogno, ne compri un altro: di cosa hai bisogno per ricominciare una vita normale? Ti servono ad esempio i documenti di lavoro, le fatture, l’archivio della tua posta, i dati dei clienti, le password che usi in rete, le foto dei figli, la musica, i film introvabili che hai scaricato. Questi sono i dati che vuoi salvare perché siano sempre disponibili in caso di bisogno. Pensa a dove si trovano.
Vai in un negozio di informatica e compra un disco esterno USB. Ce ne sono di vari modelli e dimensioni, ma tu compra il più economico che trovi. Ignora le funzioni aggiuntive, prendi il più economico.
Meglio ancora: prendine due.
Collega il disco al pc e copia tutti i dati. Copiali ogni giorno, ogni settimana, ogni mese.
Noterai che è molto lento e noioso ricopiare tutto ogni volta, per questo esistono dei programmi specializzati che rendono la cosa facilissima:
Per ciascun sistema operativo, segui le istruzioni dettagliate sul sito del wordl backup day. O fatti aiutare da un amico.
Salva i dati anche sul secondo disco, ma con tempi diversi (una volta al mese per esempio) e conserva il disco in un luogo separato. Avrai una copia di emergenza anche nel caso che i dati vengano alterati sul primo backup (ad esempio da un virus come cryptolocker).
Se sei una persona esperta, puoi come configurare un backup remoto via rete. L’idea generale consiste nel salvare i tuoi dati su un server esterno, tramite Amazon S3, Dropbox, Tahoe LAFS, Crashplan, BTsync, Syncthing eccetera. La parte esperta della cosa è che dovrai cifrare i tuoi dati prima di trasferirli, pensare a un meccanismo di recupero della chiave di cifratura separato dal recupero dati, e molte altre cose. Se ti interessa, discutiamone nei commenti.

–
L’immagine ritrae Bruce Schneier, scettico, esperto di sicurezza, crittografo e divulgatore.
Mi dico: non temere questi fogli,
togli da sopra i risvolti
di polvere e memoria:
di quello che hai scritto per lei
non svelano niente.
Del resto d’inchiostro sulla carta,
dalla tua penna a una frase
di distanza, non fanno parola:
fanno che passi il momento
di ogni altra tua storia.
***
Tentando un inventario
di noi stessi tra le cose
spogliamo con lo sguardo
il superfluo di cui siamo
le parti meno necessarie –
nelle forme di un’incolmabile
scadenza ne tiriamo le somme
e l’eccedenza tra i rifiuti
da non differenziare.
***
Ridire ad alta voce
nomi comuni di cose ancora mie
pronunciarli con la lettera maiuscola
e un’inflessione disattenta
di piacere
dicendo ci sono
coniugare un luogo un tempo e due persone.
***
Le cose restano quiete,
soprammobili di fronte alle prese
del vuoto:
una disattenzione ai movimenti
le circonda, solide e ferme
per troppa mancanza di assenza.
Non tutte a pelle
sopportano il contatto:
di colpo reagiscono, di scatto
si lasciano cadere.
***
Constatazione di un oggetto
che non sia nuovamente
anomalia della memoria
la sola cosa che resista
al pensiero e non si muova
per finire dubbiosa
in un punto della mente
così interrogativo.
Mi chiedo chi resti senza me
di questa cosa, per quanto
debba ancora servire –
se anche una cosa senza vita
possa infine morire.
All’orizzonte
di
Milo Busanelli

All’imbarco nessun problema, durante il volo neanche, poi lei scopre di aver dimenticato la guida. Lui non si scompone: rimarranno tutto il tempo sull’isola, sempre nello stesso resort, al più cambiando spiaggia. La guida è inutile.
Usciti dall’aeroporto vedono gli altri turisti che salgono sui taxi, contrattano con i tuk-tuk, partono a piedi anche se a portata di sguardo non c’è nulla, solo terra, piante tropicali, una striscia d’asfalto, niente sabbia, niente mare, i vestiti che si appiccicano alla pelle per il caldo umido, un ronzio d’insetti senza insetti, la stanchezza del viaggio e dei giorni precedenti, fatti di preparativi e lavoro straordinario per tornare col minor carico di arretrati possibile.
Si aspettano un cartello con il loro nome, ma non ci sono cartelli. Lui controlla più volte l’orologio, allora lei chiede informazioni a quelli che sembrano saperla lunga, fa qualche gesto in aria per spiegarsi meglio, ma loro scuotono la testa.
Poi sbuca un omino che li conduce a una jeep malridotta ma lavata di fresco e ai rimbrotti del cliente risponde che c’è stato qualche problema. Lui chiede quale, ma l’altro è concentrato a evitare le buche. Allora commenta che come inizio lascia a desiderare, ma lo fa nella propria lingua.
Il resort è come se l’aspettavano, se possibile anche meglio, ma lui si lamenta di una macchia sul tappeto. Una cosa è chiara: non vogliono tornare più stanchi di quando sono partiti. Poi vogliono tornare abbronzati e con qualcosa di esotico da raccontare.
A pranzo ci sono diversi tavoli vuoti, eppure credevano fosse tutto esaurito. Un cameriere biascica che qualcuno preferisce mangiar fuori. Il pesce, comunque, è ottimo, ma per sicurezza si fanno portare un’altra bottiglia d’acqua perché il tappo non sembra sigillato. Anche la seconda bottiglia ha lo stesso problema, allora bevono il vino d’importazione.
Dopo una pausa per la digestione si dirigono alla spiaggia privata. La giornata è soleggiata, le nubi sono poche e rompono la monotonia del cielo. La sabbia è bianca, finissima, morbida al tatto. Riconoscono alcune persone che hanno visto a pranzo, persone che sono lì per rilassarsi.
Si coprono di crema solare, quindi si lasciano andare. Ogni tanto passa qualche inserviente che senza disturbare raccoglie gli ordini. Chiedono da bere un paio di volte, guardano il mare, ma per fare il bagno aspettano domani. Il sole non è ancora sceso che qualcuno se ne va e dopo un po’ spariscono anche gli altri. Nel giro di mezz’ora la spiaggia è deserta.
La cena è molto simile al pranzo, ma con portate diverse. Non è male avere lo stesso tavolo; gli risparmiano la fatica di scegliere. Alla seconda portata una coppia poco lontana comincia a litigare, ma in un’altra lingua. Lui spera che qualcuno intervenga per farli smettere oppure li consigli di continuare in camera, poi pensa che potrebbe essere di fianco alla loro. Anche gli altri commensali sembrano infastiditi, ma nessuno fa niente, nemmeno i camerieri. La coppia smette di vociare e continua a mangiare in silenzio.
Tornando verso la stanza incrociano un tizio che li saluta e chiede per quanto tempo intendono fermarsi. Lui risponde di malavoglia. A lei sembra carino ricambiare con la stessa domanda. L’estraneo è lì da una settimana e dovrebbe restare un mese, ma se ne andrà tra due giorni. Lui chiede perché. L’altro risponde che è il primo volo disponibile. Lei vorrebbe fare altre domande, ma lui dice che sono un po’ stanchi.
La notte passa senza fastidi, finché si sveglia per una zanzara. Setaccia la stanza e la sveglia. Con quello che hanno pagato, inizia a dire, poi torna a letto, ma poco dopo la sente di nuovo. Lei sbuffa, non ci possono essere zanzare con l’aria condizionata. Lui dice di non trattarlo da stupido, la zanzara c’è, l’ha sentita durante il sonno e da sveglio. Ma non l’ha vista. Altrimenti l’avrebbe uccisa. Dopo un po’ qualcuno bussa con forza alla parete, allora si alzano per fare colazione, ma è troppo presto.
Quando scendono in spiaggia si accorgono che è meno frequentata del giorno prima, ma poco importa. Entrano in acqua, lei propone di fare snorkeling, ma per lui è meglio aspettare, se fanno tutto subito rischiano di stancarsi. Centellinano le bracciate nel mare basso, calmo e limpido che hanno già visto in foto, solo che in foto era più trasparente.
Una volta usciti l’aria si è rinfrescata. Stanno tutto il giorno al sole, ma nel pomeriggio lei entra per prendere qualcosa da leggere. Mentre cerca in valigia nota la zanzara sopra la testiera del letto. La schiaccia con i sandali, pulisce la macchia, poi esce.
Lui non c’è più, forse è andato in bagno. Dopo qualche minuto lo cerca. Gira la spiaggia, torna dentro, chiede se l’hanno visto, alla fine lo trova sdraiato dov’era. Comincia a leggere, ma si annoia. Controlla se è possibile connettersi alla rete, ma sono troppo lontani. Dovrebbe rientrare, ma le sembra stupido, allora ferma un inserviente e domanda se hanno i giornali. Quello chiede in quale lingua. Lei risponde e l’altro scuote la testa. Allora chiede cos’hanno. Il ragazzo snocciola un elenco e lei lo lascia andare.
Realizza di essersi addormentata quando sente una goccia sulla coscia. Controlla il cielo: le nuvole sono lontane, il mare è distante, lui sta dormendo. Eppure la goccia c’è, ma tra poco sarà asciutta; se lo raccontasse non le crederebbe nessuno. Uno scherzo, certo, cos’altro potrebbe essere.
A cena c’è qualche tavolo vuoto in più e qualche cameriere di troppo, ma il cibo è sempre buono. Lei chiede se ci sono altri ristoranti in zona. Lui commenta che non lo sa, a quello serve la guida. Lei si trattiene dal rispondere, prova a collegarsi di nuovo, ma non c’è rete. La signora del tavolo accanto dice che manca da quella mattina e nessuno sa il perché. Lui sbotta che non ha intenzione di perdere tempo su internet, lo usa per lavoro e nel tempo libero, l’ha usato per venire qua, ora vuole rilassarsi. Potrebbero almeno capire cosa sta succedendo, fa lei, ma per lui non sta succedendo nulla, sono in vacanza e basta.
Dopo il dessert pensa che con tutte queste disdette avranno un’altra camera libera. La ottiene, sembra uguale alla prima, ma il tappeto è intonso. Traslocano, poi lei propone di uscire, lui chiede perché, lei non sa rispondere, poi ammette che ha voglia di fare due passi. Lui scuote le spalle.
Si aggira da sola per i corridoi senza sapere dove andare, le porte sono chiuse, poi si ferma al bar. Le luci volteggiano sulla pista, ma nessuno muove un passo. Ogni tanto una mano porta il bicchiere alla bocca. Lei sceglie un tavolino; due signori vestiti da giovani la raggiungono.
Che senso ha una vacanza senza divertimento, dicono. Lei cerca una scusa qualsiasi per andarsene. Uno di loro chiede se quell’uomo è suo marito e lei risponde di sì, qualcosa del genere. L’altro trattiene una risata e il primo le scrive il numero della loro camera. Se avete bisogno di qualcosa, dice. Lei ringrazia, ma sono a posto, allora quello fa presente che manca l’ingrediente principale, così, nel caso si annoiassero, sanno dove trovarli.
Tornata in camera racconta tutto, ma lui non capisce dove vuole andare a parare, infine lo chiede e lei non sa rispondere. Si sdraiano e aspettano di addormentarsi, ma restano svegli.
Il giorno dopo anche il personale è diminuito. Tutta quella servitù in piedi mi dava noia, commenta lui. Lei vorrebbe dire la sua, invece propone di cambiare spiaggia. Chiede se vuole fare snorkeling. Sì, ma preferisce farlo da un’altra parte. E se viene a piovere? Lei guarda il cielo e riconosce che è nuvolo, ma non al punto da temere un acquazzone, anche se nella guida c’è scritto, lo ricorda bene, che il tempo può cambiare senza preavviso.
Alla fine fa snorkeling al largo della solita spiaggia. Avvista un paio di pesci, ma non sa come chiamarli. Si chiede quali pesci conosce, li elenca, ma si ferma subito. Chissà se c’è un istruttore anche per questo. Sbatacchia le pinne per un po’, poi capisce di non essere allenata e torna sulla terraferma. Quando lui la vede smette di parlare e torna a sdraiarsi.
Restano così, poi lei chiede chi era. Una che lavora al resort. Fanno lavorare anche le ragazzine, domanda lei, ma non è una domanda. Lui scuote le spalle; per quel che ne sa potrebbe essere maggiorenne. Una cosa è certa: con questo sole la crema non serve.
Dopo essere rientrati in camera escono subito, lui di fretta, lei dietro. Alla reception non c’è nessuno; lui suona il campanello più volte. Dopo un po’ arriva un tale, ma non è quello degli altri giorni e non conosce la lingua. Quando riescono a farsi capire quello dice che provvederà o almeno sperano. Con quel che pagano è assurdo che non abbiano cambiato la carta igienica.
Viene l’ora di cena e lei chiede di scambiarsi i posti; non vuole dare le spalle alla sala. In ogni caso non c’è molto da vedere: i pochi che rimangono si guardano intorno alla ricerca di quelli che mancano e ogni tanto incrociano gli occhi. Lui alza e abbassa la forchetta, anche se è usanza mangiare col cucchiaio.
Tornati in camera trovano la carta igienica, ma l’aria condizionata non funziona. Lui è pronto per tornare all’attacco, ma secondo lei basta lasciare la finestra aperta. E le zanzare? Lei indica la zanzariera. Lui si avvicina per verificare che non ci siano buchi. Alla fine si sdraiano perché sono stanchi.
La mattina dopo si alzano più tardi del solito e si preparano a rilento. Lui chiede com’è lo snorkeling, lei risponde che preferirebbe un’altra spiaggia. La guida ne indica una, ma non ricorda quale.
Usciti dalla stanza fanno tutta la strada che li separa dalla colazione senza incontrare nessuno e una volta arrivati non c’è nemmeno la colazione. Anche in cucina non c’è niente e alla reception hanno tolto il campanello. Lui urla qualcosa, ma si sente solo il riverbero, allora corre fuori mentre lei cerca di calmarlo, in fondo non ha fame. Io invece sì, grida.
Fuori è tutto come al solito: il porticato, le piscine, il campo da gioco, la spiaggia, solo più vuoti. Gli ombrelloni ondeggiano per il vento e qualche sdraio è rovesciata. Lui si getta là in mezzo, la sabbia che si solleva e viene spazzata via. Poi lei vede una nuvola nera che si avvicina.
Allora lo capisce, quel che sta per accadere.
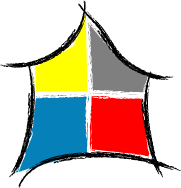 XXV Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana
XXV Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana
CITTÀ IN TRASFORMAZIONE
Risanamento e riuso. Periferie e aree dismesse. Spazi pubblici e mobilità urbana
Camerino 29 luglio – 2 agosto 2015
Palazzo Ducale – piazza Cavour
***
Temi di progetto e di conversazione
Le dinamiche sociali, politiche ed economiche in atto richiedono un cambiamento a volte radicale degli assetti consolidati delle città. Nuovi modi insediativi e mutate dimensioni d’uso degli spazi urbani, non più corrispondenti alla forma fisica e alle capacità prestazionali originarie della città, impongono una riflessione critica sullo stato di fatto e un atteggiamento aperto a programmi di rinnovamento.
Progetto, innovazione e modelli di governance inclusivi delle aspettative delle multiformi comunità insediate, insieme al risparmio delle risorse naturali, sono il terreno di coltura della nuova architettura sociale, volta alla riqualificazione delle periferie e delle aree dismesse, alla ridefinizione degli spazi pubblici e della mobilità urbana, al risanamento e riuso degli edifici abbandonati e dei comparti edilizi fatiscenti.
Programma
Le giornate di studio comprenderanno sessioni con brevi relazioni programmate, comunicazioni e conversazioni interdisciplinari alternate a laboratori all’interno dei quali tutti gli iscritti potranno presentare i loro lavori e confrontarsi sui diversi aspetti dei temi progettuali proposti. Sarà allestita la mostra delle opere presentate dai partecipanti al premio con relativo catalogo.
Nella giornata conclusiva saranno assegnati gli attestati di partecipazione e i premi SACU 2015.
Il seminario comprenderà la Festa camerte dell’Architettura con eventi d’arte, allestimenti e incontri conviviali. Una monografia del seminario sarà pubblicata su ARCHITETTURAeCITTÀ, Di Baio Editore.
Per informazioni:
Segreteria
Seminario di Architettura e Cultura Urbana
c/o Punto Informativo UNICAM, Palazzo ducale – 62032 CAMERINO
numero verde 800 054000 – tel. 0737 402000
fax 0737 402055
puntoinformativo@unicam.it
www.unicam.it/culturaurbana
Direttore
Giovanni Marucci
giovanni.marucci@unicam.it
ROBERTO ROSSELLINI
(…) Fantasia sottomarina, dalla maggior parte delle fonti filmografiche indicato come realizzato nel 1936-37, fu distribuito dalla INCOM soltanto nel 1940; tanto da far pensare che, a parte il Prélude (di cui si sono perse le tracce), gli altri due documentari di Rossellini siano stati realizzati alla fine degli Anni Trenta, fra il 1938 e il 1941, cioè nel periodo compreso tra la fine della lavorazione di Luciano Serra pilota di Goffredo Alessandrini (di cui, come vedremo, Rossellini fu aiutoregista e cosceneggiatore) e l’inizio di La nave bianca, il primo lungometraggio firmato da Rossellini. Marcella De Marchis ricorda: «Roberto intraprese un certo lavoro abbastanza regolare, anche come documentarista, grazie a un contratto con la INCOM. Cominciò con una favola marina molto bella, un documentario sui pescetti, Fantasia sottomarina». A questo riguardo occorre osservare che la INCOM fu fondata da Sandro Pallavicini soltanto nel 1938: ciò avvalorerebbe l’ipotesi che Fantasia sottomarina sia stata realizzata dopo quella data (se i ricordi della De Marchis sono esatti).
In ogni caso, esso fu un film girato in assoluta economia, quasi cineamatorialmente, con la collaborazione dei familiari (come spesso accadrà per gli altri film di Rossellini). È ancora Marcella De Marchis a ricordare: «L’avevamo girato in casa, a Ladispoli, montando una specie di acquario, con acqua di mare che filtravo con le lenzuola del mio corredo per farla più limpida. I pesci li prendevamo ogni giorno a Civitavecchia, e parecchi protagonisti morivano per strada: avevamo bisogno di molte controfigure. Quando morivano in scena, finivano a pancia all’aria, e allora dovevamo legare i pescetti con dei fili sottilissimi, e manovrarli con delle cannucce, da dietro i pezzi di roccia (…) Ci divertimmo un’estate intera con questo documentario».
L’operatore era Rodolfo Lombardi, il quale confermò, in una conversazione con Stefano Roncoroni, il carattere artigianale della produzione: «Il documentario è stato girato improvvisando, Roberto Rossellini, Rodolfo Lombardi, il terrazzo della casa Rossellini a Ladispoli, la luce del sole, il mare ed i suoi abitanti».
Già allora, insomma, si andava formando quello stile rosselliniano, quel suo modo di girare e di programmare la lavorazione, lasciando grande spazio all’improvvisazione durante le riprese, che sarà il suo proprio nelle opere della maturità. E già allora si andava manifestando quella «sensibilità minima» (sono parole di Rossellini) per le cose quotidiane, trascurabili, consuete, persino banali, che – una volta cinematografate – si animano sullo schermo di una vita propria, caricandosi di significati ulteriori. Così fu per i piccoli pesci di Fantasia sottomarina, per le loro piccole storie, che si inserivano in una struttura narrativa esile ma importante, che contrastava con la tradizione del documentarismo di quegli anni (ed anche in seguito). Non era, a vero dire, un’invenzione del solo Rossellini, perché la politica di Pallavicini alla INCOM fu proprio quella di svecchiare il documentario e renderlo più agile e spettacolare, facendo a meno del commento parlato fuori campo e puntando maggiormente sul racconto; ma certamente Rossellini fu il regista che meglio si mosse in questa direzione. Basti leggere quanto scrisse la critica, quando il film uscì sugli schermi agli inizi del 1940: «Non è quindi sulla voce del commentatore che va reggendosi nel suo svolgimento il breve film, quanto su una vicenda degli oggetti, degli animali, dei paesaggi stessi, che ha un suo logico inizio e una sua conclusione. Esempio tipico quella Fantasia sottomarina di Rossellini in cui le fredde vasche di un acquario si animano di una drammaticità umana con i suoi personaggi e con la sua vicenda».Gianni Rondolino
Roberto Rossellini
UTET [1989]
 Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.
Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.