
Non dormire
di
Maria Luisa Putti
Questa notte non passa mai. Non riesco a dormire. È tanto tempo che il sonno mi sfugge come un’ombra inafferrabile. Riesco ad addormentarmi appena, ma dopo due ore ho di nuovo gli occhi aperti, per fissare il bianco del soffitto, la luce che filtra dalle finestre, le pareti e le tende immobili, che a forza di guardarle cominciano a ondeggiare, quasi potessero venirmi incontro.
Sul muro mi sembra di scorgere il corpo di un uomo, racchiuso nella geometria perfetta di un quadrato, anzi no, di un cerchio, o di tutt’e due insieme. Mi pare di intuire le proporzioni esatte di un essere umano.
Tutto quello che ho pensato, le cose che ho disegnato, i sogni che ho creduto di avverare fingendoli sulla tela ora sono lì, sulla pietra fredda che mi si stringe addosso. È come se l’intonaco si sgretolasse, e crollasse, un frammento sull’altro. È carta che si strappa, metallo che si scioglie.
Ora il suo sorriso si deforma. Vedo anche quello sul muro adesso. Si sgrana, si slarga, come una bocca che si spalanca, una ferita. Una frase dietro l’altra, me le rigiro tutte le parole che mi ha detto in questi anni.
Come diceva? «Sei il mio amore». Non so se posso crederle. Sorrideva, e cercava qualcosa sul pavimento della mia stanza, frugando con quel suo sguardo da ragazzina, che sembra voler afferrare tutta la bellezza del mondo e catturarla per sempre. Allora si è chinata e ha raccolto una cosa così piccola che la teneva in un pugno. E poi ho visto che infilava la mano nella tasca della gonna. Mi prende in giro, sì. E poi cos’è che nascondeva in quella tasca? Ma io non faccio mai caso a nulla quando lei è così vicina. Dopo però, quando resto solo, ho la sensazione che si sia portata via la stanza intera, qualcosa di me stesso che arriva insieme a lei e con lei se ne va.
Sollevo appena la testa dal cuscino, e mi vedo riflesso nello specchio appeso alla parete di fronte al letto. Non sopporto più l’immagine della mia stanchezza, il viso segnato da anni di rovelli che mi tolgono il sonno. «Come sei bello», mi diceva. Ma forse anche quella era una bugia. Lei è bella, anche se non lo sa. Non sa nulla dei pensieri che mi tormentano, di quanto siano importanti per me tutte le sue parole, le cose che mi dice e quelle che non mi dice, e tutto ciò che immagino poi, quando non c’è, e i sogni che la riguardano, che non potrò mai dirle. Si muove e mi guarda con l’incertezza di una bambina, come se volesse chiedermi ad ogni passo una conferma: «Sei la più bella di tutte».
Si son fatte le tre. Devo cercare di dormire, fino alle sei almeno. Mi angoscia vedere le luci dell’aurora che rendono azzurra tutta la stanza. In quel momento, tra la notte e il giorno, sembra tutto finto, e ho sempre freddo, persino d’estate. Vorrei congelarmi nell’istante preciso in cui le prime luci del mattino filtrano dalla finestra, invece resto sveglio, cercando di afferrare il sonno per qualche ora, e mi abbrutisco avvitandomi sui ricordi, su dettagli insignificanti, perché i momenti che veramente voglio sono così rari che si riducono a pochi spiccioli, che conto e riconto mille volte per moltiplicarmeli dentro, e così li sbrano, li anniento, li perdo.
Questa è la mia prigione; una gabbia d’oro dalla quale non so e non posso evadere. Vorrei tanto essere uno qualunque, partire per un viaggio in cui sentirmi libero, starmene da solo, o con lei. Ricordo da bambino tutti che dicevano: «Il ragazzo ha talento», e io avevo paura di deludere mia madre, mio padre, i miei maestri. Non riesco nemmeno a godermi il lato lieve di quello che chiamano successo, ché già sto pensando a ciò che dovrò fare, ancora e ancora, per continuare a essere me, a non deludere.
Dicono che ho tante donne. Non è vero. Sono fissato nel pensiero di lei, che non si rende conto di nulla. È un pensiero che non mi lascia mai, e che non mi dà pace.
Mi ricordo che a un certo punto le ho fatto una carezza in pieno viso e lei è diventata rossa. «Nessuna donna arrossisce più ormai…». È stata questa la frase che le ho detto subito dopo, e il suo viso si è fatto più rosso ancora. Allora ha nascosto le guance tra le mani. Si vedevano solo gli occhi, e a me sembrava di ritrovare il volto di certe mie compagne di scuola.
Un angelo, ma per me è un incubo, perché non posso mai vederla, e me la immagino continuamente avvinghiata al corpo di qualcun altro, qualcuno che non conosco.
Certe volte, quando sono nel mio studio, mi convinco che in qualche modo lei mi stia guardando, che sia dietro di me, alle mie spalle. Allora mi volto d’un tratto, la cerco, ma lei non c’è.
«Tu sei mia. Tu sei la mia anima». Sono passati anni da quando le dissi questa frase, e ricordo il silenzio attonito del suo respiro. Lei se ne stava lì, incredula, immobile, sorpresa dalle mie parole. In quel momento potevo impazzire, e avrei voluto portarla via.
Di colpo mi sembra di non sapere più niente di lei. Però conosco a memoria i tratti del suo viso, la forma delle sue spalle, il profilo dei fianchi, la linea delle sue gambe, che nella mente ho ritratto mille volte, quando sovrappongo i miei pensieri, e i sogni, ai visi e ai corpi che dipingo. Se chiudo gli occhi sento pure i suoi capelli che mi sfiorano. Il fatto è che quando mi racconta qualcosa di sé, io mi lascio cullare dal suono della sua voce e quasi non l’ascolto. Mi incanto a guardare il riflesso della luce nei suoi occhi.
A me rimangono impresse solo le frasi che svelano i suoi sentimenti. Perché quelle parole nutrono la mia anima, riempiono i miei vuoti e alimentano le paure che mi vengono quando il giorno dopo resto solo e tutto mi sembra falso e non riesco più a crederle. Sono bravissimo a deformare e a distorcere le parole d’amore più belle; a farmi male trasformando la luce nel buio che ho negli occhi, sporcandone il ricordo, l’immagine assente, i pensieri. Certo che lei, con le sue carezze, mi fa del bene, e io fra le sue braccia mi sento al sicuro, e mi addormento. Ma quando poi mi manca, così tanto, mi convinco che il suo amore non esiste, che non è mai esistito; che lei è solo un corpo falso che svanisce.
Nei rari momenti che riesco a vederla, quando si stringe a me, sento che è tutto vero, che lei è mia solamente. Mi sfiora i capelli con le dita e mi guarda, piena d’amore, come se avesse sempre paura di deludermi. Invece sono io che deludo lei perché non riesco a darle niente. E quando resto solo, i pensieri mi scavano dentro, e io deformo la realtà fino a sgranarla, fino a quando tutti i miei demoni prendono forma e diventano vivi, e lei è uno di essi.
Eppure una parte di me lo sa che lei mi vuol bene veramente, per quello che sono, non per quello che rappresento. Un giorno, quando stava per uscire dalla mia stanza, ha provato a dirmelo, e in quel momento mi era sembrato bellissimo. Ma dopo sono riuscito ad abbrutire anche la purezza di quella frase e me la sono rigirata contro, fino a convincermi che in fondo non mi avesse mai capito. Non riesco a crederle, ma lei non c’entra. Sono io che non so più vivere come una persona normale.
Tempo fa l’ho vista che chiacchierava e rideva mentre camminava per strada con suo marito. Non ebbi nemmeno il coraggio di chiamarla, né di farle un cenno da lontano per salutarla come un qualunque conoscente. Lei non mi vide.
Nessuno può capire gli incubi che seguirono quell’incontro. Cominciai a immaginarla con quell’uomo. Credetti quasi di sentire la sua voce pronunciare parole d’amore per quello lì. Quell’estate fu un inferno, e così decisi che non l’avrei cercata più. Smisi di rispondere alle sue lettere e cominciai a farmi negare. Sapevo che le stavo facendo del male, ma era più forte di me. E così lasciai passare le settimane, i mesi, fino a ieri.
Ero andato a trovare certi amici che abitano dall’altra parte del fiume. Pioveva e mi ero fermato per ripararmi sotto un portico. Ho preso a camminare verso il negozio di fiori che sta proprio lì vicino, all’inizio del porticato, tra la tabaccheria e la vetrina del giornalaio, e d’un tratto me la sono trovata davanti. In un attimo i suoi occhi si sono gonfiati di lacrime, mentre cercava di sorridermi. Non ha detto nulla. Io non ho detto nulla. L’ho guardata soltanto, negli occhi, tanto, e poi ancora, negli occhi. E anche lei mi guardava. Era pallida in viso, come se dentro di sé, di nascosto, stesse combattendo una battaglia per sopravvivere, come se stesse cercando, disperatamente, di sconfiggere una malattia. Allora, d’un tratto, il ricordo delle sue guance arrossate mi ha dato una fitta di nostalgia. Mi sento in colpa. Prigioniero della mia insicurezza, intrappolato nei deliri della mia solitudine, ho fatto soffrire l’unica donna che mi abbia mai veramente amato. Ma forse non è tutto perduto. Ieri sera i suoi occhi sembravano volermi dire ancora «Sei il mio amore. Tu sarai sempre il mio amore». Sì, ne sono sicuro. E allora domani tornerò a cercarla. Domani, quando l’azzurro dell’aurora si sarà fatto chiaro, e ci sarà il sole. Sì, lei mi ama ancora ed io la cercherò di nuovo. Allora lei mi sorriderà, mi guarderà e mi stringerà più forte. Domani, lo farò domani.
Ora le pareti della stanza sembrano essersi fermate. Solo la tenda si muove appena. Le immagini che vedevo rincorrersi sul muro fino a un attimo fa lentamente si sbiadiscono. Il mio corpo pesa di una stanchezza antica. Lascio cadere le mani esauste e mi abbandono sul lenzuolo fresco di primavere insonni. Di colpo non penso più a niente, solo al momento in cui la stringerò di nuovo. La mia mente piano piano si svuota. Chiudo gli occhi. Le sue mani sembrano potermi toccare davvero.

 Davide Vargas, Racconti di architettura, tullio pironti editore, 124 pag.
Davide Vargas, Racconti di architettura, tullio pironti editore, 124 pag.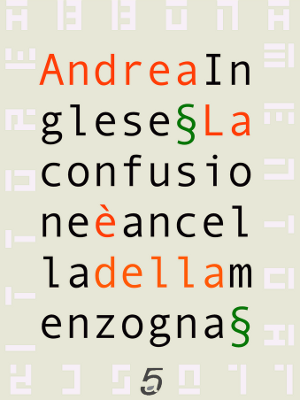







 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo




