 Ippolita
Ippolita
Nell’acquario di Facebook. La resistibile ascesa dell’anarco-capitalismo
56.478 parole, 391.364 battute sul web ed in formato ebook.
Negli ultimi dieci anni Internet ed il web 2.0 hanno ridefinito le relazioni sociali, almeno per quella parte dell’umanità al di qua del divario digitale. La possibilità di comunicare annullando tempi e distanze si è realizzata attraverso software di facile uso e con una diffusione di massa (google, wordpress.com, facebook etc.). Sono questi software di massa, incarnati nei principali prodotti di social network, che danno forma alle nostre esperienza sociali in rete e che imprimono ai nostri comportamenti forme dettate dalle scelte progettuali e dalle visioni culturali delle aziende che li hanno creati.
L’idea che la rappresentazione ideale di noi stessi in rete sia una pagina con una foto ed una scheda personale è un’evoluzione logica della rubrica telefonica o del rolodex, ma non è per nulla naturale o assoluta. E’ il frutto di una serie di scelte libere da parte dei progettisti dei vari servizi web, e di scelte più coatte di noi utilizzatori di questi servizi. Noi viviamo in una rete plasmata dal liberalismo economico, dal pragmatismo tecnologico e da ideali di trasparenza e meritocrazia, e queste idee influenzano le nostre azioni ed il nostro modo di pensare la presenza in rete.
In queste riflessioni si inserisce il pamphlet del gruppo Ippolita Nell’acquario di Facebook – La resistibile ascesa dell’anarco-capitalismo. Il testo prende le mosse dalla critica della socialità in rete quando essa si svolge all’interno di silos applicativi autoreferenziali, siano essi aziendali come Google, Facebook o Amazon, o noprofit e aperti come nel caso di Wikipedia. Oltre gli argomenti classici della net-critique, la posizione di Ippolita è fortemente politica, anticapitalistica e critica nei confronti del libertarismo di destra diffuso in USA (libertarianismo). La via di uscita è utopica, non c’è salvezza nelle tecnologie, occorre costruire con le proprie mani piccole comunità e gruppi capaci di incontrarsi di persona, sapendo che nella rete non possiamo fare a meno di stare se vogliamo essere noi stessi.
Nella prima parte del libro viene proposta una critica dei social network e di Facebook in particolare. Vengono analizzati i limiti esistenziale, psicologici ed individuali della socialità facebookiana, una realtà semplificata, impoverita e illusoria in cui la persona è merce.
Web 2.0 e social network sono concentratori di servizi di massa in una rete di per sé destrutturata, attraverso cui viene esercitato un enorme potere di omologazione. Dato che la rete pone minime barriere di accesso all’informazione, che non è quindi monetizzabile direttamente, l’unico modo per mettere a valore i propri servizi è stimolare l’accesso continuo all’informazione e la produzione continua di contenuti che ci definiscano. Questo genererà degli schemi di comportamento, dei profili personali monetizzabili in massa in vario modo. E’ il passaggio da Google motore di ricerca in una rete illuministica di documenti che riportano a persone, a Facebook concentratore turbocapitalista di una rete di persone diventate merci e come tali scambiate e rivendute.
Alla base dello stimolo affinché noi produciamo contenuti ed interazioni continue è l’idea che la trasparenza, l’apertura e condivisione siano sempre positivi, desiderabili, socialmente vantaggiosi. Condividere continuamente informazioni su di sé, ovviamente in chiave favorevole come accade in Facebook, porta però all’appiattimento delle differenze, al depauperamento dei saperi ed alla distruzione della complessità multiforme dell’individuo. Il conflitto viene semplicemente nascosto, scivola nel privato dove ciascuno può sorvegliare la figura in rete degli altri ed indulgere nel pettegolezzo.
Mentre Ippolita analizza bene la psicologia dell’essere in rete, mi pare che insista in modo forse un po’ cattolico sulla psicologia personale del rapporto coi social network: siamo narcisisti, quindi ci esibiamo e spiamo morbosamente le esibizioni altrui, in un ambiente software costruito appositamente per facilitare questo continuo pornoshow. Credo però che si debba considerare anche quanto l’ambiente software sia parte attiva nell’indirizzare il nostro comportamento, in particolare con l’uso plateale di tecniche di psicologia behaviorista (skinneriana). Ad ogni azione gradita a Facebook riceviamo un rinforzo, ad ogni dato personale che regaliamo riceviamo un premio, l’ammirazione dei pari, il sostegno degli amici; nei tempi morti c’è sempre un giochino per tenere desta l’attenzione ed assicurare che non abbandoniamo il recinto dentro cui siamo pienamente osservabili.
Farei anche una distinzione tra la critica dei problemi ontologici dei social network e quella del disegno del software. Se si critica la relazione di amicizia in Facebook perché è univoca, inadeguata a distinguere tipi diversi di relazione e di ambito sociale, si rischia di venire spiazzati da nuove funzionalità o nuovi prodotti: esiste infatti da tempo il concetto di “circoli” (come li chiama Google+) o di “liste” (in Facebook) che permettono di disegnare ambiti di persone “amiche” separati però tra loro. E’ meglio secondo me concentrarsi sul problema fondamentale di Facebook e simili: le relazioni sociali su Facebook sono piatte e superficiali perché il loro scopo è gratificare, servire, garantire la stimolazione. Avere una presenza personale sul web con la quale interagire socialmente ci spinge a semplificazioni che nella socialità quotidiana gestiamo in modo molto più sfumato e complesso. Sarà interessante vedere come viene affrontato questo problema in Diaspora, un social network distribuito e open source che non ha i problemi di privacy di Facebook, anche se a quanto ho visto finora l’impostazione progettuale è la medesima (io, la mia foto, i miei amici, i miei interessi).
La seconda parte del libro è una critica politica e filosofica al pensiero right libertarian (libertariano) che in USA gode di grande popolarità negli ambienti finanziari e imprenditoriali delle aziende ad alta tecnologia. Le idee di Murray N. Rothbard, Robert Nozick, Ayn Rand sono forse poco note in Italia e sono per certi versi difficilmente classificabili con gli schemi tradizionali destra/sinistra: vi sono uniti il concetto di libertà individuale come bene supremo da perseguire, il rifiuto dei vincoli sociali e statali visti come un freno distorcente per l’individuo, l’adozione della razionalità utilitarista come motore degli scambi sociali, l’idea che il mercato capitalista sia il luogo in cui la società possa veramente prendere libera forma.
Negli anni ’90 questa corrente di pensiero vede nelle tecnologie informatiche lo strumento con cui realizzare le promesse di una nuova società basata sui liberi individui, sul libero ed efficiente scambio di informazioni, sulla nuova economia razionale e frictionless. Esempio di questa mentalità anarco-capitalista è Peter Thiel, fondatore di Paypal e iniziale finanziatore di Facebook, nella cui visione si fondono feroce darwinismo sociale, illuminata meritocrazia, fiducia in un capitalismo senza regole, individualismo libertario. L’individuo libero in un mercato senza attriti per realizzare se stesso ed i suoi desideri è al centro delle aziende che Thiel contribuisce a creare per estrarre valore dai dati aggregati di milioni di individui, attraverso la tecnologia informatica.
Quel che trovo interessante non è tanto la critica della filosofia libertariana, un pensiero per certi versi ingenuo, astorico e semplicista, quanto la proposta di cercare analogie, influenze e contatti in campi adiacenti. Per esempio la cultura hacker, fatta di pragmatismo, informalità ma anche di forte meritocrazia (esattamente come nelle migliori università statunitensi) ha molti elementi in comune con la filosofia californiana, non ultimo il fatto che è vissuta da giovani maschi bianchi (la cosa mi da fastidio e mi affascina, dato che sono un rappresentante di questa specie). Una altro campo di analisi sono i nuovi movimenti politici dei Partiti Pirata in Svezia e Germania, centrati sul libero scambio delle informazioni, sulla centralità delle libertà individuali e sorprendentemente privi di idee sul ruolo dello Stato e della società organizzata, al di fuori di un apparente populismo (maschile, ancora una volta). Non poteva mancare infine un’analisi di Wikileaks, che sotto questa luce unisce etica hacker, ideologia del libero scambio informativo e gestione manageriale dell’informazione nella figura controversa di Julian Assange, apertamente libertariano.
Durante una presentazione del libro a Milano è stato interessante vedere il dibattito tra gli autori di Ippolita ed un lettore apertamente anarco-capitalista, che dal pubblico ha ingaggiato una ricerca di punti di contatto tra il pensiero anarchico libertario degli autori e la filosofia libertariana di Rothbard: molti punti di accordo, ma una differenza radicale nel concepire la libertà della persona, individuale e privata per Rothbard, collettiva e condivisa per Ippolita.
Che fare? La terza parte del libro affronta le teorie del cambiamento sociale reso possibile dalla rete, per confutare la “rivoluzione di Twitter” in Iran o il ruolo di Facebook nei movimenti sociali. La rivoluzione non verrà twittata e non va confusa con il comodo attivismo da poltrona, il clic facile e poco impegnativo che ci sgrava la coscienza tra una giocata e l’altra a Farmville. Viviamo in un mondo che unisce le distopie di Orwell e di Huxley, una rete di controllo capillare per potere essere liberamente noi stessi, esprimere il nostro potenziale, produrre e consumare dentro recinti invisibili e feroci.
Ippolita non ha soluzioni, non propone progetti “buoni” da opporre a Facebook, come Wikipedia o social network open source come Diaspora o Crabgrass. C’è una sfiducia radicale nella dimensione umana in rete, nella deformazione che il disegno del software, qualsiasi software, imprime sulle nostre vite. “Resistance is futile”, non possiamo adottare contromisure (anonimato, crittografia) né fare a meno della rete. Forse solo la socialità conviviale, fuori rete e in piccola scala potrà farci uscire dall’acquario ed aiutarci a costruire un mondo di relazioni veramente libere tra persone vere.
E’ la parte più sentita del libro, e quella che mostra anche i limiti della critica alla rete su basi principalmente ideologiche e politiche. Come nei capitoli precedenti anche qui si perdono occasioni di analisi su base tecnicnologica e informatica, la parte sulla crittografia è debolissima e non considera gli studi condotti su anonimato e anonymity set fatti per esempio intorno a The Tor Project, ma questo non è un pamphlet per imparare a usare Facebook in sicurezza, un how-to tecnico. E’ una chiamata alla riflessione, un’apertura di discorso contraddittoria ed appassionata, con una buona bibliografia nelle succinte note al testo ed una rara trasparenza di metodo.
Il libro verrà pubblicato in Francia per Payot & Rivages ed in Spagna per Enclave de libros, una piccola editrice di Madrid. In Italia è disponibile gratuitamente per la lettura sul sito Ippolita e come ebook a 7€, in formato epub e pdf. E’ sotto licenza aperta Creative Commons BY-NC-SA 3.0. Per ogni informazione www.ippolita.net
Recensioni:
Una recensione di Carlo Formenti su alfabeta2: Nell’acquario di Facebook
Ancora Carlo Formenti su MicroMega, con un diverso taglio: Nell’acquario di Facebook. Per una critica delle cyber utopie.
Daniele Salvini su MilanoX: Un’altra rete sociale è possibile


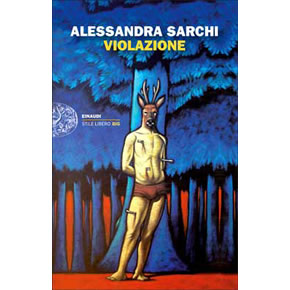 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo


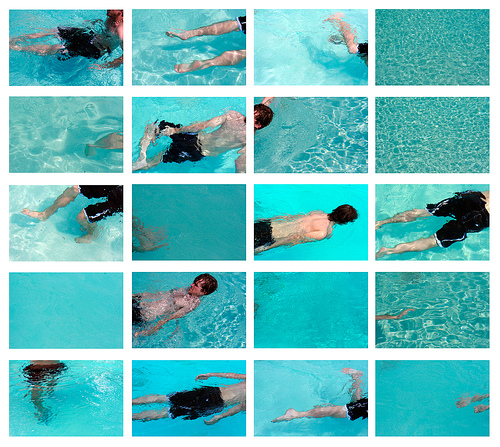




 di Severino Colombo
di Severino Colombo


