Gualberto Alvino, Scritture verticali. Pizzuto, D’Arrigo, Consolo, Bufalino prefazione di Pietro Trifone, Roma, Carocci 2024.
di Mariano Bàino
Riguarda la prosa di quattro grandi “irregolari” della letteratura italiana contemporanea questo studio di Gualberto Alvino: quattro autori «d’eccezionale competenza linguistica e consapevolezza estetica», i quali «lavorano al trivio fra prosa, poesia e speculazione lato sensu filosofica, mirando alla rifondazione dell’arte narrativa in direzione antagonistica e di ricerca, ergo trasformando in capitale questione stilistica ogni minimo dettaglio del loro operare». Difficilmente si potrebbe dir meglio, a voler cingere in un unico cartiglio i nomi di Antonio Pizzuto, Stefano D’Arrigo, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino. Certo, l’orizzonte oggidiano della scrittura, per semplicismo stilistico, per colluvie digitale, appare perlopiù disinteressato, se non proprio avverso, alla parola inquieta, non comune, e a combinazioni retoriche raffigurabili come letterarietà radicale. Nondimeno, Gualberto Alvino, che ha dalla sua una lunga fedeltà di stilcritico ai quattro scrittori siciliani, in Scritture verticali procede con forte inclinazione ad aggiornare e sviluppare l’ermeneutica testuale già affidata a saggi e articoli linguistico-stilistici, guidando il lettore alla genesi di complessi procedimenti onomaturgici, alle preziose materie laboratoriali emergenti da carteggi privati, in generale a potenti tensioni espressivistiche.
In apertura del volume, due studi sul lessico pizzutiano, il primo dei quali apre con una citazione da Lessico e stile dell’autore palermitano riguardante il neologismo «più temerario da lui forgiato»: «L’aggettivo […] mi è rimasto impresso dalla lettura di Tucidide, compiuta quarant’anni fa, e guizzatomi dentro come un ago inghiottito che torni alla luce dopo una circolazione innocua di decenni nelle viscere […]. Lamprà: che voce meravigliosa; quel rotacismo vi mobilita il lampo infondendovi arcana vibratilità. […] Nessun’altra voce direbbe, secondo me, altrettanto». Negando alla parola la mera funzione di tramite comunicativo, privilegiandone il lato ambiguo e sfingeo, l’autore di Paginette fonda la sua nozione di narrare in contrasto a raccontare, che è il campo del solo «fatterello», un «antico sistema» del ridurre, in cui i personaggi sono «documenti», mentre nel narrare essi sono «testimoni»; qui la rappresentazione «non è più offerta ab extra, come una planimetria sottoposta al lettore, ma scaturisce intuitivamente da ciò che legge, con una compartecipazione attiva, direbbe un tomista in contuizione». I principî compositivi di Pizzuto, come ognuno sa, hanno suscitato anche commenti dubbiosi, come in Cesare Segre e in altri, per l’ipotizzata propensione a un artificio insistito fino al punto di sottrarre la parola alla sua naturale circolazione, tout court al suo agire comunicativo. Ma il controverso dibattito intorno all’autore, da qualunque parte lo si voglia vedere, non rende meno benemerite le ricerche e le scoperte di Alvino, il cui scopo dichiarato — nell’inseguire l’«estro neologico» di Pizzuto e il suo tentativo «d’occupare uno spazio unico nel mondo, battezzando la cosa e transustanziandosi in essa» — è quello «di contribuire alla riapertura d’uno dei casi letterari più formidabili del secondo Novecento». In Onomaturgia pizzutiana II vengono in particolare esaminati gli scritti più tardivi: Giunte e virgole e Spegnere le caldaie, quest’ultimo dettato dall’ottantenne scrittore alla figlia poco prima di morire. Qui la decrittazione dell’«ordigno neologico» deve fare i conti con «un’evasività semantica e […] un’ambiguità figurale senza confronti nella storia dell’italiano letterario». La prospettiva è tale da dischiudersi a «innumerevoli fughe, nell’infinita circolarità». Fra primo e secondo scrutinio Alvino rileva 666 coniazioni originali. Qualche specimen: «Desertudine […]: ‘silenzio d. tosto banditi’. Da deserto secondo il rapporto solo-solitudine»; «Giambicardia […]: ‘riccioli, g., compatto magdeburgismo’. Da giambo e cardìa. ‘Pulsazione cardiaca a ritmo giambico’»; «Verseggevoli […]: ‘notari v. in clausola’. Da verseggiare col suff. –evole. ‘Che si dilettano a scrivere versi’».
Al di là di una naturale, comprensibile Familienähnlichkeit tra i profili dei quattro autori, Scritture verticali rivolge il suo focus soprattutto all’arte personale di ognuno. Nel caso di D’Arrigo molto si evince dalle lettere indirizzate all’amico ragusano Cesare Zipelli lungo l’arco di quasi mezzo secolo, contraddistinte da «un’assoluta — e, si badi, affatto involontaria — negligenza estetica», con la superficie della carta insaziabilmente inondata dall’inchiostro, e con l’evidenza di una «rapidità esecutiva e un malgoverno linguistico poco meno che traumatizzanti» se riferiti a un autore divenuto per l’opinione invalsa «l’incarnazione stessa dell’amletismo e dell’incontentabilità». L’epistolario smentisce tali miti, ci dice di uno scrittore che lungo il ventennio che va dal primo abbozzo di Horcynus Orca alla pubblicazione mondadoriana nel 1975 ha lavorato saltuariamente e senza una precisa strategia di revisione, oppresso dalla sua malattia, la sindrome bipolare. Per Alvino questo è il fil rouge che attraversa, salvo trascurabili differenze formali, tanto il modus epistolandi quanto il romanzo. La parola, «risucchiata nel gorgo infinito della coazione a ripetere, si fa motore d’una sorta di borbottio paranoide, di mantra ipnotico privo di motivazione tematica, sicché la corrente diegetica vacilla, si smorza, cede alla libera fulgurazione associativa, sotto specie d’impetuosa proliferazione, di ingovernabile narcisismo verbale schiacciato in una pressoché totale intransitività». Il furor linguisticus darrighiano, nello scrutinio di Scritture verticali, trascina con sé «forme e costrutti ai confini della grammatica», «ripetizioni non funzionali a distanza ravvicinata», «filze di subordinate del medesimo tipo», soprattutto «relative e causali, come negli scritti dei semianalfabeti». L’insieme, nel contribuire alla formazione della lingua orcinusa, determina la scommessa di D’Arrigo: il conseguimento «di un valore e di una ‘verità estetica’ senza precedenti». Epperò, se di reale scarto dalla norma e di autentico sperimentalismo linguistico si può parlare circa Horcynus Orca è essenzialmente in virtù di un lavoro che resta al di qua di un confine rigidamente lessicale, restando gli svii di natura sintattica di modesta entità. Com’è scritto in un saggio degli anni Settanta del Novecento di Ignazio Baldelli, citato da Alvino, «il genio insistentemente deformante di D’Arrigo ha la sua più evidente manifestazione stilistica nel gusto derivativo ed etimologico: lungo tutta l’opera si svolge una festa sfrenata di denominali, di deverbali, di parasinteti verbali, di parole composte e ripetute». Centralità assoluta, nello scrittore messinese, e non solo in senso squisitamente onomaturgico, del profilo lessicale, dal quale sono escluse del tutto coniazioni riconducibili al greco, poche quelle che rinviano al latino, mentre prevalgono le basi concrete e dialettali. Dal glossario allegato al secondo studio su D’Arrigo, fra le 956 voci scrutinate vi sono 554 neologismi d’autore, fra cui: «Abbranchiante […]: ‘la membrana grisposa, a. e sditata delle manuncule’ Part. pres. d’un supposto *abbranchiare, da branchia col pref.a(d) – illativo. ‘Simile a una branchia’. Ma anche da abbrancare ‘afferrare’, ‘ghermire’»; «Orcinato […]: “il suo essere orcinuso aveva pigliato la via dell’aceto degenerando in o., dall’essere la Morte e passare per immortale all’essere un mortale, a essere un morto”. Part. pass. d’un supposto *orcinare, dall’agg. lat. orcinus ‘dell’averno’, ‘dei morti’»; «Pomponellaro […]: “in gran pomponella, s’ammassarono là, […] quelle pomponellare s’allontanarono”. Dal sic. pumpinella ‘sfottò’ col suff. –aro di mestiere».
Nelle pagine di Scritture verticali dedicate all’arte della parola di Vincenzo Consolo si incontra, per sottolinearne la furia combinatoria, l’immagine dell’«olla podrida», antica pietanza della cucina spagnola, a dire di un calderone dove cuociono i più svariati ingredienti. In effetti, nei testi esaminati, da La ferita dell’aprile al Sorriso dell’ignoto marinaio, fino a L’olivo e l’olivastro, «l’amministrazione della cosa linguistica» mette in moto «sperimentalismo convulso», «esuberanza dell’elemento retorico», mescolio di codici, «esaltazione del livello fonosimbolico». Un’olla podrida che ribolle di tensioni discordanti ed esposte al rischio del feticismo lessicale, dell’acrobatismo sintattico. «Un itinerario — annota Alvino — discontinuo e talora eclatantemente contraddittorio, tenendo fermo che scrittori come Consolo — pur tutt’altro che inappuntabili […] da ogni rispetto — costituiscono una risorsa preziosa e vitale per la prosa letteraria italiana». Nell’espressivismo consoliano, «cruento ed estremistico», spicca per originalità il particolare valore dato alla metrica, con la preminenza dell’endecasillabo, in solitario o in gruppo. Gli eventi fonetici si arricchiscono di rime e quasi-rime, di assillabazioni, risonanze allitterative, fin quasi a «un’adorazione estenuata del significante». Il comparto lessicale mostra una notevole vivacità, sia in sede onomaturgica che dialettale, con l’uso di parole antiche o desuete, di neoformazioni d’autore, e soprattutto di rielaborazioni di vocaboli dialettali. Le coniazioni originali computate sono 57, con alta frequenza di univerbazioni, composizioni e forme pre- e suffissali, mentre arrivano a 184 i dialettalismi. Fra questi, «Calasìa […]: ‘Bellezza’, ‘non improbabile grecismo’, ‘si tratta sicuramente di una parola del lessico familiare dello scrittore», che non ha riscontri lessicografici siciliani né calabresi; «Cuffiesco […]: “torture, angeliche muffoliche cuffiesche”. Da cuffìa del silenzio, ‘antico strumento di tortura’»; «Incastronare […]: “sciortivano gli acini o cocci per fare, infilando o incastronando con l’oro e con l’argento, paternostri”. Incastonare + incastrare».
Nell’«universo monologico, unilingue, graniticamente atemporale» dell’opera di Gesualdo Bufalino — qui esaminata non solo attraverso Diceria dell’untore, ma anche ripercorrendo i testi poetici, gli scritti saggistici e gli elzeviri — Alvino riconosce «lo statuto d’una scrittura duttile, densa, sorprendentemente viva e vitale, capace di contrastare la dilagante mediocrità espressiva» e di offrire all’esegeta, più di ogni altra, ricchi stimoli critici. «Comparata al modulo ordinario, è certo che la lingua di Bufalino si connota per una insaziata ricerca d’inattualità, una fuga dal presente posta in essere mediante vistosi sovvertimenti topologici affatto incomprensibili fuori dell’istanza ritmica, tale intendendo non già l’edificante laccatura d’una sonorità additiva e tutta esteriore, ma signoria della misura sull’impulso, equilibrio architettonico e tonale, desiderio di rifondazione d’una civiltà letteraria». È Bufalino stesso, in Essere o riessere, a suggerire per le sue pagine una lettura musicale, «un’attenzione al ritmo, alle andature melodiche […] ai campi metaforici, alla prosodia nascosta nei meandri del periodo». Circa il lessico, tra recuperi di varianti arcaiche e ricerca di fascinose sonorità, spicca il comparto neologico, con i suoi 120 neologismi d’autore. Fra le formazioni avverbiali: «Annakareninamente […]: “finita poi suicida, a., sotto le ruote di un treno”. Da Anna Karenina, protagonista dell’omonimo romanzo tolstojano». Nel settore delle formazioni pre- e suffissali: «Irraggiunto […]: “libri amati e irraggiunti”. Da raggiunto col pref. in- negativo». Fra le procedure univerbizzanti: «Madreterna […]: “Scadendo […] dal suo trono di m.”».
Il percorso seguito da Alvino, buonissimo esempio di consapevolezza metodologica e di indagine linguistica, è provvisto di una qualità che a buon diritto lo rende imprescindibile nello studio dei quattro autori siciliani.

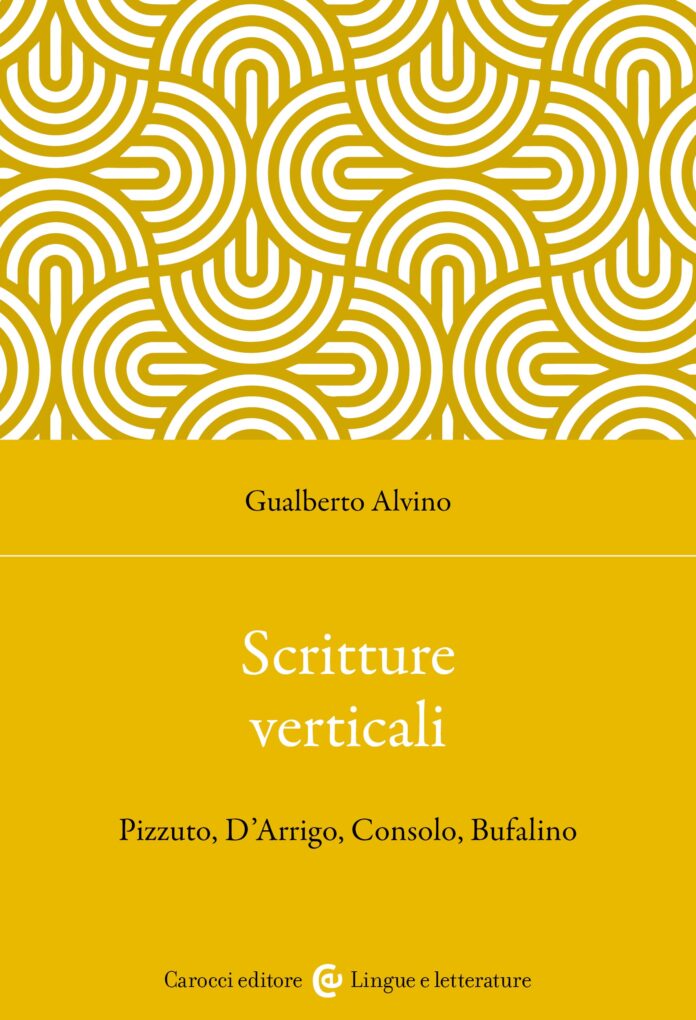
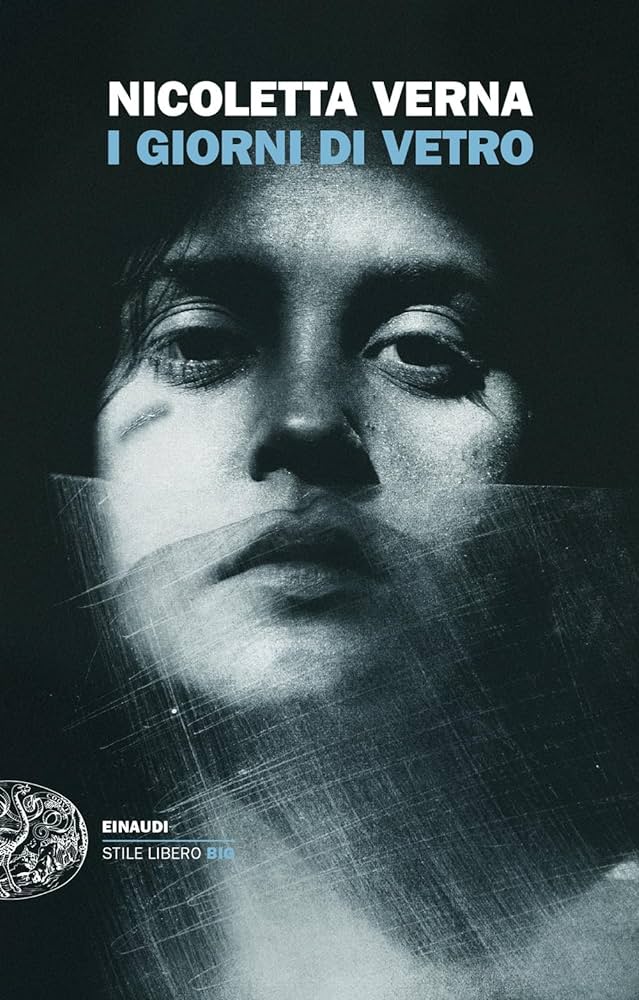






 di
di  Castronuovo inizia dunque dall’evocazione del tragico epilogo e suddivide la vita di Formiggini in una trentina di capitoletti, talvolta vere e proprie digressioni, che tuttavia restituiscono al lettore l’inventiva, la cultura e la ‘filosofia del ridere’ di questo straordinario editore, ucciso da quello stesso fascismo che all’inizio aveva paradossalmente abbracciato senza poterne prevedere l’ottusità e la vigliaccheria. Ci sono curiosità che vanno dal perché del suo nome e di quella “i” con l’accento acuto (Formiggini andrebbe scritto Formíggini) alla cronaca della distruzione delle antiche carte di famiglia, distruzione così bizzarra quanto per fortuna limitata. Poi il periodo spassoso della goliardia universitaria, con la sua vocazione per lo scherzo e la burla, gli studi a Bologna, a Modena, a Roma. Fondatore dell’Accademia del Fiasco, Formiggini finisce per conseguire addirittura due lauree, una in giurisprudenza e l’altra in lettere e filosofia, quest’ultima discutendo una tesi intitolata
Castronuovo inizia dunque dall’evocazione del tragico epilogo e suddivide la vita di Formiggini in una trentina di capitoletti, talvolta vere e proprie digressioni, che tuttavia restituiscono al lettore l’inventiva, la cultura e la ‘filosofia del ridere’ di questo straordinario editore, ucciso da quello stesso fascismo che all’inizio aveva paradossalmente abbracciato senza poterne prevedere l’ottusità e la vigliaccheria. Ci sono curiosità che vanno dal perché del suo nome e di quella “i” con l’accento acuto (Formiggini andrebbe scritto Formíggini) alla cronaca della distruzione delle antiche carte di famiglia, distruzione così bizzarra quanto per fortuna limitata. Poi il periodo spassoso della goliardia universitaria, con la sua vocazione per lo scherzo e la burla, gli studi a Bologna, a Modena, a Roma. Fondatore dell’Accademia del Fiasco, Formiggini finisce per conseguire addirittura due lauree, una in giurisprudenza e l’altra in lettere e filosofia, quest’ultima discutendo una tesi intitolata 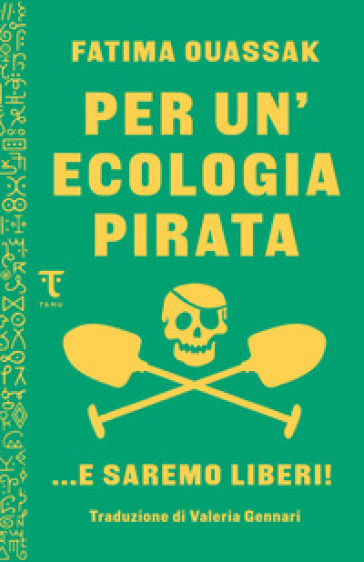




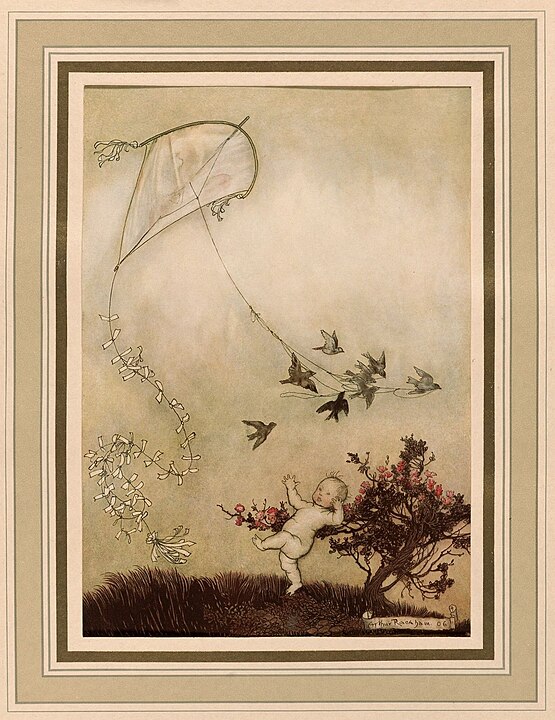

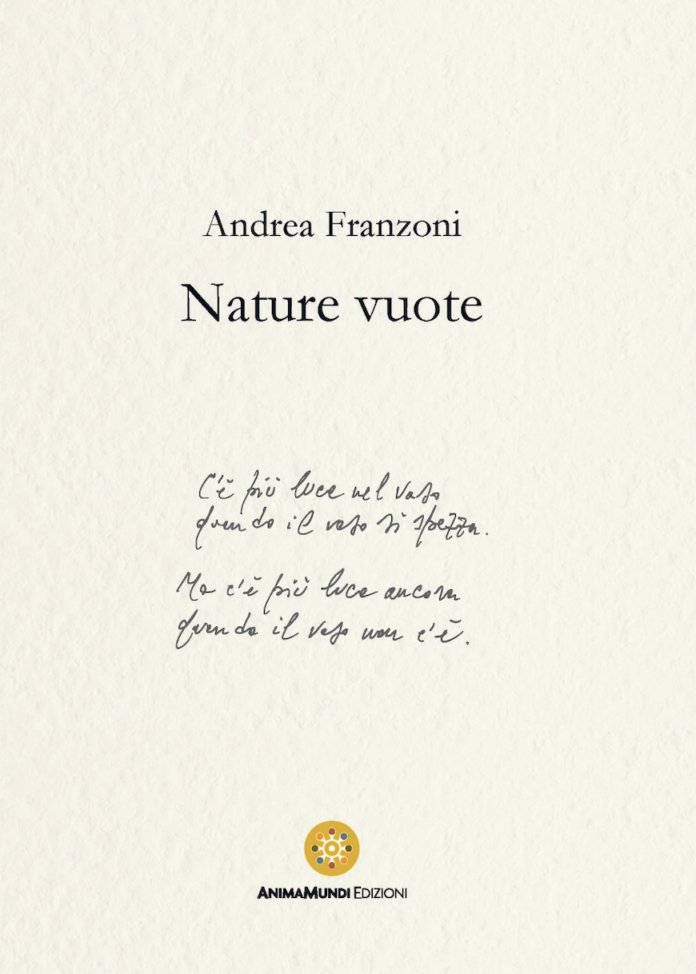
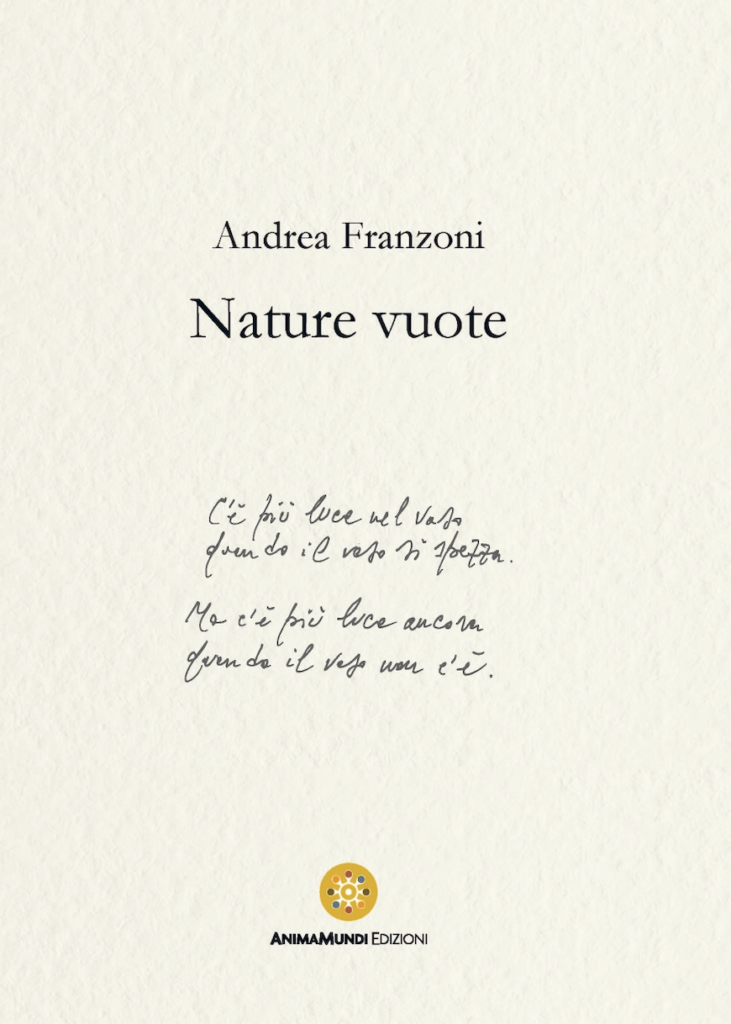



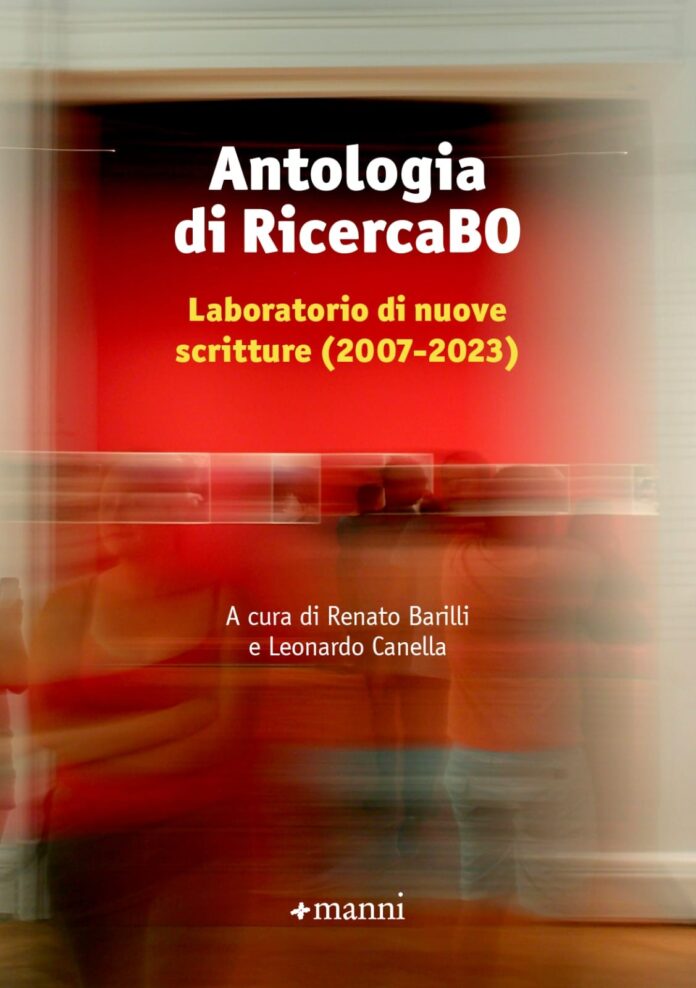


 di Francesca Matteoni
di Francesca Matteoni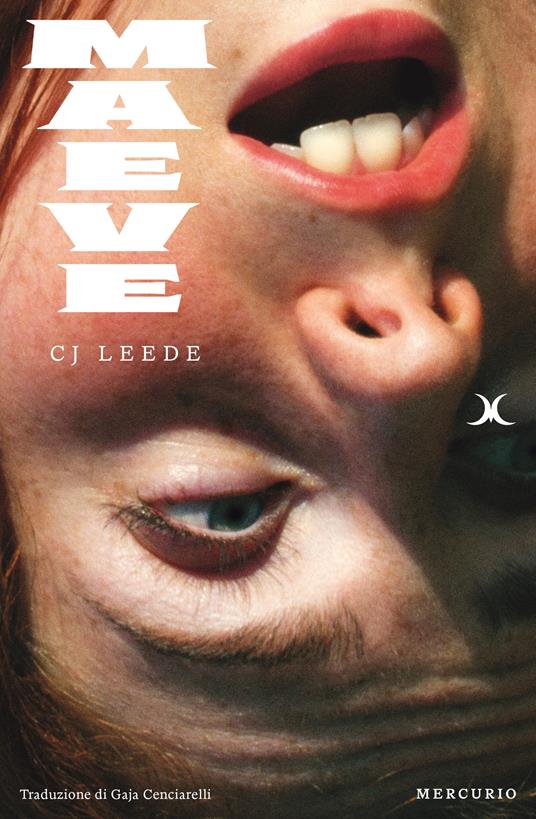

 di Lisa Ginzburg
di Lisa Ginzburg



