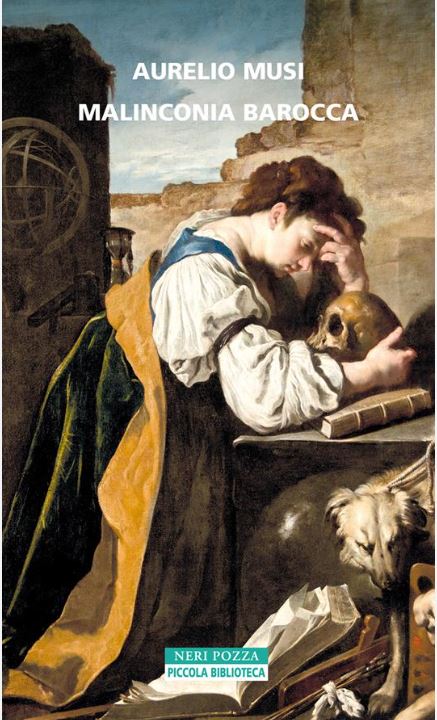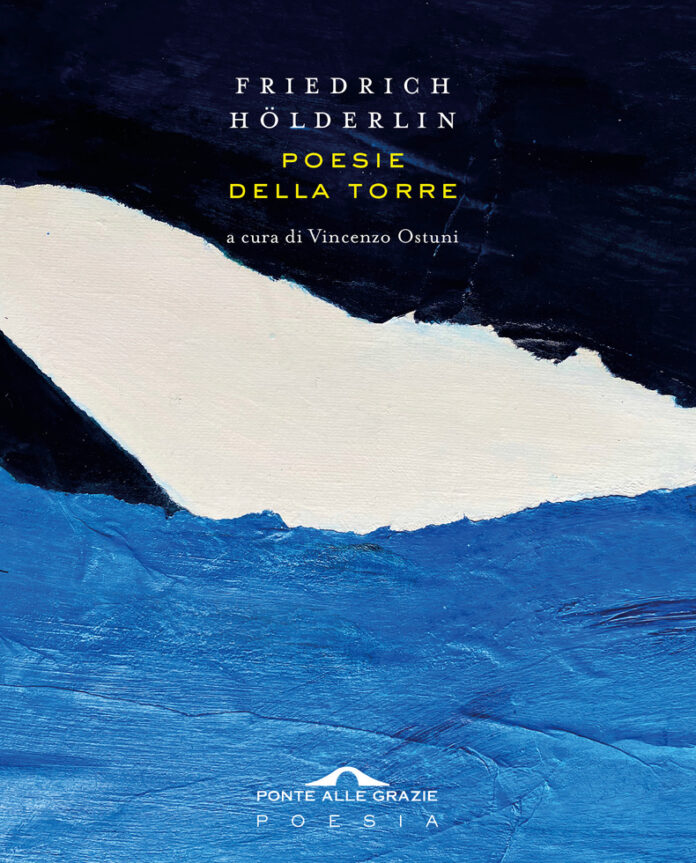A proposito di In campo la vita sparisce di Loris Caruso

di Giovanni Di Benedetto
- Prologo. L’uno e il molteplice: fenomenologia del numero 10
Nell’insieme che individua l’infinita successione dei significanti del linguaggio numerico, almeno tre svolgono appieno la funzione propria di un ipersegno: lo Zero, l’Uno e l’unione di questi nel numero Dieci. All’interno di quel particolare sistema di distribuzione collettiva del lavoro che è una squadra di calcio, il numero dieci rappresenta colui che è in grado di risolvere dialetticamente e in senso gramsciano l’antitesi manicheista dell’individuale e del collettivo: il fantasista è l’attante che attraverso il proprio genio e le proprie capacità creative individuali inventa il gioco. Allo stesso tempo, il fantasista è anche colui che organizza il gioco della squadra subordinando l’inventio alla dispositio al fine di elaborare un’elocutio performativa nel quale l’actio è sempre al servizio del collettivo. Il fantasista, come un poeta orfico-pitagorico, inventa geometrie in grado di creare dal nulla lo spazio entro il quale si manifesta il movimento che, portando al gol, altera la materia e, così facendo, il reale. Queste due qualità dell’invenzione e dell’organizzazione del gioco si concretizzano nel concetto che identifica l’idea stessa del fantasista: l’uomo-squadra, colui che, da solo, attraverso la fantasia, è capace di risolvere e capovolgere le sorti di una partita. Ma, allo stesso tempo, l’uomo-squadra è colui che mette il suo talento al servizio della squadra organizzando il lavoro dei differenti reparti e dei singoli membri in una costruzione comune. L’imperativo categorico del numero Dieci, Fare gol, è per il fantasista una frase infinitiva principale che contiene, al suo interno, una subordinata finale: segnare un gol, oppure, far (fare) gol, mettere gli altri compagni di squadra nella situazione di segnare distribuendo assist. L’uomo-squadra è un’opera-mondo nella quale i destini collettivi sono rappresentati nella traiettoria tracciata da un destino individuale. In questo, il fantasista è simile al poeta e al rivoluzionario. La vita, la morte e i miracoli di Diego Armando Maradona non solo rappresentano il manifesto più compiuto della fenomenologia del fantasista ma anche i cardini di una parabola propria soltanto agli eroi romanzeschi. La vita di Maradona non è come un romanzo. Diego Armando Maradona è romanzo.
- «Giocò, vinse, pisciò, perse»: vita e gesta di Diego Armando Maradona, donnaiolo, chiacchierone, ubriacone, divoratore, irresponsabile, bugiardo, fanfarone
En una villa nació, fue deseo de Dios
(Rodrigo, La Mano de Dios)

Nella sua Poetica, Aristotele stabilisce le convenzioni letterarie che, per secoli, avrebbero definito la teoria dei generi: uno stile elevato per la tragedia e l’epica, e uno stile basso e umile per la commedia. Il genere è così codificato con la sua forma. La lingua che narra le gesta degli eroi è condizionata dalla loro posizione sociale, la quale a sua volta determina le situazioni narrative in cui i personaggi si trovano. La nascita del romanzo moderno è spesso attribuita all’emergere del romanzo picaresco spagnolo del XVI secolo, poiché rappresenta la prima forma narrativa a rompere le convenzioni letterarie aristoteliche. Il romanzo picaresco è caratterizzato da uno stile misto in cui il registro della lingua e le situazioni narrative alternano l’alto e il basso, l’eroico e il comico, il tragico e la farsa. Il protagonista, il picaro, racconta la sua vita adottando uno stile volutamente epico: le gesta della sua vita quotidiana diventano imprese, avventure, un succedersi di situazioni narrative, un romanzo.
Anche se non avessimo mai visto un solo gol, un solo dribbling, né ascoltato un suo aforisma, né visto una sola immagine che lo rappresentasse, la semplice e rapida lettura della cronologia di Maradona sarebbe sufficiente per identificarlo come il personaggio principale di un romanzo picaresco. Con un’abilità paragonabile a quella utilizzata da Flaubert nel penultimo capitolo de L’educazione sentimentale per racchiudere la parabola esistenziale di Frédéric Moreau – in una rapida successione di passati remoti che condensano in poche righe i sedici anni di vita che separano il vuoto bianco tra il quinto e il sesto capitolo [1] (e dunque tra la giovinezza e l’età adulta) -, lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, mediante un movimento sintattico che collega una serie di passati remoti con la stessa fluidità di un enjambement (leggasi dribbling), così racconta l’episodio dei Mondiali di Usa ’94 che forse più fa da metonimia all’intera vita romanzesca di Maradona: «Jugó, venció, meó, perdió». Giocò, vinse, pisciò, perse. Di fatto, l’infanzia di Diego Armando Maradona finisce quel giorno lì: da lì in poi, il pallone sarebbe stato come la treccia di capelli bianchi che Madame Arnoux regala a Frédéric Moreau al termine del romanzo [2]. E cosa ha fatto Maradona dal 1994 al giorno della sua morte il 25 novembre 2020? Viaggiò. Conobbe la malinconia delle panchine a bordo campo, i freddi risvegli su una brandina di una clinica cubana, l’incanto dei paesaggi de La Havana e delle rovine del deserto di Sinaloa in Messico, l’amarezza delle ginocchia troncate. Ritornò; frequentò la società, ed ebbe ancora altri amori. Ma il ricordo costante del primo calcio al pallone glieli rendeva insipidi; e poi la violenza del desiderio di segnare, la freschezza della condizione fisica era perduta. Anche le ambizioni da allenatore si erano ridotte. Passarono gli anni; e gli pesò l’inerzia del suo corpo e l’indifferenza del suo piede sinistro. Giocò, vinse, pisciò, perse. L’alto e il basso. Il cielo e la terra. Gli dèi e gli uomini. Come chiosa ancora Galeano, Maradona è «un Dio sporco che ci assomiglia: donnaiolo, chiacchierone, ubriacone, divoratore, irresponsabile, bugiardo, fanfarone». Il Pibe de oro è un autentico Picaro de oro.
- In campo la vita sparisce
Diego Armando Maradona eroe romanzesco, dicevamo. Eppure le gesta di Maradona sembrano ispirare i poeti e non tanto i romanzieri (perché sia chiaro: Galeano è un grandissimo poeta, uno dei più grandi della letteratura ispano-americana). Oppure sembrano prestarsi a una forma narrativa ibrida, tra il giornalismo, il saggio e il racconto breve. Sembrerebbe che Maradona sia un oggetto narrativo fin troppo romanzesco per poterlo adattare in una forma romanzesca propriamente detta nella quale l’inventio e la dispositio riorganizzano il materiale biografico della sua esistenza. Un ulteriore ostacolo è dovuto al fatto che il suddetto materiale biografico è ormai entrato a far parte delle pagine dell’Enciclopedia Universale e che chiunque, bene o male, è a conoscenza delle gesta di Maradona. Lo spazio disponibile all’immaginazione per reinventare la narrazione della chanson de geste del ciclo maradoniano sembra essere pressoché inesistente. E allora, come scrivere un romanzo su Maradona? Se lo sarà chiesto per notti intere Loris Caruso, autore di In campo la vita sparisce (Castelvecchi). Il libro è un romanzo su Diego Armando Maradona. Lo ripeto: non una biografia romanzata, ma un vero e proprio romanzo che ha come protagonista un personaggio che all’inizio del racconto scopriamo chiamarsi Diego Armando Maradona e di cui scopriamo le gesta dall’infanzia all’adolescenza, le imprese, le peregrinazioni, i successi, la vita adulta, la sconfitta, la caduta, le sue innumerevoli morti, le resurrezioni, l’ascensione al cielo e al mito. In campo la vita sparisce si può leggere proprio come un romanzo di formazione. Le quattro parti nelle quali è suddiviso il libro – Principe, Re, Dio, Demone – permettono al lettore di seguire le peripezie di Maradona in una maniera che ricorda da vicino quella con la quale seguiamo l’avventura spirituale di Adrian Leverkuhn, il protagonista del Doctor Faustus di Thomas Mann.

Il pregio del libro di Loris Caruso è proprio quello di aver colto il grande potenziale narrativo di un uomo che sembra aver vissuto più vite: l’utilizzo costante di prolessi e analessi all’interno della narrazione permettono al testo di distaccarsi dalla cronaca e diventare un elaborato meccanismo romanzesco nel quale ritrovare le caratteristiche del genere: ai dialoghi si alternano le descrizioni, alle descrizioni le azioni (e decisamente riuscite sono le descrizioni delle azioni calcistiche); le digressioni permettono inoltre al testo delle aperture saggistiche a proposito di storia, mito, religione e sociologia. In alcune situazioni, l’armonia tra le parti è perfetta. Si veda ad esempio lo scambio tra un giovanissimo Maradona a 11 anni, portrait of the artist as young man, e il suo allenatore delle giovanili dell’Argentino Juniors, Don Francis:
– Mister, in partita si possono fare i dribbling, o bisogna sempre passarla?
– Scusa Pelusa, non ho sentito, puoi ripetere?
– Ho chiesto… ho chiesto se possiamo fare i dribbling oppure… dobbiamo fare sempre i passaggi don Francis
– Ragazzi, il dribbling è l’arte del calcio. La più grande. Se al calcio togliamo il dribbling gli togliamo tutto. Ci sono squadre che dicono ai giocatori di non dribblare perché il dribbling è rischioso, sai se perdi la palla rischi il contropiede e il gol. Ma io piuttosto che vedere una partita senza dribbling preferisco farmi una pennica al sole o mangiarmi un buon Casado con gli amici. Il calcio senza dribbling è come un asado crudo: ti sfama ma non sa di niente.
I ragazzi risero ma si ricomposero subito. Francis aveva un tono tra epico, il paterno e il militare.
– L’arte nel calcio è superare l’avversario, aprire uno spazio che prima non c’era, inventarlo dal nulla come quando alla fine di una foresta compare una radura e vedi l’orizzonte.
Ma non si può vivere solo di arte. Sarebbe bello, a me piacerebbe, ma non si può. Noi faremo i dribbling quando servono i dribbling, i passaggi quando servono i passaggi, i contrasti quando servono i contrasti e i tiri quando servono i tiri. Gli attaccanti devono dare una mano alla difesa, tutti devono dare una mano a tutti, soprattutto quando sembra che la barca stia affondando, chiaro? [3]
Quella di Don Francis non è una lezione di calcio. È una lezione di stile: come costruire una situazione romanzesca. Come costruire un romanzo su Diego Armando Maradona.
- Epilogo
Nella sezione dedicata alle Vite degli uomini illustri della Grande Enciclopedia Universale edita a Napoli nel 2123, la biografia di Diego Armando Maradona apparirà al fianco di quella di Arthur Rimbaud, celebre mercante d’oppio e trafficante d’armi francese del diciannovesimo secolo. Quanto a Maradona, le fonti lo citeranno come «il più grande poeta argentino del ventesimo secolo».
- Post-Scriptum. Parigi, gennaio-maggio 2023
Ho iniziato a leggere il libro di Loris Caruso nel gennaio 2023. Poche settimane prima l’Argentina aveva vinto il suo terzo mondiale. Ho assistito alla finale contro la Francia a Parigi, in un pub con solo argentini (essendo napoletano avevo diritto di cittadinanza). Al fischio finale, l’immensa gioia degli argentini mi ha scosso profondamente facendomi immaginare cosa avrei potuto provare se il Napoli fosse riuscito a vincere nuovamente lo scudetto, senza Diego, proprio come aveva appena fatto l’Argentina. Poche settimane fa, l’ho vissuto. È successo per davvero. Il Napoli ha vinto. Sono sceso in strada e ho chiamato il mio amico Boris che abita a Saint-Denis. Boris insegna storia, è un sindacalista della CGT e l’estate scorsa è venuto in pellegrinaggio a Napoli. Mentre gli mostravo le immagini in diretta Boris mi ha detto più o meno così: «è a questo che assomiglierà la vittoria della rivoluzione e del socialismo». Poche settimane prima, durante una delle giornate di sciopero contro la riforma delle pensioni del governo Macron, eravamo insieme Boris ed io. Nel corteo, come un’apparizione, abbiamo visto sorgere il profilo di Diego:

Boris mi ha citato una frase dello storico marxista Eric J. Hobsbawn secondo il quale i tre elementi costitutivi della coscienza di classe operaia sono il calcio, il pub e il sindacato. Ho abbracciato Boris e gli ho detto in napoletano: «Maradò, miettece ‘a mana toja».

___
Note
[1] Loris Caruso, In campo la vita sparisce, Roma, Castelvecchi, 2022, pp. 55-56.
[2] «Viaggiò. Conobbe la malinconia dei piroscafi, i freddi risvegli sotto una tenda, l’incanto dei paesaggi e delle rovine, l’amarezza delle simpatie troncate. Ritornò; frequentò la società, ed ebbe ancora altri amori. Ma il ricordo costante del primo glieli rendeva insipidi; e poi la violenza del desiderio, la freschezza della sensazione era perduta. Anche le sue ambizioni intellettuali si erano ridotte. Passarono gli anni; e gli pesò l’inerzia della sua mente e l’indifferenza del suo cuore». (G. Flaubert, L’educazione sentimentale, trad. it. di Lalla Romano, Torino, Einaudi, 1984, p. 579).
[3] «Emir, sai che giocatore sarei stato senza la cocaina? che giocatore ci siamo persi. Avrei potuto essere molto più di ciò che sono stato». (D. A. Maradona, in Maradona by Kusturica, di Emir Kusturica, 2008).







 In un momento storico in cui c’è chi propone un federalismo differenziato, sarebbe utile riscoprire la figura di Tommaso Fiore, a cinquant’anni dalla sua morte. Comprenderemmo che l’idea di un’Italia federale non è nuova. Ritorniamo a Cattaneo, scrisse Fiore in un articolo del 1923. E Norberto Bobbio considerò questo articolo fondamentale per convincere Piero Gobetti della bontà del progetto federale del milanese Carlo Cattaneo. Insomma, il federalismo non c’entra nulla con la “secessione dei ricchi” che qualcuno vorrebbe realizzare sotto mentite spoglie.
In un momento storico in cui c’è chi propone un federalismo differenziato, sarebbe utile riscoprire la figura di Tommaso Fiore, a cinquant’anni dalla sua morte. Comprenderemmo che l’idea di un’Italia federale non è nuova. Ritorniamo a Cattaneo, scrisse Fiore in un articolo del 1923. E Norberto Bobbio considerò questo articolo fondamentale per convincere Piero Gobetti della bontà del progetto federale del milanese Carlo Cattaneo. Insomma, il federalismo non c’entra nulla con la “secessione dei ricchi” che qualcuno vorrebbe realizzare sotto mentite spoglie.






 di Lisa Ginzburg
di Lisa Ginzburg