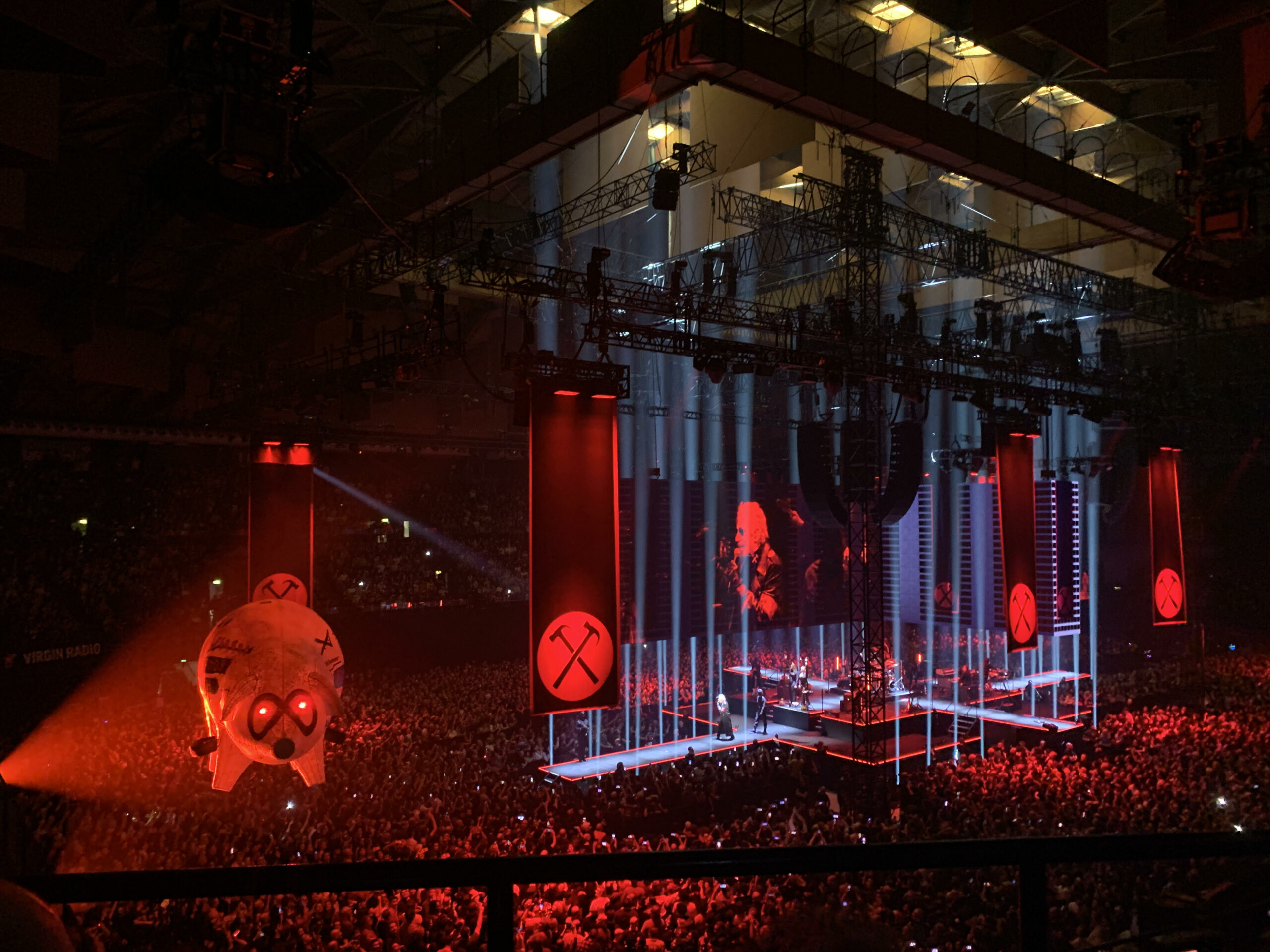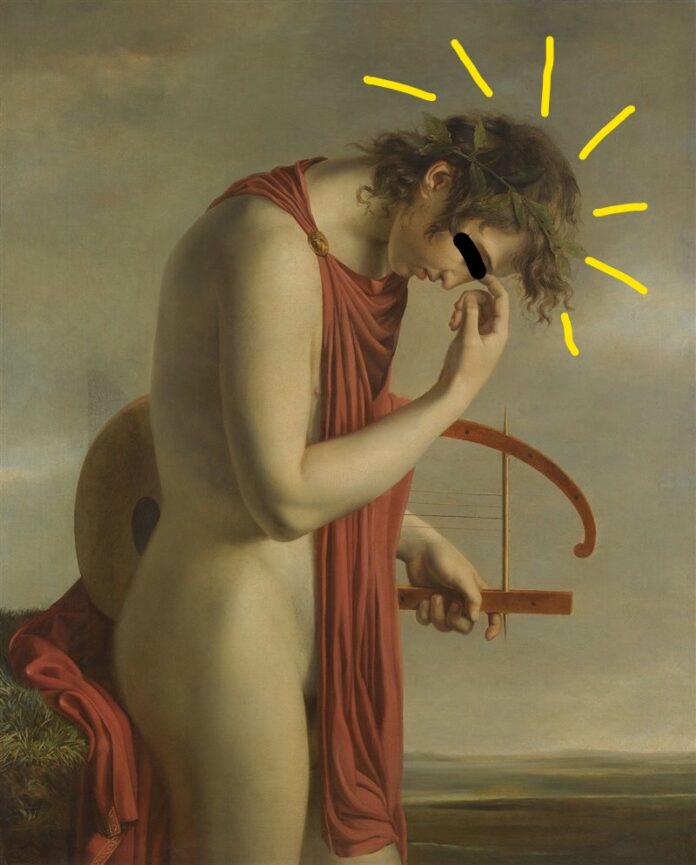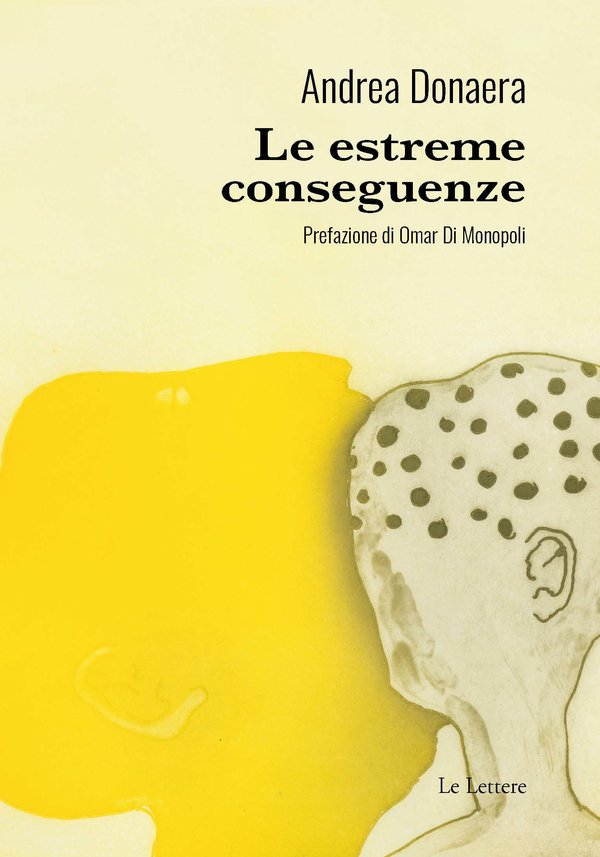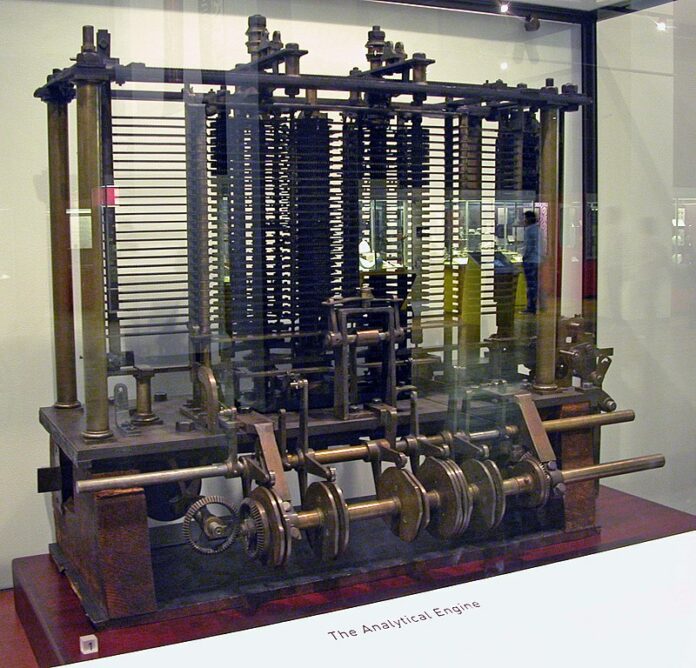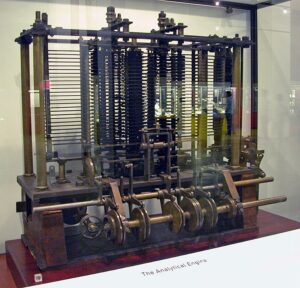di Radoslav Petković
(Questo testo è apparso per la prima volta su Nin, il 23 giugno 2020. La traduzione dal serbo è di Božidar Stanišić.)
L’epidemia di corona ha messo a nudo i punti deboli della scienza moderna e nella lotta contro di essa siamo, più o meno, tornati agli stessi mezzi usati dalle persone dei tempi passati: quarantene e isolamenti.
“Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e come che a ciascuna persona sta bene, a coloro è massimamente richiesta lì quali già hanno di conforto avuto mestiere e hanno trovato in alcuni…” [1]
Inizia così uno dei libri più famosi della letteratura europea, il Decameron di Giovanni Boccaccio. Dato che “famoso” ha cessato da tempo di significare letto, dovremmo dire qualcosa di più su questo libro. Quindi, così: a Firenze, nel 1348, durante la peggiore pestilenza, sette ragazze e tre giovani fuggono dalla città in una villa, o più esattamente in alcune ville nelle vicinanze. Trascorreranno lì dieci giorni e, siccome all’epoca non c’era né Netflix né altro di simile, racconteranno storie per ammazzare il tempo che allora, come oggi, potrebbe, in certe circostanze, essere troppo lungo; solo più tardi, nei ricordi e nei ripensamenti, si comprende che in realtà è passato in un lampo.
Ora potremmo essere tentati di dire che quelli erano tempi migliori e più creativi, in cui le persone non mettevano il naso negli schermi per consegnarsi allo streaming e dovevano invece sforzarsi un po’ ma, come sempre quando iniziamo a lodare il passato, lodatore temporis acti, non è male esercitare una certa prudenza. Nonostante le ville in cui stavano vivendo, e la natura meravigliosa, perché Boccaccio evidentemente sogna giardini paradisiaci, c’è poco che agli eroi di questa prosa possiamo invidiare. È il periodo in cui la “morte nera”, la peste bubbonica, devastava l’Europa, e la maggior parte della popolazione europea moriva in questa epidemia; due terzi o tre quarti, a seconda delle stime. Una delle eroine, o una delle narratrici del Decameron, ci dice questo: “Né altra cosa alcuna ci udiamo, se non: – i cotali son morti -; e – Gli altrettanti sono per morire -; e, se ci fosse chi fargli, per tutto dolorosi pianti udiremmo” [2] .
Ma, se possibile, le cose vanno anche peggio: quando ritorna a casa, Pampinea ci racconta di vedere lì “l’ombre di coloro che sono trapassati …, e non con quegli visi che io soleva. Ma con una vista orribile, non so donde il loro nuovamente venuta, spaventarmi” [3] .
Nonostante durante l’epidemia di corona a molte persone venissero in mente le epidemie di peste bubbonica, queste fortunatamente non sono paragonabili alla nostra a motivo del tasso di mortalità incomparabilmente inferiore; non abbiamo statistiche attendibili, ma la peste bubbonica, che per questo ha preso il nome di “morte nera”, ha ucciso tra i due terzi e i tre quarti della popolazione europea; lo stesso più o meno è avvenuto anche nella Firenze del Boccaccio. Ma ci sono alcune somiglianze, quelle che non avremmo creduto possibili.
Diciamo: la fede nel potere della scienza ha addormentato tutti e, un po’ paradossalmente, la teoria che il corona virus sia stato prodotto in laboratorio nasce proprio da questo, dalla visione del mondo estremamente antropocentrica concepita nel Rinascimento. L’epidemia di corona ha messo a nudo i punti deboli della scienza moderna e nella lotta contro di essa siamo tornati, più o meno, agli stessi mezzi usati nei tempi passati: quarantene e isolamenti. Gli storici hanno registrato come, durante l’epidemia di peste a Srem (Sirmia), nel XVIII secolo, l’esercito chiudesse le zone infette e come le punizioni per chi le abbandonava fossero molto severe, comprendevano la morte.
Nessuno protestò; allora il concetto di diritti umani era davvero sconosciuto, soprattutto nella Monarchia asburgica, e sembra che questi metodi, per quanto brutali, non fossero proprio inefficaci; un monumento vicino alla strada principale Irig – Ruma [4], popolarmente chiamato “statue”, segna il luogo in cui fu fermata la peste. Nel corso di quel secolo si svilupperà quello che viene chiamato il “cordone sanitario”. A suo tempo se ne occuperà in particolare Adrien Proust, rispettabilissimo padre di un figlio ben più famoso, Marcel Proust, e Camus, quando scriverà La peste, utilizzerà proprio il suo libro Difesa dell’Europa contro la peste. Allora, anche quella che oggi chiamiamo “distanza sociale” non era sconosciuta e sembra essere stata violata: ecco perché un personaggio dei Promessi sposi manzoniani esce in strada solamente con due pistole cariche; mi sembra che oggi, per le strade delle città serbe, questa idea non sia affatto male.
Boccaccio cita poi due spiegazioni dominanti per l’origine dell’epidemia: da un lato essa è una conseguenza della posizione dei corpi celesti, dall’altro è la punizione di Dio per i peccati umani. Per l’epidemia di corona, oltre a quelle di laboratorio, ci sono più spiegazioni. Il teologico castigo di Dio, è molto vicino a ciò che potremmo chiamare teoria ecologica; semplificando, ma non troppo, il virus è la vendetta della natura per il nostro atteggiamento nei suoi confronti; teoria particolarmente cara al pensiero di sinistra, che è felice di adottare lo schema di pensiero che caratterizzava i teologi medievali, specie quelli inclini a profezie sull’imminente distruzione del mondo; quella distruzione, e tutti gli orrori che l’accompagnano, possono essere tranquillamente paragonati a una rivoluzione che distrugge il vecchio mondo, ma solo per crearne uno nuovo che possiamo chiamare Regno di Dio, comunismo – o come vogliamo. L’epidemia di peste somigliava veramente agli orrori descrittici nell’Apocalisse di Giovanni; l’epidemia di corona ne è oggettivamente lontana nonostante che, in alcuni punti (realisticamente) e soprattutto nelle versioni mediatiche, per numerosi e apparentemente diversi motivi ma sempre con il desiderio di ottenere un qualche effetto, ci sia stato uno sforzo per avvicinare la realtà alle immagini apocalittiche; file di bare nel nord Italia o visioni del presidente serbo mentre afferma che se non gli si darà ascolto, i cimiteri di Belgrado saranno troppo piccoli per accogliere tutti i defunti; diabolici esercizi di obbedienza.
C’era anche un’altra narrazione, apparentemente terrificante, su persone che muoiono senza poter vedere i loro cari; ma la cruda verità è che questa è spesso l’immagine della morte contemporanea quando si muore in un ospedale; lo è nel cosiddetto coma artificialmente indotto – quindi drogato. Ma bisogna anche essere consapevoli che una “antica” immagine di morte, dove il moribondo giace circondato dalla sua famiglia con la quale si saluta serenamente, era l’immagine della morte ideale, la morte del giusto che, lo sanno tutti, non è obbligatoria nemmeno per il giusto; e autori del passato, come Michel de Montaigne, hanno saputo portare esempi di varie morti, comprese le morti dolorose dei giusti e le morti facili dei peccatori.
Gli incubi di Pampinea, in cui i defunti vicini e cari le appaiono con un aspetto spaventoso e orribile, ci aprono a un altro paradosso della morte. Dovremmo ricordare, a questo punto, le credenze e le usanze popolari del tempo in cui le persone morivano in casa, almeno quelle che la avevano una casa. Queste credenze e usanze nascevano essenzialmente con la motivazione e lo scopo di proteggere i vivi dalla possibile influenza maligna del defunto; con l’atto della morte, la madre o il buon nonno si sarebbero trasformati, come negli incubi di Pampinea, in un pericolo latente. Che la morte sia un grande cambiamento è certamente qualcosa su cui, immagino, sia un ateo ardente che un credente bigotto sarebbero d’accordo; ma, come scriveva Rilke, la morte è grande e può far sentire la sua voce pure in luoghi inaspettati. La civiltà occidentale di oggi sopprime il pensiero della morte; il corona ha costretto molti a iniziare a pensarci più seriamente.
Ma come sapevano bene le persone del passato, compresa la sconcertata Pampinea, essere vicini alla morte non necessariamente ci rende migliori. Sarà un caso che la prima delle storie del Decameron ci parli di un eroe a dir poco sospetto, come ci racconta Boccaccio, cioè ser Ciappelletto, che prima di morire inganna un pio frate con una falsa confessione. Sebbene fosse l’uomo peggiore possibile, dopo la sua morte fu considerato un santo e chiamato San Ciappelletto. Il soggetto in questione, in Borgogna per alcune delle sue dubbie vicende, si ammalò mortalmente e, per ripagare in un certo modo i suoi ospiti, pur inorridito ebbe l’idea di dover confessare sul letto di morte tutti i suoi terribili peccati, che nessun monaco o papa gli avrebbe perdonato; il peccatore così non avrebbe potuto essere seppellito ma sarebbe stato gettato nella fossa e sarebbero finiti malamente anche i padroni di casa. Allora chiede che gli trovino un pio monaco, il migliore che hanno, e farà della sua confessione una commedia tanto da sembrare così innocente che dopo la sua morte il popolo gli strapperà tutti i vestiti, considerando una fortuna averne il più piccolo pezzo. E lo seppellirono in chiesa, in una delle cappelle, e la gente andava ad accendere candele e fare voti.
Cosa dobbiamo pensare di questa storia, posta all’inizio del Decameron, tutta scritta, se non nell’ora della terribile epidemia, certamente con un ricordo vivissimo di essa? Nella più ampia percezione, cioè al di fuori della cerchia degli esperti, il Decameron è visto come una raccolta di allegri racconti erotici; opinione non del tutto errata, se solo si è consapevoli che queste storie, sicuramente le più popolari, sono una piccola parte delle centinaia che sono state raccontate.
È stato detto: non si mente nell’ora della morte. Se siamo ancora consapevoli del contesto ideologico in cui Ciappelletto vive e muore, la trama è ancora più drammatica: l’ultima confessione e l’ultima unzione sono l’ultima possibilità del peccatore di riconciliarsi con Dio, di ricevere il perdono ed evitare così la terrificante eternità di martirio infernale. Molto si può scrivere su questo comportamento di Ciappelletto, come è stato scritto, anche se, possiamo concludere, come uno dei più grandi lettori ed interpreti del Boccaccio, Erich Auerbach, rimproverando all’autore di aver raccontato una terribile avventura soltanto per il suo risvolto comico.
Ma che sia anche così; perché Boccaccio ha messo questa storia proprio all’inizio? Non dimentichiamo il lettore a cui l’autore si rivolge: è un testimone sopravvissuto alla peste e, quasi certamente, ha perso qualcuno degli a lui più prossimi.
Il poeta inglese Dylan Thomas ha scritto, in occasione della morte di suo padre, che non se ne vada docile in quella buona notte: Non andartene docile in quella buona notte, / i vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno; / infuria, infuria, contro il morire della luce [5]. Se Auerbach avesse perfettamente ragione, se tutto fosse solo una commedia e una farsa e se fosse proprio l’oscurità, come sanno i saggi, ad aver ragione, Ciappelletto sfrutta l’ultima occasione per deridere quella saggezza proprio come gli eroi di Boccaccio fuggono dall’orrore quotidiano all’apparizione di giardini paradisiaci, divertendosi a raccontare storie.
E la morte non avrà alcun dominio [6], scriveva ancora Dylan Thomas; almeno nella poesia, almeno nella narrazione.
Note
[1] Giovanni Boccaccio: Decameron, Utet, Torino 1958, pag. 1
[2] Ibid, pag. 15
[3] Ibid, pag. 16
[4] Cittadine in Sirmia (Vojvodina, Serbia)
[5] Traduzione di Ariodante Marianni
[6] Traduzione di Corrado Aiello
*
Radoslav Petković è nato nel 1953 a Belgrado dove si è laureato presso la Facoltà di Filologia, Dipartimento di Letteratura Generale. Ha pubblicato romanzi: La strada per Dvigrad (1979), Gli appunti dall’anno delle fragole (1983), Le ombre sul muro (1985), Destino e commenti (1993.), La memoria perfetta sulla morte (2008); raccolte di racconti: Il rapporto sulla peste (1989), L’uomo che viveva nei sogni (1998); libri di saggistica: Il saggio del gatto (1995), Parlando di Michelangelo (2006), L’internet bizantino (2007), L’uso degli elfi (2008), L’uovo di Colombo (2017).
Le opere di Radoslav Petković hanno ricevuto prestigiosi premi letterari, tra cui il Premio Nin del 2003 per il romanzo dell’anno (Destino e commenti). I suoi romanzi e raccolte di racconti sono stati tradotte in francese, greco, ungherese, inglese, tedesco, russo, slovacco e bulgaro; in italiano esistono soltanto due racconti, pubblicati nel panorama dei racconti belgradesi Casablanca serba (Feltrinelli, Milano 2003), a cura di Nicole Janigro. Le sue prose sono incluse in diverse antologie serbe e jugoslave e all’estero.
Ha tradotto dall’inglese i libri di Defoe, Chesterton, Stephenson e Tolkien.
Attualmente vive e scrive a Novi Sad.


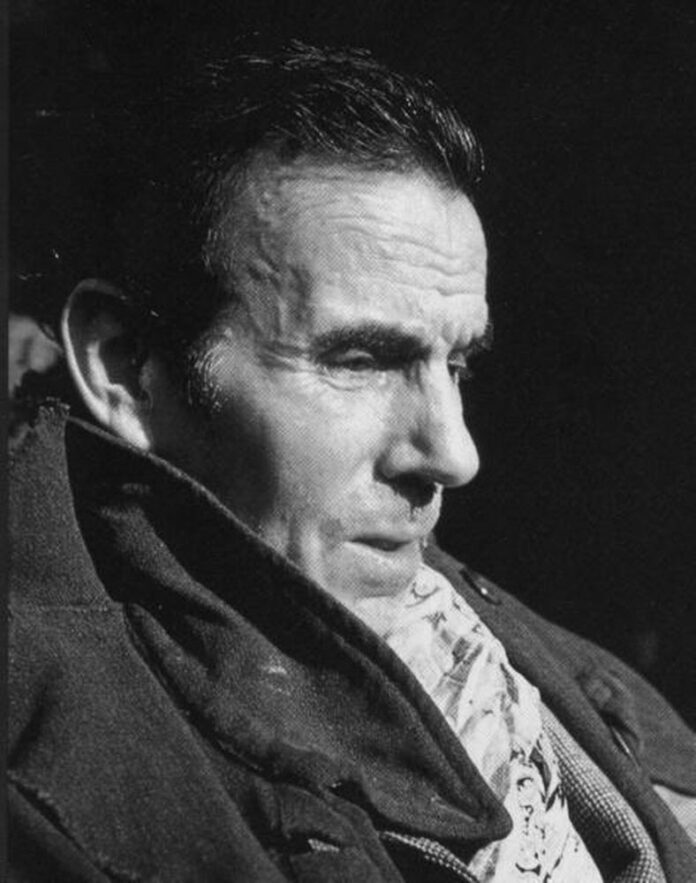
 di Mauro Baldrati
di Mauro Baldrati




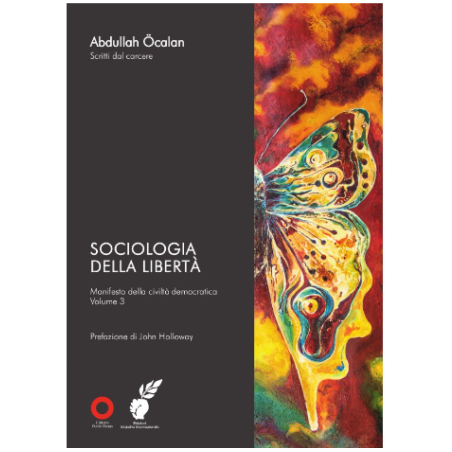
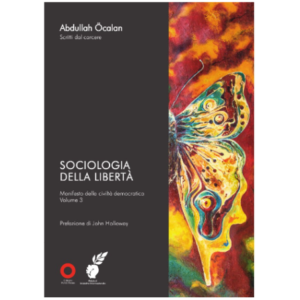



 Per motivi famigliari ho trascorso 21 giorni nella mia casa di origine e ho foggiato oggetti al tornio nel “garage dei topi”, un piccolo laboratorio casalingo ricavato da una stanza di rimessa che apparteneva a mia nonna, in disuso da parecchi anni e solo ultimamente rinnovata. Visitata nelle sere di maggiore umidità da una famigliola di scorpioni, sono andata avanti a modellare 21 oggetti di uso comune in terra bianca, quali tazze, ciotole, bicchieri, piatti, barattoli e uno spremiagrumi, non senza qualche imprecisione e qualche incidente. Essi sono andati a comporre Gea’s Dinner, un progetto sperimentale che vede un mio testo poetico frammentarsi in 21 parti, un ipertesto su ceramiche di uso comune. Ognuno dei 21 oggetti è stato decorato e cotto seguendo il processo tradizionale della maiolica che prevede una prima cottura dei manufatti a 980° e una seconda dei manufatti decorati a 930°. Gli oggetti sono rimasti dall’inizio alla fine uniti nei vari passaggi, nell’idea di perseguire il concetto di frammentazione e unione in contemporanea. Ho corso tutti i rischi del caso: di rottura, di danneggiamento, di non riuscita. Probabilmente Gea stessa si è fatta divinità tutelare dell’esperimento e ogni passaggio è riuscito senza intoppi. Ogni oggetto contiene qualche parola di un mio testo poetico inedito, che potrà esistere ed essere letto, nella sua interezza, soltanto quando gli oggetti verranno riuniti in una ipotetica “cena”.
Per motivi famigliari ho trascorso 21 giorni nella mia casa di origine e ho foggiato oggetti al tornio nel “garage dei topi”, un piccolo laboratorio casalingo ricavato da una stanza di rimessa che apparteneva a mia nonna, in disuso da parecchi anni e solo ultimamente rinnovata. Visitata nelle sere di maggiore umidità da una famigliola di scorpioni, sono andata avanti a modellare 21 oggetti di uso comune in terra bianca, quali tazze, ciotole, bicchieri, piatti, barattoli e uno spremiagrumi, non senza qualche imprecisione e qualche incidente. Essi sono andati a comporre Gea’s Dinner, un progetto sperimentale che vede un mio testo poetico frammentarsi in 21 parti, un ipertesto su ceramiche di uso comune. Ognuno dei 21 oggetti è stato decorato e cotto seguendo il processo tradizionale della maiolica che prevede una prima cottura dei manufatti a 980° e una seconda dei manufatti decorati a 930°. Gli oggetti sono rimasti dall’inizio alla fine uniti nei vari passaggi, nell’idea di perseguire il concetto di frammentazione e unione in contemporanea. Ho corso tutti i rischi del caso: di rottura, di danneggiamento, di non riuscita. Probabilmente Gea stessa si è fatta divinità tutelare dell’esperimento e ogni passaggio è riuscito senza intoppi. Ogni oggetto contiene qualche parola di un mio testo poetico inedito, che potrà esistere ed essere letto, nella sua interezza, soltanto quando gli oggetti verranno riuniti in una ipotetica “cena”.



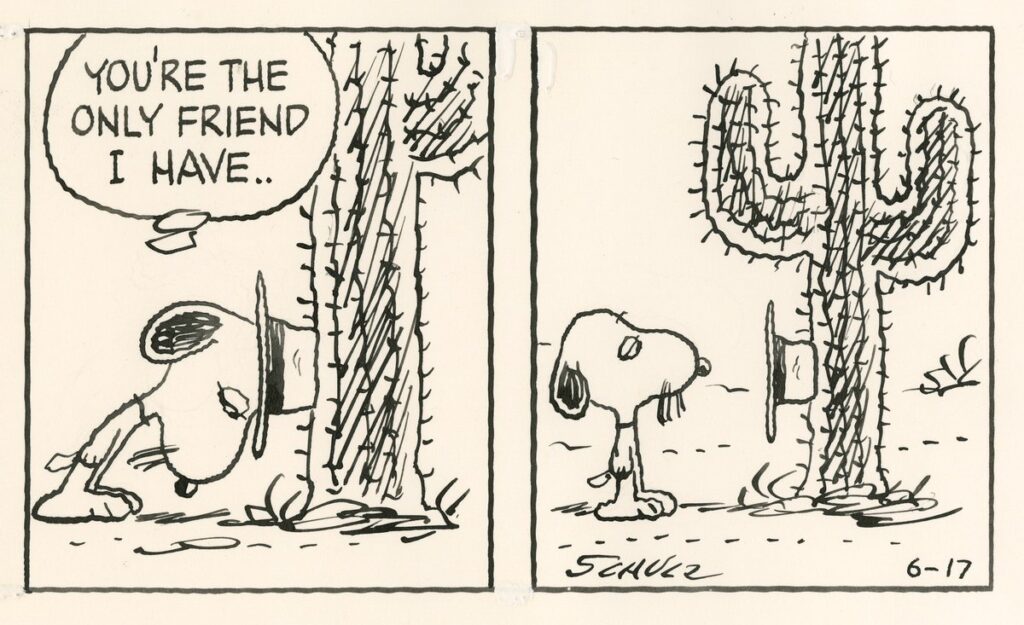

 Cronistoria di un minuto
Cronistoria di un minuto