Catarsi, sublimazione, redenzione e rinascita dell’essere umano attraverso poesia e boxe
di Dome Bulfaro
Tre incontri con la boxe per Nazione lndiana. Il poeta e performer Dome Bulfaro e la scrittrice Federica Guglielmini affrontano l’arte del pugilato, i suoi paradigmi culturali, la sua natura di sport spettacolare e poetico, invitando i lettori a riscoprire l’origine della sua forza e offrendo un’occasione di lettura, rinnovata, dell’essere umano in quanto essere sociale. Bulfaro affronterà il suo match per primo, riflettendo per appunti diaristici su boxe e poesia performativa, sul concetto di ring e sul suo ruolo simbolico e metaforico. La Guglielmini scriverà per seconda nel mese di aprile affrontando in un corpo a corpo il concetto di violenza, la figura del pugile di ieri e di oggi, specchio di un’Italia che cambia. Si ritroveranno insieme nel mese di maggio per l’incontro finale…
Il mondo è un ring
Ci sono quattro azioni individuali, inevitabili, che segnano i confini del mondo di un essere vivente: nascere, morire, combattere e non combattere. La terza di queste quattro azioni di confine, combattere, ha dato vita allo sport più antico del mondo: la boxe. I primi uomini che hanno circoscritto nella terra un cerchio e si sono battuti a mani nude dentro i confini di quel cerchio, hanno disegnato una metafora perfetta di cosa sia il mondo. Il mondo è un ring. La vita tutta è un ring.
La storia millenaria della boxe è stata scritta a suon di pugni da boxeur maschi che spesso provenivano dai margini della loro società e che sognavano di salire fino al centro del suo olimpo. Il pugilato –anche ora che sta diventando uno sport capace di attrarre anche uomini e donne della classe media che hanno studiato, che non vivono ai margini della società ma in un certo agio– preserverà sempre la sua anima di sport di frontiera, perché il suo habitat naturale è di stare nei territori più estremi della vita e della morte. Vale a dire che qualora la boxe un giorno non dovesse esser più considerata uno sport “estremo”, qualora la migliore boxe, come oggi sempre più spesso accade, non dovesse più nascere dai pugni di chi non ha nulla da perdere, certamente nascerà sempre da chi ha fame di esplorare le frontiere di se stesso: perché la boxe è per sua natura uno sport di confine, è uno sport che per esistere ha bisogno solo di tracciare un ring e due pugili che si fronteggiano.
La pugnità
Nonostante al di fuori del loro rettangolo e del loro quadrato di sfida siano tante le ombre, calcio e boxe sono i due sport che più amo. Il calcio l’ho giocato e amato fin da piccolo, il pugilato lo ammiro. Il primo lo amo perché sublima in un’arte sportiva, attraverso una palla di cuoio, il gesto del prendere a calci. Il secondo perché sublima in un’arte sportiva il prendersi a pugni.
L’aspetto che più mi affascina e conquista di questi due sport è il fatto che il gesto del picchiare, giustamente considerato nella vita ordinaria come brutale, volgare, grossolano, sia sublimato in arte; nel caso del calcio il picchiare è sublimato utilizzando principalmente i piedi, relegati solitamente nella vita ordinaria a svolgere solo funzioni come camminare o correre; e nel caso del pugilato il picchiare sia sublimato impiegando delle mani solo la postura del pugno, ovvero quella postura che limitando al massimo la manualità, ti costringe a esplorare e scoprire della mano tutta la sua straordinaria pugnità. La boxe è l’arte della pugnità, arte che per essere esercitata dal boxeur nella sua massima efficacia e bellezza, deve però coinvolgere tutto il corpo.
La mano a martello del boxeur e il gesto del picchiare che coinvolge tutto il corpo, mi ricordano il mestiere del fabbro e mi evocano la dedica che il poeta T.S. Eliot fece in The Waste Land per rendere onore a un altro autore eccelso, la quale racconta chiaramente l’essenza del mestiere del poeta: “A Ezra Pound, il miglior fabbro”. I poeti e i pugili sono fabbri.
Il poeta non è un attore ma un dicitore
Quando finisco un reading capita spesso che qualche sconosciuto mi si avvicini e dica “ma lei è un attore”, oppure “ma lei ha fatto teatro?!”. Sì ho fatto teatro, ma chi fa poesia performativa non è un attore, è un poeta.
Quando un musicista o un cantante/cantautore eseguono su un palco uno spartito o una canzone pensiamo che sia un attore?
Quando un boxeur sale sul ring o un equilibrista cammina su una corda tesa, pensiamo che sia un attore?
Perché il poeta che dice un testo ad alta voce dovrebbe essere considerato un attore?
L’arte propria del poeta è quello del fare. Quando impiega solo il linguaggio verbale del dire, che gli è proprio a differenza di quello del recitare, opera al pari di un interprete musicista, non di un attore. Quando il poeta adotta anche il linguaggio non verbale, e quindi fa poesia con tutto il corpo, agisce più come un fighter o un sordomuto che parla il LIS, piuttosto che come un attore. Con ragione, infatti, Eugenia Giancaspro adotta il linguaggio LIS nella sua ricerca poetica performativa.
Quello che sto cercando di chiarire è che il poeta anche quando dice con arte un testo poetico, in prima istanza, lo fa da poeta e non da attore.
I poeti futuristi nell’esecuzione delle loro “tavole parolibere” hanno chiarito molto bene quanto un testo scritto, in quanto testo anche visivo, debba essere visto e letto, e quindi eseguito, al pari di uno spartito. Delio Tessa, nelle sue interpretazioni, considerava i suoi testi in dialetto milanese veri e propri brani musicali in forma di parola: “come un fascio di musiche si affida all’esecuzione canora, così i miei saggi lirici attendono la voce del dicitore”. Il poeta performer non è un attore ma un dicitore.
Così come dicitore è un pugile. Dice Norman Kingsley Mailer, scrittore, giornalista, saggista e commediografo statunitense: “il pugilato è un dialogo tra due uomini che anziché parlare con la voce parlano con le mani”. Un dialogo dialettico, conflittuale, certo, ma in cui tutto ciò che i due pugili si dicono in faccia, resta chiuso e si esprime nel perimetro delle regole e dei confini del ring.
Regalare emozioni esemplari
Il pugilato ti insegna ad assorbire e incanalare colpi, emozioni, pensieri offensivi.
Quando entri nell’indifferenza o tra i fischi del pubblico ed esci tra gli applausi, evidentemente sei stato capace di regalare agli altri qualcosa di impagabile, qualcosa che gli altri nella vita ordinaria non sono quasi mai disposti a riconoscerti. Hai regalato loro speranza, coraggio, generosità, classe, sacrificio, spettacolo, arte: hai regalato emozioni esemplari. La boxe per i più non è molto remunerativa sul piano economico ma lo è moltissimo, che piaccia o meno, quasi per tutti sul piano emotivo. La poesia performativa, nelle sue due principali declinazioni dal vivo, Spoken word e Spoken music, in quanto arte del dire poesia ad alta voce, va nella stessa identica direzione: l’emozione costituisce come per la musica il primo canale di comunicazione e il suo ingresso principale. In poesia tutto, dall’accesso emotivo alle stanze della ragione e dello spirito, si fa dono esemplare.
Ring, grembo, battesimo
Il ring è un quadrato sacrificale, che le 16 corde rendono non solo un recinto, come ha ben sottolineato la scrittrice Joyce Carol Oates, ma anche una vasca battesimale, dal quale ogni volta il boxeur ne uscirà rinato. In un modo o nell’altro egli non sarà più lo stesso essere umano salito sul ring prima dell’incontro.
Perché il ring è un grembo in cui il boxer sale per ricreare se stesso, sale per capire veramente di che pasta è fatto, sale per auto modellarsi con le proprie mani. Il pugilato è uno sport molto duro, fatto per duri pronti ad ogni sacrificio. È uno sport per combattenti, che rifiutano la condanna di essere dei “nessuno” e raccolgono la sfida di diventare dei “qualcuno”. Per diventare un “qualcuno” devi però essere disposto a rinunciare a tante libertà. La boxe ti insegna che per diventare libero, come accade nella vita –gli occidentali lo hanno capito bene dopo l’attacco alle torri gemelle– devi saper rinunciare a delle libertà.
La Main de Dieu, tra le sculture più note di Rodin, rappresenta la mano destra di Dio che fuoriesce da un blocco di marmo, simbolo dell’eternità, per plasmare i corpi di Adamo ed Eva che lottano titanicamente, sull’onda della lezione michelangiolesca, per liberarsi dalla materia grezza e venire al mondo.
Il boxeur è un uomo che si fa con le proprie mani, al contrario di quanto rappresenta questa scultura. Il pugile non è tanto il Dio di se stesso quanto piuttosto il proprio demiurgo, un uomo che da “prigione michelangiolesco” della propria condizione sociale, diventa libero artefice di se stesso, colui che non è più un “nessuno”, un “inesistente”, ma uno che vale, uno che conta, uno da ricordare.
La palestra di boxe, per chi poi intraprende la via degli incontri, è come un battistero. E il ring in quanto metaforica vasca battesimale è il luogo in cui il pugile, immergendosi totalmente nel pugilato e nei suoi valori, vive un nuovo battesimo. Questa rinascita a nuova vita spesso viene sancita attraverso l’acquisizione di un soprannome affibbiato al pugile dal coach, o da un giornalista, o dal pubblico, o da altri, ispirandosi a una caratteristica tipica di quel boxeur o del suo modo di boxare. Così nascono Irma “Butterfly” Testa, Valeria “Fox” Imbrogno, Giuseppe “Flash” Parisi… come accade per i grandi eroi epici e tragici: Madame “Butterfly”, Ulisse “l’astuto”, Achille “Piè veloce”. Perché la boxe è epica scritta e detta con i pugni.
Poeteur, poeta boxeur
Ogni essere umano è in potenza un poeta performer, è poesia. Il poeta performer è un poeteur, un poeta boxeur, che ad ogni performance traccia il suo ring e combatte, armato della sua voce e del suo corpo, per liberarsi da tutte le sue sovrastrutture che lo imprigionano e mostrarsi a tutti, tanto più a se stesso, per ciò che di più vero è: opera d’arte, poesia vivente.
Boxe, gravidanza, poesia performativa
L’immagine di un boxeur incinta sarà considerata una metafora troppo azzardata e difficile da digerire da parte del mondo più maschilista e virile del pugilato. Eppure nei giorni imminenti all’incontro di boxe, il pugile che lo deve disputare mostra, sempre sul piano metaforico, ancor di più il suo essere in stato di gravidanza del suo nuovo sé: gli allenamenti corrispondono alla sua gestazione; tutti i rituali del giorno prima dell’incontro a cui per legge dovrà sottoporsi equivalgono alla fase prodromica del suo parto; il suo travaglio si consuma la sera dell’incontro da quando ci si prepara nello spogliatoio fino a quando si arriva ai piedi del ring. Poi, quando infila la testa tra le corde e si entra nel ring si approda nel grembo; quando suona il primo gong inizia il parto; e quando alla conclusione dell’incontro infila la testa nella fenditura tra le corde, l’essere umano che ne esce, talvolta col volto gonfio, o, per via di qualche taglio, talvolta col volto insanguinato, è un uomo diverso da quello entrato all’inizio dell’incontro.
La poesia performativa in cui credo insegue lo stesso principio di rinascita. Se scendi dal palco e sei lo stesso essere umano di quando sei salito prima di incontrare la poesia che sei, significa che la poesia che sei, tu non l’hai veramente incontrata, non l’hai veramente incarnata fino in fondo.
Se l’hai incarnata e sei diventato un uomo migliore hai vinto la tua sfida e puoi dire di essere stato un poeta, almeno per il tempo dei round in cui avrai combattuto. Se invece questo incontro con il tuo nuovo e migliore sé non è accaduto, significa che hai perso l’occasione di essere un poeta e allora, senza mai farti abbattere, avrai una ragione di più per riprovarci. Perché fare poesia è donare la parte più bella e migliore di sé. Come fa un riccio di mare quando ti dona la sua parte più intima e vera, dolce e tenera: il suo cuore.
Corpo ring
Quando c’è un conflitto fra due Paesi, come accade oggi tra Ucraina e Russia, si circoscrive un terreno di battaglia e si combatte. Certi che quella zona circoscritta potrebbe cambiare, allargandosi, con l’incognita di non sapere fino a che punto si allargherà l’area del conflitto e quando si richiuderà, come (quasi) tutti vorremmo. Quando si compone poesie per iscritto, il tuo campo di battaglia si traslerà su un foglio e si limiterà a una o forse richiederà un tot imprecisato di pagine… Al contrario quando boxi sai che il combattimento non sconfinerà oltre il ring, né sconfinerà oltre la somma dei minuti dei round che dovrai disputare. Perché la boxe, come dice Joyce Carol Oates, “è simile alla vita in molti particolari inquietanti. Ma la boxe è soltanto come la boxe”. È uno sport semplicissimo che si pratica rispettando poche chiare regole, in cui per vincere devi colpire cercando di non essere colpito e cercando di mandare al tappeto il tuo avversario per più di 10 secondi (KO).
Nel poeta performer il ring è il proprio corpo, concepito sia come campo di ogni battaglia, sia come strumento principe per combattere le proprie battaglie, sia come materia grossolana da sublimare attraverso il dire ad alta voce con arte.
Scrive la poetessa Antonia Pozzi “La poesia ha questo compito sublime di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci romba nell’anima e di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell’arte, così come sfociano i fiumi nella vastità celeste del mare. La poesia è una catarsi del dolore. Quando tutto, ove siamo, è buio ed ogni cosa duole e l’anima penosamente sfiorisce, allora veramente ci sembra che ci sia donato da Dio chi sa sciogliere in canto il nodo delle lacrime e sa dire quello che a noi grida, imprigionato nel cuore.”
Ma liberare ciò che è “imprigionato nel cuore” non basta né quando si fa poesia, né tantomeno quando si fa boxe. Nel film Million Dollar Baby (2004) il personaggio Eddie “Scrap-Iron” Dupris (Morgan Freeman), ex pugile nero, rimasto cieco ad un occhio per un pugno ricevuto sul ring, dice del suo fidato amico, socio ed ex allenatore Frankie Dunn (Clint Eastwood): “Alcuni direbbero che la qualità più importante per un pugile è avere cuore. Frankie invece direbbe: un pugile che è solo cuore stai tranquillo che le prende di sicuro e di brutto!” Il cuore è fondamentale sia nella boxe, sia nella poesia, ma senza la maestria del saper attaccare e difendere, può solo prendere un sacco di botte. Ogni poesia nasce da un incontro di pugilato tra il poeta e l’indifferenza; le parole e i silenzi del poeta sibilano come pugni, la sua versificazione architetta attacchi e difese, tutto il suo corpo combatte per essere e affermare nel mondo la bellezza. I poeti e gli atleti, in particolare i boxeur, sono portatori di bellezza.
Mohammed Ali vs Cassius Clay
Tutti sbagliamo e tutti cadiamo ma non tutti sanno trasformare i propri sbagli e le proprie cadute in punti di forza, trampolini di lancio, arte.
Il giovane Cassius Clay inizia a boxare, tra le tante ragioni, perché sul ring, bianchi e neri a differenza di quanto accade dov’è cresciuto, combattono di fronte l’uno all’altro alla pari.
Lì sul ring il razzismo che sconta ogni giorno nella sua Louisville in Kentucky non trova spazio.
Ali ostenta una fede in se stesso mai vista nella storia del pugilato, una fede che nel tempo scoverà la propria radice nella inossidabile fede in Dio, che in lui non vacillò mai soprattutto quando nella sua vita di pugile superstar subentrò il morbo di Parkinson.
Nessun pugile e nessun fatto, guardando alla sua fede, lo atterrarono mai, nemmeno il Parkinson, nemmeno la morte.
Questo intende Ali quando nella sua autobiografia afferma che un campione va costruito dall’interno e che conta più la volontà dell’attitudine.
Per la poesia vale la stessa legge, tanto più se performativa: va costruita dall’interno, perseguendo con una volontà ferrea lo scopo di diventare poesia vivente.
Molta follia
Vitalij Klyčko nel film omonimo Klitschko, film documentario tedesco del 2011 diretto da Sebastian Dehnhardt e ispirato alla vita dei due fratelli pugili ucraini Vitalij Klyčko e Volodymyr Klyčko (entrambi ora al fronte per combattere l’invasione russa) paragonando il pugilato agli scacchi dice che “gli scacchi sono simili al pugilato. Hai bisogno di sviluppare una strategia, e hai bisogno di pensare due o tre passi avanti riguardo a ciò che il tuo avversario sta facendo. Devi essere astuto. Ma qual è la differenza tra gli scacchi e il pugilato? Negli scacchi, nessuno è un esperto, ma tutti giocano. Nel pugilato tutti sono esperti, ma nessuno combatte. Nessuno combatte perché molti pensano che salire su un ring per prendersi a pugni sia pura follia.”
Sì, è vero, credo anch’io occorra molta follia. La poetessa Emily Dickinson ha scritto che: “molta follia è divina saggezza/ per un occhio capace / molta saggezza, pura follia”. Senza molta follia Alda Merini non avrebbe incontrato se stessa, non avrebbe esercitato il potere della poesia, sublimando in gioia pura le tragedie della propria vita, compreso l’internamento in un manicomio. Nella boxe la molta follia è divina saggezza.
Battere il tempo
Osservando due pugili sul ring ti accorgi che il pugilato si regge su quattro principi, annodati e inscindibili fra loro, come se formassero un serpente infinito, l’Ouroboros, che ancora una volta rimanda a un anello, un ring: 1- la boxe è la più antica arte dell’offesa; 2- per offendere bisogna sapersi difendere; 3- offendere è il primo principio di difesa; 4- la difesa è il primo passo per offendere.
La sua finalità è battere l’avversario e per batterlo bisogna “batterlo”, nel senso di picchiare. La boxe quindi è l’arte di “battere” l’avversario, intendendo il battere nel suo doppio significato. Ma se il pugilato è “l’arte del battere” allora la sua essenza è il ritmo. George Foreman, icona della boxe mondiale, dice che “la boxe è una specie di jazz”, Sugar Ray Robinson, altro mito del pugilato, afferma che “il ritmo, nella boxe, è tutto. Qualsiasi movimento tu faccia, nasce dal cuore: o questo ha il ritmo giusto, o sei nei guai”. Lo stesso concetto, riprendendo Ray Robinson, lo afferma Muhammad Ali. I pugni che più regalano emozioni esemplari al pubblico sono quelli che nascono dal battito del cuore. Il pugile più poetico è quello che si batte con un cuore da leone e con la massima arte pugilistica.
Il battere e il battersi mi ricordano la pratica del modellare l’argilla, specie quando si forma una scultura di grandi dimensioni, ad esempio, come lo è un essere umano a figura intera in scala reale. L’impostazione di una scultura del genere si crea mettendo argilla intorno alla struttura portante in ferro, ma la forma all’argilla la si conferisce alla materia battendola per compattarla e imprimere una precisa foggia, secondo la nostra volontà.
I pugili sono sculture viventi che si modellano a suon di pugni diretti, jab, ganci… il loro battersi ci consegnerà alla fine dell’incontro due uomini/scultura che si sono rimodellati il volto e lo spirito. Il terribile e la grazia, sono le due componenti opposte che convivono nell’arte del pugilato e che rendono questo sport profondamente poetico. E nessuno, più di Ali, ha incarnato al meglio nella figura del pugile questo ossimoro. Ali è stato per antonomasia il pugile in cui il battere era poesia.
Il pugile che sogna di diventare un Campione del Mondo di boxe, combatte e sogna di battere il tempo, sogna in cuor suo l’eternità. Lo stesso fa il poeta nel battere il tempo dei suoi versi: sogna di battere il tempo: sogna in cuor suo l’eternità.
Ring sportivo, ring sociale, ring estetico
“Il pugilato è solo lo spogliatoio, i problemi del mondo sono il ring”. Muhammad Ali con queste parole non solo spiega bene cosa sia un ring, ma rendendolo un simbolo e una metafora, ne sublima il ruolo e il senso. I ring sono campi di battaglia politica, sociale, etica. Per lui ci sono ring secondari, preparatori, come quelli del pugilato, e ci sono ring fondamentali come la segregazione sociale, i diritti, la giustizia sociale, la libertà… Dice Ali quando con la conversione alla Nation of islam assume il nuovo nome di Muhammad – “Clay” – che in inglese significa argilla – “è un nome da schiavo e io non sono più uno schiavo”. Il poeta e traduttore Albang Lefranc, autore del libro Il ring invisibile (66thand2nd, 2013) lucidamente evidenzia come “la cultura orale, anche nella poesia, propria dell’islam, è il perfetto vestito dell’Ali comunicatore, la parola aggressiva e seducente di Ali”.
Una delle battaglie più combattute da Ali è stata di tipo estetico: ha aperto un ring sociale sull’ideale di bellezza dominante nella sua società.
“Nero=bello”, principio estetico da lui sostenuto e dato quasi da nessuno come modello vincente, vs “Bianco=bello”, principio di bellezza, campione in carica da secoli, sostenuto non solo dai bianchi ma anche da molti neri. Questa sfida condotta da Ali assume un valore politico e assurge a riscatto di tutti i neri, non solo d’America. Nascere neri, sostiene Ali, è motivo d’orgoglio per un essere umano perché si ha il valore aggiunto di essere belli, i più belli di tutti, soprattutto più belli dei bianchi. Ali sa che spodestando i bianchi dal trono della bellezza fisica, toglierà parzialmente al bianco potere e quindi fascinazione, liberando i neri dai loro stati di inferiorità e schiavitù inconsci, ancora molto tangibili negli USA degli anni Sessanta e Settanta. Quando Ali afferma non solo di essere bello ma di essere il più bello, lo fa sottintendendo di essere anche più bello dei bianchi più belli. Lo scrittore e docente Marco Mazzeo nel suo libro Il sofista nero. Muhammad Ali oratore e pugile, mette bene in luce questi concetti e il ruolo socio-politico giocato da Ali; quanto egli abbia boxato fuori e dentro il ring sportivo, anche con le parole, tanto da essere considerato da molti un precursore del rap e vero poeta (come egli stesso si definiva); quanto il suo volteggiare con le parole e il suo pungere con la lingua per provocare il suo prossimo avversario – non di rado con tanto di versi e rime – trovasse una perfetta corrispondenza col suo modo di boxare sul ring sportivo. Ali stesso condensa il suo stile in una frase rimasta indimenticabile anche per la sua potenza poetica: “Volteggia come una farfalla, pungi come un’ape. Le mani non possono colpire ciò che gli occhi non possono vedere.”
Atlanta, nel 1996, Ali
Il pugile, per molti versi è un essere umano votato al sacrificio pasquale, che talvolta compie la sua trasfigurazione. E ancora una volta è Muhammad Ali, in veste questa volta di tedoforo del Giochi della XXVI Olimpiade, a donare a tutta l’umanità l’immagine più icastica quando ad Atlanta, nel 1996, nel bel mezzo del match tra lui e il Parkinson, stringendo la torcia nel pugno tremante, accende il sacro fuoco delle olimpiadi, dandole ritualmente inizio.
Il pugile sul ring innanzitutto è un essere umano che chiede di essere considerato da tutti con dignità. Sul ring di boxe prima e sul ring della vita poi, Ali ci mostra e dimostra che ogni persona, qualunque essa sia, nera o bianca, sana o malata, merita di essere trattata e considerata con la massima dignità.
Il gesto di Atlanta e la sua poesia Me, we, creata con un tempo di reazione allo stimolo “dicci una poesia”, pari a un destro-sinistro da ko tecnico, hanno dimostrato la straordinaria capacità di Muhammad Ali nell’essere un uomo capace di rappresentare tutti.
I tasti della boxe
I quattro angoli che tracciano il quadrato in cui si muove la boxe in quanto arte nobile sono: agilità, tattica, ascesa e ritmo. Ma è la sfida la fascia di corde che unisce tutti e quattro gli angoli, come le bende fanno con le 4 dita sotto i guantoni. Così come è la sfida il tappeto vibrazionale che sostiene l’incontro.
Poi ci sono i 4 angoli che rendono la boxe un’arte micidiale: potenza, velocità, precisione, resistenza.
È su questo ring che la boxe si trasforma in un pianoforte in cui la tastiera da battere si sviluppa tra la lotta per la sopravvivenza e la grazia di una danza.
Ring, anello quadrato
Gli anelli che infiliamo al dito sono perlopiù circolari ma ne esistono anche di squadrati.
Quando due per strada si picchiano, le persone che accorrono si accrocchiano, in cerchio, facendo capannello. E infatti non a caso, guardando alla storia del pugilato, il primo ring è a forma di cerchio. La parola “ring”, infatti, in inglese significa “anello”, e deriva dalla pratica di disegnare un cerchio intorno ai duellanti. I ring da circolari sono diventati “anelli quadrati” nel momento in cui i match, da incontri di un solo round (cerchio), sono stati regolamentati in riprese e intervalli, anche perché un conto è tracciare con un bastone un cerchio sulla terra, altro è costruire palchi circolari. C’è stato un periodo, nel XIX secolo, in cui i ring sono stati costruiti ottagonali e definiti da corde e pali, ma la forma quadrata si è presto affermata come quella più funzionale, anche rispetto agli angoli necessari, durante gli intervalli, all’assistenza tecnica e medica del pugile.
Del cerchio del ring resta, come riverbero, il circo mediatico –circo significa cerchio e deriva dal greco kirkos o krikos – che si riaccende intorno alla boxe dei grandi eventi. E sotto al circo mediatico, c’è un altro cerchio, un ring sotterraneo e infernale. Il pugilato è uno sport pulito ma che rischia più di altri sport di precipitare nelle mani di una cerchia torbida. Duilio Loi, campione del Mondo dei pesi welter junior tra il 1960-63, ci ricorda che: “Sul ring è una battaglia a viso aperto, nell’ambiente pugilistico intorno al ring invece è una battaglia troppo nascosta, troppi intrallazzi” (in La storia siamo noi, programma Rai).
La pagina o il palco per il poeta, al di là della loro forma fisica quadrilatera, corrispondono al suo ring circolare. La poesia che nascerà da quel campo di battaglia quadrilatero sarà l’anello di congiunzione tra lui e la comunità, sarà l’anello tra la propria esperienza personale e l’universale.
Chi boxa non fa a pugni, boxa
Fa a pugni chi si prende a cazzotti per strada, chi non ha rispetto dell’avversario, di certo non il boxeur che fa del rispetto dell’avversario un perno etico: il boxeur non fa a pugni, il boxeur boxa. Recita infatti dal 1880 il motto della British Amateur Boxing Association: “Fai la boxe, non a pugni”. Un conto è essere violenti e altro è dirsele con i pugni di santa ragione, con arte, nel rispetto del proprio avversario e delle regole del conflitto sportivo. Picchiare è un atto brutale se dissociato dall’atto e dall’etica condivisa del combattere, il cui significato è battere insieme” (dal prefisso latino cum-). Ma anche il verbo combattere, resta in fondo difettoso se riferito al pugilato. Boxare, a differenza del verbo combattere, è l’unico capace di restituire pienamente alla boxe il suo ruolo agonistico e artistico.
La legge è uguale per tutti
La palestra di boxe è un luogo di integrazione, dove ognuno è accettato per quello che è, perché si parla una lingua comune che è quella del sacrificio e del pugilato, una lingua forgiata per imparare a superare le barriere. La palestra di boxe ti insegna il rispetto, sviluppa la socialità, il mutuo aiuto, perché è frequentata da una umanità che deve spesso fare i conti con delle difficoltà. Favorisce l’integrazione, soprattutto quando è frequentata da persone di tante differenti nazionalità.
“La legge è uguale per tutti” è un principio base del nostro sistema giuridico, che dovrebbe essere la regola in un mondo che vuole essere giusto. Ma chi proviene dalla povertà impara presto che questo principio che si staglia a caratteri cubitali in molti tribunali, risulta spesso fasullo non appena viene calato nella realtà.
Questo innanzitutto differenzia la vita del ring dalla vita nella società: poche regole e chiare della boxe, a fronte di leggi ipertrofiche che generano solo confusione, insicurezza e iniquità, nella vita fuori dal ring. Il pugile trova nel ring quel rigore giusto e giustificato, che non ha trovato nella vita, dove ad ogni passo incappi in ingiustizie sociali.
Così come sul ring hai la sensazione che tutti siano uguali, lo stesso accade nei poetry slam, ovvero gare di poesia oramai diffuse in modo piuttosto capillare in tutto il mondo. Quando sali sul ring non conta il tuo curriculum vitae o il tuo conto in banca, conta solo quello che saprai dimostrare di essere. Lo stesso vale per i poeti slammer che gareggiano nei poetry slam. Il pubblico, applica poche e chiare regole, per giudicare i poeti in gara, solo ed esclusivamente rispetto a quello che dicono e come lo dicono nei tre minuti in cui calcano il palco, e non per quello che nella vita ordinaria sono o hanno.
Ed è un modo straordinario di rinegoziare la propria identità e avere la possibilità di rinascere, preservandosi l’opportunità di ripartire ogni volta da zero.
Boxe e redenzione
Il ring è il ritorno nella culla sicura, mentre il mondo fuori dal ring spesso rappresenta per il pugile la giungla in cui si sente perso: la selva selvaggia da cui Dante cerca di fuggire.
Il boxeur non fugge però dalla realtà, ma sul ring la affronta per la prima volta ad armi pari, uno contro uno, e non più uno contro tutti ad armi ìmpari, come invece accade nel mondo fuori dal ring.
Un uomo che resta intrappolato nella vita violenta della strada è un uomo incarcerato nelle leggi violente della strada e nei vicoli ciechi di qualunque altra sua interiore selva selvaggia.
Un detenuto che trova lavoro, dopo essere stato rinchiuso nel quadrato di una cella, può ambire al massimo alla “riabilitazione sociale”. Ma il più delle volte, almeno nel nostro sistema penitenziario – così ci racconta il rapper Kento nel suo libro Barre – la condizione di detenuto è l’anticamera del diventare carcerato. Null’altro. Molti ragazzi sarebbero diventati carcerati o avrebbero fatto una brutta fine se non ci fosse stata la boxe. La storia di questo sport è costellata da persone salite sul ring che nel nuovo ruolo di boxeur, si sono non solo riabilitate ai propri occhi e a quelli della società, ma si sono redente. La boxe per molti rappresenta, ancora oggi, l’anticamera della propria redenzione, specie nelle aree più disagiate e multietniche.
“Non c’era redenzione, bisognava rimanere, infornare, sfornare e vendere” scrive Manzoni nei Promessi Sposi a proposito dei fornai. Ma lo stesso vale per la vita di tutti gli esseri umani: a volte pare di camminare tutti in cerchio, come carcerati, come topini su una ruota, in un fazzoletto d’aria, in gabbia. Vale la pena vivere se vivere significa solo mangiare, defecare e produrre? La vita che ci è data, affinché non resti solo il prodotto di un atto riproduttivo, affinché acquisisca il suo senso più alto, non andrebbe riscattata, non andrebbe redenta, liberata da tutte le nostre schiavitù?
Nella mia personale esperienza, provenendo dalla povertà, e avendo avuto due genitori originari del sud Italia, con alle spalle storie molto difficili, a tratti tremende, fatte di povertà e tragedie, so bene cosa abbia significato per loro in termini di riscatto sociale, l’essere usciti dalla povertà dopo tanti sacrifici, l’essersi ritagliati un ruolo dignitoso e l’aver avuto una figlia e un figlio che hanno trovato un proprio ruolo sociale rispettato, considerato, riconosciuto. Il concetto è ben espresso dal nostro Carnera, primo (di nome e di fatto) campione del Mondo italiano dei pesi massimi “I pugni si danno, i pugni si prendono. Questa è la boxe. Questa è la vita. E io nella vita ne ho presi tanti di pugni, veramente tanti… Ma lo rifarei, perché tutti i pugni che ho preso sono serviti a far studiare i miei figli” (da Carnera – The Walking Mountain di Renzo Martinelli, 2008).
Laddove lotta un popolo oppresso, laddove lottano delle classi diseredate e sfruttate; uomini precipitati nelle spire della violenza, del vizio, del disonore… lì si disegni non una cella ma un ring, luogo di riscatto e redenzione.
Avversari del poeta performer
Il pugile è più facilmente messo spalle al muro, all’angolo, rispetto al poeta performer e ancor di più lo è rispetto all’attore.
I poeti in genere, e tanto più un poeta performer nel momento in cui sale sul palco, dovrebbero avere come primi avversari da sconfiggere l’esibizionismo, l’autocompiacimento e l’inseguimento del consenso. Il poeta che non si sente messo alle strette da questi tre avversari, difficilmente incontrerà se stesso. Più alte sono le difficoltà che affrontiamo in un incontro e più sarà facile sapere chi siamo veramente.
Varcare la soglia del ring
Il pugile che varca la soglia del ring è pronto a parlare un linguaggio virile, tragico, poetico che ha come fine l’autoaffermazione. Ogni suo gesto atletico si fa espressione non solo di un individuo ma di una società che con lui si identifica.
Una vita intera si condensa in 3 minuti di tempo e tutto ciò che accade, dal semplice inarcamento della schiena per superare le corde, al mettere il paradenti, dall’abbraccio in clinch, a un pugno incassato e sferrato: tutto, dai più piccoli dettagli a quelli più eclatanti, viene amplificato dal linguaggio della boxe all’ennesima potenza. L’ampificazione mediatica di un incontro di pugilato, da questo punto di vista, non è altro che la ulteriore gran cassa, di una amplificazione già propria del gesto sportivo e della boxe in particolare.
Il grado di spettacolarità di questo sport risiede nel linguaggio stesso della boxe, teso a non tirare semplicemente un pugno, ma a cercare con allenamenti estenuanti e nell’incontro la perfezione del colpo, il pugno che metta l’avversario KO.
Varcare la soglia del dolore
La volontà di superare la soglia del dolore è propria del boxeur ma anche del poeta. Le poesie svolgono anche questo ruolo. Tracciano con le loro parole una soglia del loro dolore.
La boxe ti insegna ad andare oltre il dolore, ti insegna a gettare il cuore oltre il recinto del dolore ma ti insegna anche che a volte, dopo che le hai provate tutte proprio tutte, bisogna saper dire basta e gettare la spugna.
Si può vincere anche quando accetti e comprendi che è tempo di gettare la spugna o che è tempo di appendere i guantoni al chiodo, si può vincere anche riconoscendo che l’avversario è stato migliore di te o che, l’avversario non lo è stato, ma accetti con sportività il verdetto degli arbitri.
Perché la boxe ti insegna a vincere ma soprattutto a bere il calice della sconfitta e della perdita.
Si è sconfitti non quando si perde ma quando ti nascondi dietro degli alibi, quando non riconosci che avresti potuto dare molto di più e non l’hai fatto, si è veramente sconfitti quando non si ha il coraggio di guardarsi dritti negli occhi, quando cedi il campo alla paura di perdere tutto. Dovesse capitare di perdere, se hai dato tutto, non sarai un perdente se sarai pronto ad accettare, accogliere, trasformare una sconfitta in una grande lezione di vita.

Valeria Imbrogno
Voglio chiudere lasciando il centro del ring a Valeria Imbrogno, psicologa ed ex Campionessa del Mondo di Boxe, categoria Minimosca, che avrò come ospite della finale del Ring Rap Poetry Slam (https://www.poesiapresente.it/news/ring-rap-poetry-slam/), il torneo di Mille Gru (https://millegru.org/) che si concluderà l’8 aprile 2022 (evento in cui ospiteremo anche Giuliano Logos, Campione del Mondo di poetry slam in carica): “Per diventare un vero atleta si deve praticare una forma di ascesi sportiva nello sforzo di perfezionarsi: verranno promossi unità e armonia personali, raffinando la mente e superando i limiti corporei. In presenza di un’autentica cultura sportiva, si rimane entro il confronto, senza cadere nello scontro. Il pugile ha l’obbligo di essere metodico e sistematico anche davanti ad un momento cosi’ difficile come un’aggressione e lo fa per la sua stessa sopravvivenza. Il suo gesto è razionale e non brutale, cerca di sottomettere l’avversario nel rispetto delle regole. La perdita di etica del gesto in sé è superata dalla valutazione complessiva del pugilato come arte che si pratica per ottenere traguardi individuali rendendo imprescindibili dei principi morali su cui si basa la pratica stessa perché questa sia un atto umano accettabile: il principio di responsabilità, di integrità della persona, del sano agonismo, del rispetto assoluto dell’altro e del superamento di sé. Questi principi valgono come guida per valutare positivamente un’attività sportiva qual è il pugilato, in modo che sia il degno e giusto coronamento della persona.”
Bio
Dome Bulfaro (1971), poeta e performer, tra i più attivi in Italia nello sviluppo della poesia performativa e della poetry therapy. Su invito degli Istituti Italiani di Cultura ha rappresentato la poesia italiana in Scozia (2009), Australia (2012), Brasile (2014), Argentina (2020/2021), Germania (2022). Ha ideato e cofondato la LIPS, Lega italiana poetry slam e ha raccontato il movimento slam, internazionale e italiano, nel libro Guida liquida al poetry slam (2016). Ha fondato e dirige dal 2020 con Simona Cesana PoesiaPresente LAB, prima scuola italiana di poesia performativa, poesiaterapia e scrittura poetica, e la rivista Poetry Therapy Italia. È incluso nella prestigiosa antologia Tempo: Excursions in 21st Century Italian Poetry (2022) a cura di Luca Paci, tradotto da Cristina Viti.
Federica Guglielmini è nata a Rimini nel 1986. Vive e lavora a Milano. Dopo il diploma in psicopedagogia e la laurea in Lettere moderne ha vissuto a Chicago, nella Windy City dell’Illinois. Tornata dagli Stati Uniti ha collaborato con la Casa della poesia di Milano al fianco di Tomaso Kemeny, organizzando eventi culturali. É scrittrice ed educatrice. Ha curato la rubrica “Vieni all’angolo con noi, la cultura del ring” per la Federazione pugilistica italiana Lombardia.






























 La ricerca poetica di Lorenzo Mizzau in questi anni si è concentrata su due aspetti. Il primo è quello della tensione narrativa. I suoi testi, infatti, descrivono situazioni, in cui ovviamente agiscono dei personaggi (Tom in questo caso) e si riconoscono scenari, ambienti, luoghi. Insomma come in ogni narrazione vi è uno spazio e soprattutto un tempo che scorre. Nel caso di Mizzau – come si vede leggendo il primo dei due testi – la temporalità è duplice: quella della scena del testo e quella (esibita e dichiarata) che separa il narratore-poeta dal protagonista. E a fronte di tutto questo scorrere del tempo, la narrazione però non parte, inciampando su sé stessa, come se fosse contrastata da qualche intralcio non pienamente visibile. Se ne ricava un senso di stasi e di immobilità. Questa immobilità conduce al secondo punto: la rappresentazione del soggetto sofferente. L’io di Mizzau non è in armonia con il mondo, ma nemmeno in una fase di scontro. E del resto non si può dire neanche che l’io subisce il mondo: semmai lo ha già subito, ne è rimasto vittima o ferito, e ora vive il conseguente dolore e l’inevitabile disagio: un disagio che trova espressione in immagini e tenta una sua via di espressione attraverso le continue allitterazioni, che creano un significativo rumore di fondo. Ed è con questo rumore di fondo che Mizzau cerca di sintonizzare il suo lettore.
La ricerca poetica di Lorenzo Mizzau in questi anni si è concentrata su due aspetti. Il primo è quello della tensione narrativa. I suoi testi, infatti, descrivono situazioni, in cui ovviamente agiscono dei personaggi (Tom in questo caso) e si riconoscono scenari, ambienti, luoghi. Insomma come in ogni narrazione vi è uno spazio e soprattutto un tempo che scorre. Nel caso di Mizzau – come si vede leggendo il primo dei due testi – la temporalità è duplice: quella della scena del testo e quella (esibita e dichiarata) che separa il narratore-poeta dal protagonista. E a fronte di tutto questo scorrere del tempo, la narrazione però non parte, inciampando su sé stessa, come se fosse contrastata da qualche intralcio non pienamente visibile. Se ne ricava un senso di stasi e di immobilità. Questa immobilità conduce al secondo punto: la rappresentazione del soggetto sofferente. L’io di Mizzau non è in armonia con il mondo, ma nemmeno in una fase di scontro. E del resto non si può dire neanche che l’io subisce il mondo: semmai lo ha già subito, ne è rimasto vittima o ferito, e ora vive il conseguente dolore e l’inevitabile disagio: un disagio che trova espressione in immagini e tenta una sua via di espressione attraverso le continue allitterazioni, che creano un significativo rumore di fondo. Ed è con questo rumore di fondo che Mizzau cerca di sintonizzare il suo lettore.


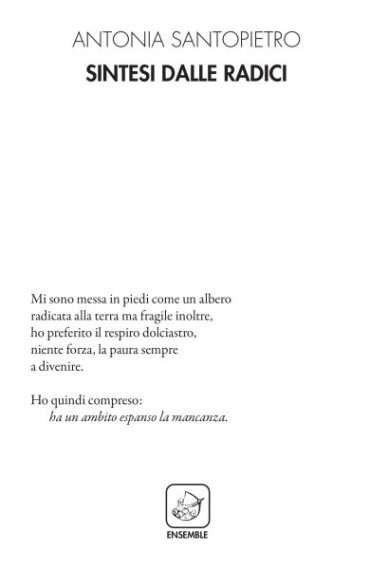
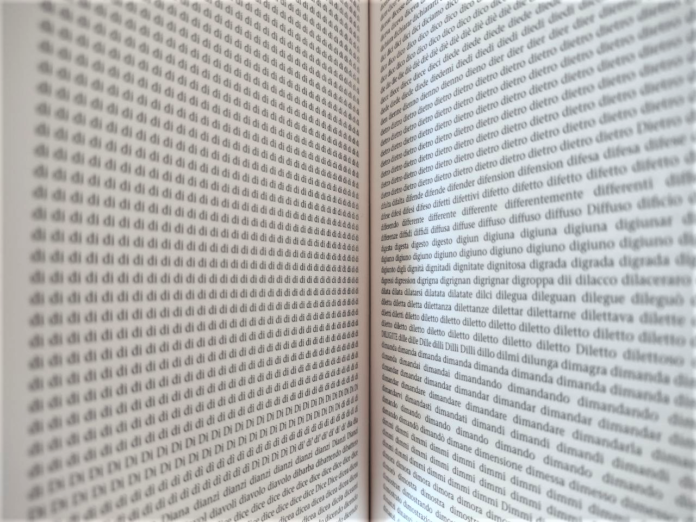








 a cura di Franco Buffoni
a cura di Franco Buffoni

 Quando Dattadeva fece venire gli sbirri nella sede centrale, lì al Mulino, all’inizio credetti che stesse portando all’estremo le logiche da brigatisti del Carme e di Girolamo – scatenare una repressione per attivare una mobilitazione generale, pensa tu cosa mi toccava sentire nei rapporti che ci facevano i nostri.
Quando Dattadeva fece venire gli sbirri nella sede centrale, lì al Mulino, all’inizio credetti che stesse portando all’estremo le logiche da brigatisti del Carme e di Girolamo – scatenare una repressione per attivare una mobilitazione generale, pensa tu cosa mi toccava sentire nei rapporti che ci facevano i nostri.



