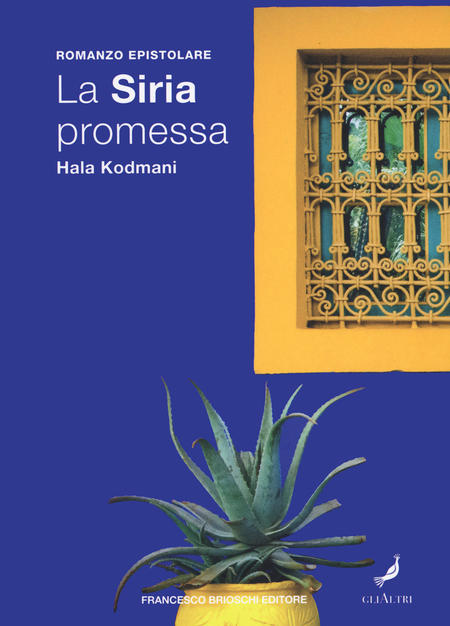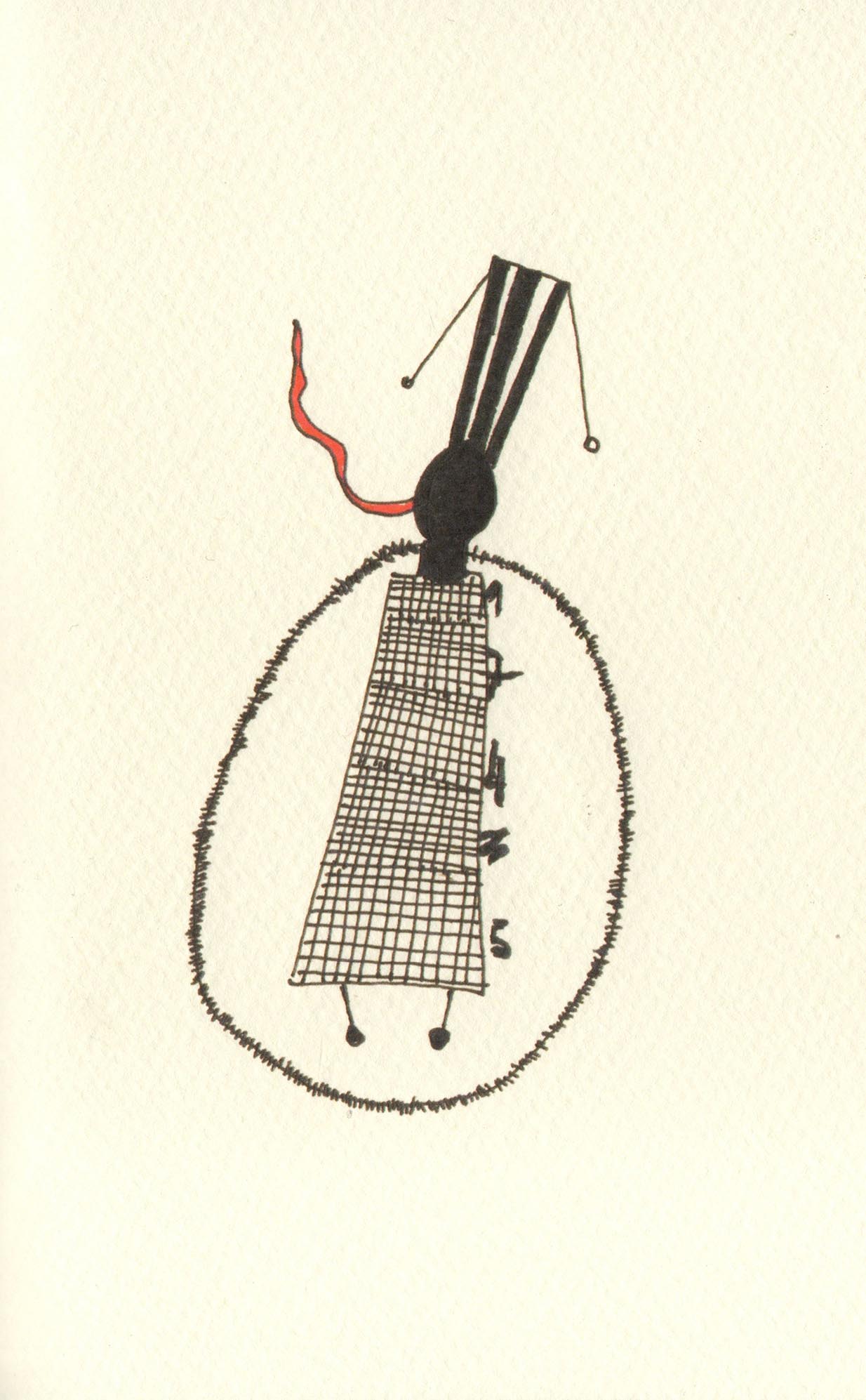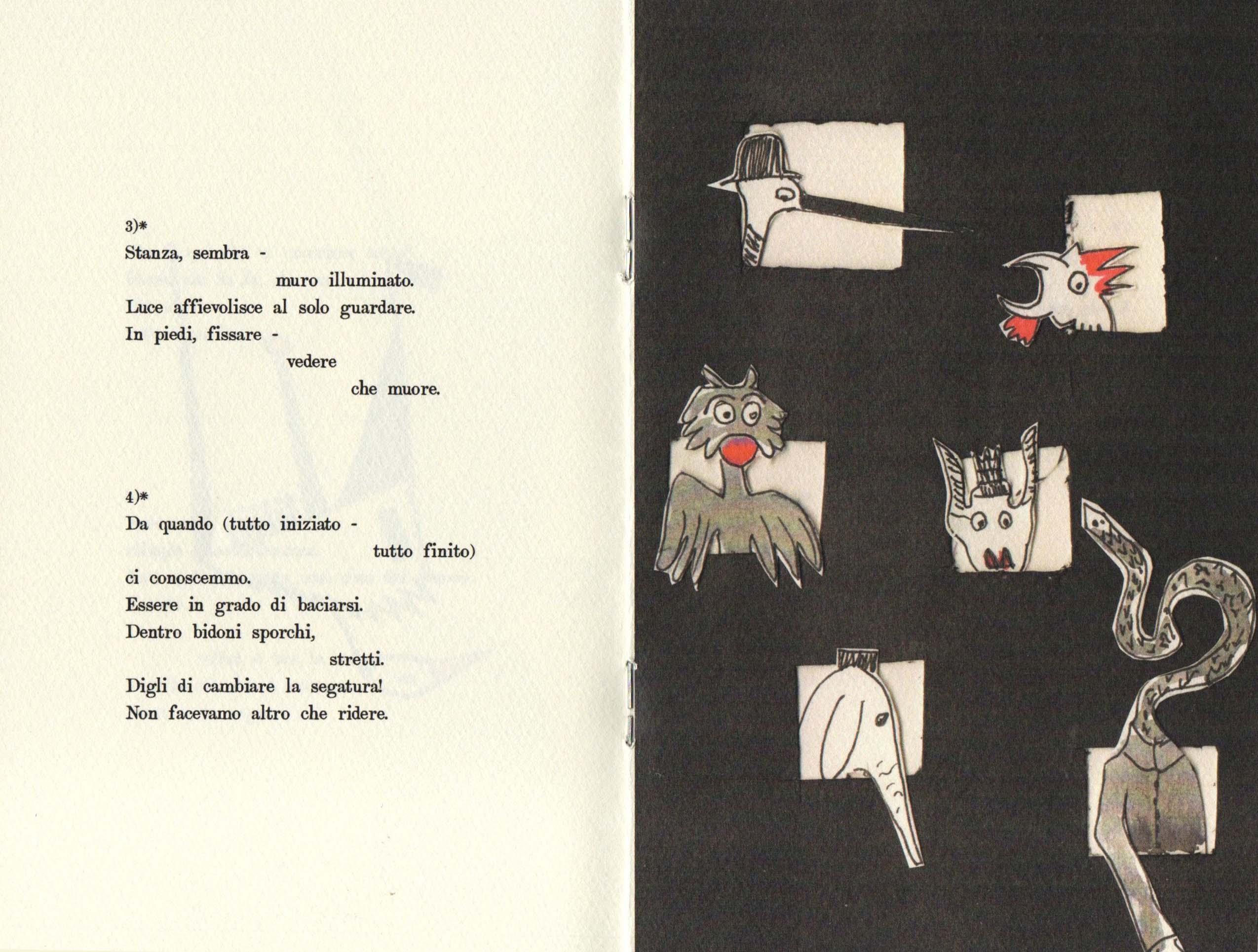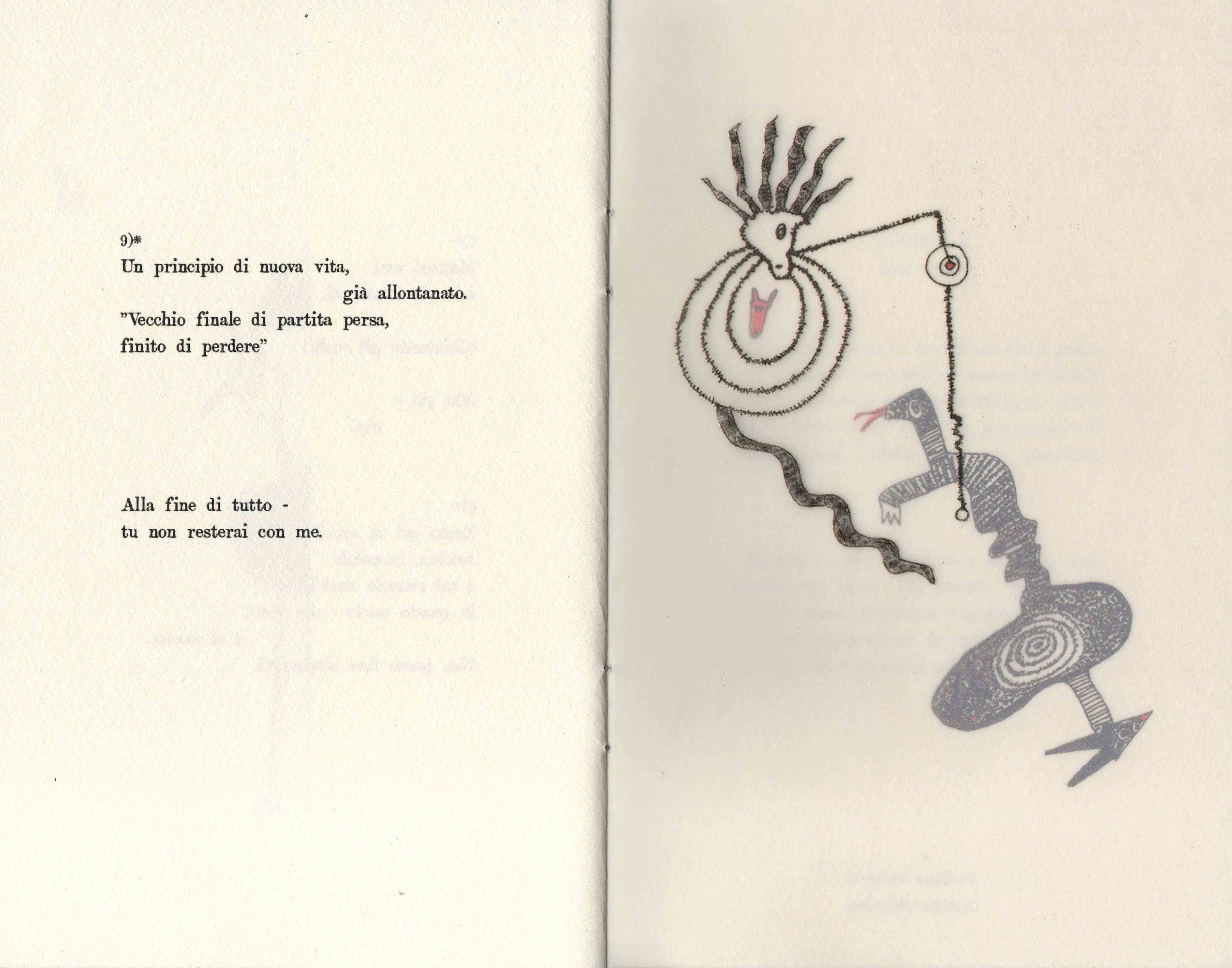di Riccardo Valsecchi – @inoutwards
[parte 4 di 4 – leggi la parte 1 – parte 2 – parte 3]
8. LA TERRA PROMESSA
What happens to a dream deferred?
Does it dry up
like a raisin in the sun?
Or fester like a sore—
And then run?
Does it stink like rotten meat?
Or crust and sugar over—
like a syrupy sweet?
Maybe it just sags
like a heavy load.
Or does it explode?
(Che cosa succede ad un sogno differito?
Si prosciuga
Come uvetta al sole?
Oppure marcisce come un’infezione—
E poi si espande?
Puzza come carne marcia?
O fa la crosta e lo zucchero sopra––
come un dolce sciropposo?
Forse semplicemente sprofonda
come un un carico pesante.
Oppure esplode?)
“Harlem” di Langston Hughes – da “Montage of a Dream Deferred”, 1951
Nell’estate del 1988 il decano degli allenatori italiani, Valerio Bianchini, detto “il profeta”, immagina, in un editoriale pubblicato su Repubblica, di poter ingaggiare Isiah Thomas per la propria squadra, la Scavolini Pesaro: “Anche noi vorremmo poter dire: lottiamo con i Pistons per strappare Isiah Thomas alla NBA, portarlo in Italia e trasmettere in diretta la firma del suo mega-contratto per la Scavolini, ma questo è semplicemente impossibile.”
Chissà. Forse, se glielo avessero chiesto…
Un anno dopo la sconfitta al Garden e le polemiche per le dichiarazioni di Isiah nel post-partita, i Pistons sono infatti reduci dall’ennesima delusione: nonostante siano riusciti, finalmente, ad eliminare i Celtics di Bird, hanno appena perso la prima finale NBA della storia di Detroit contro i Lakers dell’amico del cuore Magic. Il quale, per una gomitata di troppo, non parlerà più ad Isiah per i successivi trent’anni. Qualcosina di peggio. Quando l’Olimpo della NBA acconsentirà a confrontarsi con i mortali del pianeta terra alle successive Olimpiadi di Barcellona del 1992, Magic, in combutta con Bird e Michael Jordan, porrà un veto sulla presenza di Isiah. Rancori e gelosie che ancora oggi animano le discussioni sui siti di gossip sportivo, dato che Thomas, vincendo finalmente l’anello NBA nelle stagioni 1988-89 e 1989-1990, e perdendo solo in semifinale l’anno successivo contro i Bulls di Michael Jordan, – aka Mr. Air, MJ, o Black Jesus per gli adepti di questa religione chiamata basket -, confermerà di essere ancora, in quel 1992 olimpico, a tutti gli effetti, il più forte playmaker in circolazione.
Respiro. Wow. Trent’anni sono passati da quell’articolo, eppure ero sicuro di non averlo sognato. Certo, quella di Bianchini era una provocazione, ma spiegatela ad un ragazzino di dodici anni! Ricordo le emozioni, i sogni. Non sarebbe stato il primo talento NBA ad arrivare in Italia: Bob McAdoo, che aveva vinto l’anello con i Lakers nel 1982 e nel 1985, giocava nella mia squadra del cuore, l’Olimpia Milano. Neppure si trattava del primo afro-americano ribelle. Nel lontano 1968, sempre a Milano, aveva giocato Jim Tillman, anche se fu mandato via dall’allenatore Cesare Rubini perché “troppo nero”; poi, nel 1974, era arrivato a Varese Charlie “Sax” Yelverton, che dalla NBA era stato cacciato per essersi rifiutato, in segno di protesta, di alzarsi in piedi durante l’inno americano. La squadra varesina, grazie in gran parte a questo esuberante ribelle con la passione del sax, aveva poi dominato la pallacanestro europea per il decennio successivo, con un incontestabile record di dieci finali di Coppa Campioni consecutive. Ma Isiah era di un’altra categoria. E per un’intera estate sognavo di trovarmelo di fronte al campetto comunale: “Ehy kid, do you want to shoot some loops? Hey ragazzino, vuoi fare qualche tiro?”
I bambini sognano, ed in quei sogni c’è innocenza, emozione… ed un pizzico di apprensione nell’affrontare il mondo in cui vivono. Mi sveglio, felice, sudato, contento. Di fronte a me c’è il poster di Magic, sulla sedia la maglietta dei Bad Boys. Il sogno prende la forma di un’ipotetica fantasia. Parlo da solo: “Isiah Thomas viene a giocare in Italia, lo incontro per caso, e diventa mio amico. Come lo racconto ai compagni di scuola?” Non è tanto una questione di credibilità che mi spaventa. Piuttosto, quale potrebbe essere la loro reazione? L’immagine si precipita al Pianella, nel palazzetto dello sport di Cantù dove il mio allenatore di allora- il quale, per fare l’americano, intercalava un “ok” ogni tre parole – mi portava a vedere le partite della fortissima squadra locale, che militava nella prima serie. Ricordo la bolgia, il luccichio del parquet, lo stridio delle scarpe sul legno, ed i versi del pubblico quando un giovane giocatore nero, Dan Gay, prendeva palla, e, DUNK, schiacciava in faccia all’avversario: “Uh uh uh, uah,” il verso della scimmia, e giù tutti a ridere. Io non rido. Ritorno nella mia stanza, ed Isiah non c’è più.
Quando Dan Gay arriva in Italia, nel lontano 1985, a Rieti, non gli pare vero. L’antica cittadella nell’entroterra laziale non è certo Roma, Milano o Firenze; qui non si respira l’aria frizzante dei grandi centri della moda e dell’arte italiana. Eppure la gente, questi bianchi un po’ scuri che parlano un dialetto ostico, ma non sembrano così ostili come gli italo-americani del ghetto da cui è stato abituato a tenersi alla larga, lo accolgono calorosamente, con un’ospitalità inaspettata. Dan è cresciuto a Tallahassee, contea di Leon: immense piantagioni di cotone che stanno ancora lì a raccontare il passato recente di un territorio con la più alta concentrazione di schiavi di tutta la Florida ed una storia di linciaggi e segregazione che si trascina fino ai giorni nostri. La pellicola scorre indietro nel tempo, siamo nella seconda metà degli anni sessanta. Dan è un bambino e sua madre lavora in un ristorante per bianchi. Un giorno, di ritorno da scuola, scappa dall’autovettura del padre e s’infila nel locale dalla porta principale. Gelo, silenzio. Gli sguardi dei presenti che lo fulminano all’istante: “Che cosa ci fa quel piccolo n- in sala?” tuona una voce dai tavoli. Poi una mano lo afferra e lo porta via. È quella di suo padre, pastore evangelista, che Dan osserva, con ammirazione, ogni domenica, dal pulpito, mentre predica uguaglianza e giustizia per tutti, al di là del colore della pelle. Ma come si può credere alla giustizia ed uguaglianza se il mondo intorno ti costringe a vedere te stesso diversamente?
Intanto Dan cresce, centimetro dopo centimetro, alla stessa velocità del nastro che si riavvolge fino agli anni Ottanta. I due metri e sei d’altezza gli valgono una borsa di studio per giocare con i Ragin’ Cajuns della Southwestern Louisiana University (oggi University of Louisiana at Lafayette). Nella NCAA, il campionato nazionale di basket universitario, si scontra contro future leggende quali Hakeem Olajuwon, Clyde “the Glide” (l’aliante) Drexler, Karl “the Mailman” (il postino) Malone, Patrick Ewing, Joe Dumars, ma quando nell’estate del 1983 viene selezionato dai Washington Wizards per giocare nella NBA, Dan declina: tecnicamente non è ancora pronto e l’offerta economica non è molto allettante. Che cosa fare? Rimanere negli Stati Uniti dove, nella migliore delle ipotesi, lo aspetta una carriera come controfigura di qualche più scarso giocatore bianco, oppure tentare la carta Europa, dove il livello tecnico è sicuramente inferiore, ma proprio per questo potrebbe ritagliarsi qualche possibilità e, per lo meno, essere considerato per quello che vale? Sceglie il vecchio continente e, dopo un anno di apprendistato in Olanda, approda in Italia, nella seconda serie di quello che è, a quei tempi, considerato il campionato più competitivo fuori dagli Stati Uniti.
Il telefono squilla per qualche secondo prima che una voce, corposa e vivace, risponda. “Hello, Industrial Frigo USA.”
“Hi, il mio nome è… parlo con il signor …”
Dan, che oggi ha 59 anni e lavora come rappresentante di un’azienda bresciana di prodotti per la refrigerazione, divide il suo tempo tra la Florida e l’Italia, ma è ormai più italiano che americano. In Italia ha giocato nella massima serie fino al 2007, stabilendo il record di longevità nella pallacanestro europea. Anche se la nostra conversazione si svolge telefonicamente per via del lockdown pandemico, non faccio fatica ad immaginarmelo ancora in gran forma. Un colosso, d’altezza e d’intelligenza: arrivato in Italia come outsider, con lavoro e dedizione è diventato un protagonista assoluto del nostro campionato. Parla con emozione dei suoi primi anni europei. Al suo approdo in Olanda, osserva coppie di diversa etnia passeggiare mano per la mano e non può credere ai suoi occhi. In Italia, a Rieti, viene accolto come una star. La gente lo abbraccia, lo ferma per strada e trascina nei ristoranti e nei bar per offrirgli dolci, specialità nostrane, un bicchiere di vino… Un’esperienza scioccante per uno cresciuto dall’altra parte dell’oceano dove, all’ingresso dei ristoranti, durante la sua infanzia, si trovavano ancora i cartelli “no n-“. Gli chiedo se abbia mai subito episodi di razzismo in Italia: “A parte i cori dei tifosi avversari e qualche commento sulla mia vita privata da parte della stampa, esplicitamente no. Ma è anche vero che da atleta, in uno sport globalmente dominato da giocatori afro-americani, mi trovavo in una condizione privilegiata. Non potevo comunque fare a meno di notare i commenti degli italiani nei confronti degli immigrati, che in quegli anni cominciavano ad arrivare numerosi dal Nord-Africa. Specialmente quando giocavo per Cantù e Treviso. Oggi la situazione è perfino peggiorata.” Domando se gli fosse mai capitato di sentirsi vittima di stereotipi razzisti da parte di giornalisti sportivi italiani: “Purtroppo questo succedeva spesso.” Ci pensa un poco: “Mi faceva strano che ancora sui giornali italiani si usasse la parola n-. Ma, come con gli insulti dei tifosi, ho imparato a non farmi condizionare da un manipolo di ignoranti.” Lo stuzzico su quale sia stato l’avversario più difficile. Si commuove: “You know, quando sono arrivato a Rieti, ho giocato con Joe Bryant…” Indisciplinata ma inarrestabile ala dal canestro facile, Bryant arriva in Italia nel 1985 dopo una decennale carriera nella NBA. “C’era sempre questo marmocchio con lui, suo figlio…” Sospira: “…Kobe… Magro, striminzito, faceva fatica a far arrivare la palla all’altezza del cesto. Eppure ogni giorno, immancabilmente, finiti gli allenamenti, saltava in campo e mi si attaccava al braccio fino a costringermi ad andarlo a sfidare uno contro uno. Un’ossessione…”
Quel marmocchio ne farà di strada. La sua tenacia e competitività che già dimostrava a sei anni lo porteranno a stare lassù, nel firmamento dei più grandi maestri della palla a spicchi: cinque titoli NBA, un premio come miglior giocatore nella stagione 2008, due come miglior giocatore delle finali, quarto marcatore di sempre nella storia NBA, due titoli olimpici. Kobe “Black Mamba” Bryant è deceduto con la figlia in un incidente in elicottero nel gennaio del corrente 2020. In un messaggio inviato ai fan il 16 aprile 2016 per annunciare il proprio addio alla pallacanestro giocata, aveva così ricordato quelle antiche sfide tra le mura della città sabina: “Ora lo posso dire. Dan Gay è stato l’unico giocatore al mondo ad avermi sempre schiacciato in testa.”
Dan ride: “Anch’io lo racconto in giro. Nessuno mi crede, fino a quando non spiego che Kobe aveva solo sei anni.”
Nel 2015 l’Absolutely Free Editore ha pubblicato, a firma Andrea Barocci, una biografia che ripercorre l’esperienza italiana di un giovanissimo Kobe Bryant. Lo scarico incuriosito. Ne traduco ad alta voce alcuni passaggi ad un’amica, Amy, voglio sapere che cosa ne pensa: “Quella coppia [Joe e Pamela Bryant], lui un CALIFFO del basket, lei una AFRODITE NERA, aveva qualcosa di affascinante agli occhi dei reatini. (…) Lei, la DEA, era alta, con lineamenti del volto regali e un fisico statuario; per qualche misteriosa ragione, neppure il vento che soffiava dal mare riusciva a scompigliarle i capelli morbidi e vaporosi. Un’APPARIZIONE CELESTIALE che, appunto come il vento, aveva lo stesso effetto sui reggini: LI FACEVA USCIRE DI SENNO.”
Ancora: “Quelli che passavano con le macchine abbassavano il finestrino e GRIDAVANO I PIÙ VARIEGATI COMPLIMENTI a Pamela. Quando lei intuiva che qualcuno le stava rivolgendo un apprezzamento VOLGARE, abbandonava per un istante la classe che la contraddistingueva, si girava senza mai fermarsi e tranquillamente rispondeva: “Fuck you”. Poi riprendeva il suo allenamento.” So già come va a finire, ma continuo: “[Pamela] si sedeva nel parterre, dietro a uno dei canestri. Prima delle gare il copione non cambiava mai, ed ERA SPASSOSISSIMO: i tifosi, qualsiasi fosse il loro posto assegnato, passavano davanti a Pam con fare indifferente, poi all’unisono giravano la testa per ammirarla; infine, SODDISFATTI, proseguivano.”
Tutt’altro che “spassosissimo” per me, Amy comincia ad innervosirsi: “Joe era un MOSTRO inarrestabile per chiunque(…). Gli appassionati di pallacanestro sapevano che PAGANDO IL BIGLIETTO per una partita con lui in campo, non si sarebbero pentiti. Stravedevano per quel GIGANTE D’EBANO che metteva allegria solo a guardarlo.”
“Ebony?” mi interrompe Amy.
“Sì, si usa per descrivere una persona d’origine africana senza offenderla…”
“Senza offenderla? Asshole! Quando la smetterete di trattarci come pezzi d’arredamento da esibire nei vostri dannati freak show?” rimarca lei scuotendo la testa. Le faccio notare che anche negli Stati Uniti esiste una rivista afro-americana intitolata, per l’appunto, “Ebony”.
“Certo,” incalza inviperita. “La differenza è che quando noi usiamo questa parola, lo facciamo per non dimenticare ciò che i miei antenati hanno dovuto subire prima di permettere ad una persona come me di parlare alla pari con una persona come te. Quando la usi tu, mi ricorda quello che i tuoi antenati hanno fatto alle donne e gli uomini come me in nome della vostra dannata supremazia.” Scuote rassegnata il capo: “What’s wrong with you, Italians? Che cosa c’è di sbagliato in voi italiani?”
La storia della pallacanestro italiana inizia in sordina. L’insegnante di ginnastica senese Ida Nomi Venerosi Pesciolini, senza averne mai visto una partita dal vivo, ne traduce il regolamento e lo presenta al Concorso Ginnico di Venezia del 1907 come “palla al cerchio, un gioco particolarmente adatto alle signorine».” Una nuova traduzione viene presentata qualche anno dopo dal professore Guido Graziani, il quale per lo meno, conosce il gioco per averlo imparato dall’inventore stesso, James Naismith, con cui ha lavorato allo Springfield College. Bisogna comunque aspettare 10 anni per la prima partita ufficiale. È una caldissima e solare giornata di giugno e, poco fuori dal centro di Milano, nella sontuosa ed imperiale Arena Civica, trentamila persone aspettano l’arrivo trionfante dell’eroico ciclista Girardengo, che, in questa stagione 1919, ha dominato dalla prima all’ultima tappa il più popolare degli eventi sportivi italiani, il Giro d’Italia. In un angolo del complesso sportivo, su un prato misto a sassi, goffi individui si cimentano nell’arduo tentativo di infilare la palla in un rudimentale cesto appeso ad un palo storto. Un righino di poche parole in calce al Corriere della Sera suggella l’inaugurazione formale della pallacanestro italiana: “Aviatori Malpensa-Automobilisti Monza 8-8. Partita interessante e giocata con slancio!”
Tuttavia, nonostante la fortuita presenza di tanto numeroso pubblico alla prima milanese, malgrado gli sforzi del professor Graziani e qualche insperato successo contro la selezione transalpina – a cui si aggiungono batoste umilianti contro Stati Uniti e Lettonia -, la popolarità del basket fatica a decollare. Ci vuole un’inaspettata svolta: per puro caso, questa palla a spicchi, più ovale che tonda, con una rilegatura laterale che ne rende il palleggio imprevedibile, attrae l’attenzione di un ragazzino di nome Bruno, di cognome Mussolini. Si tratta del figlio prediletto del Duce, ed i risultati di questo provvidenziale incontro non si fanno attendere: 43492 sono gli iscritti alla Federazione Italiana Pallacanestro nel 1935; i Gruppi Universitari Fascisti (GUF), l’Opera Nazionale Balilla (OPN), ogni associazione atletica che desideri sopravvivere nella morsa del totalitarismo di regime si dota di una squadra di basket; al giovanissimo figlio del duce, che gioca nella società Parioli di Roma insieme al fratello Vittorio e alla futura stella del cinema Vittorio Gassman, viene dedicata la Coppa Italia — dal 1936, per l’appunto Coppa “Bruno Mussolini”. È così che la “palla al cerchio”, già ribattezzata “palla al cesto”, finalmente pallacanestro, si trasforma da “gioco per signorine” a “sport ideale per migliorare validamente e durevolmente la razza,” come lo definisce la rivista Lo Sport Fascista.
“Il giuoco della pallacanestro,” riporta il Corriere della Sera del 28 novembre 1933 in un articolo intitolato “Il fascismo per l’avvenire della razza”, “è al tempo stesso uno sport armonioso e atletico, che conferisce snellezza e vigore, che dona al corpo grazie e gagliardia, e che ha anche notevole pregi spettacolari col vantaggio di una estrema facilità d’installazione.”
Ancora, da “Il Littoriale del 12 febbraio 1935: “Crediamo opportuno rilevare come la pallacanestro sia ormai diventato lo sport prediletto della gioventù fascista in virtù del suo alto valore fisiologico e delle sue doti intrinseche che, perfezionando mirabilmente le qualità che il giocatore naturalmente possiede, sviluppano soprattutto la prontezza, il coraggio e l’intuizione.
PRONTEZZA, CORAGGIO ed INTUIZIONE che sono, e debbono essere, le doti principali delle giovani Camicie Nere.
L’esercizio di questo giuoco sviluppa anche le facoltà mentali e rende abituali il senso della disciplina e del dovere, costringendo il giocatore a sacrificare il proprio successo per quello di tutta la squadra.
DISCIPLINA, CORAGGIO e SACRIFICIO, ecco i canoni fondamentali della dottrina fascista. Chi dunque meglio della gioventù fascista può apprezzare la bellezza ed il valore di questo sport fisiologicamente completo?”
Firmato, “il cestista”.
Ovviamente, in questi anni, per “il cestista,” la pallacanestro è uno sport per bianchi: qualcuno potrebbe insinuare che sarebbe stato difficile immaginare altrimenti, dato che, anche negli Stati Uniti, dove il gioco è nato, agli afro-americani non è consentito giocare nelle squadre ufficiali, nella nazionale, neppure partecipare alla American Basketball League, precorritrice della NBA. Non che il gioco non sia praticato nelle comunità black. Tutt’altro: la pallacanestro, nonostante il bando dalle competizioni dei bianchi, è, appunto per quella “facilità d’installazione” descritta nell’articolo del Corriere della Sera, il gioco più comune tra i giovani afro-americani, i quali già dal 1907 sono organizzati in squadre denominate “five” dal numero dei giocatori e competono in N- League sparse un po’ ovunque sulla East Coast. È difficile, inoltre, immaginare che nessuno si accorga che ad Harlem, New York, un quartiere diviso all’altezza di Lenox Avenue tra comunità afro-americana ad ovest ed immigrati italiani di prima generazione ad est – 110 mila nel censo del 1930, tre volte più numerosi che nella tanto decantata Little Italy in Lower Manhattan -, gioca una squadra di soli afro-americani, i Renaissance Five, i quali, oltre a vincere ogni competizione a cui è concesso loro partecipare, stanno rivoluzionando il gioco con una tattica basata su una fitta rete di passaggi “dai e vai”, una precisa disposizione sul campo, un ritmo forsennato, ed uno spirito di squadra unico. Tutt’al più che al Renaissance Casinò, la balera-palestra dove giocano, si esibisce quotidianamente l’orchestra di Fletcher Henderson, la quale annovera un giovane trombettista di nome Louis Armstrong, popolarissimo fin dai primi anni Trenta in Italia – il jazz è un’altra delle passioni americane e non particolarmente bianche dei figli del duce -, anche se, per compiacere il nazionalismo fascista, nella sua prima tournée italiana del 1935 viene ribattezzato Luigi Fortebraccio. Il dominio dei Rens è straordinario, come testimonia l’ineguagliato record di 2318 vittorie e 381 sconfitte in 26 anni di esistenza. La loro fama d’innovatori è tale che alle partite, tra i fans in delirio, s’infiltrano gli allenatori delle squadre professioniste con la speranza di carpirne i segreti. E, seppure il bando per i giocatori afro-americani sia esteso anche ai fantastici Rens, le squadre della ABL, un po’ con la speranza di riaffermare la propria supremazia, un po’ per l’incredibile folla pagante che accompagna le loro esibizioni, fanno a gara per sfidarli.
“Avevamo una regola, quella del dieci,” ricorda William “Pop” Gates, il playmaker. Mantenere un vantaggio di dieci punti, consapevoli che, alla fine della partita, questi punti sarebbero scomparsi misteriosamente dal referto arbitrale. Non che cambiasse molto: “Nel momento in cui un’irresistibile forza incontra un oggetto irremovibile, qualcosa è destinato ad accadere,” scrive il cronista sportivo del quotidiano afro-americano New York Amsterdam il 2 dicembre 1931 in occasione della vittoria dei Rens contro gli Original Celtics, pluricampioni della lega professionistica. E quando, nell’estate del 1939, le federazioni ufficiali accettano la partecipazione delle due migliori squadre afro-americane – i Rens e gli Harlem Globetrotters, originari di Chicago – al primo World Championship of Professional Basketball, indovinate chi stravince il torneo con uno scarto medio di 10 punti a partita? Ma non sono solo i Rens a determinare la superiorità dei quintetti neri: gli Harlem arrivano terzi, ma solamente perché, per ovviare ad una finale completamente afroamericana, gli organizzatori avevano fatto in modo che incontrassero i Rens in semifinale.
Mi dispero a trovare, tra gli archivi storici dei quotidiani sportivi italiani, un articolo, una citazione, una misera allusione ai Rens o a qualsiasi altra squadra o giocatore afro-americano precedente al secondo conflitto mondiale. Nulla. Eppure, con un po’ di sorpresa, scopro che il quartiere di Harlem non è propriamente sconosciuto ai cronisti italiani. Tutt’altro: “Uscendo da Central Park e incamminandosi lungo la Lenox Avenue, dopo un breve tratto si è già ad Harlem, la città nera,” dal Corriere della Sera del 16 marzo 1931. “Forse vi sono altrove in Africa e negli Stati Uniti città abitate da n- più vaste e popolate, ma nessuna ha il carattere, l’attività, la potenza e il significato di Harlem.”
Il mio viaggio nella “cronaca americana” sulla stampa italiana dell’epoca è un’epica rilettura al contrario della storia del secolo scorso come mi è stata impropriamente insegnata a scuola. Là dove mi avevano indottrinato che la capitale culturale mondiale degli anni Venti era la Parigi di Picasso, Hemingway, Scott Fitzgerald, scopro che, tutt’al più, la capitale francese era una “sorta di copia ed incolla” di quello che succedeva ad Harlem: dalle balere e dai circoli tra Lenox Avenue e la settima, i lavori di Langston Hughes, Claude McKay – tradotto in Italia molto prima di Hemingway e Fitzgerald -, Palmer Hayden, James Weldon Johnson, Zora Neale Huston e Countee Cullen erano giunti nei bistrot parigini insieme alle musiche di Sidney Bechet, Arthur Briggs, Louis ”Braccioforte” Armstrong, Duke Ellington, e da lì, poi, avevano conquistato Berlino, Londra, Roma, perfino Mosca. Approdata alle Folies Bergère, Parigi, direttamente dal Plantation Club sulla 126ma, Harlem, Josephine Baker e la sua “Danse Sauvage” avevano scatenano, tra folle di fans impazziti, gerarchi nazisti e fascisti prolifici di doni, e bigotti che la accusano di stregoneria, il caos per mezza Europa. “I N- ad Harlem hanno sconvolto il ritmo artistico del nostro tempo,” scrive Curio Mortari su La Stampa dell’11 dicembre 1932: “Hanno dato un suono ed un nome all’ondata felicemente primordiale sgorgata dalla guerra.”
L’Italia e gli italiani, ovviamente, non sono vergini di razzismo: lo hanno praticato in epoca pre-coloniale, poi regolamentato ed innalzato a sistema con la progressiva conquista della Libia e del Corno d’Africa. Ma se questo tipo di oppressione trova la sua attuazione perlopiù lontana dal suolo patrio, in luoghi sconosciuti ed esotici dai connotati semi-romanzeschi, Harlem, mecca di artisti intelligenti che invadono con i loro suoni e libri le nostre case e sale da ballo, di pugili in grado di mandare knock-out l’eroe nazionale Primo Carnera, e di riottosi attivisti che bloccano i quartieri e l’ambasciata italiana a New York per protestare contro l’occupazione dell’Etiopia, si trasforma nell’eponimo di un pericoloso risveglio di coscienza che travalica i confini statunitensi: “Noi vediamo il pericolo nero avanzare attraverso l’oceano Atlantico,” scrive Umberto Fracchia in un articolo del Corriere della Sera del 19 agosto 1928 dal titolo provocante, “Magia Nera”: “… e (vediamo) il deserto africano ai ritmi sincopati del “jazz”, rivestito delle sgargianti penne delle danzatrici di “camel-walk” e preceduto da un nugolo di eroi equivoci e malfamati di cui il popolo negro già imborghesito di Nuova York e dintorni deve sentire un sacro orrore ed una giusta onta. Ma tutte le vergogne viene il momento in cui si possono lavare, magari col sangue. E intanto molti incominciano a credere che una questione negra esista realmente allo stato d’incubo, non soltanto per gli Americani o per i n-, ma per tutto il mondo civilizzato. Per costoro c’é sulla faccia della terra una massa bituminosa che fermenta, un nero lievito umano che gonfia. E Josephine Baker, Siki, Clarence Donald, e mille altre figure reali o immaginarie che la cronaca trasferisce ai romanzi e che i romanzi restituiscono alla cronaca, sarebbero come le bolle di aria che scoppiano alla superficie dei calderoni d’asfalto o, se più vi piace, i fiori splendenti o miserabili che sbocciano su quella nera gleba.”
Ma come ostacolare questa “nera gleba” che tanto nella cultura quanto nello sport, sembra destabilizzare la supremazia bianca? “Senza arrivare alle esagerazioni alle quali americani ed inglesi arrivano,” scrive Carlo Volpi nel 1929 sullo Sport Fascista, “senza cioè considerare i n- uomini inferiori e spregevoli, è però interessante vedere il perché la loro razza possa dare (allo sport) tanti uomini di così eccelsa classe. Da che cosa dipende quella supremazia che in parecchi casi hanno luminosamente provata? Io credo che consista soprattutto in alcune caratteristiche fisiche, tutte proprie della razza nera, pur non negando una certa rapidità di riflessi che non può chiamarsi intelligenza — poiché anche in alcune specie animali è spiccatissima (…). Per il resto il n- dimostra di essere tutt’altro che intelligente. Tutt’al più egli è furbo, trucchista e traditore, poiché non conosce che cosa sia la lealtà. L’unico modo di farsi rispettare da un n-, è quello di picchiarlo, di dimostrargli con la forza la sua inferiorità; allora diventa pusillanime…”
Gli anni del conflitto mondiale sono un vuoto nella storia della pallacanestro italica. Bruno Mussolini muore in un incidente aereo nel 1941 e, con lui, l’interesse del regime. È solo nell’estate del 1944 che, con la liberazione di Roma e l’insediamento di truppe alleate nella Città Eterna, l’attenzione dei quotidiani sportivi viene catturata da un gruppo di straordinari giocatori neri che vincono tutte le partite. Si fanno chiamare New Mexicans ed appartengono alla 92ma Divisione della Quinta Armata, l’unico corpo militare interamente afroamericano sul suolo europeo. Nel 1947, due anni dopo la fine della guerra, in un Paese alla ricerca di una nuova identità che possa in qualche modo cancellare vent’anni di totalitarismo fascista, Aldo Mairano, coraggioso ed ambizioso imprenditore alla presidenza della Federazione della Pallacanestro Italiana, decide di compiere un atto storico: nomina allenatore della nazionale di pallacanestro italiana Eliot Van Zandt, giovane soldato di fanteria della 92ma e professore di ginnastica laureato alla Black Historical Tuskegee University dell’Alabama. Diciannove anni prima di Bill Russell nella NBA, quarantuno anni prima di John Thompson, che guida la nazionale Statunitense alle Olimpiadi di Seoul del 1988, l’Italia ha il primo allenatore professionista afro-americano della storia.
L’impatto di Van Zandt sulla pallacanestro italiana è immenso: non solo ci insegnerà le innovazioni che avevano fatto la fortuna dei Rens, ma, attraverso il suo caparbio lavoro, forgerà gli allenatori che guideranno le squadre italiane a dominare in Europa nei decenni successivi. Non sapremo mai se la sua nomina da parte di Mairano fosse stata dettata da coraggio antirazzista o provocazione: l’imprenditore genovese, infatti, finisce alla direzione della pallacanestro solo dopo aver perso per una manciata di voti le elezioni alla presidenza del prestigioso Comitato Olimpico. La nomina di Van Zandt, poi, aggettivato “n- e color cioccolato” nelle cronache dell’epoca, non sembra godere di particolare popolarità tra i giornalisti ed i giocatori della vecchia leva; quattro anni dopo, nonostante un ottimo quinto posto agli europei del 1951, viene licenziato. Diventato preparatore atletico dell’A.C. Milan nel 1956, Van Zandt muore nel 1959 in volo verso gli Stati Uniti per un’operazione ai reni.
Dan è ancora al telefono. È una fucina di racconti e aneddoti. Nel 1988 si sposa con una ragazza pugliese e due anni dopo acquisisce la cittadinanza italiana. Finalmente può realizzare il suo sogno, vestire la maglia azzurra e partecipare ai mondiali ed alle olimpiadi: non è impossibile, di atleti oriundi l’Italia del calcio ne ha avuti a bizzeffe. Anche il basket aveva avuto il suo “straniero” con passaporto italiano: Mike D’Antoni, che aveva vestito la casacca azzurra nel 1989. L’unico inconveniente, nessuno di questi oriundi, per lo meno per quel che riguarda i giochi di squadra, era mai stato nero. Ad eccezione di Van Zandt, che però non era stato un giocatore.
“Il problema,” spiegano dalla Federazione, “non è razziale, ma semplicemente burocratico: per poter giocare nella nazionale italiana deve essere iscritto al campionato come italiano e non come straniero.” Dan ci prova una prima volta nel 1991, la domanda viene rigettata. Nel 1992 idem. Anno 1993, esordisce in nazionale Carlton Meyers, di padre caraibico e madre italiana, quindi Dan spera finalmente che… niente da fare. Il presidente della Federazione Italiana, Gianni Petrucci, adduce un ritardo della domanda da parte del giocatore. Sarà per l’anno successivo? Macché, questa volta la scusa è che Dan, acquisendo il diritto alla nazionale, permetterebbe alla propria squadra, la Fortitudo Bologna, di rinforzarsi ulteriormente con un altro straniero. Ai giornalisti che lo incalzano, Dan risponde con passione: “Non crediate che sia facile decidere di cambiare cittadinanza: io l’ho fatto con entusiasmo perché sono in Italia ormai da 12 anni, pago fior di tasse e ho messo su famiglia. (…) Ma io ci credo. È questo che non hanno capito.”
A 35 anni, dopo sei anni di trafile burocratiche, Dan esordisce finalmente in nazionale nel 1996: l’anno successivo contribuirà alla conquista di una storica medaglia d’argento agli Europei di Barcellona. Chissà se avesse potuto fare parte della selezione nazionale qualche anno prima.
EPILOGO
Una lunga giornata autunnale. Passeggio per Causeway street. Un po’ per la pandemia, un po’ per la ricorrenza del Giorno del Ringraziamento, Boston è vuota. Risuona vuota, con un soffio gelido che sale dall’Oceano. Il Garden, che sorgeva in fondo a questa strada, è stato rimpiazzato da un centro commerciale. Osservo l’edificio da fuori provo ad immaginare i suoni, le voci, i rumori di quel 29 maggio 1987. Mi sembra di sentire la palla che rimbalza mentre Isiah si prepara a tirare i liberi.
Oggi, Isiah Thomas e Larry Bird non sono più avversari. Anzi, per una stagione, nel 2003, hanno perfino lavorato fianco a fianco agli Indiana Pacers: Isiah come allenatore, Larry come dirigente. Entrambi sono personaggi culto nello stardom televisivo NBA: appaiono in telecronache, documentari, talk show, interviste… Raramente insieme. Quando capita, Larry scherza sul fatto che la persona più delusa dalla sconfitta dei Pistons in quella finale di conference fosse sua madre, gran tifosa di Isiah. Anche Magic si è riconciliato con Isiah, in un confronto televisivo sul canale ESPN con tanto di pianto in stile “reality show”.
Il TD Garden, dove giocano attualmente i Celtics, si trova proprio dietro il centro commerciale. È chiuso. La stagione sportiva non è ancora iniziata, chissà quando si potrà tornare a vedere una partita dal vivo. Procedo per West End, dopo Whole Food scorgo il Museo di Storia Afro-Americana. Anche questo è chiuso.
Gli Stati Uniti – o l’America, nell’accezione che spesso si usa in italiano, come se ne esistesse una sola – non sono molto cambiati dagli anni Ottanta. George Floyd è stato ucciso il 25 maggio di quest’anno, soffocato per otto minuti e 46 secondo dal ginocchio di un poliziotto bianco. A Kenosha, Wisconsin, il 23 agosto, un poliziotto ha sparato per ben sette volte nella schiena di Jacob Blake mentre questi tentava di entrare nella propria autovettura. I suoi tre figli, di otto, cinque e tre anni, seduti nei sedili posteriori, hanno assistito all’esecuzione. Secondo dati raccolti dal Washington Post, 1020 sono le persone uccise quest’anno dalla polizia americana: gli afroamericani muoiono nelle mani delle forze dell’ordine ad una percentuale due volte e mezzo maggiore di ogni altro gruppo etnico.
Proseguo. A pochi isolati si trova il Tempio N. 11, fondato da Malcolm X. Quanto suonano profetiche oggi le sue parole, non è vero? Qui dietro si erge la Massachusetts State House, ne scorgo la cupola: cerco la placca commemorativa del famoso discorso tenuto da Martin Luther King nel 1965. Alla morte del reverendo, Indro Montanelli scrisse: “Non aveva la stoffa del grande capo carismatico, trascinatore di folle. Gliene mancavano anche i requisiti fisici, che specie agli occhi di una popolazione ancora PRIMITIVA e INFANTILE come quella di colore hanno la loro importanza.”
Non si tratta solo di beceri residui della cultura fascista, piuttosto della stessa retorica che oggi viene usata contro gli immigrati o gli italiani di prima e seconda generazione. Mi torna in mente un particolare. Durante le ricerche per questa storia, qualcuno mi ha parlato di Van Zandt come l’esempio di come gli italiani, in fondo, non fossero mai stati razzisti… detto da un bianco ad un bianco, mi risuona nelle orecchie come un’ammissione di colpa.
La brezza oceanica si trasforma in un fastidioso senso di vergogna. Per fortuna tutt’intorno i negozi espongono cartelli in supporto di Black Lives Matter. So che molti sono solo di facciata. Ma è una facciata importante, che echeggia e da forza a tante vittime invisibili. Quanti siamo i bianchi disposti a scendere in piazza per protestare contro il razzismo? Tanti, per lo meno qui, negli Stati Uniti. Rivedo le manifestazioni che quest’estate, da Minneapolis e Kenosha si sono estese a tutto il continente, e poi in tutto il mondo. Non trovo la placca commemorativa, ma scopro un monumento che racconta una storia che non conoscevo. È dedicato a Crispus Attackus, il primo martire della Rivoluzione Americana. Non un aristocratico, non un bianco, bensì uno schiavo di origine afro-americana ed indiana. Sono ormai arrivato a Boston Common, il sole splende sopra gli aceri rossi che ossigenano il parco. Mi siedo su una panchina. Immagino Bill Russell e KC Jones arrivare, li vedo da lontano, alti, giovani, eleganti come usavano gli atleti e gli intellettuali di una volta. Apro un libro che ho comprato in un negozio dell’usato. Una gemma, è una prima edizione, originale del 1955. Leggo.
“È giunto il momento di rendersi conto che il dramma interrazziale messo in scena nel continente americano non ha solo creato un nuovo uomo nero, ma anche un nuovo uomo bianco. Nessuna strada riporterà mai più indietro gli americani alla semplicità del piccolo villaggio europeo dove gli uomini bianchi si permettono ancora il lusso di considerarmi un estraneo. In realtà non sono più un estraneo per nessun americano vivo. Ciò che distingue gli americani dagli altri popoli è che nessun altra popolazione è mai stata così profondamente coinvolta nella vita degli uomini neri, e viceversa. Di fronte a questo fatto, con tutte le sue implicazioni, si può vedere che la storia del problema dei neri americani non è solo macchiata dalla vergogna, ma è anche una sorta di conquista. Perché, anche quando il peggio è stato detto, bisogna anche aggiungere che la sfida infinita posta da questo problema è stata sempre, in qualche modo, perennemente accolta. È proprio questa esperienza nero-bianco che può rivelarsi di valore indispensabile nel mondo che affrontiamo oggi. Questo mondo non è più bianco, e non sarà mai più bianco di nuovo.”
James Baldwin, Notes of a Native Son (1955)
Si ringraziano per i contributi la Black Five Foundation, Rhinold Lamar Ponder, Dan Gay III, Saverio Luigi Battente, Mario Arceri e Valerio Bianchini.
[parte 4 di 4] Leggi tutte le 4 parti:
The clutch – canestri e razzismo sotto pressione (1/4)
The clutch – canestri e razzismo sotto pressione (2/4)
The clutch – canestri e razzismo sotto pressione (3/4)
The clutch – canestri e razzismo sotto pressione (4/4)
immagine via Wikimedia Commons
 (Pubblichiamo un estratto da Alcott, Le nostre teste audaci. Lettere dalla creatrice delle sorelle March, a cura di Elena Vozzi, L’Orma Editore 2021. Le lettere sono precedute dalle introduzioni della curatrice che, nell’introduzione generale al volume, spiega come la vita (1832-1888) dell’autrice di Piccole donne sia sempre stata poco conosciuta.
(Pubblichiamo un estratto da Alcott, Le nostre teste audaci. Lettere dalla creatrice delle sorelle March, a cura di Elena Vozzi, L’Orma Editore 2021. Le lettere sono precedute dalle introduzioni della curatrice che, nell’introduzione generale al volume, spiega come la vita (1832-1888) dell’autrice di Piccole donne sia sempre stata poco conosciuta.