di Jamila Mascat
Saggista e militante femminista decoloniale, Françoise Vergès ha da poco pubblicato in Francia un libro intitolato Une théorie féministe de la violence. Pour une politique anti-raciste de la protection (La Fabrique, 2020). In questa intervista l’autrice riflette sul tema della violenza nel panorama femminista contemporaneo, denunciando i limiti e le contraddizioni delle correnti femministe cosiddette “punitive e carcerali” che invocano l’intervento repressivo dello Stato come unico rimedio contro le violenze di genere. Che cosa significa, invece, per le femministe anticapitaliste e antirazziste pensare la protezione e la difesa dei propri corpi altrimenti?
JM: Cominciamo proprio dal titolo del tuo ultimo libro Une théorie féministe de la violence: che cosa significa pensare la violenza strutturalmente radicata nelle società contemporanee a partire da una prospettiva femminista e decoloniale? E in che misura una simile prospettiva è in grado di apportare nuovi elementi di comprensione?
FV: Per prima cosa si tratta di precisare che la violenza distruttiva e sterminatrice che prolifera nelle società odierne non ha nulla di nuovo, così come le violenze sessuali e sessiste. Il dato di novità è legato all’intensità, al modo in cui il capitalismo neoliberale e finanziarizzato si lancia alla rincorsa di profitti esorbitanti, l’estrattivismo che ne deriva, le guerre economiche che ne conseguono contro le popolazioni del Sud Globale e poi anche più recentemente contro i paesi del Nord del mondo (basti pensare al caso della Grecia), la crisi climatica, la devastazione sistematica delle terre da parte dell’agrobusiness, il prosciugamento del suolo e del sottosuolo, la privatizzazione e la militarizzazione esponenziale dei mari e degli oceani, i femminicidi, le politiche assassine condotte contro militanti indigeni e antirazzist*, la negrofobia senza limiti, l’islamofobia, la caccia a* migranti, ecco, tutto questo dice di una forte accelerazione delle violenze razziste e sessiste e di un’intensificazione dello stato di guerra permanente contro intere popolazioni.
La violenza è una necessità del capitalismo, e il razzismo gli è consustanziale. La maniera in cui i media e i governi denunciano insistentemente la violenza degli oppressi – che protestano e che lottano per rispondere alla violenza dello Stato, del patriarcato, del razzismo e del capitalismo – facendone un minaccia alla pacifica coesistenza sociale dimostra a che punto il potere sia costretto a occultare e dissimulare regolarmente il proprio esercizio della violenza.
Eppure, le lotte continuano, anzi si moltiplicano e, come dicevo, subiscono un’accelerazione: le manifestazioni di Black Lives Matter in tutto il mondo, le proteste delle femministe e queer del Sud globale contro il femminicidio e la violenza neo-liberale, le lotte delle comunità indigene e rivoluzionarie. Sono questi movimenti che mi hanno spinto a ripensare il femminicidio e la violenza sessuale e di genere non come una prerogativa esclusiva della dominazione maschile (secondo lo schema “donne vittime vs uomini carnefici”) ma come il sintomo più eclatante e più “eloquente” di una violenza che pervade il mondo ed è sotto gli occhi di tutti. Il divario crescente tra lo sviluppo della tecnologia e il progresso della medicina, tra le tecniche di sorveglianza destinate a proteggere la vita di pochi e il fatto che miliardi di persone siano fatalmente private di acqua e aria pulita e al tempo stesso controllate, monitorate, ultrasfruttate, dimostra che l’espansione e l’avanzamento del capitalismo razziale possono soltanto accrescere le disuguaglianze.
Se, come diceva il filosofo marxista francese Georges Labica, il capitalismo non è altro che una forma di “industrializzazione dell’omicidio”, lo sviluppo della tecnologia ha reso e continua a rendere possibile la sistematizzazione crescente di questa produzione industriale di violenza omicida. La demolizione dei diritti del lavoro, la “scelta” obbligata tra morte o vita in schiavitù, l’impunità dello stupro di uomini e donne migranti e la normalizzazione delle politiche di predazione sono tutte l’espressione manifesta di una volontà di fare della violenza il perno dell’organizzazione sociale per intensificare lo sfruttamento di tutt*.
Ho scelto di adottare una prospettiva femminista decoloniale – antirazzista, anticapitalista e antimperialista – per parlare della femminilizzazione dei corpi subordinati e del modo in cui vengono trasformati in corpi usa e getta, eliminabili, violentabili, corpi dai quali il capitalismo razziale estrae tutta la forza fisica e psichica possibile, e ai quali, simultaneamente, rifiuta la cura e nega il diritto all’infanzia, all’età adulta e alla vecchiaia nella misura in cui, per questi corpi, le tre età si confondono in un tempo unico e monotono logorato da fatica e esaurimento.
La mia prospettiva femminista guarda in primo luogo a quelle vite, le più fragili, che sono state fabbricate come sempre suscettibili di essere sfruttate e uccise, per suggerire che la violenza contro le donne deve essere compresa in relazione a tutte le violenze che il capitalismo inevitabilmente produce.
Non si tratta però di svelare una violenza inevitabile che avrebbe a che fare con l’essenza della “natura umana” o di denunciare una violenza maschile inesorabile. Né si tratta di dire che l’abolizione del capitalismo sia la garanzia di una pace perpetua. Quello che dico è che il capitalismo istituisce un simile regime di violenza generalizzata in nome della necessità di sfruttare, e lo esercita in tutti gli ambiti della vita. L’analisi femminista che difendo permette di evidenziare gli intrecci e le intersezioni che sussistono tra forme di dominio e sfruttamento, e di mettere a nudo, a partire da quei corpi condannati dai potenti ad essere torturati, violentati, smembrati e assassinati perché resi oggetto, come cantano le femministe in Cile, il nocciolo del capitalismo razziale.
L’idea che il capitalismo debba diventare “inclusivo”, che possa essere riscattato eliminando le disuguaglianze troppo evidenti, è chiaramente una non-alternativa. Puntualmente il capitalismo ha dovuto fare delle concessioni ai movimenti che lo contestavano, pur continuando ad esercitare una violenza inaudita e sottile sulle classi lavoratrici, e in particolare sul lavoro precario, sul lavoro meno qualificato e sul lavoro nero dei senza documenti. Si obietterà che il capitalismo produce benessere, facilita la soddisfazione dei bisogni primari e che il capitalismo cinese, per esempio, ha permesso alla Cina di uscire dalla povertà nell’arco di pochi decenni. Ma se così fosse, perché la ricetta non funziona per tutti? E, soprattutto, qual è il prezzo da pagare? Rimango anticapitalista e aggiungo antimperialista, profondamente antimperialista – e perciò antirazzista e antipatriarcale. Come dice Angela Davis, non c’è anticapitalismo senza antirazzismo e viceversa. Il femminismo decoloniale che difendo non può che dirsi antimperialista proprio perché antirazzista. Di questi tempi dovrei aggiungere antifascista. Ma tutti questi aggettivi non devono essere intesi come una concatenazione astratta, hanno un significato molto concreto, che rinvia all’articolazione e agli intrecci delle varie lotte, in vista della costruzione di una solidarietà internazionale.
JM: Nel tuo libro illustri un paradosso interessante – e di particolare attualità in Francia, alla luce dell’offensiva autoritaria e liberticida rilanciata dal governo negli ultimi mesi (penso alla Legge sulla sicurezza globale e al Disegno di legge a sostegno dei principi della Repubblica) in cui ancora una volta la bandiera dei diritti delle donne viene sventolata per giustificare l’adozione di misure di sicurezza stigmatizzanti e razziste. Se, da un lato, storicamente le femministe sono sempre state in prima linea nel denunciare la violenza sessista e sessuale contro le donne, dall’altro, alcune di loro, in particolare le esponenti di quel femminismo che definisci come “carcerario e punitivo”, chiedono che giustizia sia fatta facendo appello proprio alla legittima violenza dello Stato. Come e quando è emerso questo paradosso, che alla fine non è poi così paradossale?
FV: Questo paradosso apparente che vede le donne, per un verso, denunciare la violenza subita e, per l’altro, fare appello alla violenza punitiva dello Stato, è in realtà il frutto di una profonda differenza di posizionamento e di analisi. Nel femminismo contemporaneo che si rifugia sotto l’ala protettrice dello Stato regna una confusione ideologica specifica, che deriva dall’iscrizione di questo femminismo nel solco di una storia europea elevata al rango di storia universale e dalla sua intima relazione con lo Stato borghese. Dal momento che la parola “femminismo” è stata coniata in Occidente, dove si sono tenuti i primi grandi raduni femministi, dal momento che la tradizione ha fatto dei testi scritti dalle donne europee (e talvolta dagli uomini europei), i testi fondatori dell’ideologia e delle teorie femministe, e dal momento, infine, che la storia del femminismo si è sviluppata secondo una logica europea che ha tendenza a celebrare le vittorie conquistate sul piano liberale dei diritti – al punto che il diritto di voto, per esempio, è considerato prioritario rispetto all’uguaglianza razziale -, per tutte queste ragioni, il femminismo intrattiene un rapporto di complicità con lo Stato borghese. Se ha avuto difficoltà a far posto alle rivendicazioni delle donne proletarie, figuriamoci quanto sia e sia stato in grado di comprendere le ragioni delle donne razzializzate, delle donne migranti e delle donne del Sud globale! Questa complicità originaria spiega la fiducia di alcune correnti femministe nella giustizia dello Stato e nelle sue istituzioni repressive, minimizzandone il portato razzista, sessista e di classe. Eppure i pochi provvedimenti contro la violenza sessuale e di genere che esistono sono sempre stati ottenuti tramite le lotte; lo stato non ha mai concesso diritti per magnanimità.
Queste leggi, che solo le lotte femministe sono riuscite a strappare allo Stato, sono misure oggi in corso di liquidazione in molti paesi e la cui applicazione è diventata sempre più difficile, creando frustrazione e senso di ingiustizia. Per esempio, lo stupro è riconosciuto come un crimine dalla legge, ma coloro che lo subiscono sono costrette a passare attraverso un percorso così lungo e tortuoso per sporgere denuncia che spesso preferiscono abbandonare. Ci sono le femministe che obiettano: “Ma allora il crimine dovrebbe rimanere impunito? Non dovremmo piuttosto sostenere le donne che ne sono vittima?”. Senza nulla togliere al ruolo svolto dai centri di assistenza e di accoglienza per le donne che hanno subito violenza, mi rifiuto di restare intrappolata in questo tipo di conversazione. Anziché trasformare le donne in vittime, si tratta di restituire loro autonomia e capacità di agire. Il discorso assistenzialista sulla protezione spesso insiste sulla vulnerabilità essenziale delle donne: per essere ascoltate, dobbiamo prima ammettere la nostra debolezza e quindi il nostro bisogno di essere protette dalle forze dello Stato. Le femministe decoloniali rifiutano questa vittimizzazione che relega le donne, specialmente quelle razzializzate, a una condizione di debolezza. Le donne nere e razzializzate del Sud del mondo non sono deboli, sono forti, sono abituate a resistere ad aggressioni di una brutalità incredibile, a superare situazioni che le donne borghesi abituate, al contrario, a vivere protette e tra gli agi conquistati attraverso secoli di sfruttamento coloniale, non sarebbero mai in grado di sostenere. Le femministe decoloniali che promuovono l’autodifesa comunitaria sanno che mandare in prigione centinaia di migliaia di uomini (per la maggior parte razzializzati) non servirà a proteggerle dalla violenza. Le femministe nere sanno che il razzismo, che affonda le sue radici nella schiavitù, è ciò che le rende violabili e uccidibili, così come lo sanno le donne aborigene e razzializzate. Le femministe decoloniali comprendono la schiavitù sessuale come una manifestazione della cattura e dello sfruttamento dei corpi e non come l’unica conseguenza dell’organizzazione mafiosa della tratta. Il femminismo che ha fiducia nello Stato, uno Stato la cui ricchezza si basa sullo sfruttamento (e quale Stato fa eccezione alla regola?) è idealista perché si ostina a credere che esistano diritti umani inalienabili laddove, visibilmente, questi diritti sono riservati solo ad alcuni cittadini di alcuni paesi.
Hai perfettamente ragione a sottolineare l’offensiva autoritaria e liberticida che la Francia sta attraversando in questo momento e il modo in cui i diritti delle donne sono di nuovo oggetto di una strumentalizzazione repressiva. Macron non perde occasione di ribadire che la Repubblica francese è naturalmente egualitaria, e perciò a favore dell’uguaglianza delle donne e degli uomini. Ripete continuamente che la laicità è garanzia di questa uguaglianza, in una società in cui la maggior parte degli impieghi part-time sono assegnati dalle donne, in cui il lavoro di cura, altamente femminilizzato, è privatizzato e sottopagato, in cui le molestie sessuali e la discriminazione razziale sul lavoro sono all’ordine del giorno nei settori dei servizi, della pulizia e della cura, e in una società in cui alle donne velate viene affibbiato lo status di vittime sottomesse al patriarcato. Mai il femminismo è stato così sfacciatamente al servizio del neoliberalismo e dell’imperialismo. Questo femminismo tutto incentrato sulla difesa dei “diritti delle donne”, come scrivevo nel mio libro precedente, Un femminismo decoloniale, offre al neoliberalismo e all’imperialismo le risorse lessicali e ideologiche necessarie per giustificare tanto le politiche di intervento militare quanto la repressione delle persone razzializzate. La violenza contro le donne diventa il terreno su cui queste femministe costruiscono un’ideologia repressiva, che non ne intacca le cause. Si tratta poi di una violenza individualizzata, per far fronte alla quale non sono previste soluzioni collettive autonome, secondo una logica che inevitabilmente genera frustrazione e scoraggiamento perché, nonostante la repressione, la violenza non si ferma.
Marlène Schiappa, fino a poco fa ministra delle pari opportunità e per la lotta contro le discriminazioni, attualmente delegata presso il ministero dell’Interno in qualità di segretario di stato per la cittadinanza, è un esempio paradigmatico di questo tipo di femminismo: difende strenuamente leggi liberticide e razziste in nome dei diritti delle donne, ma non denuncia mai pubblicamente il razzismo e la negrofobia diffusa, né contesta il suo governo per i rapporti che intrattiene con l’Arabia Saudita. In compenso, ha sempre qualcosa da ridire sulle donne velate e sull’Islam. In fondo, però, la sua posizione non è paradossale. Difende un femminismo borghese bianco, pro-capitalista e pro-imperialista. Il patriarcato con cui se la prende non è il patriarcato del neoliberalismo. Non per questo le nego il diritto di definirsi femminista. Si tratta piuttosto di evidenziare sempre le differenze teoriche, pratiche e oggettive che esistono tra i femminismi di liberazione e questi femminismi – di stato, aziendali, civilizzatori, imperialisti, femonazionalisti.
JM: Quando si parla di violenza sessuale gli uomini sono generalmente considerati gli unici responsabili. Eppure, senza assolvere il patriarcato dalle sue colpe, nel tuo libro sollevi la questione del ruolo svolto dalle donne che hanno attivamente preso parte – in epoca coloniale o nel contesto di interventi imperialisti più recenti – all’esercizio di pratiche violente, torture e stupri contro uomini colonizzati/indigeni. Come interpreti questa missione compiuta dalle donne al servizio della macchina da guerra (neo)coloniale?
Leggendo i resoconti degli stupri di uomini neri, indigeni, migranti e musulmani, in situazioni di guerra aperta o latente, sono rimasta molto colpita nel constatare il fatto che questi stupri fossero assai più numerosi di quanto si pensi e che spesso fossero compiuti da donne soldato. Ho voluto perciò sottolineare questa femminilizzazione del corpo maschile indigeno, arabo o nero, una femminilizzazione che nasce sotto il segno della razza ed espone il corpo alla violenza dello sfruttamento (economico, sessuale, culturale), ne fa un corpo da violentare. In altre parole, all’interno dell’etero-patriarcato il processo di femminilizzazione crea distinzioni tra donne, uomini e persone non-binary. Ne derivano almeno due istanze del femminile, una che è da proteggere paternalisticamente (da parte dello Stato e del patriarcato) e una di cui si autorizza lo sfruttamento.
Questa divisione non è del tutto coerente, e le donne che s’illudono di essere protette obbedendo e conformandosi alle norme etero-patriarcali, razziali e capitaliste possono sempre essere catapultate nel campo dei corpi da uccidere, violentare e smembrare. La razza, però, rimane una linea fondamentale attraverso cui viene concepita la femminilizzazione. Le donne possono quindi approfittare della femminilizzazione razziale dei corpi neri e indigeni. Nel suo libro consacrato alla storia di donne bianche proprietarie di schiavi (They Were Her Property. White Women as Slave-Owners in the American South), la storica Stephanie E. Jones-Rogers mostra che queste donne erano brutali tanto quanto gli uomini bianchi. Avevano piena consapevolezza del fatto che gli esseri in loro possesso costituissero un capitale che garantiva loro status sociale e ricchezza, e partecipavano senza remore al commercio e alla tratta degli schiavi. Erano tutt’altro che innocenti. Il colonialismo ha permesso a queste donne di essere proprietarie di piantagioni, di trarre profitto del lavoro forzato degli schiavi. Per questo hanno saputo chiudere un occhio sugli abusi perpetrati contro questi ultimi dai loro figli, padri, mariti – stupri, rapine, omicidi – e spesso li hanno perfino giustificati o incoraggiati.
Il razzismo permette alle donne di mentire, rubare, stuprare, torturare le persone razzializzate. Quante false accuse di furto le donne nere hanno dovuto sopportare! Le donne bianche, invece, hanno spesso accusato ingiustamente gli uomini neri sapendo bene che rischiavano di farli linciare. Le cosiddette Karen, il nome dato alle donne bianche che continuano a mentire, ieri come oggi, dimostrano che nel XXI secolo il razzismo è ancora un’arma nelle mani delle donne bianche e che queste ultime non esitano ad usarla, dicendo, come avviene in Francia, per esempio, di essere state molestate da giovani neri e/o musulmani, anche se non è vero, o denunciando l’esistenza di bar per soli uomini nei quartieri popolari, che non esistono. Poiché la razza è una modalità attraverso la quale si sperimentano la classe e il genere, anche le donne non-bianche possono occupare questa posizione di potere e di dominio sugli uomini razzializzati. La guerra, il razzismo, l’antisemitismo, l’islamofobia, la xenofobia sono per l’appunto i contesti in cui le donne occupano senza esitazione una posizione di potere e di dominio.
JM: Parliamo delle responsabilità del “femminismo punitivo e carcerario” nella costruzione simbolica delle mascolinità degli uomini razzializzati e nella stigmatizzazione e oppressione concreta di questi corpi maschili. I “maschi razzializzati” sono quotidianamente oggetto della violenza istituzionale, tanto sul piano mediatico/discorsivo quanto su quello materiale/repressivo. Quali sono le conseguenze di questa spirale di violenza sulla costruzione delle mascolinità degli uomini razzializzati?
FV: Per fortuna le mascolinità razzializzate tornano ad essere oggetto di studio analitico. L’etero-patriarcato propone una mascolinità basata sul diritto di esercitare la forza, il potere e la sessualità. Ci sono uomini per cui questa non è una definizione appropriata. Da tempo la letteratura racconta storie di figli schiacciati dal potere del padre – o anche della madre che assume il ruolo di gendarme del patriarcato. Il patriarcato ha impiegato del tempo per imporre questo modello di mascolinità, lo Stato ha dato una mano, la loro complicità è storica. È una mascolinità normativa che costringe i corpi e prescrive ingiunzioni. Dal momento che il genere è razzializzato, la razza agisce sul processo di mascolinizzazione e, per esempio, all’epoca della schiavitù, il corpo maschile è animalizzato, femminilizzato, investito di una sessualità minacciosa e incontrollabile. L’orientalismo, diversamente, affibbia agli uomini arabi una mascolinità dura e misognina. Il lavoro forzato, le leggi coloniali che criminalizzano l’omosessualità, l’imposizione di codici familiari sembrano costrutti lontani, ma non è così. La maggior parte degli stati post-coloniali ha scelto di mantenere in vigore le leggi coloniali anche se la costituzione le ha abolite, come in Sudafrica, dove le persone queer, trans, sex workers e non-binary continuano ad essere discriminate e bersaglio di violenza.
Ma per rispondere più direttamente alla tua domanda, la spirale di violenza di cui il femminismo punitivo e carcerario è complice (anche se si difende da questa accusa dando prova di denegazione) colpisce effettivamente gli uomini razzializzati. È la guerra razziale e sessista a prenderli di mira. La colonizzazione ha razzializzato i generi, ovvero il binarismo tra donne e uomini non è universale, è attraversato dalla razza: non si è donna, ma donna indigena, nera, musulmana, ebrea, lo stesso vale per l’uomo. Questa condizione onnipresente non concede ai corpi razzializzati di accedere alle stesse misure di protezione di genere che vengono riconosciute agli uomini bianchi e alle donne bianche. Gli uomini razzializzati non sono concepiti né trattati con lo stesso rispetto e dignità di un uomo bianco occidentale.
Sappiamo che classe, genere, razza si intersecano, e che queste intersezioni non sono solo attraversate da altre intersezioni – età, (dis)abilità ecc. – ma anche sussunte all’interno di costruzioni che si evolvono storicamente e rispetto alle quali l’imperialismo svolge un ruolo fondamentale. I giovani rifugiati, migranti, esiliati, che mostrano coraggio, forza, e una straordinaria capacità di superare ostacoli incredibili resistendo a un razzismo assassino, e che per questo dovrebbero essere ammirati, vengono discriminati e squalificati in quanto detentori di una mascolinità minacciosa. L’imperialismo agisce sul modo in cui le mascolinità razzializzate sono mediate e costruite, il femo-imperialismo gioca ovviamente un ruolo in questo processo. I movimenti decoloniali di de-patriarchizzazione sono fondamentali oggi per operare una de-mascolinizzazione capace di smantellare modelli di mascolinità intesi come sinonimo di dominio e abuso di potere.
JM: Il sottotitolo del tuo libro “per una politica della protezione antirazzista” esprime un’esigenza che non riguarda solo le donne, ma qualsiasi popolazione vulnerabile esposta alla violenza istituzionale. Per queste popolazioni, che non godono del diritto alla protezione dello Stato, cosa significa “proteggersi”? Da chi, prima di tutto, e come?
FV: Esatto, il punto è proprio come proteggersi. Da chi ? Dallo sfruttamento, dall’espropriazione, dal razzismo, dalla colonizzazione e dall’imperialismo. Come? Combattendoli senza tregua, svelando i meccanismi e la perversione delle politiche di protezione basate sulla selezione – di classe, razza, sesso, origine, età, religione – e sulla punizione carcerale che ha come sola conseguenza la moltiplicazione delle carceri, e quindi della miseria, dell’isolamento, degli abusi e della violenza.
Gli oppressi hanno sempre implementato le proprie politiche di protezione – impedendo alla polizia militarizzata di entrare impunemente nei quartieri e nelle case, impedendo gli sfratti, falsificando documenti, organizzando vie di fuga clandestine, creando nascondigli e rifugi, mettendo le armi a disposizione delle comunità minacciate, creando le proprie scuole, cliniche, chiese, attività, università. In questo contesto l’obiettivo di una giustizia riparatrice e rigeneratrice è di reintegrare il reo nella comunità rendendolo consapevole del danno perpetrato.
Ciò che voglio sottolineare è l’interdipendenza tra persone che possono essere molto diverse, ma che fronteggiano gli stessi “nemici” – la fame, il freddo, la povertà, il razzismo, il capitalismo, il sessismo, la violenza dello stato, la polizia, la giustizia di parte – e decidono di organizzare la solidarietà. C’è bisogno d’impegno quotidiano, di un enorme sforzo, perché nulla nella società occidentale odierna dominata dall’individualismo ci insegna l’interdipendenza e la solidarietà.
Lo Stato protegge a condizione di poter stabilire chi ha diritto alla protezione, come viene esercitata e da chi viene applicata. C’è quindi sempre una tensione tra le richieste di protezione portate avanti da parte dei cittadini rispetto, ad esempio, ai beni pubblici da difendere lottando – i diritti sul lavoro, il diritto alla salute, all’educazione, alla casa, il diritto ad essere messi al riparo dalle calamità naturali (cicloni, terremoti, pandemie…) – e il modo in cui lo Stato concepisce la sua protezione.
Il riconoscimento del bisogno comune e condiviso di protezione – fisica e psicologica – si situa agli antipodi tanto della protezione condizionata dello Stato quanto dell’ideologia individualista e menefreghista che dice: “Se ce l’ho fatta io, nonostante tutti gli ostacoli, allora può farcela chiunque. Basta volerlo”; è questo mito individualista della volontà, profondamente reazionario, serve spesso a giustificare il razzismo.
Protezione decoloniale antirazzista significa quindi, prima di tutto, riconoscere che un essere umano ha bisogno di protezione (alla nascita un essere umano è incapace di sopravvivere senza protezione) e che è legato da vincoli di interdipendenza con il suo ambiente e con gli altri esseri viventi. È un rifiuto dell’individualismo, dell’idea che possiamo cavarcela da soli, che non abbiamo bisogno di nessuno. La solidarietà è un riconoscimento di questa esigenza di protezione contro le forze egoiste del neoliberalismo: siamo insieme, ci sosteniamo a vicenda, ci consoliamo a vicenda, sappiamo che non siamo soli, che i compagni e le compagne di lotta sono lì. Dobbiamo nutrire questa concezione collaborativa e collettiva della protezione, perché è costantemente indebolita dagli egoismi, dalle gelosie e dalle rivalità. Non dobbiamo sottovalutare le conseguenze distruttive per la psiche prodotte dal razzismo, dal sessismo e dal capitalismo. Siamo “messi male”, ma non mettiamo a fuoco le cause perché tutto – la scuola, l’informazione, l’organizzazione della società, le ideologie dominanti – ci educa a non indagare le cause storiche e profonde del nostro malessere, ma a dare la colpa agli altri. Oppure siamo diventati sospettosi perché siamo stati ingannati, maltrattati, ci rifiutiamo di avvicinarci ad altri per paura di essere feriti e delusi.
Per creare questa protezione solidale, bisogna superare la paura, saper amare, accettare le differenze, riconoscere le proprie difficoltà e imparare a confortarsi con gli altri, rifiutando i toni moraleggianti. Si tratta di un processo in cui non si deve mai approfittare della vulnerabilità altrui per affermare il proprio ego o per creare dipendenza. Il come è, ripeto, tutto basato sul lavoro collettivo e sullo sforzo quotidiano a partire dalla consapevolezza che l’interdipendenza è davvero l’opposto della dipendenza.







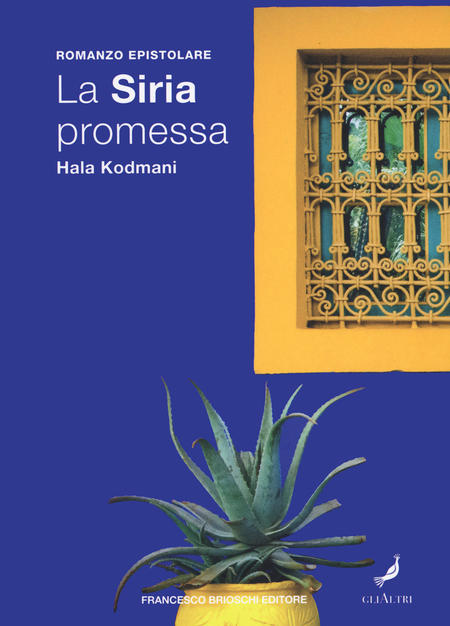



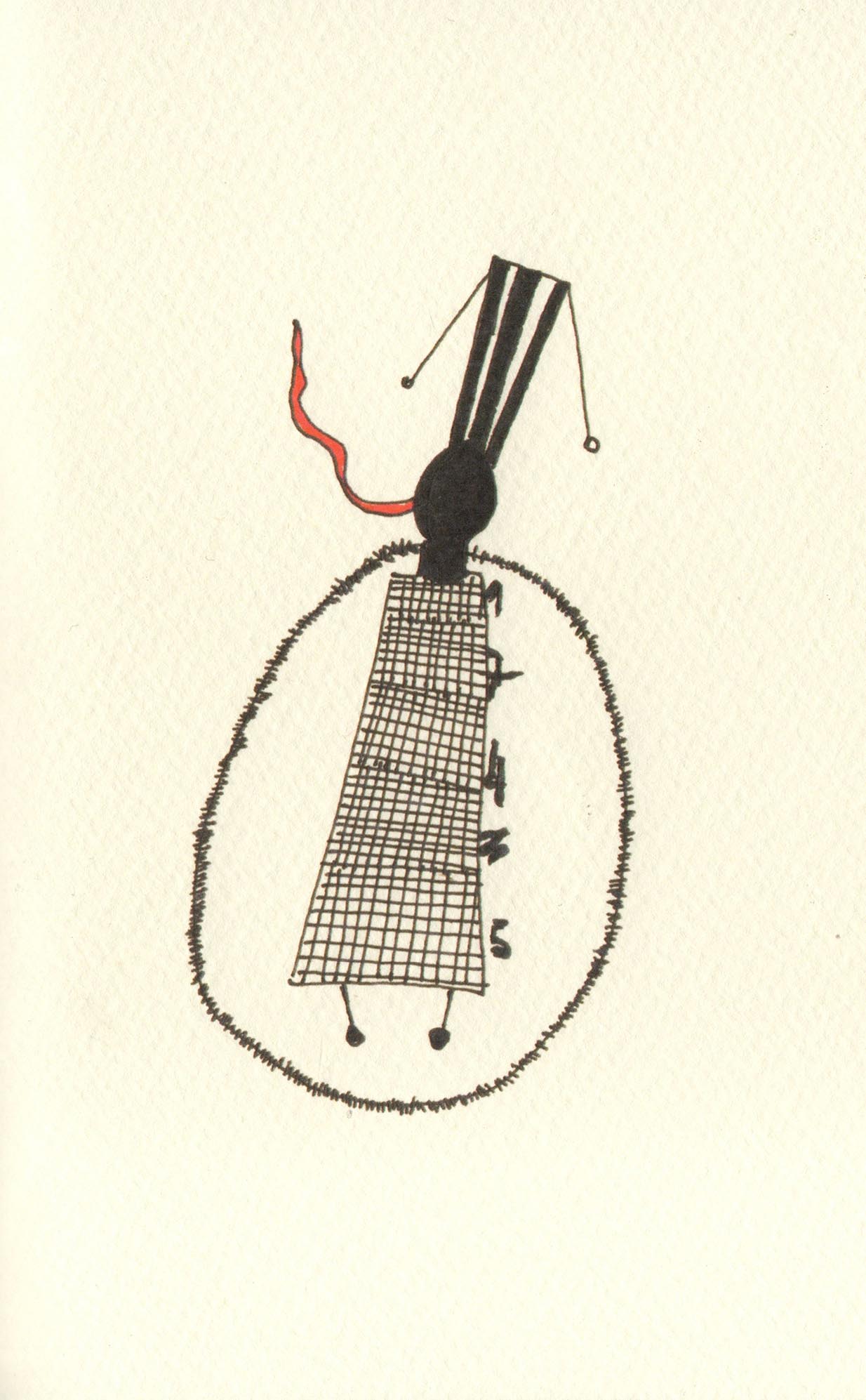
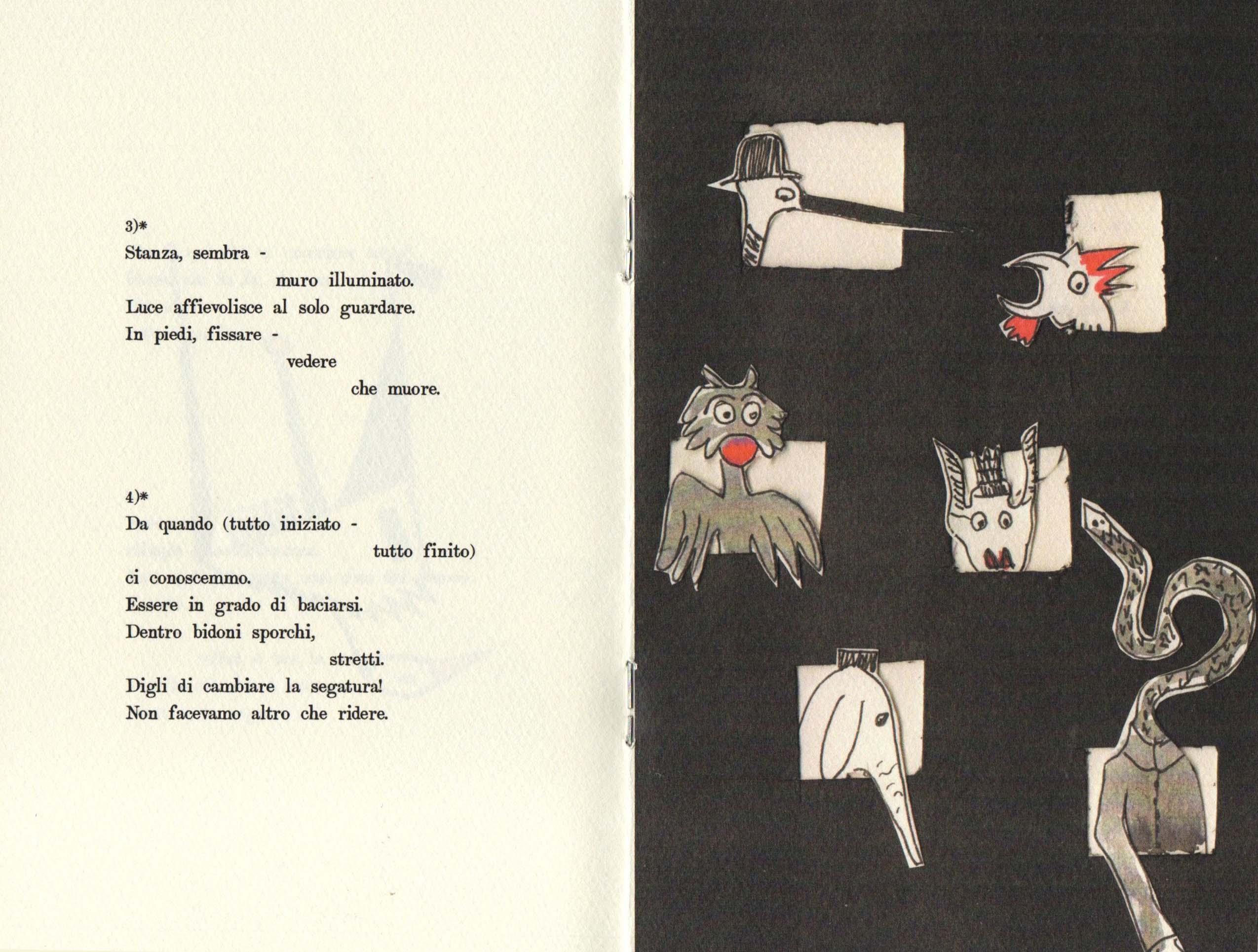
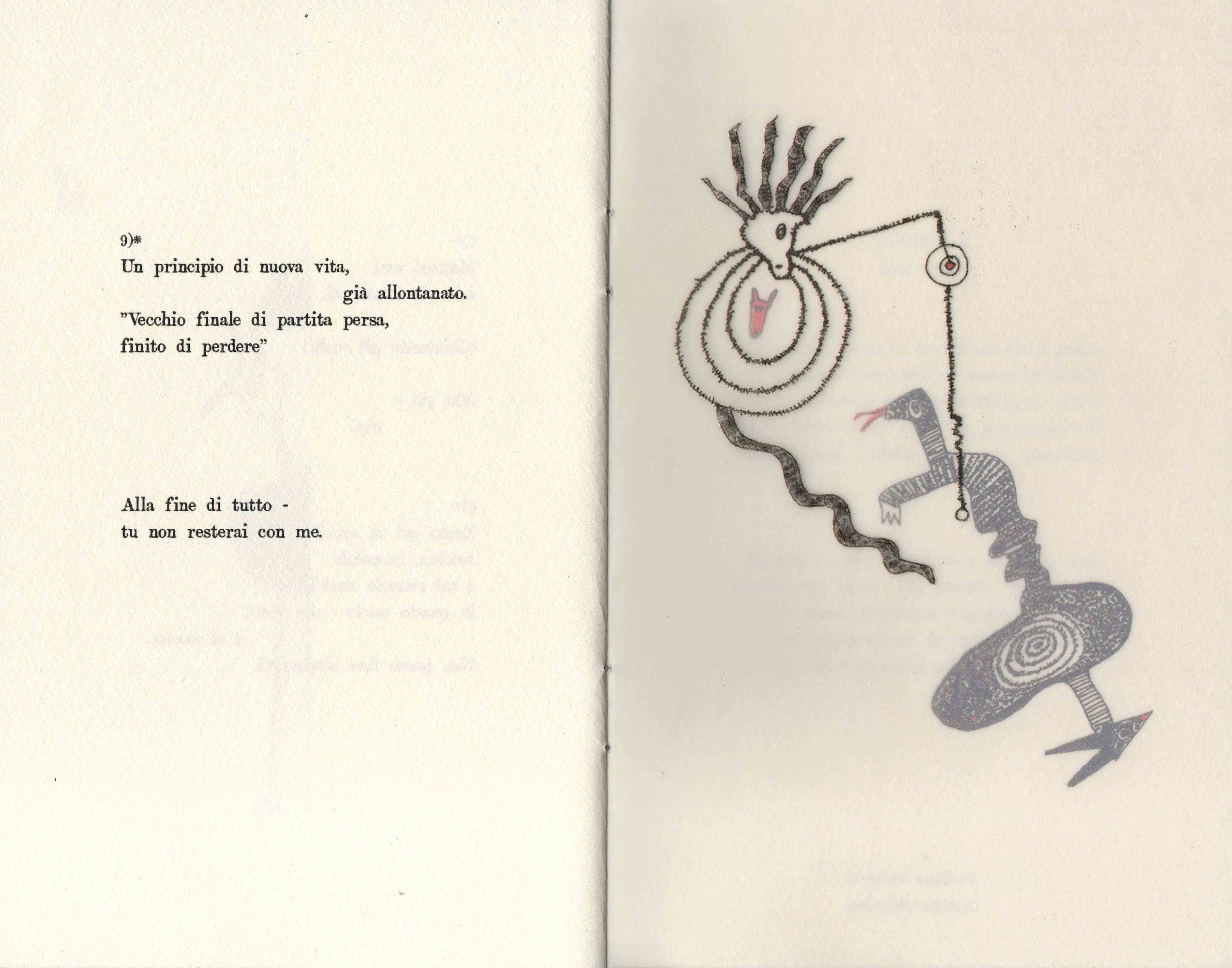


 Ezio Puglia (1982) fa parte di quella che vorrei chiamare la “scuola bolognese” del fantastico. Perché è un dato di fatto che, da un quarto di secolo a questa parte, i migliori libri sulla letteratura fantastica – e sul fantastico italiano – pubblicati in Italia siano venuti tutti da studiosi che o si sono formati a Bologna, o vi hanno lavorato per lunghi periodi, o entrambe le cose. L’elenco non è lungo, e vale la pena di compilarlo: penso ai nomi di Remo Ceserani (Il fantastico, Bologna, il Mulino, 1996), Vittorio Roda (I fantasmi della ragione. Fantastico, scienza e fantascienza nella letteratura italiana fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1996; Studi sul fantastico, Bologna, CLUEB, 2009), Ferdinando Amigoni (Fantasmi nel Novecento, Torino, Bollati Boringhieri, 2004), Angelo M. Mangini (Letteratura come anamorfosi. Teoria e prassi del fantastico nell’Italia del primo Novecento, Bologna, Bononia University Press, 2007), Luigi Weber (curatore insieme a Mangini dell’opera collettiva Il visionario, il fantastico, il meraviglioso tra Otto e Novecento, Ravenna, Allori, 2004 e poi 2006). Ho citato libri che risplendono di fulgida luce nel campo degli studi sul fantastico; alla lista viene ora ad aggiungersi Il lato oscuro delle cose. Archeologia del fantastico e dei suoi oggetti di Puglia (postfazione di Angelo M. Mangini, Modena, Mucchi, 2020, pp. 320), degno erede di quella che può essere descritta, per l’appunto, come una tradizione di studi consolidata e caratterizzata da tratti comuni – uno fra tutti, il rigore storico, teorico, metodologico.
Ezio Puglia (1982) fa parte di quella che vorrei chiamare la “scuola bolognese” del fantastico. Perché è un dato di fatto che, da un quarto di secolo a questa parte, i migliori libri sulla letteratura fantastica – e sul fantastico italiano – pubblicati in Italia siano venuti tutti da studiosi che o si sono formati a Bologna, o vi hanno lavorato per lunghi periodi, o entrambe le cose. L’elenco non è lungo, e vale la pena di compilarlo: penso ai nomi di Remo Ceserani (Il fantastico, Bologna, il Mulino, 1996), Vittorio Roda (I fantasmi della ragione. Fantastico, scienza e fantascienza nella letteratura italiana fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1996; Studi sul fantastico, Bologna, CLUEB, 2009), Ferdinando Amigoni (Fantasmi nel Novecento, Torino, Bollati Boringhieri, 2004), Angelo M. Mangini (Letteratura come anamorfosi. Teoria e prassi del fantastico nell’Italia del primo Novecento, Bologna, Bononia University Press, 2007), Luigi Weber (curatore insieme a Mangini dell’opera collettiva Il visionario, il fantastico, il meraviglioso tra Otto e Novecento, Ravenna, Allori, 2004 e poi 2006). Ho citato libri che risplendono di fulgida luce nel campo degli studi sul fantastico; alla lista viene ora ad aggiungersi Il lato oscuro delle cose. Archeologia del fantastico e dei suoi oggetti di Puglia (postfazione di Angelo M. Mangini, Modena, Mucchi, 2020, pp. 320), degno erede di quella che può essere descritta, per l’appunto, come una tradizione di studi consolidata e caratterizzata da tratti comuni – uno fra tutti, il rigore storico, teorico, metodologico. radicalmente il senso e a volte lo capovolge. Di seguito, esaminerò alcuni esempi di quanto vado affermando.
radicalmente il senso e a volte lo capovolge. Di seguito, esaminerò alcuni esempi di quanto vado affermando.
 La volontà di rimanere solidamente ancorato alla storia del fantastico otto-novecentesco induce inoltre Puglia a ridiscutere il canone del genere, al quale apporta leggere ma significative modifiche: nel campo della letteratura italiana, ad esempio, Papini si guadagna un posto di assoluto rilievo, che non molti studiosi erano stati finora disposti a riconoscergli (cfr. pp. 229-233). Una delle modifiche di cui sopra, del resto, non è tanto leggera, anzi; la torsione impressa da Puglia alle categorie precedentemente ammesse fa vacillare sul suo piedestallo nientemeno che l’autore considerato da generazioni di colleghi scrittori e poi di studiosi come il fondatore, o per lo meno il primo indiscusso maestro, del fantastico ottocentesco: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Per Puglia, Hoffmann non è fantastico: un’asserzione sorprendente, che merita qualche parola di spiegazione. Cominciamo col sottolineare che questa opinione di Puglia ne riecheggia un’altra, famosa e controversa: quella di Todorov secondo cui Edgar Allan Poe, alter ego di Hoffmann e inquilino anch’egli del cuore bifronte del canone ottocentesco, non sarebbe, in realtà, un autore fantastico. “D’une manière générale”, aveva rilevato il teorico franco-bulgaro, “on ne trouve pas dans l’œuvre de Poe de contes fantastiques, au sens strict, à l’exception peut-être des Souvenirs de M. Bedloe et du Chat noir. Ses nouvelles relèvent presque toutes de l’étrange, et quelques-unes, du merveilleux” (Tz. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, cit., p. 54). In nome della storia, Puglia capovolge intenzionalmente – e con piena ragione – l’opinione di Todorov: “Poe, un autore spinoso per tutti coloro che hanno cercato di elaborare una definizione teorica del fantastico […], al genere storico può essere aggregato senza problemi” (pp. 10-11). Ma poi, sempre in nome della storia (e però con un ragionamento che il recensore non si sente di approvare), lo stesso Puglia mette al bando, come si è detto, il grande predecessore dell’americano: “A rigore, la letteratura di Hoffmann, compresi quei testi che di solito vengono riconosciuti come l’incarnazione più pura del fantastico, non può essere inclusa all’interno del genere storico. La ragione è banale: il fantastico non esisteva ancora al tempo in cui Hoffmann scriveva quelle opere che erano destinate a diventare prototipi di una nuova tipologia narrativa” (p. 10). È, mi sembra, un bel paradosso: a forza di storicizzare, Puglia finisce con il raggiungere gli esiti aporetici di chi invece, della storia letteraria, faceva “cavalièrement litière”, almeno se sottoscriviamo le accuse che a Todorov rivolge il solito Finné (J. Finné, La littérature fantastique, cit., p. 34). Laddove Todorov, cedendo a “cet enchantement que procure la radicalité” (Tz. Todorov, Devoirs et délices. Une vie de passeur, entretiens avec C. Portevin, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 112), aveva decretato l’espulsione di Poe dal canone, il giustissimo scrupolo di Puglia per i contesti storici della letteratura spinge lo studioso italiano a staccare dal muro, nella galleria di ritratti del fantastico europeo, quello che riproduce le fattezze di Hoffmann: seguendo percorsi diversi e anzi opposti, lo strutturalista e lo storicista finiscono per convergere nell’ostracismo ai danni di uno dei due maestri unanimemente riconosciuti del secolo d’oro del fantastico. Non sarebbe più sensato – questo il parere di chi scrive – lasciare entrambi al loro posto, visto che non abbiamo argomenti davvero decisivi per rettificare il giudizio di un paio di secoli di letteratura e di critica? A chiudere il cerchio del paradosso, annoto qui che il più volte citato Finné – acerrimo fustigatore, come si è visto, di Todorov, ma da una postazione di fatto interna allo strutturalismo – aveva anticipato l’opinione di Puglia su Hoffmann, definendo quest’ultimo “le moins fantastique de tous les conteurs allemands” (J. Finné, La littérature fantastique, cit., p. 185): in altri termini, il medesimo amor di storia persuade Puglia a dissentire su Poe dallo strutturalista Todorov e, viceversa, a consentire (credo inconsapevolmente) su Hoffmann con lo strutturalista Finné; i casi strani della teoria del fantastico!
La volontà di rimanere solidamente ancorato alla storia del fantastico otto-novecentesco induce inoltre Puglia a ridiscutere il canone del genere, al quale apporta leggere ma significative modifiche: nel campo della letteratura italiana, ad esempio, Papini si guadagna un posto di assoluto rilievo, che non molti studiosi erano stati finora disposti a riconoscergli (cfr. pp. 229-233). Una delle modifiche di cui sopra, del resto, non è tanto leggera, anzi; la torsione impressa da Puglia alle categorie precedentemente ammesse fa vacillare sul suo piedestallo nientemeno che l’autore considerato da generazioni di colleghi scrittori e poi di studiosi come il fondatore, o per lo meno il primo indiscusso maestro, del fantastico ottocentesco: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Per Puglia, Hoffmann non è fantastico: un’asserzione sorprendente, che merita qualche parola di spiegazione. Cominciamo col sottolineare che questa opinione di Puglia ne riecheggia un’altra, famosa e controversa: quella di Todorov secondo cui Edgar Allan Poe, alter ego di Hoffmann e inquilino anch’egli del cuore bifronte del canone ottocentesco, non sarebbe, in realtà, un autore fantastico. “D’une manière générale”, aveva rilevato il teorico franco-bulgaro, “on ne trouve pas dans l’œuvre de Poe de contes fantastiques, au sens strict, à l’exception peut-être des Souvenirs de M. Bedloe et du Chat noir. Ses nouvelles relèvent presque toutes de l’étrange, et quelques-unes, du merveilleux” (Tz. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, cit., p. 54). In nome della storia, Puglia capovolge intenzionalmente – e con piena ragione – l’opinione di Todorov: “Poe, un autore spinoso per tutti coloro che hanno cercato di elaborare una definizione teorica del fantastico […], al genere storico può essere aggregato senza problemi” (pp. 10-11). Ma poi, sempre in nome della storia (e però con un ragionamento che il recensore non si sente di approvare), lo stesso Puglia mette al bando, come si è detto, il grande predecessore dell’americano: “A rigore, la letteratura di Hoffmann, compresi quei testi che di solito vengono riconosciuti come l’incarnazione più pura del fantastico, non può essere inclusa all’interno del genere storico. La ragione è banale: il fantastico non esisteva ancora al tempo in cui Hoffmann scriveva quelle opere che erano destinate a diventare prototipi di una nuova tipologia narrativa” (p. 10). È, mi sembra, un bel paradosso: a forza di storicizzare, Puglia finisce con il raggiungere gli esiti aporetici di chi invece, della storia letteraria, faceva “cavalièrement litière”, almeno se sottoscriviamo le accuse che a Todorov rivolge il solito Finné (J. Finné, La littérature fantastique, cit., p. 34). Laddove Todorov, cedendo a “cet enchantement que procure la radicalité” (Tz. Todorov, Devoirs et délices. Une vie de passeur, entretiens avec C. Portevin, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 112), aveva decretato l’espulsione di Poe dal canone, il giustissimo scrupolo di Puglia per i contesti storici della letteratura spinge lo studioso italiano a staccare dal muro, nella galleria di ritratti del fantastico europeo, quello che riproduce le fattezze di Hoffmann: seguendo percorsi diversi e anzi opposti, lo strutturalista e lo storicista finiscono per convergere nell’ostracismo ai danni di uno dei due maestri unanimemente riconosciuti del secolo d’oro del fantastico. Non sarebbe più sensato – questo il parere di chi scrive – lasciare entrambi al loro posto, visto che non abbiamo argomenti davvero decisivi per rettificare il giudizio di un paio di secoli di letteratura e di critica? A chiudere il cerchio del paradosso, annoto qui che il più volte citato Finné – acerrimo fustigatore, come si è visto, di Todorov, ma da una postazione di fatto interna allo strutturalismo – aveva anticipato l’opinione di Puglia su Hoffmann, definendo quest’ultimo “le moins fantastique de tous les conteurs allemands” (J. Finné, La littérature fantastique, cit., p. 185): in altri termini, il medesimo amor di storia persuade Puglia a dissentire su Poe dallo strutturalista Todorov e, viceversa, a consentire (credo inconsapevolmente) su Hoffmann con lo strutturalista Finné; i casi strani della teoria del fantastico! bbe poco opportuno chiudere questo resoconto senza accennare a un altro aspetto fondamentale e innovatore del libro di Puglia: l’attenzione agli oggetti che lo pervade in ogni pagina. Finora si sapeva, sì, che l’oggettualità del fantastico era importantissima; ma lo si sapeva quasi esclusivamente grazie al saggio di Lucio Lugnani sugli oggetti mediatori e al volume di Francesco Orlando sugli oggetti desueti: ovvero due ricerche di grande valore e due topoi assolutamente decisivi, ma per l’appunto soltanto due (cfr. rispettivamente L. Lugnani, Verità e disordine: il dispositivo dell’oggetto mediatore, in R. Ceserani et alii, La narrazione fantastica, cit., pp. 177-288, e F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, Torino, Einaudi, 1993, seconda edizione riveduta e ampliata presso lo stesso editore nel 1994). Puglia invece – pur rifuggendo dalla casistica, e avvisando il lettore che nel suo libro non si troverà nessun “elenco esaustivo delle cose auratiche e spettrali del fantastico ottocentesco” (p. 12) – ci fa discernere e apprezzare i mille volti, spesso affascinanti, delle cose descritte nei racconti e nei romanzi fantastici: oggetti inquietanti, assurdi, erotici, da collezione; feticci, reliquie, indizi, rifiuti; oggetti surreali, alieni, spettrali e auratici (secondo la bipartizione principale, abbozzata alle pp. 11-12); e via di seguito. E grazie al punto di osservazione particolare – ed estremamente fecondo – costituito dalla rappresentazione letteraria degli oggetti, getta nuova luce su molti capolavori del fantastico otto-novecentesco che ci illudevamo di conoscere a menadito.
bbe poco opportuno chiudere questo resoconto senza accennare a un altro aspetto fondamentale e innovatore del libro di Puglia: l’attenzione agli oggetti che lo pervade in ogni pagina. Finora si sapeva, sì, che l’oggettualità del fantastico era importantissima; ma lo si sapeva quasi esclusivamente grazie al saggio di Lucio Lugnani sugli oggetti mediatori e al volume di Francesco Orlando sugli oggetti desueti: ovvero due ricerche di grande valore e due topoi assolutamente decisivi, ma per l’appunto soltanto due (cfr. rispettivamente L. Lugnani, Verità e disordine: il dispositivo dell’oggetto mediatore, in R. Ceserani et alii, La narrazione fantastica, cit., pp. 177-288, e F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, Torino, Einaudi, 1993, seconda edizione riveduta e ampliata presso lo stesso editore nel 1994). Puglia invece – pur rifuggendo dalla casistica, e avvisando il lettore che nel suo libro non si troverà nessun “elenco esaustivo delle cose auratiche e spettrali del fantastico ottocentesco” (p. 12) – ci fa discernere e apprezzare i mille volti, spesso affascinanti, delle cose descritte nei racconti e nei romanzi fantastici: oggetti inquietanti, assurdi, erotici, da collezione; feticci, reliquie, indizi, rifiuti; oggetti surreali, alieni, spettrali e auratici (secondo la bipartizione principale, abbozzata alle pp. 11-12); e via di seguito. E grazie al punto di osservazione particolare – ed estremamente fecondo – costituito dalla rappresentazione letteraria degli oggetti, getta nuova luce su molti capolavori del fantastico otto-novecentesco che ci illudevamo di conoscere a menadito.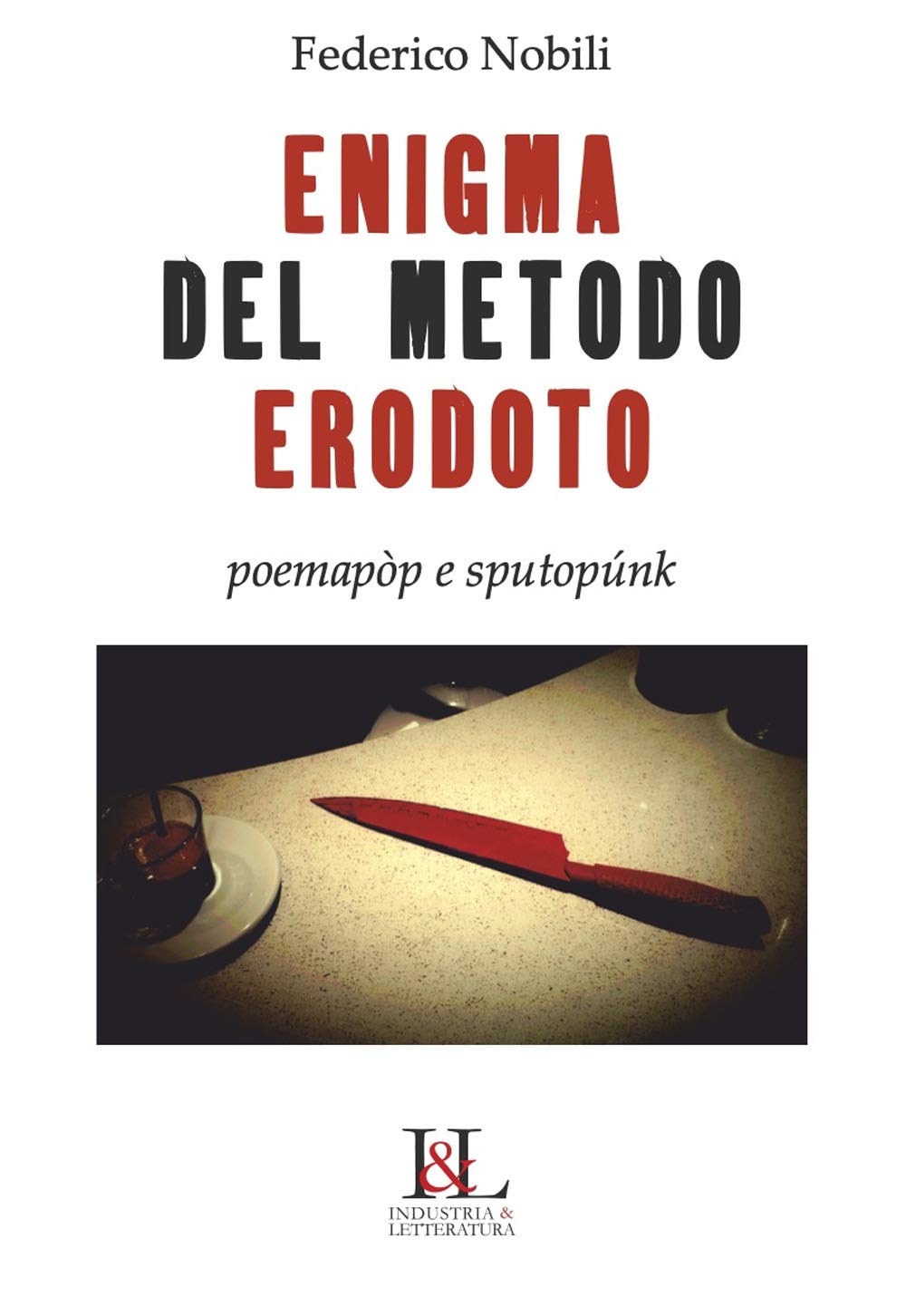
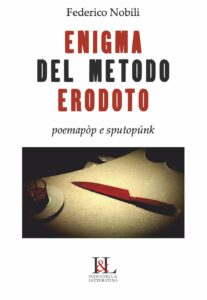 odoto
odoto
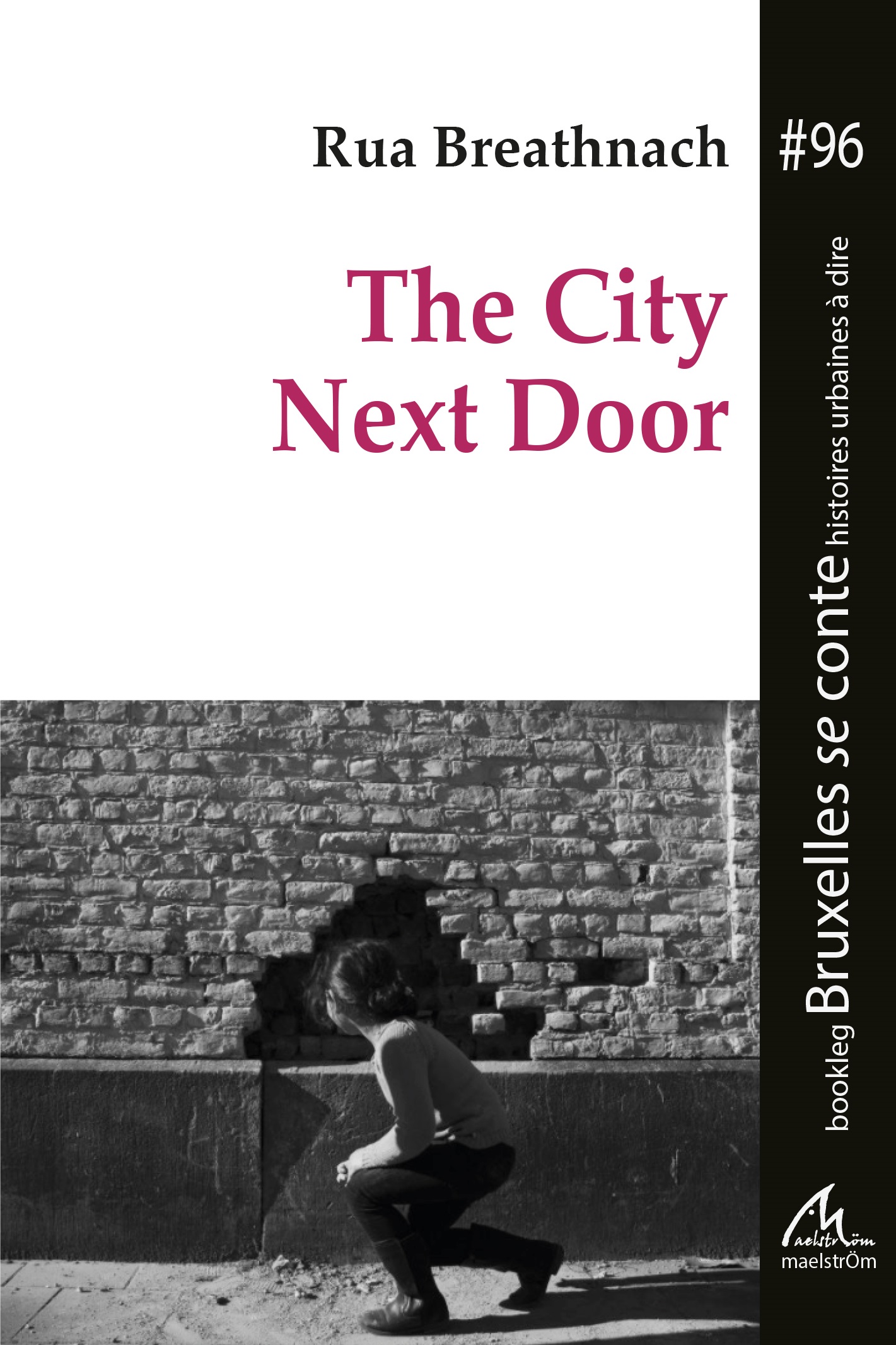
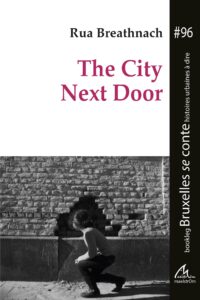 Nota dell’autore
Nota dell’autore