
di Tommaso di Dio e Alessio Paiano
A.P. – Verso le stelle glaciali (Interlinea, 2020) è un libro costruito attraverso un’architettura interna molto ragionata, e ciò credo lo renda un caso alquanto insolito, se consideriamo che lo spazio concesso a questo tipo di scritture sia molto ridotto rispetto a ciò che si crede essere il ‘far poesia’. Forse perché sei riuscito a imporre un incastro tra le sezioni che non si declina mai in una fuoriuscita totale: se consideriamo singolarmente le parti che compongono il libro, non le immagino come tratti isolati, ma come deviazioni che continuano un unico percorso di partenza. Sei tu stesso che cerchi faticosamente, ma con successo, di far passare il filo rosso, di tenere il tutto, accompagnando il lettore in questo mondo apparentemente disperso. Quando in apertura presenti i quattro percorsi dicendo che «nessun ordine è però prescritto», quasi ci si sente di fronte a una frantumazione già avvenuta, alla deriva dei continenti (vista la centralità della geografia nella raccolta), ma fai capire infine che ci troviamo davanti a un organismo ben funzionante, un pianeta che si regge grazie a miriadi di forze opposte e contraddittorie.
T.D.D. – Sono felice, Alessio, che questo nostro dialogo cominci proprio da qui: da questioni architettoniche. Nella scrittura, fino ad adesso, per me è stato molto importante, diciamo, separare il momento della stesura di un testo dal momento compositivo. È un atteggiamento che però non mi sembra così strano: sono molti i libri, sia lontani che più recenti, che mostrano un’attenzione di questo tipo, dal modello insuperabile delle Ecloghe virgiliane fino, che so io, a Pitture nere su carta di Mario Benedetti, ma, per citare alcuni altri libri di poesia recenti che per me sono imprescindibili, prova a pensare per esempio allo stupendo Tre opere di Florinda Fusco oppure ai più recenti Posti a sedere di Luciano Mazziotta e Appartamenti o stanze di Carmen Gallo. Anzi, penso che proprio la fluidità degli ultimi venti anni, il fatto che molta, moltissima poesia sia oggi fruita in rete, abbia acuito invece in diversi autori l’esigenza di strutturare in maniera più solida il libro di poesia: proprio per evitare che il singolo testo sia lasciato solo e indifeso nella deriva che trascina via oggi ogni testo (deriva che è invece oggetto di appropriazione di tanti altri autori che condividono a ripetizione testi di #poesia nei loro profili social). Il libro è, anche, un modo per dare maggiore “resistenza semantica” ai singoli componimenti, dare loro rilievo: e in questo senso è anche un sintomo, oltre che uno strumento. Per tornare al mio lavoro, per me scrivere e strutturare quanto ho scritto sono due processi che considero nel medesimo gesto della “scrittura”, ma li avverto completamente diversi: seguono logiche e metodi quasi opposti. Se da un lato la scrittura delle singole poesie avviene quasi sempre a partire da un’urgenza che non ha obiettivi prefissati né abitudini a cui affidarsi (scrivere è per me camminare al buio, letteralmente, verso dopo verso), comporre poi un libro è invece frutto di un calcolo che vorrebbe rispecchiare una precisa idea di mondo. In questo senso mi troverei in imbarazzo a commentare una mia poesia, ma non nel raccontare qui del mio libro: il libro di poesia è, anche, un veicolo ideologico. Non ho infatti mai pensato, per quanto ho fatto fino ad ora, al libro di poesia come ad una semplice raccolta di poesie, ma sempre come un organismo progettuale. Con Verso le stelle glaciali volevo dunque qualcosa, avevo un obiettivo, sebbene non sia emerso da subito dai materiali che avevo nei miei file-faldoni, ma mi si è reso sempre più chiaro durante i mesi in cui lavoravo alla selezione e alle sequenze. Mi venivano alle mani aggregazioni distinte di testi, con centri molto lontani fra loro e tensioni equipollenti, ma distinte nella forma e nei modi, sebbene tutti tendessero a qualcosa che non era detto, che non era nel detto. E dunque, lentamente, è emersa l’idea di insistere su questa difformità: comporre un libro di libri, che, da un lato, tenesse il lettore sempre dentro i segni della scrittura (immaginavo questo libro come una geografia a spirale, un oggetto quadrimensionale dentro cui il lettore potesse compiere più percorsi in tutte le direzioni, in avanti e all’indietro, andando dai versi alle immagini verso la prosa e tornando indietro ancora), dall’altro volevo che il lettore vivesse l’esperienza che tutto ciò che era in gioco non fosse lì: non fosse nel libro, non fosse in quei segni, ma si giocasse fuori, a libro chiuso. Da qui la sensazione delle continue deviazioni a cui fai giustamente riferimento, a cui si unisce però una possibilità: quella di leggere il libro in maniera lineare, dalla prima pagina all’ultima. Verso le stelle glaciali è anche un itinerario in quattro geografie consecutive, connesse fra loro da una voluta progressione allegorica. Ma non volevo che il lettore pensasse che questo fosse l’unico ordine possibile; anzi l’invito nell’avvertenza ha proprio questa funzione: insinuare l’idea che un libro di poesia possa proprio essere usato differentemente da quanto avviene per un libro di narrativa o di saggistica, che introietta in maniera spesso inerte la logica della progressione lineare alfabetica. Un libro di poesia può, anche, essere aperto a caso: accoglie il favore dell’alea. Può essere attraversato e usato, di volta in volta, come amuleto, come bussola, come labirinto, ovvero come protezione dal male, come strumento di orientamento o come spazio in cui perdersi. A queste tre funzioni faccio riferimento nel libro: a volte i versi spaesano, a volte guidano, a volte vogliono che accada qualcosa, che qualcosa si allontani o si avvicini. Volevo dare l’impressione delle infinite potenzialità che la poesia, questo forma simbolica, ha maturato nella sua lunga storia. Per seguire la tua metafora, posso dire così: Verso le stelle glaciali è pensato come un ammasso galattico, una nebula di stelle composta da quattro piccole galassie distinte (gli itinerari) a cui si sono aggregati col tempo, per forza gravitazionale, altri materiali (le immagini, le prose), ma ogni galassia, ogni itinerario, è un mondo in sé compiuto. In questo senso sì, hai perfettamente ragione: il lettore si trova già di fronte ad una frantumazione, ma tutti questi frammenti sono resi coesi e coerenti dalla costante presenza di un Grande Attrattore, un centro invisibile, remoto, freddo: è questa energia che spinge ogni elemento al successivo e ognuno di essi al di fuori della propria galassia-itinerario, verso quelle che chiamo le stelle glaciali, ovvero verso la fine di ogni luce, una massa buia, una sorta di buco nel cosmo o nel linguaggio: verso qualcosa che la parola non può dire (e che Lacan, forse, chiamerebbe il Reale).
A.P – Volendo rispettare l’architettura da te proposta nel libro, la prima sezione si distingue dalle altre per uno sguardo completamente rivolto all’altro: mi pare che recuperi una certa tradizione che tu hai ovviamente frequentato, quella che trae cioè dal bestiario metropolitano il proprio materiale di scrittura. Eppure, se una considerazione va fatta per evitare eccessive semplificazioni, l’Io che si fa osservatorio delle figure incontrate non presenta alcuni intenti moralistici, né pretese etnografiche e quindi voyeuristiche; questa tematica delle minoranze, che rischia davvero ormai di apparire kitsch e posticcia per chi la sfrutta ai fini di un retorico sensazionalismo, tu la affronti ponendo una totale distanza dello sguardo poetico, una distanza che percepisco come rispetto umano, un’umile delicatezza che nel testo più volte alludi addirittura di voler ridurre al silenzio. Quali riflessioni ti hanno spinto a operare in tal senso?
T.D.D. – Dici bene: la prima parte è per me una sezione di raccordo con Tua e di tutti ed è anche un modo per ricapitolare una certa modalità di scrittura che ha fatto e fa ancora parte della mia storia. Parlo, come hai intuito, di una certa frontalità con l’esperienza fenomenica, virata all’espressionismo, che mi viene dall’incrocio di alcuni autori di lezione lombarda: il mio amato Clemente Rebora, Vittorio Sereni, un certo Fortini e giù, fino a certe aree della scrittura di Milo De Angelis. Mettici in più che sono nato e vivo in una città e che spesso lo scatto iniziale della scrittura avviene proprio per strada. Detto ciò, per me era importante partire da dove vivo, dal luogo concreto della mia esistenza. Si parte sempre da qualche parte e in quella sezione l’ho dichiarato: parto da una tradizione precisa e da una geografia determinata. Mi interessava poi in questa sezione provare a fotografare delle solitudini. Non era però al centro del mio interesse il piano esistenziale della questione, con tutto il corredo emotivo che conosciamo; volevo far emergere quanto la solitudine rappresenti una forma di esclusione: un effetto, insomma, di una certa determinazione materiale. Come hai giustamente notato, questo è un tema portante del libro. La seconda sezione lo mette al centro di una relazione umana, la terza di quella di un gruppo (il rapporto fra il capitano e la ciurma), nell’ultima la cosa infine si ripete e si trasforma. La prima sezione propone una serie di ritratti di persone, o da sole o in scena con altri, micro coaguli umani, però sempre sconnessi, slegati, separati da un “resto”: che escludono colui che le guarda o sono stati esclusi. Sia nel ritratto della donna in metropolitana che nel caso di soggetti plurali (penso a Dentro camminano, di p. 20) è in gioco la stessa dinamica. In questo contesto, mi sono deciso ad inserire anche un testo che tratta direttamente di un episodio che è accaduto a cinquecento metri da dove abitavo. Nel 2017, un ragazzo richiedente asilo, ospite in un centro di accoglienza, si è tolto la vita impiccandosi sulla massicciata che corre lungo i binari della Stazione Centrale. Più volte durante la settimana, nei giri a piedi nel mio quartiere, passavo davanti a quel punto: davanti a quel momento. Dopo alcuni mesi, è emerso questo testo e sono stato indeciso fino all’ultimo se inserirlo, proprio perché non volevo assolutamente che si creasse quell’effetto kitsch, fra il pietistico e il voyeuristico, che tu dici. Ci son volute moltissime stesure, varianti, tagli e spostamenti; ho cercato di tenere presente il monito di Fortini: «quando si legge un ragionamento politico, il tasso di ridondanza emotiva dovrebbe essere ridotto al minimo»[i]. Infine, però mi sono deciso (anche contro il parere di alcuni amici lettori): mi sembrava che completasse la geografia della prima sezione, che fosse dentro lo sviluppo del libro. Era, anzi, un punto fondamentale, proprio perché rappresenta, all’estremo, l’apparire di qualcosa che, pur accadendo vicino a noi, ci esclude: ci riduce al silenzio. Per via delle nostre condizioni, non solo spesso non riusciamo a dare a questi incontri umani attenzione alcuna; ma di fronte ad essi sperimentiamo una sorta di impotenza, di incapacità. Ci vengono meno le parole, proprio perché, su di essi, la continua logorrea dei nostri discorsi non riesce ad esercitare alcun potere. Questi buchi, queste aree di silenzio, di sottrazione del discorso a se stesso, attraggono la mia scrittura. La mia poesia infatti non parla di quel ragazzo suicida, ma proprio del fallimento, di fronte a ciò, della mia cultura. Era per me evidente che davanti ad un gesto del genere nessun discorso avesse più senso, nessun discorso in lingua italiana, dico. Crolla e va a zero tutto il linguistico. Appare una breccia, una crepa, dentro la storia della lingua con cui mi esprimo e di cui sono il prodotto. Non so se riesco a spiegarmi, ma sento che in luoghi del genere, di balbuzie, di interruzione del discorso, si possa aprire lo spazio per la poesia. Da queste riflessioni, nasceva il tentativo di rendere questo e gli altri ritratti più scultorei possibile, solidi, spigolosi, stereometrici e distanti: come se stessi provando a descrivere delle erme, davanti alle quali sostare ammutoliti. La vita umana come l’apparire di un enigma, la poesia come l’eco sonora di questo enigma.
A.P. – Veniamo alla seconda sezione che forma la serie ospedaliera del libro. Anche qui mi pare di poter riaffermare il discorso fatto in precedenza sul silenzio, però non è più il proprio silenzio ma quello dell’altro, che faticosamente ancora dice, ricorda, nomina. Qui riporti chiaramente una tua esperienza intima, ma lo fai ancora una volta senza condividerti del tutto, spostando continuamente lo sguardo verso altre dimensioni: parli di ritrovamenti, grotte, scavi archeologici, e non si riesce facilmente a comprendere il senso finché leggendo non si comprende che la resistenza di chi soffre assomiglia proprio a un cavare fuori la vita, farne appunto un reperto scoperto in estremo. C’è un tentativo di ‘uscir fuori’ che riguarda non solo le due presenze nel testo, ma un mondo che si nasconde e attende di venire alla luce – a dimostrazione che le singole parti del libro comunicano tra loro in maniera non casuale ma ben congeniata.
T.D.D. – Esattamente. Proprio in questo senso, la poesia si fa eco del silenzio dell’altro, ne accoglie il suono, non tradendone (spero) il vuoto da cui emerge. C’è una poesia di Margherita Guidacci che dice così: «Il vuoto si difende/ non vuole che una forma lo torturi»[ii]. L’esperienza di essere così vicini ad un uomo, un amico, che in coma non poteva più parlare, sapendo che quell’amico aveva fatto della sua vita la ricerca di una parola, è stato davvero sentire precipitare tanti saperi, tanti discorsi inutili. Ho anche pensato, del tutto insensatamente nel dolore di quei giorni, che quella condizione fosse il capitolo estremo della sua ricerca: che non potesse che continuare così, afona e inudibile, la sua poesia. Per via di un riduzionismo coatto, siamo abituati a pensare che la realtà sia una, quella dei sensi; e invece di fronte alle esperienze più profonde della nostra vita, la realtà ci viene incontro come una stratificazione, una geologia piena di fori, passaggi, cunicoli: una paleografia di mondi. In quei momenti, vera non è solo la cosa che vedo, ma come emerge ciò che vedo, il processo e i legami attraverso cui uno strato si offre e si dà a vedere dall’altro: come soltanto attraverso un mondo si possa dire la verità di un altro. Allora per provare a dire di quell’incontro con il corpo sensibile del mio amico steso sul lettino, ho dovuto fare emergere anche i discorsi e i pensieri attraverso cui provavo a comprendere quanto stava accadendo. Ecco che così la realtà dei sensi e quella della mente si sono accostate, una all’altra: il registro delle sensazioni a quello dei pensieri con cui provavo a comprendere quanto vedevo. In questo senso, mi sembrava che ciò che vivevo potesse essere messo a disposizione di una conoscenza: credo che la poesia (e lo dico nell’eco di un verso di Fortini che amo moltissimo[iii]) possa offrire una possibilità di conoscenza, esattamente come la meditazione, il teatro, la filosofia, ecc.; ma non tanto perché trascrive un’esperienza biografica: più purché riesca a mostrare come precisamente accade che una vita si trascriva. La poesia è un metodo e la mostrazione di un metodo. Non è infatti un caso che si parli proprio qui di caverne e di arte rupestre. In queste pagine, provo a mostrare come la preistoria non sia un’epoca del passato, ma un presente: un certo stato della materia che chiamiamo vita. A questo stadio “pre-istorico”, possiamo accedere ogniqualvolta crolla il nostro automatico “istoriare” la vita con i discorsi logici e rassicuranti, che mettono tutto in ordine, entro un piano solo. Lì, di fronte a quei momenti di emozione e densità, emerge un mondo di resti indecifrabili, di forze anonime, millenarie: vediamo quanto siamo fatti di un tempo immenso, di fronte al quale non abbiamo alcun sapere.
A.P. – Veniamo alla parte più sorprendente del libro, che è questo viaggio immaginario via nave. Innanzitutto sarebbe interessante capire, oltre ai personaggi storici indicati nel testo, come le tue letture pregresse abbiano ispirato questo gruppo di poesie. Credo sia importante che un libro di poesia contenga deviazioni simili, anzi, per certi versi lo trovo rinfrancante, vuol dire che al di là dell’iper-soggettivismo che impera sulle produzioni poetiche vi è ancora spazio per quelle che tu definisci ‘bugie della mente’ (p. 57). Come è accaduto, che arrivato a questo punto del libro, tu abbia pensato di dover spingere il soggetto al di là, farne la pedina impazzita di un viaggio che successivamente interesserà tutti gli orizzonti spaziali? Qui siamo nell’orizzontalità, immagino questo viaggio come una linea retta inarrestabile, anche il verso vuole essere letto con una certa fretta, un impeto che a volte mi ha ricordato certa poesia della prima avanguardia europea, mentre a volte mi pare che tu miri a fare di queste pagine un monologo drammaturgico: «La terra si spacca; la terra/ è un barile d’oro» (p. 73).
T.D.D. – Sì, Alessio, davvero questa sezione ha sorpreso anche me. Non saprei dire esattamente come sia venuta fuori. Ha preso corpo lentamente, definendosi con sempre maggiore precisione a partire da un’estate. All’inizio è stato il gioco della scrittura a muovermi: ho iniziato a trasporre alcuni frammenti del diario di Colombo entro il corpo dei miei versi e ho visto cosa succedeva. Mi sembrava che potessero funzionare: che provocassero un effetto, un potenziale di energia da gestire. Poi ho capito che molti testi che avevo scritto precedentemente potevano essere lievemente modificati per rientrare all’interno di questa sezione. È come se un tentativo un po’ casuale avesse creato un effetto magnetico che ha attratto retrospettivamente molti altri materiali e li ha orientati. Lavorandoci sopra (e ci ho lavorato a lungo), a poco a poco, mi sono accorto che la sezione è di fatto una mise en abîme dell’intero libro e a causa di questo effetto di imbottigliamento telescopico mi sono anche reso conto meglio del libro che stavo costruendo. Di sicuro, hanno giocato un ruolo importante alcune suggestioni letterarie e cinematografiche. Penso immediatamente al Fitzcarraldo di Herzog e alla poesia e alla prosa di Àlvaro Mutis (il personaggio di Maqroll il Gabbiere ha avuto un grande effetto su di me), ma anche a quella di William Carlos Williams (che dedica ai viaggi di Colombo un capitolo del suo In the American grain) e di Ezra Pound, con le sue poesie per interposta persona (forse è merito suo il tono un po’ avanguardistico che hai sentito). Se penso alla letteratura italiana, devo dire che mentre lavoravo alla sequenza avevo in mente le costruzioni narrative di Giorgio Caproni e il lavoro che Maurizio Cucchi ha fatto sulla narrazione per frammenti, in un libro come La luce del distacco o L’ultimo viaggio di Glenn. Certamente, come hai visto bene, è riemersa anche, per vie sotterranee, l’esperienza di scrittura teatrale che ho coltivato un decennio fa con la compagnia metà siciliana metà milanese Esiba Teatro. Scrivere poesie, per me, non è mai un’esperienza piacevole; eppure nella composizione di questa sezione mi sono anche divertito: ho cercato una leggerezza nuova e ho provato a fuoriuscire da un immaginario che sentivo irrespirabile. A muovermi verso questo stato d’animo, è stato il bisogno di fuggire dal dolore della sezione precedente: avevo voglia di liberarmi di me, di farmi fuori, di andare via; e così di liberare la mia poesia, portarla al di là dal ghetto di un certo “realismo esistenziale disforico”, che attanaglia tanta poesia italiana (compresa la mia). Questa libertà di disegno si è poi riversata su tutta la struttura del libro portandola all’estremo, al cosmico. Il viaggio di Colombo, nella sua emblematicità, rappresenta il paradigma dell’Occidente. Con il suo progetto di «buscar el levante por el poniente», Colombo è al contempo un uomo antico e un uomo moderno: animato da una fede senza dubbi, che saremmo tentati di chiamare “medievale”, ha nondimeno fatto tramontare un mondo e trasformato il futuro dell’umanità, aprendo le porte dell’epoca moderna, atlantica, e dando inizio involontariamente ad un genocidio fra i più terribili della storia. In fondo – e questa è una tesi della sezione – il suo viaggio non è così diverso dalla danza intorno al fuoco degli abitanti di Guanahanì, l’antico nome di San Salvador: ognuno di loro non cercava che di dar forma ai propri fantasmi con gli strumenti e i riti che la propria storia gli metteva a disposizione. L’uomo non cerca che se stesso, ma crede di cercare Dio e l’oro.
A.P. – In alcuni punti del testo è la stessa voce narrante a svelare la macchinazione narrativa: lo fai quasi ogni volta che nomini «questa umana mente. Debole. Precaria» (p.70), «la mente che di sé/ sempre asseta» (p. 95), oppure quando parli di «un tragitto/ in una mente senza fine mai» (p. 88); ma ancora più significante è questo passaggio, in cui l’Io si rivolge a un altro (probabilmente lo stesso nominato in precedenza): «Raggiungimi. Se io non posso arrivare a te/ che tu mi sopravvenga, che tu almeno/ mi soprammonti dall’alta/ riva del mondo» (p. 80). Adesso, sembri dire, una doppia finzione (la poesia e una realtà ulteriore, per adesso il viaggio, che si espande dall’organismo del libro, biforcandolo) può colmare quei limiti che finora sembravano invalicabili, cioè la distanza e il silenzio dell’altro.
T.D.D. – È un’interpretazione che mi piace molto, Alessio: l’idea della “doppia finzione” che si ritorce su stessa, annullandosi. Descrive un movimento su se stesso, un dinamismo senza movimento locale, ma non immobile, in cui ritrovo ciò che mi sembra essere Verso le stelle glaciali. Il viaggio che ho provato a tracciare è proprio una visione. La sua stessa implausibilità lo dichiara: nei versi si mischiano elementi della contemporaneità a ricostruzioni storiche, stralci biografici a veri e proprio prestiti dalle parole del diario di Colombo (che a sua volta – giova ricordarlo – è la traduzione ricostruita di un originale perduto). Alla fine di 1492 il viaggio approda in un continente nuovo: le Indie di un immaginario rinnovato. Questa terra nuova è quella che si invoca lungo il tragitto; ma come si vede subito, non appena il lettore approda all’ultima sezione, questa nuova terra non ha nulla di speciale: è anzi un ritorno alla città, un ritorno ad una geografia assai simile a quella della situazione di partenza, tranne che per lo sguardo con cui la si descrive. È come se dicessi che la realtà, per arrivare a farsi propriamente reale, debba passare attraverso una torsione o una “finzione” come dici tu. «Perché́ non era in luogo donde potesse/ scoprire il lume, io vidi un lume» (p. 87): la circolarità paradossale, tautologica, descritta da questi versi è al centro di tutto il libro e al centro di cosa penso sia l’esperienza artistica. C’è una riflessione di Jacques Derrida che mi viene in soccorso qui, tratta da una conferenza tenuta in Italia nel 2002[iv]. Il filosofo francese ci ricorda che quando diciamo “esperienza” non sempre intendiamo una cosa sola. Da un lato, infatti, diciamo “esperienza” quando qualcosa si presenta nel nostro presente: è qui, davanti ai nostri sensi, adesso. Dall’altro, la parola “esperienza” è legata al verbo latino experiri e al greco πειράω, che suonano anche nel tedesco Erfarhrung. L’etimologia ci racconta di qualcosa che “si tenta”, che “si azzarda”: di una “sfida” che si porta su di sé; qualcosa che passa dal lontano (l’inglese “far”) e dall’incertezza del pericolo. Di qui, dice Derrida, l’esperienza si manifesta non come «la relazione presente a ciò che è presente», ma come «viaggio non programmabile, il viaggio la cui cartografia non è disegnabile, un viaggio senza design, un viaggio senza disegno, senza scopo e senza orizzonte». Derrida ci ricorda allora che “fare esperienza”, in questo secondo senso, passa sempre attraverso l’eterogeneo, attraverso un non possibile, paradossale passaggio per un pericoloso e non pronosticabile “altro”. Il filosofo conclude con queste parole: «un viaggio che non fosse in vista di ciò che non è in vista, sarebbe ancora un viaggio? O soltanto turismo?». Ecco la poesia che voglio (e spero di aver mostrato) si oppone radicalmente a questo uso turistico del linguaggio. Cerca di portare il lettore più lontano possibile, di mettere in allerta le parole che usiamo tutti i giorni, spingerle verso «un tragitto/ in una mente senza fine mai»: verso un punto in cui il calamo si rovescia sulla carta e si naviga nel nero, attraverso il nero, annotando il nero di tutte le rotte. Se sono stato capace di far udire il «nitrito» che si annida nelle Nubi di Magellano e di far vedere, nella notte, la candelina che Colombo dice di aver visto la notte prima di toccare terra, quel tremore impossibile e debolissimo che si levava e oscillava all’orizzonte, allora sono riuscito a far passare il lettore attraverso un’esperienza poetica.
A.P. – «Possa io essere/ dappertutto fuori dagli anfratti evaso, la scossa/ tua voce seguendo» (p. 117). Alla fine troviamo questa totale espansione, come se tu avessi ridotto il soggetto a pura nominazione nelle cose, perché chi nomina e usa la parola si immerge in ognuna di esse. Compaiono qui alcuni riferimenti alla dimensione digitale («Sullo schermo poi. / Qualcuno che digita; qualcuno/ che dice io» (p. 103), che tu non sembri intendere come una separazione; al contrario, la sovrapposizione tra i vari livelli del reale è così labile che ripensando al libro emerge il dubbio che le navigazioni narrate, marittime o astronomiche, siano frutto di una riscrittura, un divertissement via Google Maps e Star Chart. Alla fine lo dici tu stesso in una delle Mappe: «L’artista allora non avrebbe che continuato il medesimo discorso che aveva trovato lì, cominciato dal suo predecessore in chissà quale epoca remota» (p. 130). Abbiamo vagato alla ricerca dello stesso ossessivo e indefinibile punto.
T.D.D – Dici bene. L’ultima sezione del libro è il tentativo di comporre un rito personale: è, più delle altre sezioni, una vera e proprio azione. Dapprima, finalmente approdati nella terra nuova, ci si riappropria delle percezioni: ci si lascia sgretolare e si trascrivono i nomi senza dare giudizio alcuno, ma solo per percepirli, per gustarli: «si muove. Evapora. Ride» (p. 106). Come se ogni forma e la forma stessa del libro non fossero che una nuvola di possibilità, movimento in evaporazione, prossimo a sparire nell’azzurro. È come un ritorno alla prima sezione, ma lisergico: se nella prima dominava il tono scultoreo di un destino inappellabile che coglieva le figure per la strada, nell’ultima tutto è invece sospeso e privatissimo. Ho cercato un’intimità che non sia oscena, una forma di rappresentazione della vita occidentale del 2020 che non fosse un’offesa ai morti della storia e a chi soffre oggi. Appare la tecnologia sì, ma anche i campi di aprile: non c’è contraddizione. I testi poi sono ricchi di autocitazioni, non solo dalle altre sezioni del libro, ma anche dai miei libri precedenti e persino dalla mia prima plaquette, Favole: come se questa ultima sezione fosse la ricapitolazione di tutto il mio percorso di scrittura (in questo senso è simile all’ultima sezione di Tua e di tutti, che aveva proprio il titolo La ricerca dell’esperienza). Ci sono infatti, alternate, poesie più recenti (come Arrivano al paese molti pianti di p. 99) e poesie che ho scritto invece molti anni fa e che non avevo mai pubblicato (come Lo hanno lasciato da qualche parte di p. 113 che è probabilmente la più antica del libro). La sezione però poi precipita verso un imbuto. Fra le varie stesure, qui ho addirittura pensato che ci sarebbe potuta essere una sorta di tana del Bianconiglio: sì, proprio quella in cui cadde Alice nel capolavoro di Lewis Carroll Alice in Wonderland. Volevo mostrare che l’uscita del libro fosse in realtà l’entrata in un mondo rinnovato. Alla fine ho rinunciato a questa idea un po’ bislacca perché ho capito che la vera buca del Bianconiglio, quella che abbiamo sempre a disposizione, non è che il pronome di prima persona “Io”. Lì c’è tutto: da lì parte il movimento definitivo. Se non si entra da lì, non si può uscire: ogni fuoriuscita, ogni terza persona, deve partire da questo affondo, da questa offerta radicale di ciò che si ha di più caro. Io, in questo libro, ho offerto il mio primo ricordo in assoluto: l’immagine dei miei genitori, in una Fiat Cinquecento color celeste, sotto la neve dell’85, mentre guardiamo la casa dove sarei cresciuto. La sequenza finale è una sorta di precipizio dentro la “O” di “Io”. Le ultime poesie sono disposte in maniera tale che il lettore si prepari a questo inabissamento: dopo aver guadagnato il tempo dell’attenzione (p. 109) e aver prestato attenzione alla compresenza delle molte realtà dentro la realtà (p. 110), ecco che viene incontro l’Io, al cui fondo non c’è che il Sé: «un cielo// fra gli occhi azzurri delle nuvole sguarnite» (p. 112). E dopo? Ecco, quanto dici tu mi sembra perfetto: dopo c’è la membrana labile fra mente e percezione, fra mente interna e sensi esterni. Tutto diviene accettato e offerto dentro un “Sì”. E il viaggio ricomincia, nelle prose: all’indietro.
[i] Fortini fa riferimento all’elaborazione di un discorso in versi tenuto durante una manifestazione a Firenze nel 1967, dal titolo Intervento alla manifestazione per la libertà del Vietnam. Si veda Fortini, Saggi ed epigrammi, Mondadori, Milano, p. 1793.
[ii] Sono gli ultimi due versi della poesia Il vuoto e le forme, dal libro omonimo del 1977.
[iii] Penso all’incipit folgorante «Esiste nella poesia una possibilità» e a quanto segue, in Poesia e errore, del 1959.
[iv] Jacques Derrida, Pensare al non vedere, in Pensare al non vedere. Scritti sulle arti del visibile 1979-2004, Jaca Book, Milano, 2016.
da Verso le stelle glaciali:
*
Un uomo entra
per ragioni oscure, oltre la porta scorrevole
di un piccolo supermercato. Oltre il getto
d’aria condizionata
e oltre tornelli, casse, scaffali; ha sparato
ad altri uomini fra le merci kosher. Mentre guardo
dal cellulare la notizia e sovrappensiero
ad alta voce la dico, tu stai
seduto; e non parli, immerso
nell’odore di urina e proteine animali. Guardi
oltre il letto, oltre il tavolo. E per tutta
l’estensione tu sei
dimensione di nulla spazio né tempo, quasi non più
cognizione, né memoria. Dentro la caverna, hanno trovato
residui organici, rocce e frammenti di corno
sbozzato in zagaglie. Per ragioni oscure
in fondo a tutto questo; sulle pareti di pietra
e con milioni di mani
è stato dipinto un uomo.
*
Mappa 4
Se si segue con scrupolo e con attenzione le mappe precedenti, ci si troverà in un’area la cui mappa è un insieme di segni che vanno individuati più con il tatto che con la vista. Nondimeno, fin da quando la grotta di Lascaux è stata scoperta (12 settembre 1940), una delle ipotesi degli interpreti, contestata in verità da alcuni altri, è stata quella di essere di fronte ad un linguaggio articolato. Gli animali dipinti da centinaia di mani sulle ruvide e difformi pareti della grotta rappresenterebbero tutt’altro che la proiezione istintiva delle paure o dei desideri delle comunità umane che lì si riunirono per migliaia di anni, ma una precisa disposizione significativa, qualcosa come una frase sola, che si articola in centinaia di anni e centinaia di metri di profondità; i cui verbi e i cui nomi non sono le stilizzate nostre lettere dell’alfabeto, ma i profili e le azioni che le potenze animali mettono in scena. L’artista allora non avrebbe che continuato il medesimo discorso che aveva trovato lì, cominciato dal suo predecessore in chissà quale epoca remota. Col tempo, ogni animale, legato opportunamente all’altro, porta impresso sulle pareti un messaggio che agli antichi interpreti risultava del tutto evidente. Dentro la grotta insomma, a discapito del buio più assoluto, è tutto chiaro: toccando gli spigoli umidi, rannicchiandosi fin dentro i più bassi cunicoli e avendo finalmente il viso e le dita a pochi millimetri dal muso di un bovino o di un cervide dipinto, proprio quando la lampada smette di mandare l’ultimo debole baluginio e si rimane da soli nel più profondo nero, tutta la storia umana torna leggibile. Chi arriva fino a qui, si dice possa raggiungere un luogo che gli studiosi chiamano La Mente. È un’area di solitudine e di inesorabile necessità; in essa si entra in contatto con ciò che precede nel tempo e supera nello spazio. Arrivati qui, la mappa smette di mostrare una direzione e mostra invece se stessa.
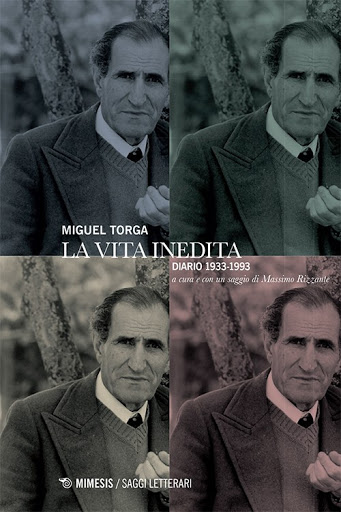 [Esce per Mimesis, “La vita inedita”, che presenta per la prima volta in Italia il Diario (1933-1993) di Miguel Torga, una delle più importanti figure della letteratura portoghese del XX secolo. Torga è poeta, romanziere, saggista e drammaturgo. L’edizione è a cura di Massimo Rizzante, di cui pubblichiamo il saggio introduttivo, seguito da alcuni estratti del diario. Di Torga NI si è già occupata, dedicandogli un volumetto: “L’universale è il locale, meno i muri” (collana Murene).]
[Esce per Mimesis, “La vita inedita”, che presenta per la prima volta in Italia il Diario (1933-1993) di Miguel Torga, una delle più importanti figure della letteratura portoghese del XX secolo. Torga è poeta, romanziere, saggista e drammaturgo. L’edizione è a cura di Massimo Rizzante, di cui pubblichiamo il saggio introduttivo, seguito da alcuni estratti del diario. Di Torga NI si è già occupata, dedicandogli un volumetto: “L’universale è il locale, meno i muri” (collana Murene).]

 Il libro di Bruno Vespa e la “mucca sacra” dal latte avvelenato
Il libro di Bruno Vespa e la “mucca sacra” dal latte avvelenato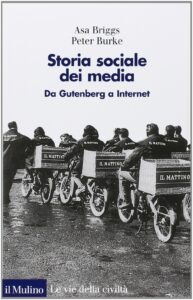 Negli ultimi decenni, gli studi sulla storia dell’editoria e della comunicazione hanno contribuito a complicare lo scenario, aiutandoci a comprendere come la fruizione degli scritti a stampa non debba essere necessariamente considerata come un fattore di emancipazione sociale, tanto nel passato quanto nel presente. Limitandoci all’analisi dello scenario europeo, siamo oggi in grado di osservare che la svolta tecnologica inaugurata da Gutenberg ebbe effetti discontinui e contradditori. La possibilità di riprodurre e diffondere in serie i testi contribuì, infatti, ad abbattere drasticamente i costi e coinvolgere una schiera di lettori molto più ampia. Ne conseguì un potenziamento del comune senso critico e una più intensa partecipazione ai dibattitti intorno a eventi sensazionali o a fenomeni di pubblico interesse, che in alcuni periodi si manifestò in maniera intermittente e in altri in maniera più costante (sul tema si veda il libro di Peter Burke e Asa Briggs, Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet, Il Mulino). Tuttavia, quella stessa capacità di penetrare in maniera ramificata il corpo sociale riuscì anche a stimolare nuove forme di adeguamento ai dettami delle autorità secolari o ecclesiastiche, dei potentati nobiliari, o degli interessi economici dei ceti dominanti. La stampa aveva quindi i suoi padroni e – seguendo le esigenze dei committenti o le logiche del profitto – riusciva anche a diventare una potente catalizzatrice di conformismo: in altre parole, suggeriva alle persone come comportarsi, cosa pensare, cosa comprare, di cosa fidarsi, di cosa aver paura (su questo versante, sono utili le considerazioni di Mario Infelise, I padroni dei libri, Laterza, e Sandro Landi, Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna, Il Mulino).
Negli ultimi decenni, gli studi sulla storia dell’editoria e della comunicazione hanno contribuito a complicare lo scenario, aiutandoci a comprendere come la fruizione degli scritti a stampa non debba essere necessariamente considerata come un fattore di emancipazione sociale, tanto nel passato quanto nel presente. Limitandoci all’analisi dello scenario europeo, siamo oggi in grado di osservare che la svolta tecnologica inaugurata da Gutenberg ebbe effetti discontinui e contradditori. La possibilità di riprodurre e diffondere in serie i testi contribuì, infatti, ad abbattere drasticamente i costi e coinvolgere una schiera di lettori molto più ampia. Ne conseguì un potenziamento del comune senso critico e una più intensa partecipazione ai dibattitti intorno a eventi sensazionali o a fenomeni di pubblico interesse, che in alcuni periodi si manifestò in maniera intermittente e in altri in maniera più costante (sul tema si veda il libro di Peter Burke e Asa Briggs, Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet, Il Mulino). Tuttavia, quella stessa capacità di penetrare in maniera ramificata il corpo sociale riuscì anche a stimolare nuove forme di adeguamento ai dettami delle autorità secolari o ecclesiastiche, dei potentati nobiliari, o degli interessi economici dei ceti dominanti. La stampa aveva quindi i suoi padroni e – seguendo le esigenze dei committenti o le logiche del profitto – riusciva anche a diventare una potente catalizzatrice di conformismo: in altre parole, suggeriva alle persone come comportarsi, cosa pensare, cosa comprare, di cosa fidarsi, di cosa aver paura (su questo versante, sono utili le considerazioni di Mario Infelise, I padroni dei libri, Laterza, e Sandro Landi, Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna, Il Mulino).








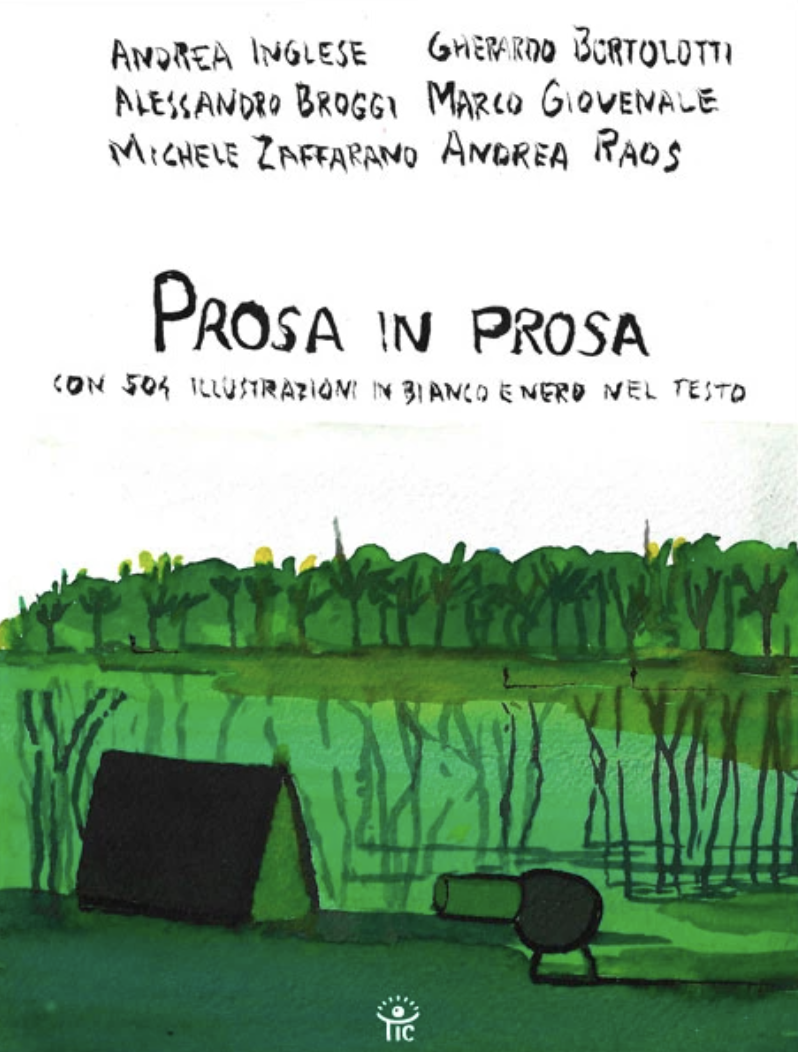


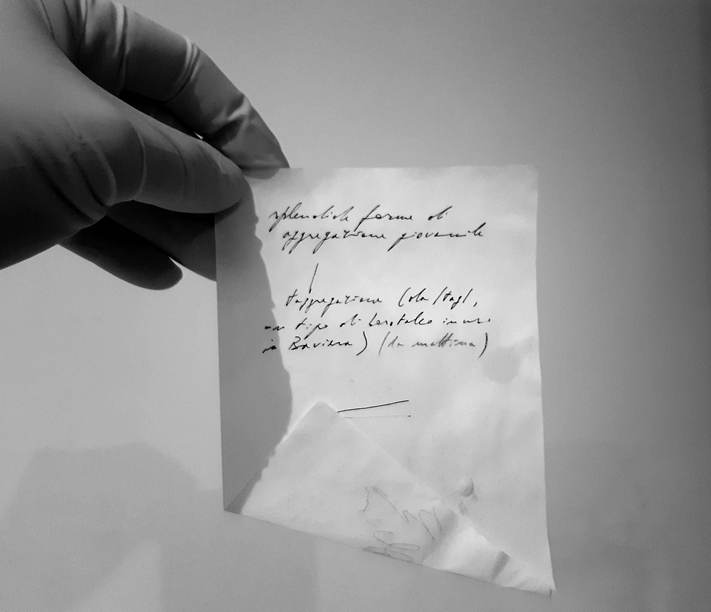

 C’è una scena dell’Amleto di Laforgue che mi viene sempre in mente quando si tratta di definire che cosa sia per me «poesia». Amleto si rivolge a Orazio, l’amico assoluto, e lo prega di precederlo, per dire in sua vece, entrando, quelle parole «che lo uccidono».
C’è una scena dell’Amleto di Laforgue che mi viene sempre in mente quando si tratta di definire che cosa sia per me «poesia». Amleto si rivolge a Orazio, l’amico assoluto, e lo prega di precederlo, per dire in sua vece, entrando, quelle parole «che lo uccidono».


 Fine del gioco
Fine del gioco


















