di Luigi Preziosi
Marzo 1116. Dal porto di Genova salpa una galea, carica di merci, comandata da Guglielmo Embriaco detto il Malo, appartenente ad uno dei casati più illustri della città (gli Embriaci), e circondato dalla fama di eroe della crociata da poco terminata: è anche grazie alla sua idea di smontare le navi della flotta genovese per trasformarle in macchine da assedio e torri d’assalto che Gerusalemme è caduta.
Dalla Terra Santa ha portato un vaso di smeraldo esagonale, in cui si dice che Cristo abbia mangiato l’agnello nell’ultima cena: qualcosa di molto simile al Graal, o forse proprio il Graal. Quindici anni prima, a Cesarea, un vecchio sapiente ebreo ha insinuato il dubbio che fosse un falso, asserendo che l’originale era stato trafugato: labili indizi lo darebbero rintracciabile in qualche località della Cornovaglia bretone. Dopo tanto tempo, ora Guglielmo vuole conoscere la verità. Per questo arma la Grifona, una galea di nuova concezione, e con più di 190 uomini fa rotta verso Gibilterra, puntando poi verso l’Atlantico, fino alla remota Bretagna francese, seguendo una rotta raramente prima battuta. Dopo un viaggio drammatico, ricco di avventure e di-savventure, di incontri, di agguati ed inseguimenti sul mare, di tempeste oceaniche di proporzioni mai viste dai marinai genovesi, arriverà alla meta, dove si confronterà con le memorie di antiche leggende, relative al regno di un tempo remoto di re Gradlon e e alla antica città sommersa di Ys.
Ma gli episodi più inquietanti avvengono sulla galea, dove, nelle notti di novilunio, quando le tenebre avvolgono la nave, si sgrana la lugubre sequenza delle efferate uccisioni di tre ufficiali, ai quali viene viene ogni volta estirpato il cuore dal petto. Il comandante è costretto allora ad improvvisarsi inquisitore, con l’aiuto di un giovane scrivano, Oberto da Noli: l’indagine non dimostrerà altro che l’impotenza del comandante ad arrestare gli omicidi, e la soluzione si paleserà con diverse modalità, mostrando quali inaspettate forme possa assumere l’affermarsi della giustizia tra gli uomini. In parallelo alla ricerca di Guglielmo si dipana la storia di Giannetta Centurione, figlia di un ricco mercante genovese, mandata in moglie per motivi di fusione di patrimoni familiari al rampollo di una delle famiglie più in vista della città. Odiata dalla matrigna, e riottosa all’idea di un matrimonio di convenienza con chi non ama, riesce a far fiorire in sé un senso di spiccata indipendenza, manifestato sia nello scegliere un amore diverso da quello a cui è destinata, sia nel coraggio che la sorregge nel compiere scelte decisive per la sua stessa esistenza.
Questa, in estrema sintesi, ed omettendo per evidenti motivi il finale, la storia raccontata da Giuseppe Conte in I senza cuore (Giunti, 2019), recente prova narrativa di un autore che ha percorso gli ultimi decenni della nostra letteratura cimentandosi innanzitutto con la poesia (si veda, a definirne l’accertato valore, l’Oscar Mondadori del 2015, giunto al culmine di una trentennale attività), ma capace di svariare con esiti altrettanto convincenti nella saggistica, nel teatro e nel romanzo. Nella prove narrative Conte applica con esito felice la propria disponibilità all’esplorazione di temi, trame ed anche soluzioni stilistiche diverse: se ne può misurare l’ampiezza anche solo confrontando il medioevo (non privo però di rimandi sottintesi alle penombre della nostra modernità) di I senza cuore con la bruciante contemporaneità del suo penultimo romanzo, Sesso e apocalisse ad Istanbul, uscito appena un anno fa, teso a rappresentare le angosce, che, pur radicate in un remoto passato, popolano ancora a pieno titolo i nostri giorni.
I senza cuore fa propri i topoi classici di più di un genere letterario. E’ con tutta evidenza un robusto romanzo storico, per la sua precisa collocazione temporale: af-fascina il senso di autenticità che percorre tutto il libro, derivante dall’accurata ricostruzione storica, e dall’altrettanto accurata descrizione del mondo marinaresco medievale (a fine libro è presente perfino un glossario dei termini utilizzati). Figura sto-ricamente accertata è poi Guglielmo il Malo, detto anche Guglielmo Testa di Martello, a cui Conte attribuisce una personalità perennemente oscillante tra carnale ferocia ed ingenua religiosità: ne testimonia le gesta Jacopo da Varagine nella Cronaca della città di Genova (Guglielmo poi, prima di diventare protagonista del romanzo di Conte, attraverserà rapidamente anche la Gerusalemme liberata). Ed è Guglielmo che, di ritorno dalla Crociata, porterà con sé il vaso di smeraldo, che, altro elemento di verità storica, è attualmente conservato nel Tesoro di San Lorenzo a Genova. Di lui, però, dal 1112 in avanti non si hanno più notizie nelle cronache dell’epoca, il che autorizza la virata verso quel grado di libertà superiore consentita in linea generale dal romanzo di avventura, senza che perciò solo ne debba scapitare la densità di significato etico della narrazione. Con ciò Conte supera un pregiudizio storico (ultimamente per fortuna un po’ attenuato) nei confronti del romanzo d’avventura, e rende allo stesso tempo omaggio ad alcuni classici della narrativa anglosassone: basti pensare a Melville, Conrad, Stevenson…
E l’avventura che sostanzia il romanzo è originata dall’ansia di conoscere la verità che ritorna dopo anni a tormentare Guglielmo, che trova occasione di manifestarsi anche durante l’infruttuosa inchiesta sugli omicidi dei suoi ufficiali. La declinazione (anche) poliziesca della trama, con tutto ciò che implica in tema di tensione verso la verità, può indurre ad accostare il protagonista al Guglielmo da Baskerville del Nome della rosa. Ma lo sforzo investigativo del Guglielmo di Eco tende all’affermazione della ragione sulle tenebre della superstizione: la conoscenza intuitiva empirica (la dimestichezza con l’uso del rasoio di Occam gli consente le semplificazioni necessarie allo scopo) è in grado di svelare i misteri del mondo che ci circonda. Guglielmo il Malo, pur respingendo le ipotesi di creature demoniache come autrici dei delitti, come invece sostiene il cappellano di bordo, vive invece un medioevo pieno, nel quale non si percepiscono ancora premonizioni del futuro umanesimo. La sua ricerca punta ad una verità metafisica: per gli uomini del suo tempo lo spirito pervade la materia ed il mondo non è tutto conoscibile.
Guglielmo non è l’unico a cimentarsi con la ricerca della verità. Il romanzo brulica di personaggi, di cui Conte tratteggia bene i tratti essenziali a mano a mano che a ciascuno tocca una parte nella complessa macchina narrativa: dagli ufficiali massacrati Primo Spinola, Lanfranco Piccamiglio e Astor Della Volta, ognuno con caratteristiche caratteriali ben definite, al gelido tesoriere Bernardo Malocello, al cappellano don Rubaldo Pelle, al mastro d’ascia Carnac il mancino, arruolato durante la traversata e diventato in breve braccio destro di Guglielmo, a padre Brennan, custode nella biblioteca del suo convento di un insieme indistinto di memorie storiche e leggende, e tanti altri. Ed una rinnovata riflessione su se stessi, un diverso riconsiderare il modo di rapportarsi con il mondo sommuove alcune coscienze durante la navi-gazione: in particolare il mastro d’ascia Pietrabruna, che, sbarcato a Lisbona, lascia i compagni ed il suo antico comandante per immergersi nel misticismo sufi, e lo scrivano Oberto da Noli, che cerca armonia ed equilibrio in Seneca e Virgilio, autori appassionatamente compulsati durante la traversata; anche Giannetta in fondo sperimenterà la tensione verso il rinnovamento di sé, al termine di un itinerario psicologico certo non consueto.
Ma la nostalgia della verità innerva una ragione più specifica, fondamento del viaggio della Grifona e del suo capitano. La ricerca di Guglielmo solo apparentemente è simile alle tante quêtes che affollano le narrazioni medioevali: ha, al contrario, una sua specifica originalità. Guglielmo non cerca, infatti, un oggetto miracoloso dall’incerta esistenza: lo possiede già, cerca invece la prova della sua autenticità. E’ dal possesso non dell’oggetto, ma della verità sull’oggetto, che potranno derivare gli effetti miracolosi che Guglielmo si aspetta, ed in cui crede. Ed allora, l’itinerario per questa ricerca non attraversa le selve in cui si erano aggirati Parsifal e Galaad, ma il mare, tant’è vero che è durante la lunga navigazione che gli uomini in ricerca a bordo della Grifona giungono a qualche forma di composizione delle inquietudini che li affliggono. Alla malia del mare, rappresentata con mano felice nella sua obiettiva naturalezza, nelle bonacce e nelle tempeste, Conte pare attribuire una sorta di funzione catartica, che supera la contingenza necessitata dall’economia della narrazione: se è ve-ro (Keats insegna) che la verità si rivela nella bellezza, è proprio nello smisurato splendore del mare che i naviganti della Grifona (e noi con loro) la possono cercare.

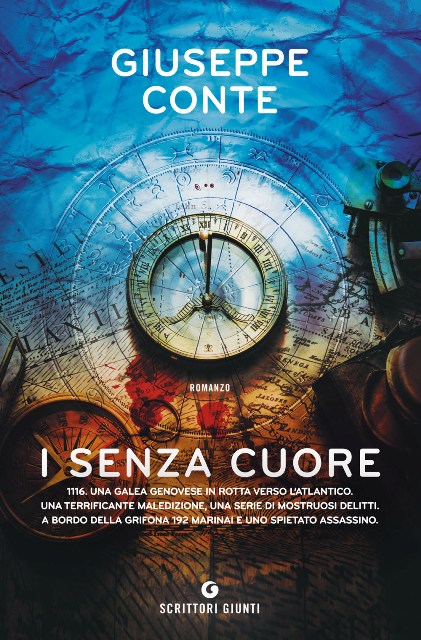

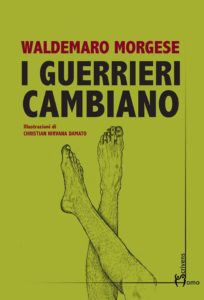
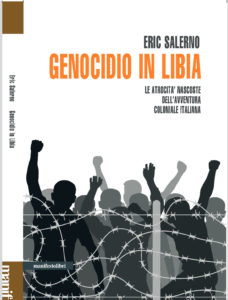

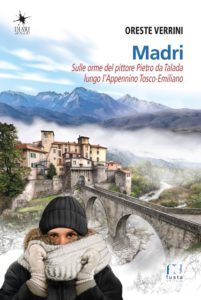
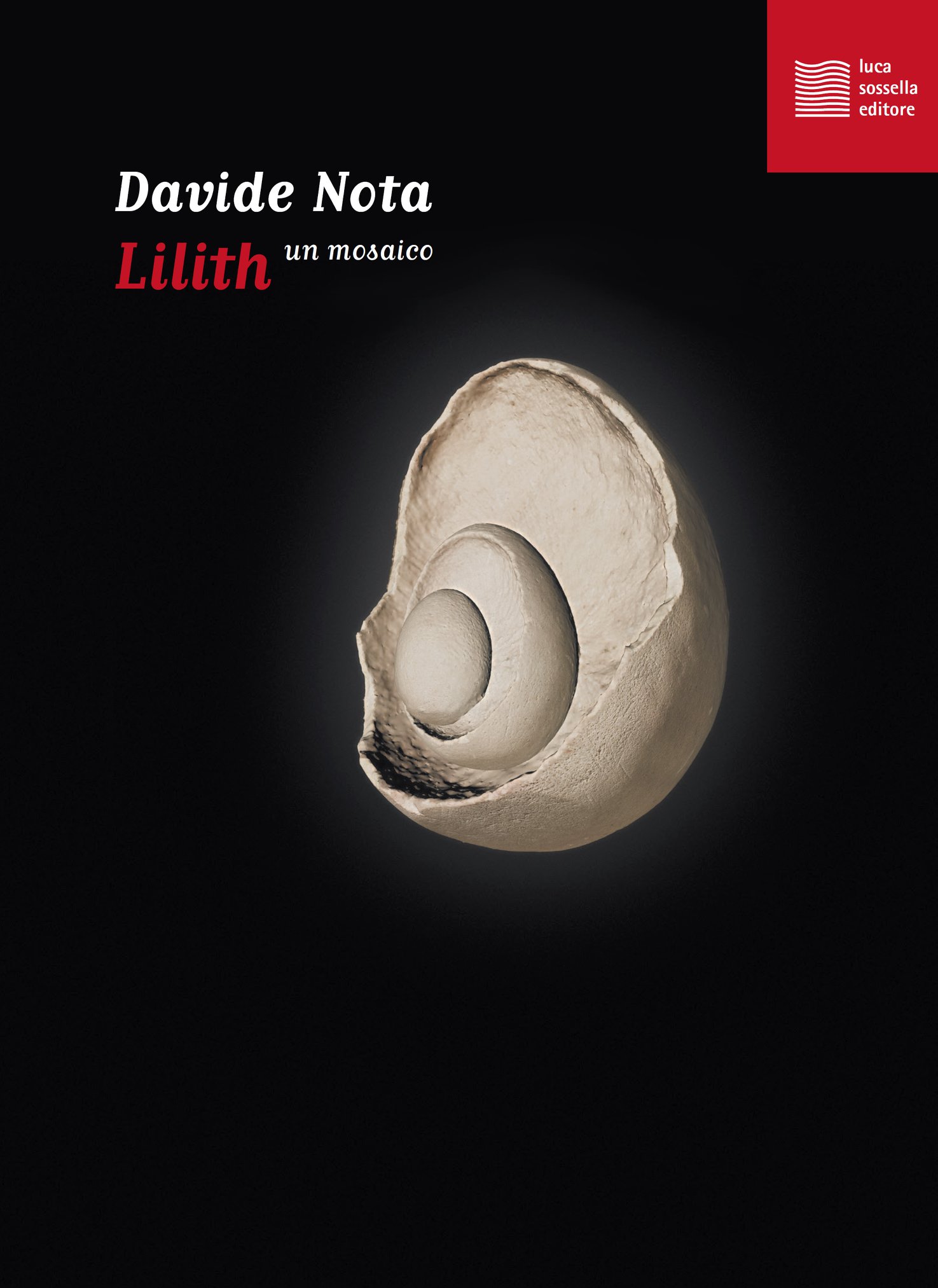
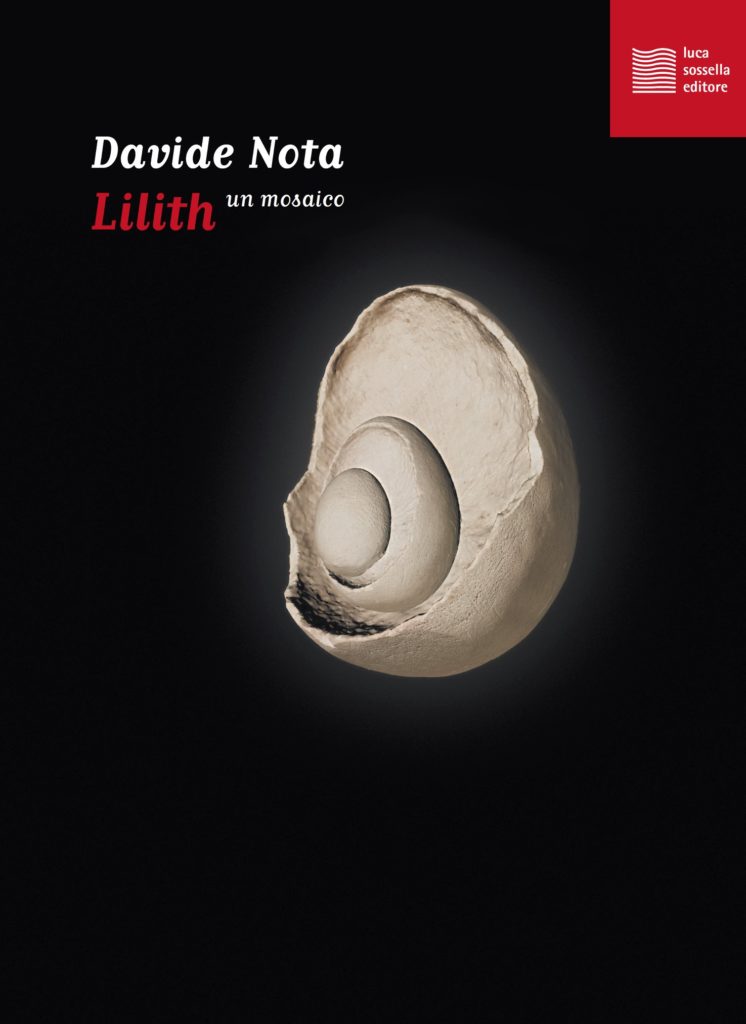



 [Questo pezzo è uscito sulla rivista “Qui Libri” di settembre. Mi è stato chiesto di scegliere una parola che testimoniasse in qualche modo, stilistico ma anche tematico, per la scrittura del romanzo Parigi è un desiderio. In coda al pezzo, un breve estratto del romanzo.]
[Questo pezzo è uscito sulla rivista “Qui Libri” di settembre. Mi è stato chiesto di scegliere una parola che testimoniasse in qualche modo, stilistico ma anche tematico, per la scrittura del romanzo Parigi è un desiderio. In coda al pezzo, un breve estratto del romanzo.]
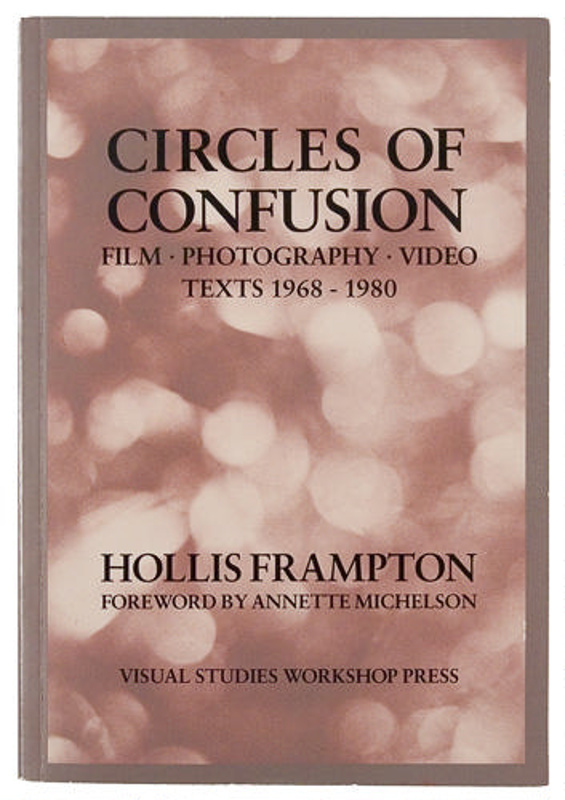












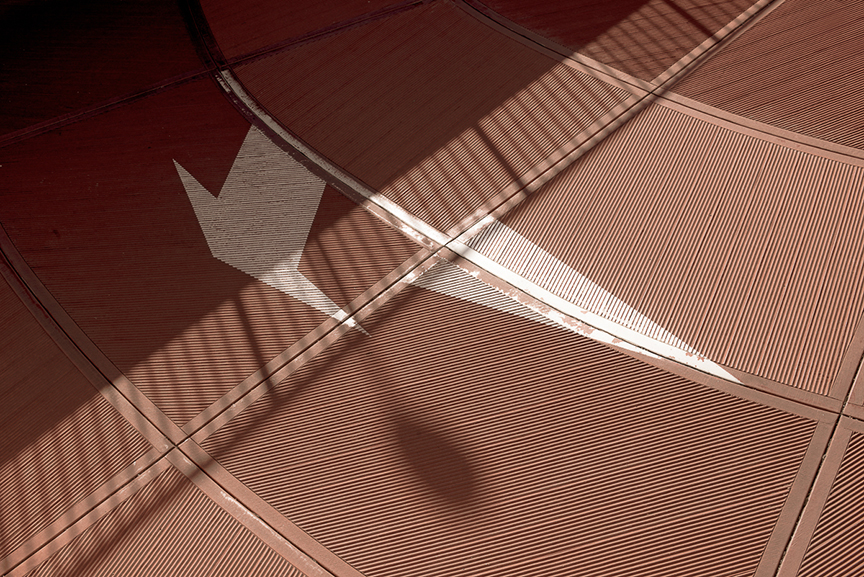

 di
di Dalla archeologia del pop sixty di Son Of a Lovin’ Man dei Buchanan Brothers alle rimasticature r&b di Mitch Ryder & The Detroit Wheels con Jenny Take A Ride. Siamo su un ottovolante sparato a tutta velocità nella musica anni Sessanta. La giostra è condotta dai parrucconi delle case discografiche impegnati ad estrarre i soldi dalle tasche della gioventù americana ancora lontana dalla ribellione, grazie a una musica-merce, senza velleità artistiche o sociali. Il gioco sui registri alto/basso della cultura ci fa salire altissimi con un Neil Diamond, che per rubare la battuta a uno dei personaggi del film, Sam Wanamaker/Nicholas Hammond: «cattura la zeitgeist dei tempi», e poi si scende in basso con una Hey Little Girl di Dee Clark che avrebbe giustificato una carneficina da parte del buon Bo Diddley. Come spiegare il guazzabuglio musicale messo in piedi dal Quentinone? Rileggiamo in chiave 45 giri il mito di Superman di Umberto Eco? Lo consideriamo solamente del pulp musicale? Non serve: stappiamoci una Old Chattanooga Beer sul divano con Cliff/Pitt, usando un citazionismo appropriato a Tarantino: «Da quel gran paraculo che è», come ha scritto Luca Giannelli su Intellettuale dissidente. La musica comunque gira. Dov’è che toppa il film, allora? Nel non avere utilizzato la stessa precisione per dipingere il quadro sociale.
Dalla archeologia del pop sixty di Son Of a Lovin’ Man dei Buchanan Brothers alle rimasticature r&b di Mitch Ryder & The Detroit Wheels con Jenny Take A Ride. Siamo su un ottovolante sparato a tutta velocità nella musica anni Sessanta. La giostra è condotta dai parrucconi delle case discografiche impegnati ad estrarre i soldi dalle tasche della gioventù americana ancora lontana dalla ribellione, grazie a una musica-merce, senza velleità artistiche o sociali. Il gioco sui registri alto/basso della cultura ci fa salire altissimi con un Neil Diamond, che per rubare la battuta a uno dei personaggi del film, Sam Wanamaker/Nicholas Hammond: «cattura la zeitgeist dei tempi», e poi si scende in basso con una Hey Little Girl di Dee Clark che avrebbe giustificato una carneficina da parte del buon Bo Diddley. Come spiegare il guazzabuglio musicale messo in piedi dal Quentinone? Rileggiamo in chiave 45 giri il mito di Superman di Umberto Eco? Lo consideriamo solamente del pulp musicale? Non serve: stappiamoci una Old Chattanooga Beer sul divano con Cliff/Pitt, usando un citazionismo appropriato a Tarantino: «Da quel gran paraculo che è», come ha scritto Luca Giannelli su Intellettuale dissidente. La musica comunque gira. Dov’è che toppa il film, allora? Nel non avere utilizzato la stessa precisione per dipingere il quadro sociale. Vorrei iniziare questa conversazione su la bambina (il verri, 2018, collana diretta da Milli Graffi), ritratto autobiografico di un’infanzia vissuta tra due famiglie, quella d’origine e quella adottiva, negli anni Cinquanta, soffermandomi su quella che a me sembra una questione centrale: lo sviluppo dell’identità femminile. Sia la protagonista che gli altri personaggi in primo piano sono donne. In questo senso si può parlare di un’identità femminile fluida e multiforme che dalla protagonista fluisce verso gli altri personaggi?
Vorrei iniziare questa conversazione su la bambina (il verri, 2018, collana diretta da Milli Graffi), ritratto autobiografico di un’infanzia vissuta tra due famiglie, quella d’origine e quella adottiva, negli anni Cinquanta, soffermandomi su quella che a me sembra una questione centrale: lo sviluppo dell’identità femminile. Sia la protagonista che gli altri personaggi in primo piano sono donne. In questo senso si può parlare di un’identità femminile fluida e multiforme che dalla protagonista fluisce verso gli altri personaggi? La lingua della poesia è per Landolfi lo spazio musicale della confessione, dell’interrogazione di sé, dell’affabulazione interiore. Una sorta di palcoscenico dell’anima. Scandaglio nel segreto di un’intimità confrontata costantemente con l’azzardo del vivere, con la pena del vivere. Esplorazione di sé affidata al suono di una parola che conosce bene l’artificio e il gioco delle maschere, e tuttavia nel suo farsi verso e ritmo, cioè tempo e insieme visione, allestisce un teatro che è rito di difesa dal nulla incombente, dal nero orlo che circonda la parola stessa.
La lingua della poesia è per Landolfi lo spazio musicale della confessione, dell’interrogazione di sé, dell’affabulazione interiore. Una sorta di palcoscenico dell’anima. Scandaglio nel segreto di un’intimità confrontata costantemente con l’azzardo del vivere, con la pena del vivere. Esplorazione di sé affidata al suono di una parola che conosce bene l’artificio e il gioco delle maschere, e tuttavia nel suo farsi verso e ritmo, cioè tempo e insieme visione, allestisce un teatro che è rito di difesa dal nulla incombente, dal nero orlo che circonda la parola stessa. 

