teoria di che cosa
(estratti, 2015 – in fieri)
[ da: ai bordi della blatta ]
e adesso e adesso perché impelle
ripetere il mai detto, reintentarsi del problema della polvere
inesplosa delle spore, la casa cosa essendo scarsi tratti
fatti in terra con il gesso, nemmeno, fratti in testa
col discorso, mettiamo // che in questo sia possibile disporre
parola «blatta» sotto un’altra, «radiatore» (va pensato
anche un soggetto percipiente): tutto e niente / conta infatti
averla vista, ma per entro quale e quanta imprevisione (partizione)
le incapaci successive passeranno
frasi o meno di strappare quella e moto
molto moto alla parola «tanatosi»
*
primo, è l’iguanodonte, secondo le rigonfie
meduse fra i pilastri
della circonvallazione – oggetti
per indurre allora ancóra // quattro le domande
da rivolgere alla blatta, per cominciare, alla necro-
mimèsi, se sia o meno cioè possibile descriverli,
perché e dove, e finalmente
da chi, se non da quello stesso
altro sé che adesso espone
un suo progetto voce roca, fronte contro
radiatore, di dizionario in cui il sintagma
storia umana sia previsto / tanto fra i sinonimi
della flessione «perpetrarsi»
quanto fra quelli del lemma «estinzione»
*
il cui anagramma è «ostinata», si attaglia
morta non è morta
al fatto che vedere sia a suo modo un modo della
predazione e che nel buio, della bocca da cui queste,
delle altre anche se aperte, stia taciuto un odassismo,
o detto meglio peggio: preparazione di una zanna.
VARIANTE: al fatto che a vedere siano gli occhi, non siano
gli occhi propriamente; ESEMPIO (più citazione): pensiamo
ad un punto di attacco, di vista
tecnicamente possibile, come in “Testa elaborata secondo
il metodo del Trasferente” (nel Manoscritto di Dresda,
folio 91r), e tuttavia impossibile,
umanamente («a meno che Dürer non tenga al di sopra
dei suoi occhi una testa mozzata»); PREMESSA: si attaglia
al bisturi di Christopher Tipping, Delaware, Pennsylvania,
donde i sette che sappiamo
in cui poi blatta ancóra vivere,
giorni o meno e se-
nza quella
*
dal diario di qualcuno, giorno il 13 novembre,
lo lego mentre lo leggo, anno il 70 d.N., che vale
«dopo Nagasaki»: la finestra è un rettangolo sopra
il radiatore e dentro non
si danno àceri – disàmare – Gerione – lo stormo
nero urtato dalla cosa che da dietro gli occhi guarda
se diventa o non diventa una murena
di storni nel cielo – sotto, leggevo, c’è la blatta che manca,
ha lo stesso colore dell’inchiostro che impedisce
l’impedimento qui nell’uso che già è il proprio
analogo in pragmatica, distribuito dalle frasi, giorno il 12
settembre, lungo il bordo intitolato “del sostare”, 1),
per minuti fronte all’àcero, 2) di accettarne il “come se”
del non silenzio, 3) poi di scegliere se dirne
e dirne in termini di 4): «urlìo» o «cavitazione».
questo concerne la domanda, in cui la blatta non si dà
che cancellandosi. e la risposta, in cui chiunque
qualunque riguarda, così come l’inverso.
[ da: 35 argomenti per la stesura di 10 tesi sulla blatta ]
5.
Se prendiamo la definizione
aristotelica
di blatta, c’è un nome di soggetto
(polites)
che è definito da un prendere parte
(metexis)
a un modo dell’agire
(l’archein)
e al patire che a quello corrisponde
(l’archesthai).
Se esiste un proprio della blatta, risiede
in questa relazione
che non è una relazione
tra soggetti ma che è
una relazione tra due termini
contraddittori
grazie alla quale
si definisce un soggetto.
6.
Il proprio della blatta è l’esistenza
di un soggetto definito
dalla sua partecipazione a dei contrari.
La blatta infatti un tipo
paradossale di azione: essa ci parla
di un essere che a un tempo
è l’agente di un’azione
e la materia su cui tale
azione si esercita.
7.
In altre parole, l’opposizione di praxis
e poiesis
non risolve per nulla il paradosso
della definizione della blatta.
14.
O nell’Iliade quando
Polidamante si lamenta del fatto
che suo fratello Ettore non tenga
in conto il suo parere: «con te», dice,
«non bisogna, chi è blatta, parlare».
Blatta infatti non designa
una categoria
sociale inferiore: fa parte della blatta
colui che non rientra
nei conti, colui che non ha
parola da fare
intendere. Fa parte della blatta
colui che parla quando
non deve parlare,
chi prende parte a ciò
di cui non ha parte.
18.
L’essere divenuta della blatta
rimanda il suo concetto a ciò che essa
non racchiude. La blatta si specifica
in relazione a ciò per cui si separa
da ciò a partire da cui
è divenuta; la sua legge
di movimento è la sua
propria legge formale.
19.
La blatta è dunque l’esistenza
supplementare
che inscrive nel visibile il conteggio di coloro
che non sono contati
o la parte di chi è senza
parte, l’esistenza che inscrive
supplementare
l’uguaglianza degli esseri parlanti
senza la quale la stessa
ineguaglianza è impensabile.
20.
Ciò che la blatta identifica col tutto
della comunità
è una parte quindi vuota, è una parte
sovrannumeraria,
che separa la comunità dalla somma
delle parti del corpo
sociale. Questa
separazione primaria
fonda la blatta come azione
dei soggetti che eccedono
il conteggio delle parti
della società.
21.
Il cuore di tutta la questione
blattoidea
risiede dunque nella
interpretazione
di questo vuoto e di questo
soprannumero.
26.
Esistono due modi di contare le parti
della comunità: o si contano soltanto
le parti reali, i gruppi
effettivi, definiti dalle differenze
di nascita, dalle funzioni,
dai luoghi, dagli interessi
che costituiscono il corpo
sociale escludendo
supplementi, o invece si conta
in più
una parte dei senza
parte. Chiameremo
il primo modo polizia,
blatta il secondo.
28.
L’essenza della blatta, si capisce,
è la manifestazione del dissenso
come manifestazione
di uno scarto del sensibile rispetto
a se stesso,
che fa vedere ciò che prima
non aveva ragione di essere
visto, dentro un mondo
mette un mondo
diverso.
29.
La polizia ne dice: non c’è niente
da vedere, ne dice: lo spazio
della circolazione
non è nient’altro che lo spazio
della circolazione.
La blatta consiste
nel trasformare questo spazio
della circolazione in quello della
manifestazione di un soggetto,
nel riconfigurare
lo spazio e quel che c’è,
all’interno di esso,
da fare, vedere, nominare.
30.
D’altra parte, a guardare la realtà,
ovvero ciò che è diventata, si è resa
insopportabile l’essenza
affermativa della blatta, per essa inevitabile.
La blatta deve volgersi contro
ciò che costituisce il suo proprio
concetto, così diventando
incerta fin nella
sua più intima fibra.
31.
Una difficoltà pratica consiste nel sapere
qual è il segno che permette
di riconoscere il segno, ovvero
come ci si assicura che la blatta
che vi sta di fronte e non emette
suoni con la bocca
stia articolando un discorso
invece di esprimere soltanto
un certo stato,
di morte o di magari
tanatosi.
33.
Sembra certo a priori che qualsiasi
definizione si possa
dare della blatta e che qualsiasi
definizione si possa
dare della blatta, sia sempre un malinteso
supporre che nella
formulazione si esprima ciò che
si vuol dire realmente. Eppure
la tendenza, l’urto, indicano qualcosa.
36.
La blatta, essendo costruzione di un mondo
paradossale
che mette insieme mondi
separati, non ha dunque luogo proprio
né soggetti naturali (non è, il soggetto
blattoideo, un gruppo di interessi, non è
un gruppo di idee. Il soggetto
blattoideo è l’operatore
di un dispositivo peculiare
di soggettivazione del dissenso
attraverso cui c’è nel mondo
la blatta)
37.
Lo ripeto: l’essenza della blatta risiede
nei modi di soggettivazione
dissensuale
che manifestano la differenza
della blatta rispetto
a se stessa.
(Non consentite: il consenso
è la riduzione della blatta
a polizia, è la fine della blatta,
il ritorno allo stato
di cose normale. Lo stato
di cose normale
è quello in cui non si dà blatta).
38.
È possibile comunque definire un legame
positivo
tra l’esistenza senza proprietà
di un modo del discorso
e la moltiplicazione senza legge
del molteplice. Ciò presuppone una certa
idea dell’anarchia
blattoidea che riassumiamo come segue:
la blatta è quel tipo di discorso che disfa
le partizioni tra reale
e finzionale, tra la prosa
e la poesia, o detto ancóra
meglio: tra il proprio
e l’improprio.
39.
Abbiamo quindi a che fare con una
figura dell’alterità
più vile ed insieme più pura: quel
molteplice senza
nome che in latino
si chiama proles e si chiama
proletarius e si chiama
in età moderna col termine
omonimo di blatta, che non è il nome
di una categoria sociale ma
quello di un molteplice
singolare, che analizza l’essere-
insieme immettendo
distanza nei corpi produttivi
e riproduttivi
rispetto a se stessi.
42.
La blatta allora è questa
corporeità
indecisa che immette disordine
tra i corpi, che crea un ambiente
in cui si espone il disordine che ogni
separa, corpo da se stesso.
[ da: esercitazioni per l’innesco della blatta ]
1.
se un occhio colpisce la blatta
la blatta manca oppure
la blatta c’è ma è entrata
in tanatosi
ho scritto «un occhio» l’articolo
ne comporta quindi un altro
lo porta in bocca una cernia che attraversa
la casa nel punto l’atlante
in cui s’incrocia il meridiano quindicesimo
col parallelo 35
(cos’è vedere)
vedere è dunque vedere
la polvere che sotto il radiatore
le mattonelle
in uno col tentacolo che sfiora nel nero
un occipite poi splenio
senza urticare è importante
senza urticarli più
2.
se un occhio colpisce la blatta
la blatta manca oppure
la blatta c’è ma è stata
disinnescata
diversamente
se un occhio colpisce il radiatore
e l’altro colpisce
la sabbia in sospensione intorno al gomito
c h e s t a t o c c a n d o i l f o n d a l e
c h e s t a t o c c a n d o i l f o n d a l e
c h e s t a t o c c a n d o i l f o n d a l e
c h e s t a t o c c a n d o i l f o n d a l e
allora si dà blatta oppure
la blatta è stata innescata
3.
se coniughiamo ovvero usiamo l’infinito
abitare (frequentativo, si noti, di «habere»)
dove tutto è stato preso ad altri
se coniughiamo l’infinito abitare
p. es. all’iguanodonte, p. es. alle rigonfie
meduse fra i pilastri
della circonvallazione
la blatta c’è ma è quella di Tipping
decapitata
la blatta manca mancandole
il possibile – è possibile
che sia invece un’invenzione
(la blatta)
continua, del presente
*
[Riguardo teoria di che cosa di Fabio Teti, di Niccolò Furri]
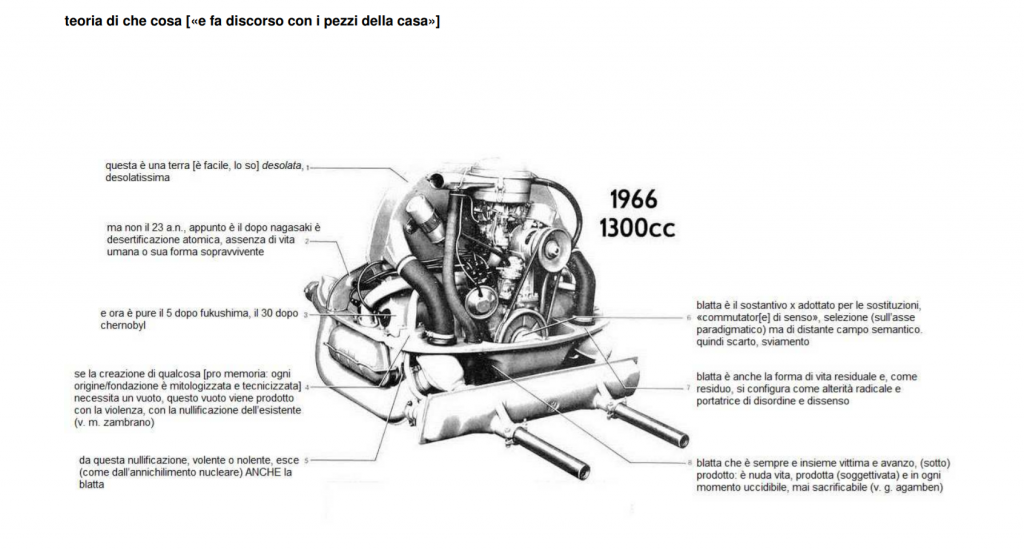
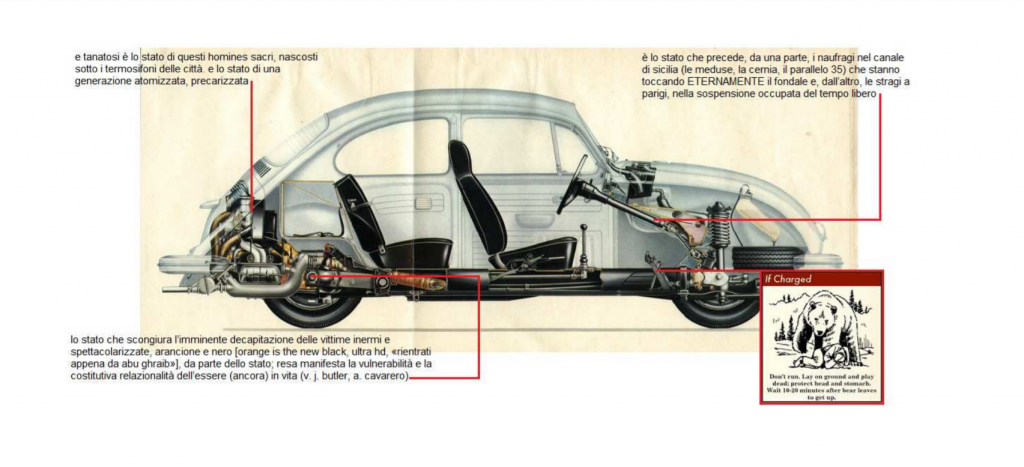
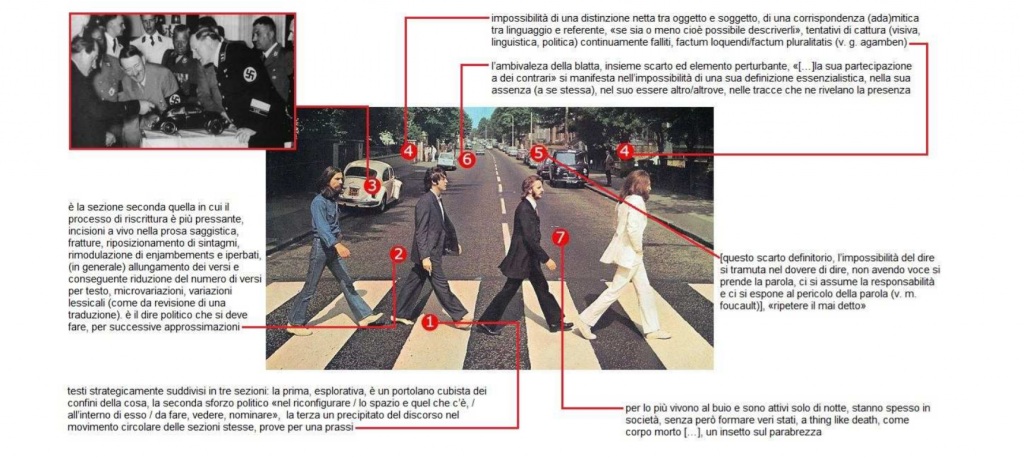
*
Variabile vs. Variazione
Note su Teoria di che cosa di Fabio Teti
di Alessandro De Francesco
In questa occasione di lettura generata dal laboratorio Prove di ascolto mi interesso a due scritture della stessa generazione: quelle di Daniele Bellomi e di Fabio Teti, che mi sembrano tra l’altro accomunate da un elemento formale non altrettanto visibile nelle scritture di ricerca italiane anche di una mezza generazione precedente: l’attenzione per la metricità versificatoria. Se la questione del ritmo è sempre stata al centro del discorso poetologico degli ultimi decenni, su scala internazionale, un approccio metrico del verso è invece stato principalmente l’appannaggio, negli ultimi anni, di scritture piú tradizionali, per lo meno in Italia. Bellomi e Teti operano, nei modi che sono loro propri, una riattivazione del gesto metrico all’interno di un approccio per cosí dire sperimentale. Essendo due tra gli autori piú significativi della nuova generazione italiana, è un fenomeno da prendere sul serio. Inoltre, la lingua italiana si presta a una ritmicità metrica subito fortemente ondulante, per non dire musicale, che in questi versi di Teti, in particolare, dato il tema, produce un evidente effetto ironico.
Tale effetto è acuito dalla semantica scientifico-filosofica, che prevale sugli altri registri per accerchiare il suo feticcio concettuale, sociale, biologico: la blatta. Benché il testo ne dia non poche definizioni, in particolare politico-sociali, assimilando la blatta alla classe proletaria, che però non è qui “il nome / di una categoria sociale ma / quello di un molteplice / singolare”, è inevitabile chiedersi innanzitutto quale sia il ruolo della blatta in questi testi, e perché questo animale sia stato scelto al posto di altri. Se l’andamento della serie di testi fa pensare, sin dal titolo della seconda sezione (35 argomenti per la stesura di 10 tesi sulla blatta), alle Tesi su Feuerbach di Marx e, nella sua struttura descrittiva, al Tractatus di Wittgenstein e quindi anche all’Etica di Spinoza, la figura della blatta ci rinvia inevitabilmente a Gregor Samsa. Con l’insetto kafkiano, mi sembra, la blatta di Teti ha in comune un aspetto centrale: sono entrambi variabili, nel senso algebrico. Non già simboli o allegorie, ma piuttosto variabili riempite di volta in volta dal loro ruolo sociale, politico, ed anche grammaticale, come indicano bene i quattro testi introduttivi, Ai bordi della blatta. Variabili le cui funzioni sono quelle dell’epoca storica, dal preistorico “iguanodonte” al Mar Mediterraneo, tra commerci, guerre e immigrazioni: queste le coordinate “in cui s’incrocia il meridiano quindicesimo / col parallelo 35”. Variabili quindi tanto vuote – in quanto variabili, in quanto vuoti possibili, pre-eventi – quanto piene, anzi pienissime, e tale contrasto, oltre a renderle figure certamente metafisiche, le rende anche e soprattutto figure ironiche: “Il cuore di tutta la questione / blattoidea / risiede dunque nella / interpretazione / di questo vuoto e di questo / soprannumero.”
L’ironia, quando si indirizza alla moltitudine (di blatte o di uomini, giacché la blatta è variabile per ogni moltitudine, sincronica e diacronica) e alla storia, non può che essere triste. Ecco, a mio avviso, la ragione sostanziale della scelta della blatta in questo contesto. L’essere piú basso e triste a cui si possa pensare, qui però riattivato dall’ironia in qualità di variabile storica non solo come funzione descrittiva, ma persino come motore di evoluzione sovversiva: “il consenso / è la riduzione della blatta / a polizia, è la fine della blatta […] Lo stato / di cose normale / è quello in cui non si dà blatta”. La blatta è l’animale sporco contro la pulizia della polizia, è la moltitudine sotto il “radiatore”, che soffre ma resiste. La blatta incarna (è il verbo giusto) in quanto variabile gli emarginati, i dimenticati, tutti coloro che esistono nonostante che si faccia finta del contrario: “fa parte della blatta / colui che non rientra / nei conti, colui che non ha / parola da fare / intendere.” A differenza dell’insetto kafkiano, siamo anche per questo in presenza di un insetto ben definito: la blatta e non un altro insetto simile, non uno scarafaggio qualsiasi. Le differenze si moltiplicano: la blatta è qui moltitudine e non individuo, e soprattutto non v’è un processo di metamorfosi ma piuttosto di coincidenza letterale nella variabile tra blatte e gruppi sociali.
Si impone quindi una distinzione fondamentale: nonostante l’apparenza, questi testi non sono variazioni sul tema. Non v’è un preesistente tema della blatta, un tema-guida ben definito su cui la poesia possa costruire il suo gioco linguistico, bensí un tema-blatta, in cui la blatta è il tema e il tema è la blatta, il vuoto della variabile riempito dalla moltitudine delle vicende e delle parole. La blatta si situa al contempo al livello del contenuto e della forma, della storia e del poema, come mostrano i versi performativi del testo n. 42: “il disordine che ogni / separa, corpo da se stesso.” Del resto, la blatta può assumere essa stessa una funzione poetologica, ma non metapoetica, nella misura in cui la sua presenza come variabile a tutti i livelli non autorizza – altro legame possibile con Wittgenstein – nessun metalinguaggio: “la blatta è quel tipo di discorso che disfa / le partizioni tra reale / e finzionale, tra la prosa / e la poesia”.
Per la medesima ragione, la blatta stessa non è esente da questa operazione di separazione espressa dai due passaggi appena citati. Il suo possibile sovversivo, situandosi nella tristezza della storia, si dà soltanto in un’operazione di disfacimento che la affetta e incide, direi nei due sensi di entrambi i termini: incide su di essa, e la separa da se stessa incidendola: “la blatta c’è ma è quella di Tipping / decapitata // la blatta manca mancandole / il possibile”. Christopher Tipping, citato varie volte nel testo, è un entomologo americano che ha studiato in forma sperimentale, durante gli anni 2000, la capacità che hanno le blatte di vivere per varie settimane anche decapitate. Questo perché la loro testa, diversamente da quella di molti altri animali tra cui gli uomini, non è direttamente collegata a funzioni vitali come la respirazione, e perché le blatte sono capaci di vivere per periodi relativamente lunghi senza mangiare (si pensi anche qui a quanto detto sopra sui reietti della società).
Il tema dell’incertezza del possibile è identificato con molta giustezza sia da Teti che da Bellomi come fattore politico e storico essenziale nel nostro presente. In questi testi di Teti la decapitazione della blatta indica grottescamente una generazione di presente senza possibile, un presente destinato quindi a vita breve: “è possibile / che sia invece un’invenzione / (la blatta) / continua, del presente”, indicano gli ultimi versi, in cui la blatta, anche decapitata, mantiene eroicamente la sua funzione di variabile. Cosa resta quindi da fare alla poesia, arte del possibile, in questo contesto? Come si è visto, la poesia non è esente dalla variabile-blatta, ed anzi lo smembramento ironico del corpo-blatta è anche uno smembramento poetico, non solo e non tanto, nei versi di Teti, nel senso della partizione tra poesia e prosa che essi menzionano esplicitamente, ma anche e soprattutto nella partizione di un metro volto e generare un ritmo proprio, in un serialismo integrale – si direbbe quasi –, tematico e ritmico, che rivela ancora una volta lo statuto ontologico della blatta come variabile piuttosto che come variazione. E con questo non si è risposto alla domanda.
*
Su Teoria di che cosa di Fabio Teti, 2016
di Silvia Tripodi
[…] riorientava tutta la sua ricerca in funzione di ciò che chiamava i modi di soggettivazione. Non si trattava assolutamente di un ritorno al soggetto, era una nuova creazione, una linea di rottura, una nuova esplorazione dove i rapporti precedenti con il sapere e il potere cambiavano.
Se si vuole, una nuova radicalizzazione. Persino il suo stile cambiava, rinunciava agli scintillii e alle esplosioni e scopriva una linearità sempre più sobria, sempre più pura, quasi pacata. Il fatto è che tutto questo non era una semplice questione di teoria. Il pensiero non è mai una faccenda di teoria. Erano problemi di vita. Era la vita stessa.
(Pourparler, Gilles Deleuze, pag. 141. Edizioni Quolibet, 2014)
La blatta infatti non può
essere definita
da alcun soggetto che le pre-
esiste. È nella forma
della sua relazione che va cercata
la differenza blattoidea che permette
di pensare il suo soggetto.
La blatta come terzeità estranea a sé stessa, che nella logica delle relazioni, non giunge a rappresentare una sintesi; piuttosto è attraverso il suo dispiegamento e il suo uso nel testo, che vengono ridefiniti gli ambiti del soggetto e della soggettivazione, di significato e significante. Tentando nessuna teoria quindi, o tentandone alcune, profittando di alcune teorie. Tra le quali quella di Adorno. Lasciandone traccia, lasciando tracce, nei testi. Lasciando i testi alle tracce.
Gli spazi della blatta sono “microfisici” e “macrofisici”.
La blatta come intelletto pubblico. Come grimaldello tra pubblico e privato. In Spazio di destot “la medusa staccata a riva si scioglie al sole”. La “disfazione” si compie attraverso il linguaggio, per mezzo del suo progressivo biologico disfacimento organico.
In Teoria di che cosa sembra che l’archeologia barocca di termini, di commutatori di senso, che sono alcune delle peculiarità enunciative di Fabio Teti, abbia trovato un nuovo habitat naturale in stilemi meno giocosi, in forme linguistiche ritratte, a tratti amare, più piane; i dispositivi teorici che incorporano quest’oggetto/soggetto metalinguistico, ne assimilano il senso fino a una progressiva concrezione attraverso una lingua più secca, stavolta ironicamente scientifica. Quest’ombra che sfugge da tutti i lati, che affiora in superficie, che si rivela, che si trova presso tutte le cose, tra gli interstizi della logica, nelle relazioni causa-effetto, nelle relazioni di scambio.
Se con la coda dell’occhio scorgiamo la blatta, in quell’attimo la possediamo.
Che cos’è un soggetto deprivato della sua blatta.
Cosa serve.
Che cos’è un soggetto a cui si aggiunge una protesi in forma di blatta.
Che cos’è un oggetto che somiglia a una blatta, ma non lo è.
A cosa serve.
In che misura la sua servibilità è o non è importante.
Quali sono i criteri di somiglianza tra la blatta e il mondo.
Che funzione hanno.
Forse non hanno funzione ulteriore se non quella di essere il paragone tra la blatta e il mondo.
Se anche il mondo è la blatta (e viceversa).
Se anche il mondo e la blatta (e).
Che cosa significa lavorare la blatta e cavarne profitto.
Che tipo di salario danno se si allevano blatte.
Che livello di operosità hanno le blatte.
Un dispositivo elementare all’interno del testo.
Una singolarità generica collocabile a più livelli.
Qual è la sua discendenza politica.
*
Prove d’ascolto è un progetto di Simona Menicocci e Fabio Teti

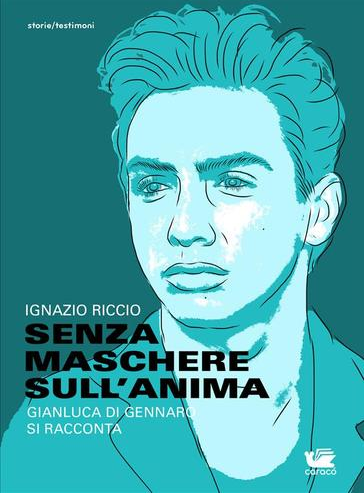 di
di La storia di Gianluca Di Gennaro però non è solo la storia di un giovane attore che riesce a “cogliere” il momento giusto, a giocarsi le sue chance, il debutto a quattordici anni in
La storia di Gianluca Di Gennaro però non è solo la storia di un giovane attore che riesce a “cogliere” il momento giusto, a giocarsi le sue chance, il debutto a quattordici anni in 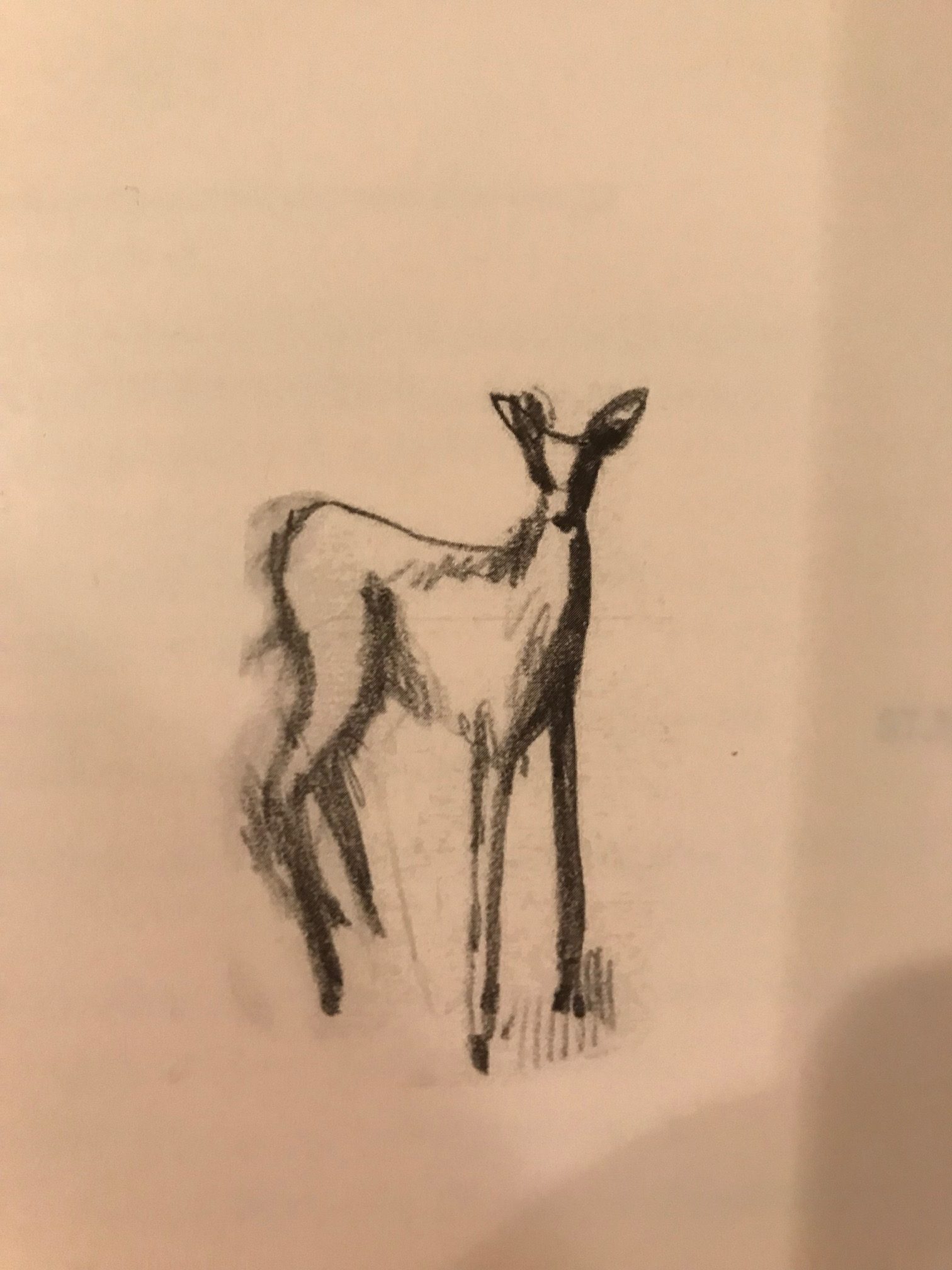


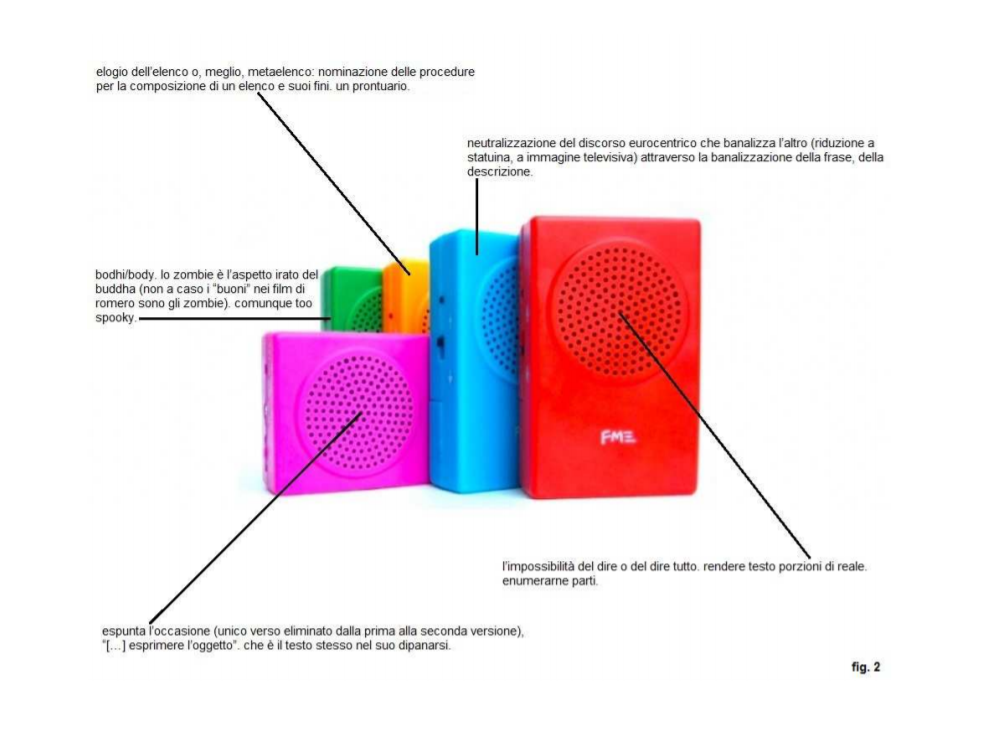
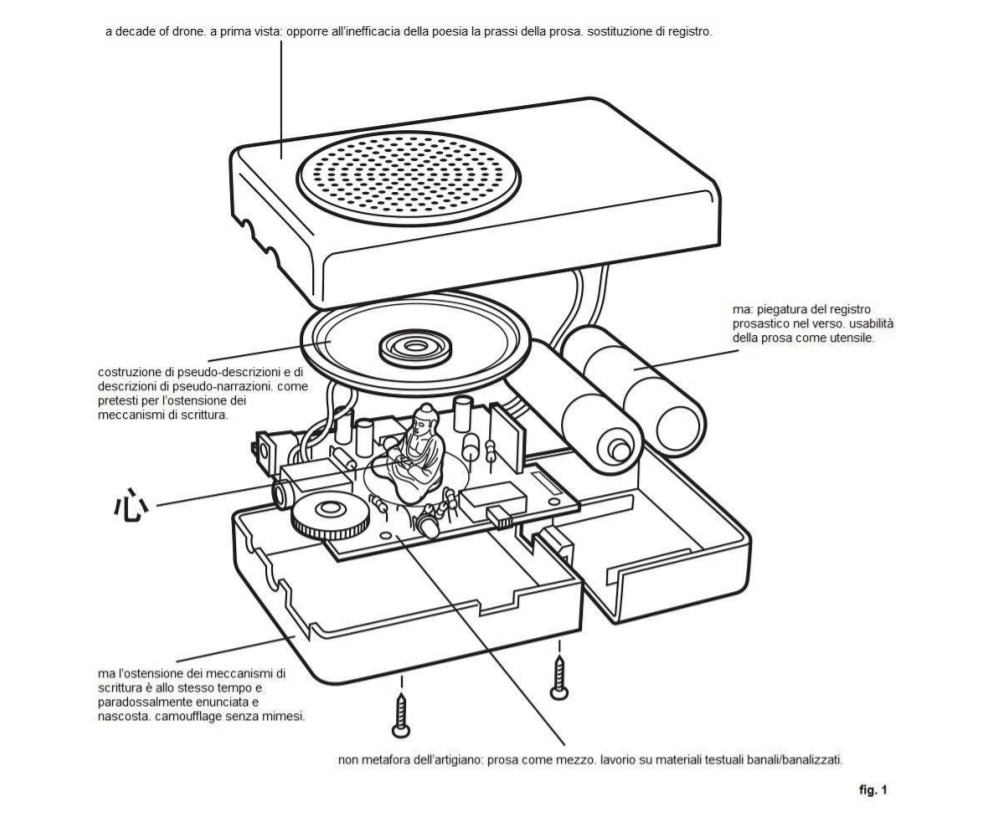
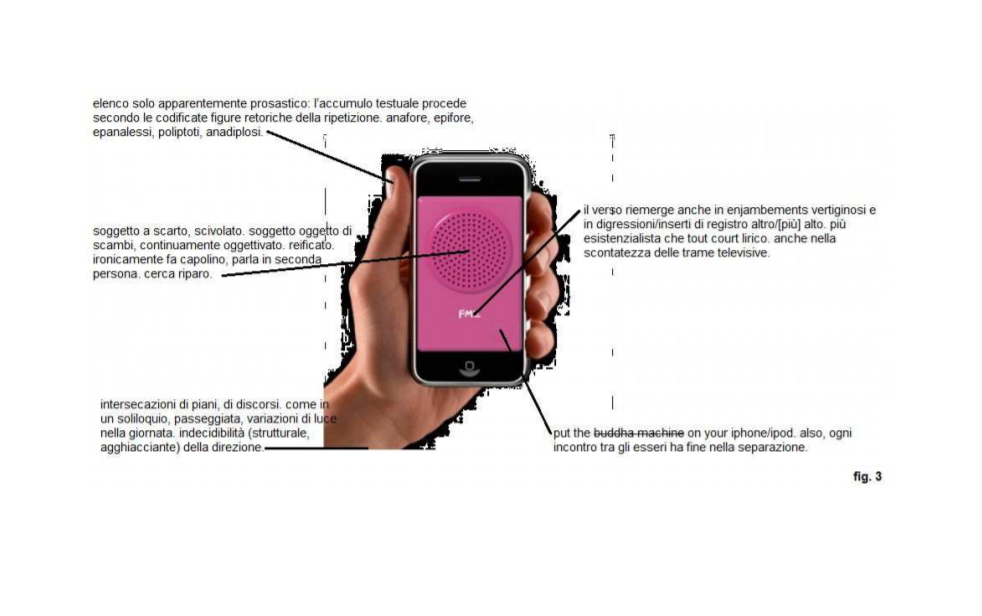

 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta

 Avevo letto Pacific Palisades prima di vederne la mise en scene fatta con la regia e la lettura di Alessandro Baricco e la con video installazione e con la musica dal vivo di Michele Tescari suonata dall’autore e dai suoi musicisti, a Roma nel programma RomaEuropa Festival.
Avevo letto Pacific Palisades prima di vederne la mise en scene fatta con la regia e la lettura di Alessandro Baricco e la con video installazione e con la musica dal vivo di Michele Tescari suonata dall’autore e dai suoi musicisti, a Roma nel programma RomaEuropa Festival.

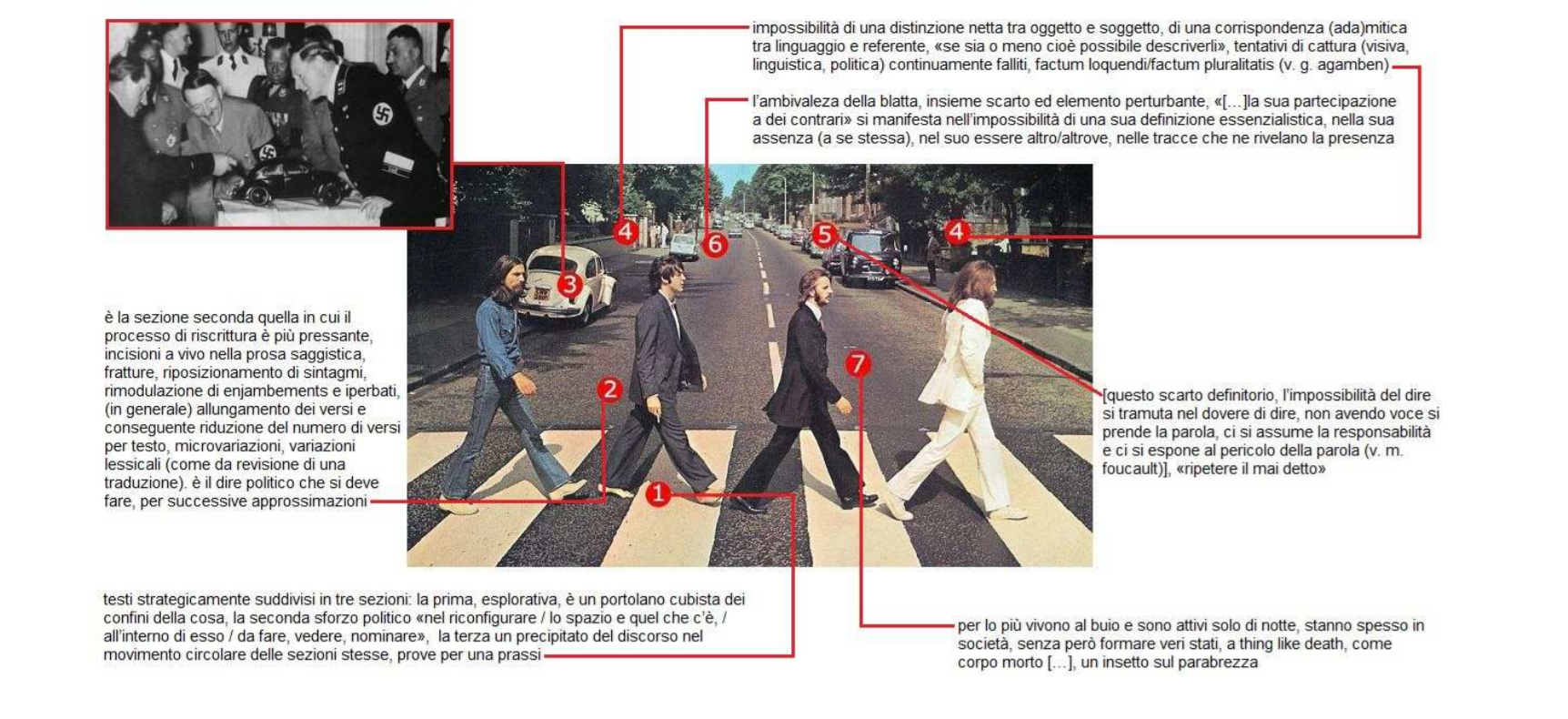
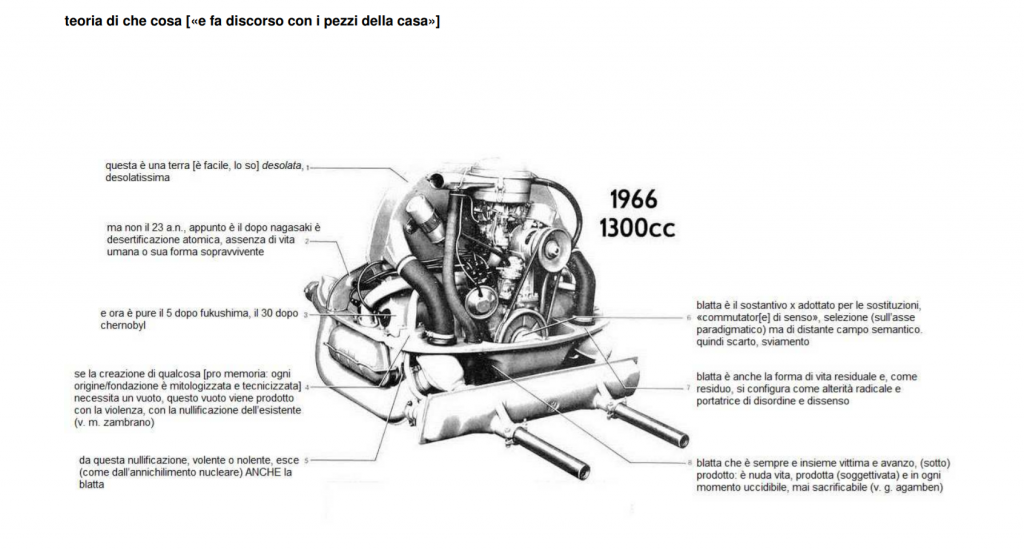
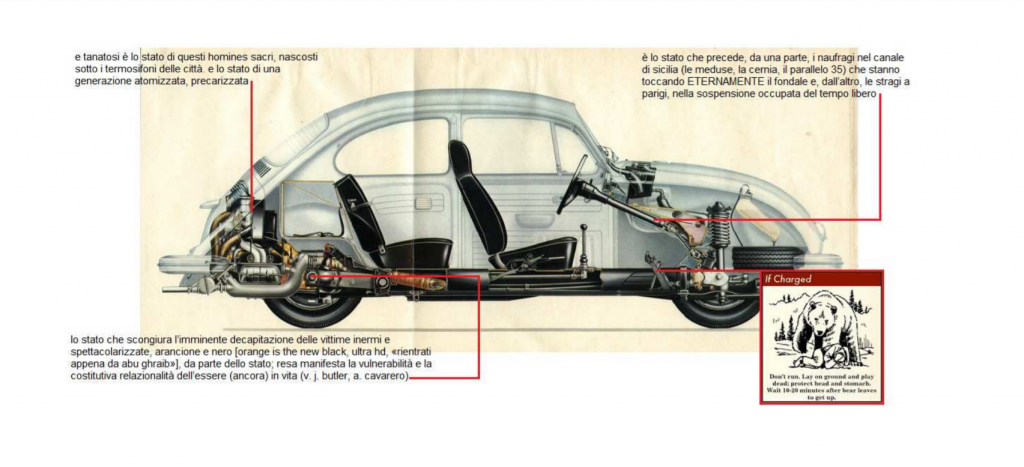
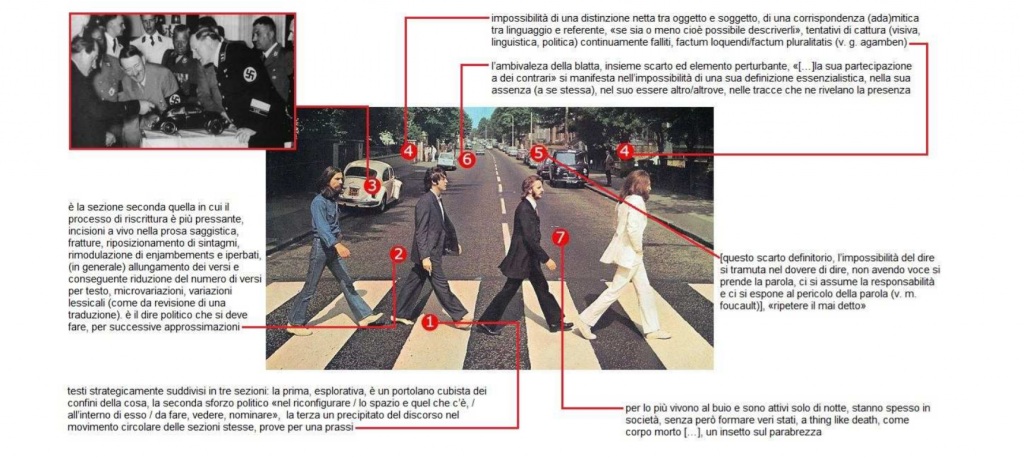
 Nota
Nota
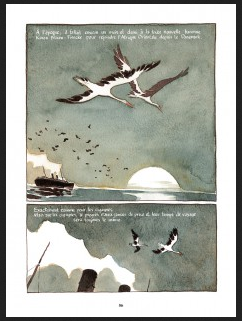

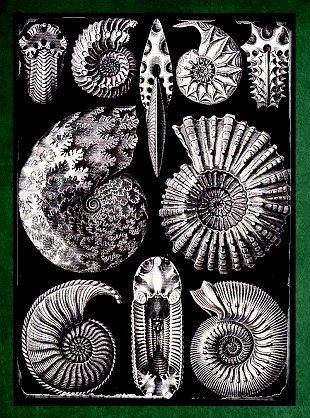


 “È solo una questione di distanza, di messa a fuoco, se mi allontano un po’ il disegno lo vedo anche nel caos”.
“È solo una questione di distanza, di messa a fuoco, se mi allontano un po’ il disegno lo vedo anche nel caos”.

