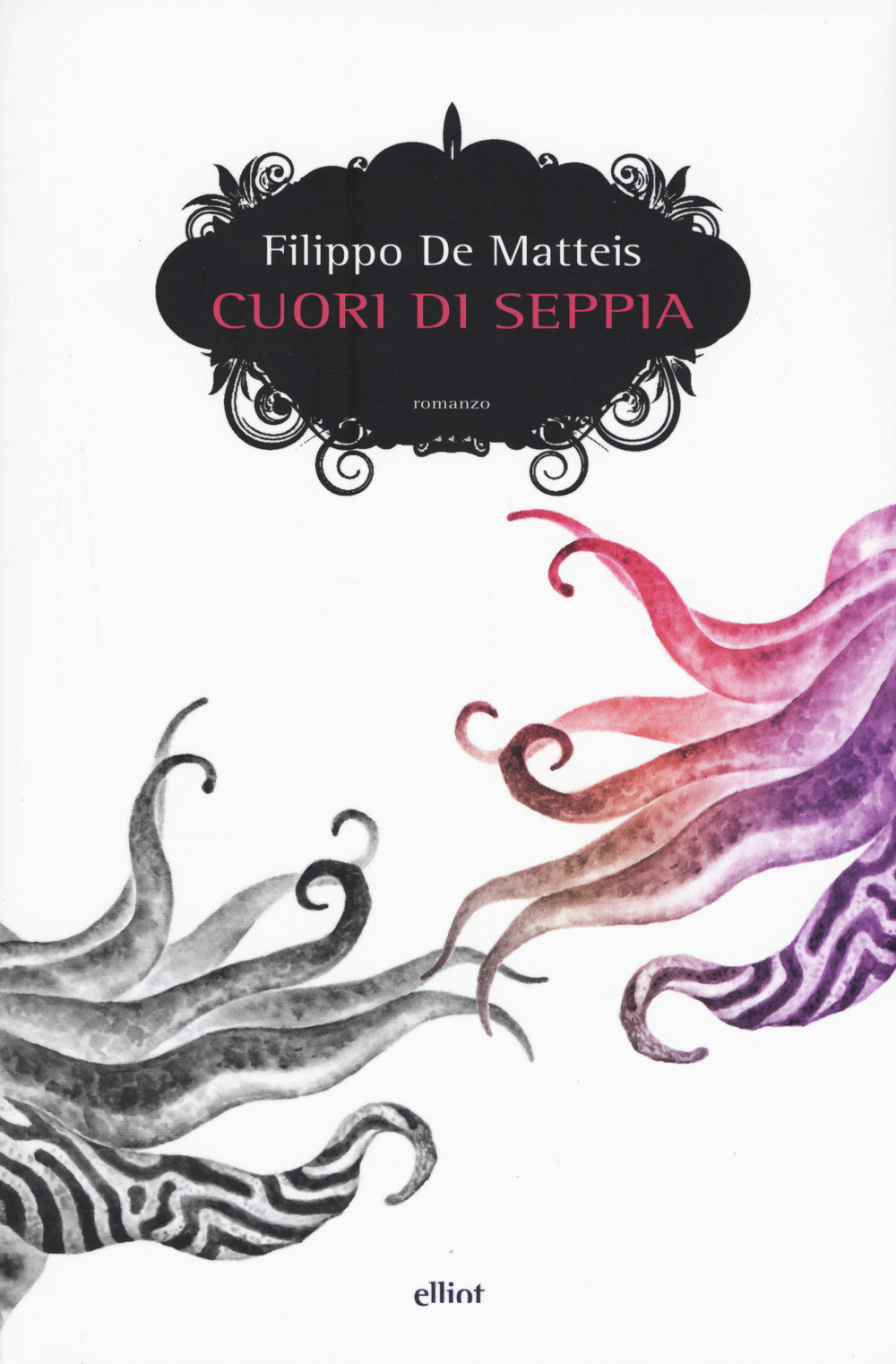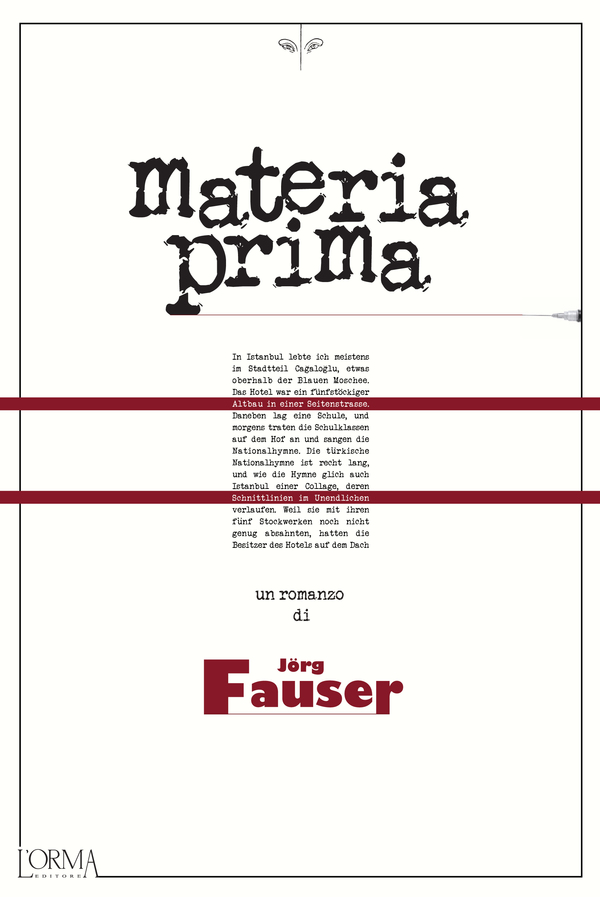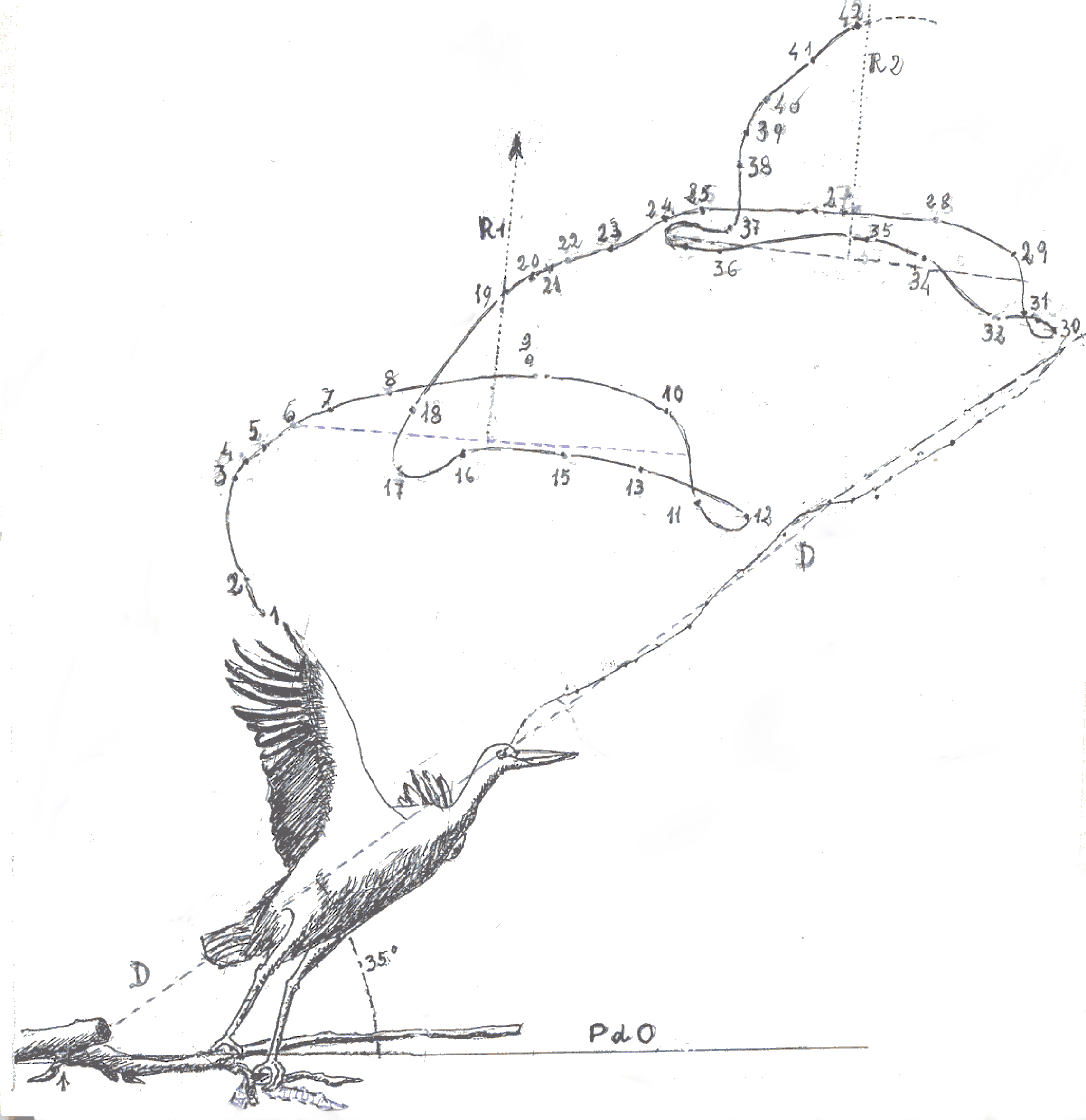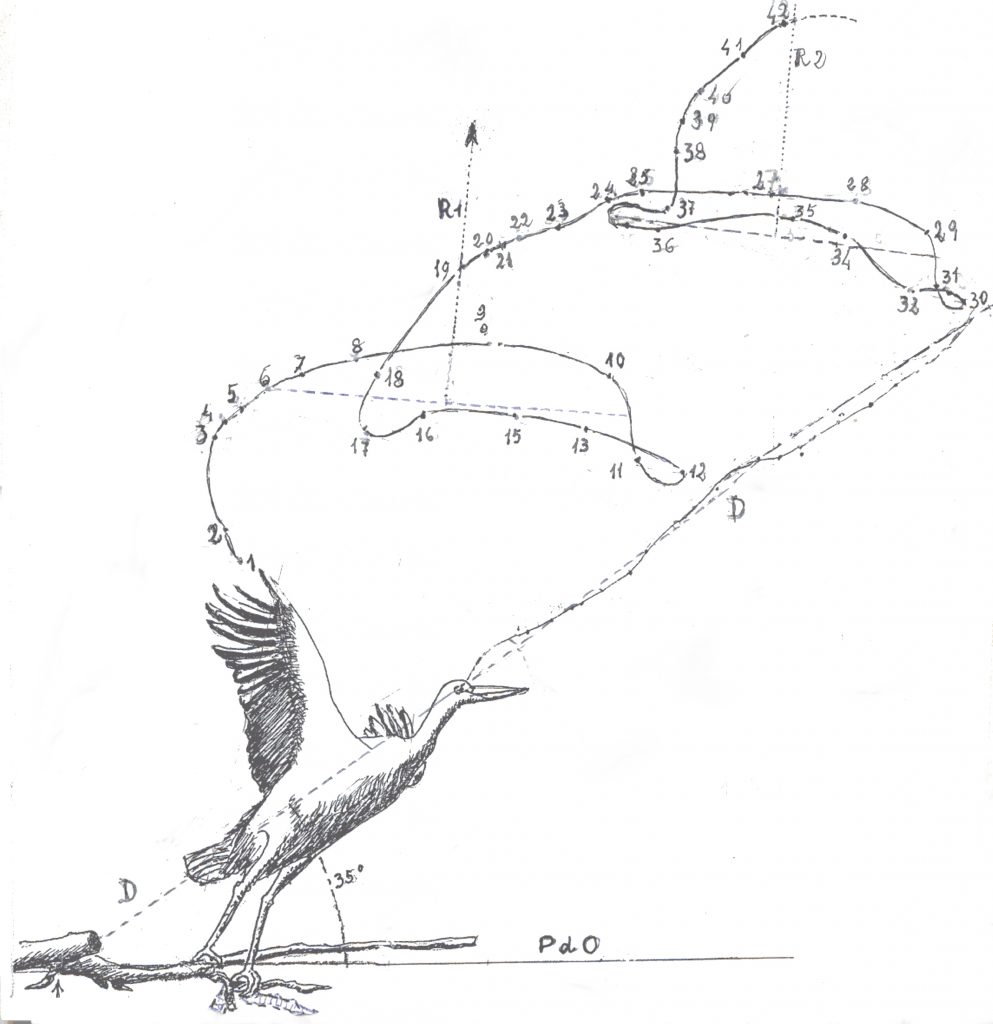Carissimi,
Ex-Indiani
Autori postati dai Redattori di Nazione Indiana
Lettori di Nazione Indiana
Commentatori di Nazione Indiana
sono anni e anni e anni che venite qui a leggerci gràtis, avete letto, gratuitamente, al momento attuale, 10.485 articoli di redattori e ospiti, avete fatto 148.134 commenti.
CROWDFUNDING non troppo educato [litote lenitiva]
«HAVE A NICE DAY»: LA COAZIONE ALLA MIMESI IN ‘VERSO OCCIDENTE L’IMPERO DIRIGE IL SUO CORSO’
di Andrea Corona
1. «Fondamentalmente non fanno altro che starsene lì in piedi». La generazione b(a)loccata di Mark, Tom e Drew-Lynn
Parlare di David Foster Wallace non può fare a meno di suscitare un entusiasmo prossimo a quello di chi si appresta a sfondare una porta aperta. Tale entusiasmo, tuttavia, è destinato a fare i conti con un’agrodolce presa di coscienza nel momento in cui si decide di passare dalle parole alla scrittura: scrivere di un autore complesso come Wallace è, infatti, un’operazione molto faticosa. Non c’è quasi pagina, nei suoi scritti – saggi e romanzi, come pure racconti brevi, articoli e interviste – che non sia in grado di far scattare dei meccanismi nella testa del lettore, per una gamma di stimolazioni intellettuali (in cui si accavallano riflessioni, associazioni con altri testi, collegamenti e ponti con altri autori) che si traducono in uno stato di sovreccitazione, prima di risolversi in affaticamento mentale. Le porte di cui si diceva, dunque, continuano a restare aperte; ma con la consapevolezza, adesso, di quanto fossero vere le parole di Robert Musil allorquando ne L’uomo senza qualità scriveva che «Se si vogliono varcare senza danno delle porte aperte, bisogna tener presente il fatto che gli stipiti sono duri» (Musil 1992: 16).
Varcare una porta aperta ma dagli stipiti duri significa, nel nostro caso, ritrovarsi a fare i conti con un autore i cui testi sono, da un lato, dei “libri-mondo” capaci di fornire su un piatto d’argento una quantità non numerabile di informazioni, spunti e rimandi, ma che, dall’altro, de-sistematizza continuamente il proprio sistema. Essendo il pensiero wallaciano totalmente libero (e, per l’appunto, non sistematico), esso è libero anche, per così dire, dall’obbligo di fornire delle risposte esaurienti e/o definitive. Pur seguendo un percorso di riflessione logico e progressivo, l’autore appare spesso (e proprio in virtù di tale libertà) non lineare e tortuoso. Per esprimere al meglio questo concetto teorico, sarà forse utile prendere in prestito un passo de I testamenti traditi in cui Milan Kundera chiarisce che:
Pur sostenendo la necessità di una forte presenza del pensiero in un romanzo, rifuggo da quello che viene definito «romanzo filosofico», asservimento del romanzo ad una filosofia, «messa in racconto» di idee morali o politiche. Il pensiero autenticamente romanzesco (quello che il romanzo conosce da Rabelais in poi) è sempre asistematico, indisciplinato; è simile a quello di Nietzsche; è sperimentale; apre brecce in tutti i sistemi di idee da cui siamo attorniati; prende in esame (specialmente attraverso i personaggi) tutte le strade della riflessione tentando di arrivare in fondo a ciascuna di esse (Kundera 2000: 168).
Ecco, dunque: Wallace è uno scrittore che apre brecce di continuo, che lo fa per mano dei suoi personaggi (ivi inclusi quelli di nome David Wallace ) anziché attraverso la mera edificazione di un apparato di teorie morali o convinzioni politiche, e che spinge le proprie riflessioni alle estreme conseguenze, ma in modo tale che “estreme” non significhi mai “ultime”.
E, ciò premesso, domandiamoci ora: quali tematiche veicolano, seppur in modo non sistematico e non lineare, le opere di David Foster Wallace? Ebbene, solo per citare alcune tra le più presenti, sono certamente da tenere in conto l’incomunicabilità, il solipsismo e la solitudine, il rapporto spesso ossessivo con il proprio corpo (e dunque con la dismorfofobia), la relazione tra il mercato e le paure collettive, il legame tra il divertimento e la pubblicità, l’analisi dei grandi spettacoli d’intrattenimento di massa (e dell’influenza di questi sui loro fruitori, ossia gli spettatori), l’interdipendenza di realtà e fiction.
È evidente che ci troviamo dinanzi a un autore che affronta temi di grande attualità. Ma il punto è un altro: chi legge Wallace ne ricava, più propriamente, una sensazione di familiarità. Come se lo scrittore riuscisse a farci sentire tutti chiamati in causa, e lo facesse dicendo cose che ci riguardano. Molto interessante, in tal senso, è una dichiarazione di Luca Bargagna, attore e regista teatrale, nonché autore degli spettacoli Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso (tratto dal romanzo omonimo) e Il dono (tratto stavolta dalla raccolta di racconti Brevi interviste con uomini schifosi). Nella sua dichiarazione, Bargagna ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto a portare Verso Occidente a teatro, affermando che si tratta di
“un romanzo assolutamente attuale perché scritto alla fine degli anni Ottanta ma che riesce a declinare quelle che sono ancora oggi le paure della generazione fra i trenta e i quarant’anni. In qualche modo, dietro l’impalcatura del romanzo, c’è un’impostazione fotografica, ossia il tentativo di fotografare una generazione come la nostra, che si ritrova in mezzo, che non ha più dei riferimenti, non ha più dei padri, ma non ha neanche la possibilità di strutturare o ipotizzare un futuro, per cui una generazione bloccata” (Bargagna 2014) .
In effetti, in questo romanzo (lungo circa duecento pagine nelle varie edizioni, e dunque piuttosto breve rispetto agli abituali standard dello scrittore di Ithaca) sono presenti praticamente tutti gli spunti di cui sopra e che, nell’ottica di un volume sul mondo di oggi visto attraverso il filtro wallaciano, si rivelano assolutamente funzionali allo scopo. Seguendo uno schema di allontanamento e riavvicinamento al testo, andremo dunque a toccare questioni di forte pregnanza contenutistica, e lo faremo a partire proprio dalla stasi di una generazione bloccata (e, come si vedrà, baloccata).
Un’immagine che immortala in modo molto efficace la situazione di stallo in cui si trovano i protagonisti del romanzo – Mark Nechtr, Drew-Lynn Eberhardt e Tom Sternberg – è infatti quella che li vede letteralmente impantanati e incerti sulla destinazione che li attende. Una destinazione, sia chiaro, meramente geografica; ma che reca nondimeno l’emblema di un destino simbolico, condiviso e collettivo:
Perciò fondamentalmente non fanno altro che starsene lì in piedi, come farebbe chiunque, in mezzo a una montagna di bagagli; si sentono un po’ impantanati, stanchi, con la tipica tensione da “ci siamo quasi ma non ancora”, con la sensazione che ci sia un posto preciso dove devono trovarsi a un’ora precisa, ma senza aver raggiunto alcun consenso sul modo di arrivarci […] sono emblematicamente incerti su dove andare da questo punto in poi (Wallace 2001: 57-58).
E l’adagio si ripeterà quando, più avanti, ritroviamo una irritabilissima e infantilmente imbronciata Drew-Lynn (moglie – incinta – di Mark e antico oggetto di un timido amore adolescenziale da parte di Tom) alle prese con mille borbottii e lamentele: «E non siamo nemmeno sicuri di dove si trovi Collision rispetto a questo aeroporto. A ovest di qui, ma quanto? Ci si arriva a piedi? C’è una strada? Non abbiamo visto altro che granturco. Disorientante […]. Tutta questa regione mette paura» (ivi: 82-83).
Si tratta di personaggi spaesati e vulnerabili che risultano, per molti aspetti, simili a dei bambini che chiedono incessantemente quando si arriva a casa.
2. «Per chi è una casa la Casa Stregata? E perché costruire una Casa Stregata in ogni grande città, secondo le leggi del marcato?». J.D. Steelritter e il potere “oikonomico”
Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso è il secondo romanzo di David Foster Wallace. Curiosamente, in quanto comparve per la prima volta nella raccolta di racconti del 1989 La ragazza dai capelli strani, è da molti considerato a sua volta un racconto. Ad ogni modo, indipendentemente dalla definizione che se ne vuol dare , si tratta di una narrazione che si rapporta, dialogandovi a distanza ma soprattutto prendendone in chiave ironico-polemica le distanze, con un testo sperimentale del 1968 di John Barth dal titolo La casa dell’allegria. Storie da stampare, incidere su nastro, recitare.
Quel che ci preme è fare innanzitutto presente che, se nell’orbita di un discorso più marcatamente critico-letterario (ma anche storico-letterario), Verso Occidente nasconde, al di là dell’evidente rivisitazione in chiave parodica, delle importanti riflessioni sulla teoria letteraria, sulla metanarrativa e sul racconto postmoderno, dal mero punto di vista dei contenuti si distacca dall’opera di Barth per fotografare, come appunto si diceva, i disagi di una generazione bloccata.
Non che l’incomunicabilità o la difficoltà a relazionarsi fossero aspetti assenti ne La casa dell’allegria, ma la generazione degli anni Ottanta, descritta da Wallace in maniera così esageratamente “imbambolata” e quindi facilmente malleabile e governabile, risulta agli occhi del lettore odierno talmente vicina alla nostra da meritare un approfondimento in primo luogo sociologico. Vediamo ora perché.
Si inizi col dire che l’episodio che dà il via agli eventi narrati in Verso Occidente è la realizzazione di uno spot televisivo della catena di fast-food McDonald’s. E si aggiunga, poi, che non si tratta di una réclame come tante.
Siamo a Collision, una sonnolenta cittadina dell’Illinois, dove l’intraprendente pubblicitario J.D. Steelritter ha organizzato una riunione con tutti gli attori, comparse incluse (tra cui i nostri Mark, Tom e Drew-Lynn), che abbiano mai recitato in uno dei 6659 spot McDonald’s girati fino a quel momento. «E sentite questa: la Riunione è stata ideata e promossa così bene che tutti quelli che sono ancora vivi hanno promesso di partecipare. Il cento per cento di risposte positive, come J.D. sa bene, non è un caso». Veniamo così a sapere che «l’ideazione e l’organizzazione di questo gala sono da anni la passione principale di J.D. Steelritter», il quale «Fin dall’inizio aveva previsto un risultato del genere» (ivi: 70).
In altre parole, era tutto calcolato. E questo, come mostreremo a breve, costituisce un primo elemento di interesse. Ma andiamo avanti. Tra i principali punti di forza dell’operazione, che includono vari privilegi per gli accorrenti attori, ce n’è uno in particolare che sembra far gola agli invitati. Se è vero che non tutti possono usufruire ad esempio del «trasferimento a bordo di macchina da clown sul luogo della Riunione», in quanto servizio riservato esclusivamente agli ospiti più puntuali, è però vero che per tutti i quasi 44.000 ex attori in arrivo sul luogo è incluso nel pacchetto «[l’]accesso alla discoteca numero uno di una catena che promette di espandersi alla velocità di un carcinoma, di essere nel prossimo millennio il posto dove farsi vedere» (ivi: 70-71).
E che questa discoteca giochi un ruolo importante nei piani del pubblicitario lo si intuisce da un particolare: nelle sale d’aspetto dell’aeroporto dell’Illinois centrale, dove giungono gli attori prima che un’apposita navetta li conduca a Collision, campeggia un poster gigantesco, su cui appare un enorme J.D. Steelritter accanto a un enorme Ronald McDonald, un Ronald che assomiglia a J.D., sotto il cerone, nello stesso strano modo in cui, per dire, il rugby assomiglia al football; l’enorme Ronald tiene in mano un manifesto promozionale, solo leggermente meno enorme, del prototipo di una discoteca Casa Stregata […] sembra grosso modo una casa normale, come quelle che ti aspetteresti di vedere a decine in qualsiasi quartiere dormitorio, fatta eccezione per l’enorme ghigno da cadavere che sarebbe la porta della Casa Stregata. L’espressione di J.D. è congegnata in maniera tale da farvi già sentire privati di qualcosa per non essere lì con loro (ivi: 55).
Se il primo era relativo al calcolo, gli altri elementi che ci interessano riguardano rispettivamente il mercato, la paternità e il governo della casa. Andando con ordine: la grande Riunione dei 44.000 attori segnerà l’apice ma anche il superamento e la fine degli spot McDonald’s perché darà luogo, certo, al più importante spot di sempre, ma questo sarà tale in quanto la pubblicità numero 6660 è l’ultima in programma, l’ultima prevista, l’ultima che verrà mai girata. Parallelamente a ciò, avrà luogo l’inaugurazione della catena di discoteche “Casa Stregata”, con una «in ogni grande città, secondo le leggi del mercato» (ivi: 32).
J.D., apprendiamo poi, ha un figlio. E «Lo stesso figlio di J.D. Steelritter, DeHaven Steelritter, è un marchio di fabbrica umano. Un clown. Il clown. È il Ronald McDonald di questa campagna ormai da un anno» (ivi: 41-42). Ecco perché il pagliaccio del poster gigante assomiglia a J.D. come il rugby assomiglia al football: perché è suo figlio. Ma di «quel pagliaccio del figlio» (ivi: 43) parleremo più a fondo nel prossimo paragrafo.
Ora concentriamoci sull’elemento “casa”. Ricorrono, nel romanzo, passaggi che sottolineano come gli spot McDonald’s riescano a far sentire a casa chi li guarda, oltre che chi li interpreta – basti pensare che la politica aziendale prevede, per chiunque sia mai comparso in uno spot, «un coupon senza scadenza che gli dà diritto a un numero illimitato di hamburger gratis in ogni ristorante della catena, dovunque, in qualunque momento» (ivi: 51); ma ancora più illuminante ci sembra un passo in cui il narratore, ripercorrendo i pensieri di J.D., si domanda: «Una Casa Stregata deve essere qualcosa di più che un divertimento? Qualcosa di più che una forma di divertimento nuova e perfezionata? L’idea stessa di “casa” sta giocando un ruolo in questa campagna, invisibilmente?» (ivi: 36). Ebbene, la risposta è sì.
Stacchiamoci adesso dal testo wallaciano per tracciare una sintesi di questi primi spunti: il calcolo, il mercato, la paternità e il governo della casa.
In riferimento al potere del mercato, come ha rilevato il gruppo di filosofi napoletani Collettivo 33, i nostri tempi registrano un’immanenza della sovranità all’economia e viceversa, in quanto «Nell’economico agisce un’istanza di sovranità e nella sovranità un’istanza di calcolo. L’economico ha bisogno della sovranità – il politico – per funzionare e la sovranità si esercita per “calcolare” la società» (Collettivo 33 1997: 12).
Ma qual è l’esito di questo gioco? Un gioco assai simile a quello che, nel romanzo di Wallace, è praticato così abilmente dal personaggio di Steelritter? Come ci indica ancora il Collettivo, il diffondersi degli enunciati economici ha portato a una lingua depoliticizzante che sembra far ritorno a qualcosa di antico quanto la figura del pater familias, del responsabile del governo della casa (oikos) e, quindi, a quel responsabile dell’oikonomia che esercitava un potere e un controllo dispotico sui figli e in generale su tutti membri dell’oikos.
Ha dunque ragione Hannah Arendt quando in Vita activa afferma che l’attuale dominio dell’economia non è che l’estensione mondiale del governo della casa: «con il sorgere della società, cioè con l’estendersi della “comunità domestica” (oikia) o delle attività economiche al dominio pubblico, la gestione della casa e tutte le faccende che rientravano precedentemente nella sfera familiare sono diventate una questione “collettiva”» (Arendt 1989: 142).
La cosiddetta globalizzazione assume perciò, anche in Wallace, col cui testo ora ritorniamo a dialogare, un significato ontologico e linguistico: «Per chi è una casa la Casa Stregata? Forse per i bugiardi, i tipi creativi, i promotori di campagne pubblicitarie, i potatori alle prese con il grande albero della lingua» (Wallace 2001: 61).
Ecco allora che, se «il dominio dell’economico è tale che nessun luogo gli sfugge, anzi ogni luogo è continuamente preso e dislocato dal processo tecno-economico» (Collettivo 33 1997: 14), a maggior ragione, «con una Casa Stregata in ogni grande città, secondo le leggi del mercato» (Wallace 2001: 32), la comunità domestica proseguirà nel suo progetto di estensione su tutta la terra. Ma con una differenza: l’espansione avverrà non già più con «l’insegna del ristornate sotto casa per il mondo intero» (ivi: 52) o col sorriso di un clown che augura «una buona giornata» (ivi: 99), bensì con un «enorme ghigno da cadavere» (ivi: 55) stampato sulla porta d’ingresso.
3. «E quel pagliaccio del figlio». DeHaven Steelritter, i “consumati” e la produzione di adulti-bambini
Il capovolgimento da sorriso a ghigno non si manifesterà all’improvviso, perché sarà preannunciato dall’espressione intermedia, vacua e apatica, del novello (ma al contempo ultimo, si ricordi, dal momento che dopo di lui non ve ne saranno altri) Ronald McDonald. E la grottesca smorfia, sorta di equivalente orale di una palpebra a mezz’asta, pare sia sempre appartenuta a questo figlio neghittoso e indolente che si presenta come «Un bambino che è uscito dal grembo della madre infastidito» (ivi: 43).
In riferimento al «terzo Ronald McDonald nella storia del franchising americano» (ivi: 44), alias DeHaven Steelritter, leggiamo infatti che
“è chiaro che non apprezza l’occasione che gli è capitata, che non gli piace il lavoro che fa; e, ancora peggio, la sua antipatia per quel lavoro la dimostra come farebbe una persona addormentata, con un piagnucolio intorpidito e un broncio assoluto da bambino: espressione che ha in faccia ora, e da quel broncio J.D. è infastidito e innervosito, dal corrugarsi della pelle del figlio sotto quel folle sorriso dipinto… ha un’aria grottesca, le labbra e il rossetto formano una specie di cerchio grossolano, e l’impressione che danno (e che non dovrebbe mai dare una bocca che rappresenta un ristorante) è semplicemente quella di un buco, di una monetina senza nessuna incisione, di un’entrata vuota da cui vorresti solamente uscire” (ibidem).
Di indole diametralmente opposta a quella del genitore e contraddistinto da una cronica insofferenza al lavoro, come pure da una sistematica sottrazione preventiva a tutto ciò che «non è al cento per cento facile e piacevole» (ivi: 42), DeHaven, nel momento in cui «alza le spalle con quell’apatia alla “che ci vuoi fare?” con cui affronta ogni ostacolo» (ivi: 43), assume un atteggiamento di attesa e passività che non è poi così diverso, a ben vedere, da quello degli altri personaggi.
Così come per il disorientamento palesato dinanzi a un destino perennemente evanescente e aleatorio, anche per la fissità si può parlare di una componente letterale e non solo metaforica delle vite di Mark, Tom e Drew-Lynn. Si pensi allora, ad esempio, al momento in cui «tutti e tre questi bambini ormai sessualmente maturi» (ivi: 77) fissano lo schermo della tv. Che si tratti di quello posto nella sala d’aspetto e che trasmette le repliche del tanto amato telefilm Hawaii Five-O, o che sia quello del piccolo televisore a gettoni che distrae finalmente Drew-Lynn dai suoi rovelli mentali, i nostri protagonisti si rendono, a uno sguardo esterno, sottosviluppati e inamabili (cfr. ivi: 90-91).
E proviamo a comprendiamoli meglio, dunque, questi bambini sessualmente maturi (ricordiamo che Mark e Drew-Lynn stanno per diventare genitori) grazie all’identikit che il narratore traccia del loro coetaneo – e certamente non meno sottosviluppato e inamabile – DeHaven Steelritter:
Ma allora, DeHaven K. Steelritter? adulto? figlio putativo? possibile erede? usurpatore? Chi mai potrebbe amare questo DeHaven Steelritter? Età: dovrebbe proprio farsi la barba; altezza: sta sempre ingobbito, deliberatamente; peso: chi potrebbe dirlo, sotto i vestiti di pelle o questo costume a pois coi fianchi larghi e le scarpe a punta?; istruzione: dato che la scuola non è al cento per cento facile e piacevole “non vale un cazzo”; aspirazioni professionali: comporre musica atonale (a quanto dice), ricevere ottimi stipendi facendo il minimo indispensabile e passare il resto del tempo a cazzeggiare (a quanto pare). Lui rappresenta il Prodotto. È Ronald McDonald. Di professione. Questo figlio, questo orzaiolo sulla palpebra del cosmo, questo incomprensibile SHRDLU nello slogan pubblicitario del cosmo rappresenta “il ristorante sotto casa per il mondo intero” (ivi: 42).
Il quadro che emerge non è certamente dei più edificanti, eppure sarebbe crudele non tener conto del fatto che DeHaven sia fondamentalmente, come si diceva, l’incarnazione stessa del prodotto. Illuminante il flashback sull’episodio d’infanzia – risalente al tempo in cui frequentava la prima media – di colui che diventerà il futuro Ronald McDonald: «rimasto a casa da scuola […] per uno di quei misteriosi raffreddori senza febbre che chiedono a gran voce di essere stroncati sul nascere, augura a J.D., con la più completa innocenza, l’innocenza di un bambino davanti a una televisione, una buona giornata» (ivi: 99).
Eccoci giunti, dunque, alla radice del male, all’eziologia della malattia: l’innocenza di un bambino che, plagiato da un televisore acceso, al momento di salutare il padre ripete meccanicamente “Have a nice day”, la formula standard rivolta al cliente dall’impiegato delle grandi aziende. Non è difficile, a questo punto, immaginare cosa stesse guardando in quel momento (magari, e non è un azzardo pensarlo, stava guardando proprio lo spot McDonald’s del 1970 in cui il Tom bambino di nove anni s’infatuò della Drew-Lynn bambina di dodici anni).
E parimenti importante è il passo relativo al disturbo dell’umore di Mark. Caratterizzato da un temperamento immancabilmente serafico, Mark, nei rari momenti di sovreccitazione, diventa tuttavia simile a uno spettatore seduto in prima fila (cfr. ivi: 26). Che la genealogia della sua apatia coincida con quella di DeHaven non è dato saperlo con sicurezza; ma certo è che, allo stato attuale:
Non è che le emozioni di Mark siano distorte o disturbate, è che lui ha problemi a relazionarcisi. Ecco perché appare in genere sereno e distaccato, neutralmente cordiale. Quando le prova, è come se alle emozioni gli venisse negato l’accesso. Non sente mai di possedere le sue emozioni. Quando ne ha, se ne sente lontano; si sente fuori dal proprio corpo, estraneo (ivi: 121).
Non un broncio né una smorfia, ma nemmeno l’ombra di un sorriso in questo ritratto in carne e ossa dell’alienazione agli altri e a se stessi. Ma sul solipsismo si avrà modo di parlare più avanti, perché prima di passare in esame un’ulteriore tematica sarà bene allontanarci nuovamente dal testo wallaciano per vedere come le problematiche appena emerse siano state affrontate in anni più recenti.
A venire in mente, qui, è innanzitutto il bel libro del 2010 di Benjamin Barber Consumati. Da cittadini a clienti in cui si afferma che la quotidiana offerta di giochi a premi, concorsi, gratta e vinci, anche quando estesa alle pratiche più futili o alle interminabili raccolte di bollini e coupon, rappresenta di fatto la creazione di un comportamento infantilistico utile ad alimentare una cultura del consumo a ogni costo:
L’infantilizzazione tende a indurre comportamenti puerili in soggetti adulti e a preservare l’aspetto infantile nei bambini che cercano di crescere, persino quando sono “legittimati” a consumare […]. L’ethos infantilistico è straordinariamente abile nel creare una domanda di mercato incoraggiando la generazione di falsi bisogni nella società opulenta, in modo da garantire la vendita di tutti quei prodotti e servizi che il capitalismo, con zelo, sta producendo in eccesso (Barber 2010: 119-120).
Quella della produzione di adulti-bambini, dunque, è una strada intrapresa dal marketing per ovviare a tutta una serie di “resistenze” e obiezioni che solitamente fermano il consumatore adulto di fronte a un acquisto. Non si tratta solamente di produrre oggetti per bambini, quindi; ma di trasformare gli adulti in bambini una volta che li si è posti dinanzi all’oggetto/prodotto desiderato. Per questo motivo, l’utilizzo della forma ludica, ribaltata anche nel linguaggio della comunicazione commerciale, viene ad essere lo strumento privilegiato per la regressione verso l’infanzia di sempre nuovi bambini sessualmente maturi.
E si consideri, sempre in quest’ottica, la rilevanza assunta dalle discoteche, oramai importate all’interno dei contesti più disparati; così che, manifestazioni tradizionalmente riservate a un pubblico di persone mature, come le olimpiadi, si stanno trasformando sempre più in colossali operazioni d’intrattenimento. Si tratta di manovre dirette ai nuovi consumatori di ragazzi e appunto, ancora una volta, di adulti-bambini. È quanto ha ravvisato anche il giornalista Curzio Maltese quando, seguendo la cerimonia inaugurale delle olimpiadi di Londra 2012, parlò, e a ragione, di
“un allegro ripasso di tutti i miti della letteratura infantile, da Mary Poppins ad Alice, con al culmine della rappresentazione J. K. Rowling, la creatrice di Harry Potter, che legge Peter Pan. Senza dimenticare naturalmente il coro di bambini che intona “God save the queen”, sotto lo sguardo commosso di nonna Elisabetta. Per finire ovviamente con la trasformazione dello stadio olimpico in un’immensa discoteca” (Maltese 2012: 7).
4. «Dividere uno specchio con una massa di attori»: lo spettatore in controcampo e la coazione alla mimesi
Siamo ritornati alle immense discoteche, dunque, e l’abbiamo fatto con un’immagine che rimanda al “solipsismo da folla” (altrimenti detto “alone together”) di Mark Nechtr e della sua generazione. Sono proprio solipsismo e folla gli elementi fondanti di un passo collocato da Wallace al centro del romanzo (ma che rimanda direttamente alla sublimazione della scena finale):
tutti noi, e Mark lo saprebbe bene se si prendesse la briga di chiederlo a J.D. Steelritter, che in passato ha fatto ampie ricerche sulle paure derivanti da illusioni solipsistiche, tutti noi abbiamo le nostre piccole illusioni solipsistiche, spaventose intuizioni di una nostra assoluta singolarità: crediamo di essere gli unici della casa […] a provare, quando il sole tramonta, lo stesso tipo di panico che un bambino dell’asilo prova quando la mamma si allontana. Di essere solo noi ad amare i solo-noi. Di essere solo noi ad aver bisogno dei solo-noi. Il solipsismo ci tiene insieme, e J.D. lo sa. Sa che ci sentiamo soli in mezzo a una folla; senza fermarci a pensare a cosa ha dato vita a quella folla. Sa che siamo, sempre, volti in mezzo a una folla (Wallace 2001: 128).
Si tratta di un passo emblematico in quanto riferito alla medesima folla che compare nell’epilogo, ossia la «folla di coloro per i quali la casa è stata messa lì: quelli riccamente bisognosi, quelli che rifuggono fobicamente da ciò che è chiuso, quelli a cui serve un riparo. Bambini» (ivi: 216).
Prima di esaminare la scena conclusiva del romanzo, lanciamo una nuova occhiata al di fuori del testo narrativo per guardare a quella evaporazione delle sensazioni e delle emozioni paventata da Camille Dumoulié, intellettuale francese che in un saggio del 2004 metteva in guardia dal controllo dei godimenti operato dalla pubblicità. La tesi di Dumoulié è che l’immagine pubblicitaria, onnipresente, ha già realizzato ciò che essa propone al desiderio dello spettatore: una vita ricca di colori, di gioia, di originalità; ma pur sempre una vita virtuale.
Proprio come in quel vecchio spot della Kodak in cui tre piccole pesti – le “Kodakettes” – si aggirano per la città e, a mo’ di banda di criminali, rubano letteralmente i colori: scattando foto ad abiti, coppe di gelato e mazzi di fiori, non solo spogliano cose e persone della loro precedente vitalità cromatica, condannandole a un bianco vuoto e spettrale, ma privano di qualsiasi gusto o profumo tutto ciò che catturano su rullino, mentre sghignazzano divertite e lo slogan recita «Kodak il ladro di colori» .
Una vita virtuale, dicevamo per l’appunto, e non già più una vita activa, per quello che è un mero simulacro del godimento, ma che, nondimeno, ha come diretta conseguenza nel reale «Un’umanità trasformata in fantasmi che attraversano la vita come in un permanente Halloween, ridotta allo stato di corpi stravolti e vampirizzati dalle stesse immagini che devono imitare» (Dumoulié 2004: 97). Tale è l’operazione del virtuale mediatico sul mondo: esso vampirizza la vita anticipando il godimento. E non potrebbe del resto essere altrimenti dal momento che, con la pubblicità, «si gode per voi, si è già goduto. Non avete più nulla da desiderare» (ivi: 98).
Non è un caso, allora, che il finale di Verso Occidente si risolva in una sorta di godimento abortito, dal momento che Wallace ferma la narrazione prima di mostrare un qualsivoglia scorcio di appagamento, divertimento o allegria. Ed eccoli i nostri eroi, così come appaiono nell’ultima pagina, trascinarsi alla stregua di morti viventi alle soglie della Casa Stregata. Consumati dalla fatica del percorso (un percorso iniziato molti anni addietro e che li ha gradualmente, con un lento lavorio del tempo, trasformati da cittadini a comparse), quelli che vediamo sono dei volti ormai anonimi di una folla indistinta di 44.000 clienti
Che, stanchi, ma in tempo, arriveranno a ciò che è stato costruito. Che è di gran lunga troppo tardi per tirarsi indietro. E dunque avanti, verso la Riunione Di Tutti Coloro Che Sono Comparsi, verso la Via d’Uscita, verso la Casa Stregata, […] progettata secondo standard universali per essere – al di là di tutta la campagna propagandistica che la sosterrà – nient’altro che quello. Una casa (Wallace 2001: 216).
A questo punto, occorrerà pur dire qualcosa su come sia fatta questa casa all’interno. Ebbene, a tal proposito Wallace fornisce un unico particolare, ma assolutamente pregnante, nel momento in cui ci informa che «la Casa Stregata, dice il dépliant, è stata accuratamente progettata utilizzando soprattutto un sistema di specchi» e che si tratta perciò, in sostanza, di «Un posto affollato e pieno di specchi» (ivi: 90).
E non è una coincidenza che già nel romanzo d’esordio di Wallace, La scopa del sistema, vi sia spazio per ampie trattazioni relative a immagini riflesse, specchi e narcisismo, dismorfofobia e solipsismo (con un capitolo, il secondo, interamente dedicato al tema). Sono alcuni degli argomenti-chiave di uno scrittore che ha anticipato sin dai primi lavori degli anni Ottanta una serie di questioni che avrebbero caratterizzato i dibattiti sociologici dalla fine degli anni Novanta in poi.
Basti pensare alla “folla solitaria” di consumatori analizzata da David Riesman nel saggio omonimo o all’Homo consumericus di Gilles Lipovetsky, fino a quella “McDonaldizazione” del mondo presa in esame da George Ritzer e che fa il paio con le famose disamine sulla globalizzazione e sulla solitudine del cittadino globale proposte da Zygmunt Bauman, in cui il mondo si riduce a fabbrica di attrazioni passeggere, mentre il cittadino del mondo a “turista” della suddetta fabbrica (cfr. Riesman 2009, Ritzer 1997 e 2003, Lipovetsky 2007, Bauman 1999 e 2000).
Pur senza sviscerare in maniera esaustiva una tale quantità di spunti e rimandi bibliografici, possiamo valerci di un’immagine, stavolta cinematografica, che ci sembra assai pertinente nonché utile a sintetizzare gran parte del discorso wallaciano relativamente a questo secondo gruppo di punti – la fissità e il solipsismo, gli specchi e l’immagine speculare, il rapporto fra attori e spettatori – che sono venuti a delinearsi.
Quando in Verso Occidente si legge che «Sternberg non è affatto sicuro che gli piaccia l’idea di dividere uno specchio con una massa di attori» (Wallace 2001: 90), non può non venire in mente la sequenza d’apertura del film In girum imus nocte et consumimur igni di Guy Debord – frase palindroma che darà anche il titolo a un suo saggio – in cui il filosofo mostra che «L’attuale pubblico di una sala cinematografica, intento a guardare fissamente davanti a sé, sta di fronte, in un perfetto controcampo, agli spettatori, che dunque sullo schermo non vedono altro che se stessi» (Debord 1998: 7).
Ebbene, si sappia che in Verso Occidente questo fenomeno ha luogo letteralmente. Se infatti Tom Sternberg «ha con gli specchi un rapporto di amore-odio» (Wallace 2001: 90) è perché, da un lato, ambisce a diventare attore di professione ma, dall’altro, il suo aspetto è segnato da «un fatale difetto fisico. Ha un occhio completamente rivoltato verso l’interno della testa» (ivi: 49). E sappiamo che non si tratta di un occhio cieco, ma di un occhio che vede, sebbene Tom «di quello che vede l’occhio rivolto all’indietro non parla» (ibidem).
Lo sguardo di Sternberg, possiamo dunque affermare, è a sua volta palindromo, speculare nella misura in cui i suoi occhi non guardano nella stessa direzione, né in direzioni opposte ma entrambe esterne, bensì rispettivamente all’esterno e all’interno, separandosi là dove si toccano e toccandosi là dove si separano. In altre parole, i suoi occhi formano il medesimo gioco di campo/controcampo mostrato da Debord. E sarà lo stesso Wallace a trattare esplicitamente questo concetto nel suo romanzo successivo, Infinite Jest (1996).
Nella famosa nota 24 di Infinite Jest, quella relativa all’estesa filmografia di James Incandenza, oltre a non mancare un riferimento al regista Hollis Frampton (autore, aggiungiamo noi, di un film muto del 1969 intitolato Palindrome e che si chiude significativamente con la didascalia «Et consimumur igni»), compare un «pubblico come cast riflesso», insieme spettatore e attore protagonista di un bizzarro film, The Joke:
The Joke (La beffa). A.S. Latrodectus Mactans Productions. Pubblico come cast riflesso; 35 mm x 2 telecamere; lunghezza variabile, bianco e nero; muto. Parodia degli «eventi specifici del pubblico» di Hollis Frampton, due videocamere Ikegami Ec-35 riprendono nella sala il pubblico del «film» e proiettano sullo schermo le immagini risultanti – il pubblico della sala che guarda se stesso guardare se stesso mentre comprende la «beffa» e si mostra sempre più imbarazzato e a disagio e ostile, comprendendo di far parte dell’involuto flusso «antinarrativo» del film (Wallace 2006: 1187).
Questo sguardo in controcampo – o, se lo si preferisce, questo sguardo/controsguardo – assume, in Infinite Jest come già in Verso Occidente, i tratti di un’efficace metafora: se le passate generazioni di spettatori avevano da fare i conti con lo schermo cinematografico e con quello del televisore per affacciarsi ai mondi mostrati nelle pubblicità e nei film, la generazione attuale non si limita ad affacciarsi a determinati scenari, perché ha in aggiunta la possibilità di interfacciarsi costantemente con uno schermo – che sia quello di un televisore o di un monitor, di un tablet o di uno smartphone – fino, però, a rivoltare subito verso l’interno uno sguardo che non ha fatto in tempo a guardar fuori, condannandosi in ultima istanza a riflettere incessantemente se stessa e la propria immagine in un gioco vertiginoso di rincorsa, o perdita, di identità.
Volendo in conclusione individuare un senso complessivo che colleghi tutti questi spunti, possiamo dire che l’esito del nostro discorso sembra condurre a ciò che potremmo definire come coazione alla mimesi, intendendo con quest’espressione un processo che fa capo alla passività esasperata di quell’“Io minimo” che, mosso da impulsi ambivalenti, coniuga dentro di sé il sentimento di onnipotenza narcisistica con la percezione del proprio vuoto e della propria debolezza (cfr. Lasch 1981 e 1985, Lipovetsky 1995 e 2007).
Avendo inizio in età infantile con la ripetizione meccanica degli slogan pubblicitari, tale coazione alla mimesi ha il suo tratto distintivo nell’emulazione e nella riproduzione, e quindi nella mancata opposizione ai desideri seriali – di cui l’Io subisce la seduzione anche in età adulta – e nella mancata reazione alla forza livellante di un’indifferenziazione che, confinando le soggettività in un monadico isolamento, tutto uniforma senza nulla accomunare.
Per un mondo – e Wallace lo insegnava già trent’anni fa – omogeneizzato nei costumi e nei pensieri tanto quanto lo sono i burgers di McDonald’s.
Fonti citate
Bibliografia:
Arendt 1989: H. Arendt, The Human Condition (1958), trad. it. Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano.
Barber 2010: B. Barber, Consumed: How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults, and Swallow Citizens Whole (2007), trad. it. Consumati. Da cittadini a clienti, Einaudi, Torino.
Barth 1974: J. Barth, Lost in the Funhouse. Fiction for Print, Tape, Live Voice (1968), trad. it. La casa dell’allegria. Storie da stampare, incidere su nastro, recitare, Rizzoli, Milano.
Bauman 1999: Z. Bauman, Globalization. The Human Consequences (1998), trad. it Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari.
Bauman 2000: Z. Bauman, In Search of Politics (1999), trad. it La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano.
Collettivo 33 1997: Collettivo 33, Per l’emancipazione. Critica della normalità, Cronopio, Napoli.
Debord 1998: G. Debord, In girum imus nocte et consumimur igni (1978), trad. it Id., Mondadori, Milano.
Dumoulié 2004: C. Dumoulié, Controllo dei godimenti e fascismo soft, in “L’espressione”, anno II, n. 1, Cronopio, Napoli, pp. 83-99.
Karmodi 2012: O. Karmodi, David Foster Wallace. Un’intervista inedita, Terre di Mezzo, Milano.
Kundera 2000: M. Kundera, Les Testaments trahis (1992), trad. it. I testamenti traditi, Adelphi, Milano.
Lanier 2010: J. Lanier, You’re Are Not A Gadget: A Manifesto (2010), trad. it Tu non sei un gadget, Mondadori, Milano.
Lasch 1981: Ch. Lasch, The Culture of Narcissism (1979), trad. it La cultura del narcisismo, Bompiani, Milano.
Lasch 1985: The Minimal Self. Psychic Survival in Troubled Times (1984), trad. it L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di cambiamenti, Feltrinelli, Milano.
Lipovetsky 1995: G. Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain (1993), trad. it L’era del vuoto. Saggio sull’individualismo contemporaneo, Luni, Milano.
Lipovetsky 2007: G. Lipovetsky, Le Bonheur paradoxal: essai sur la société d’hyperconsommation (2006), trad. it. Una felicità paradossale. Sulla società dell’iperconsumo, Raffaello Cortina, Milano.
Maltese 2012: C. Maltese, Harry Potter e discomix. Sono giochi da bambini i veri clienti di domani, in “La Repubblica”, 28 luglio 2012, p. 7.
Musil 1992: R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (1933), trad. it. L’uomo senza qualità, Mondadori, Milano.
Riesman 2009: D. Riesman, The Lonely Crowd (1961), trad. it La folla solitaria, Il Mulino, Bologna 2009.
Ritzer 1999: G. Ritzer, The McDonaldization of Society. An Investigation into the Changing Characters of Contemporary Social Life (1993), trad. it. Il mondo alla McDonald’s, Il Mulino, Bologna 1999.
Ritzer 2003: G. Ritzer, Expressing America: A Critique of the Global Credit Card Society (1995), L’era dell’iperconsumo. McDonaldizzazione, carte di credito, luoghi del consumo e altri temi, Franco Angeli, Milano.
Wallace 2000: D. F. Wallace, Brief Interviews with Hideous Men (1999), trad. it. Brevi interviste con uomini schifosi, Einaudi, Torino.
Wallace 2001: D. F. Wallace, Westward the Course of the Empire Takes Its Way (1989), trad. it Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso, minimum fax, Roma.
Wallace 2004: D. F. Wallace, Oblivion (2004), trad. it. Oblio, Einaudi, Torino.
Wallace 2006: D. F. Wallace, Infinite Jest (1996), trad. it. Einaudi, Torino.
Wallace 2008: D. F. Wallace, The Broom of the System (1987), trad. it. La scopa del sistema, Einaudi, Torino.
Wallace 2008: D. F. Wallace, Girl with Curious Hair (1989), trad. it. La ragazza dai capelli strani, minimum fax, Roma.
Wallace 2011: D. F. Wallace, The Pale King (2011), trad. it. Il re pallido, Einaudi, Torino.
Sitografia:
LiveJournal (www.livejournal.com)
The New York Review of Books (www.nybooks.com)
YouTube (www.youtube.com).
Filmografia:
G. Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, documentario, Francia 1978, 100 min.
H. Frampton, Palindrome, film muto, USA 1969, 22 min.
J.-B. Mondino, The Color Theft, spot pubblicitario, Francia 1987, 1 min.
Teatrografia:
L. Bargagna, Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso, Compagnia Blu Teatro, Italia 2014.
L. Bargagna, Il dono , Compagnia Blu Teatro, Italia 2016.
Rivoluzionare il sogno. Note su “Le giunture del sogno” di Sergio Finzi
 di Gianluca Garrapa
di Gianluca Garrapa
Se ti dico “psicoanalisi”, probabilmente penserai a “inconscio” e la parola “sogno” la collegherai a “interpretazione dei sogni”. Invece “Le giunture del sogno” è tutt’altra cosa. Le giunture del sogno (Luca Sossella editore, 2016) è un saggio, ma a tratti ricorda un romanzo filosofico, dello psicoanalista Sergio Finzi che, lungi dal ripercorrere la chiave interpretativa freudiana del sogno, evidenzia la sua struttura geometrica connessa con le leggi della natura, del corpo e del pensiero. Un sogno, dunque, più vicino alla filosofia e all’etica, alla matematica e alla libertà dell’uomo.
Je so’ pazzo – un film di Andrea Canova
di Mariasole Ariot
“Ogni realtà sociale è, per prima cosa, spazio”.
Braudel
Riabitare i luoghi di confine significa riscriverne la storia senza cancellarla – là dove tutto sembra(va) votarsi proprio a questo: all’oblio. Significa dare alla storia precedente, per sottrazione, una nuova voce.
Riabitarli, riscriverli, e infine raccontarli: perché senza una narrazione che sappia entrare nei sotterranei di un passato dimenticato e di un presente riedificato, con occhio spalancato ma con la delicatezza che non sfonda i muri ma li apre come si aprono le maglie del sottile, il nuovo resterebbe confinato all’invisibile.
Il regista Andrea Canova, realizzando il film per la giovane etichetta Inbilico Teatro & Film – e con l’aiuto di una campagna di crowdfundig per sostenere le spese di post-produzione, con un incedere largo ma in sordina, senza sovrapporsi ai rumori e alle voci del luogo ma posizionandosi dal lato della testimonianza, restituisce una visibilità per molto tempo mancata: ripercorrendo il territorio che si propone di raccontare, lo attraversa non solo nella sua dimensione spaziale, ma anche in quella temporale: è l’alternanza tra il movimento creativo dell’oggi e la staticità coatta di ciò che era ieri l’ex ospedale psichiatrico di Sant’Eframo, ora sede del collettivo Je so’ pazz che, occupandolo nel 2015, l’ha rifondato, dandogli una nuova possibilità di parola, di respiro, di libertà.
La struttura carceraria, ricavata dalle mura antiche di un vecchio monastero del ‘600, convertito in ospedale psichiatrico giudiziario nel 1978 a seguito della Legge Basaglia, e chiuso definitivamente nel 2008, è un’architettura imponente. Un’architettura abitata per anni da un mondo confinato e invisibile, in cui Michele Fragna, voce e corpo narrante che appare a tratti, nell’imprevisto della discorsività visuale, attraverso i suoi vecchi scritti poetici di ex internato, fa riemergere ciò che prima era – e ciò che prima non era – Sant’Eframo.
“Quand’anche fosse son pazzo, e allora?/Mi rimane un tanto per essere felice/ Mi rimane un tanto per le mie sofferenze/Mi rimane un tanto per dire ho un amico, per dire ti odio, ho paura/ed altro ancora/Mi rimane un tanto per dire: sono un uomo”
Michele Fragna
Dove il colore predominante era il grigio, ora sono murales e tinte forti, dove prima era silenzio, ora sono risa di ragazzini che giocano a pallone, dove prima erano detriti, ora spunta un sottile strato erbaceo, dove prima era muraglia di separazione, ora è palestra di roccia, dove prima erano letti imbrattati di umori, ora c’è il suono di un violino, dove prima erano grida soffocate, il battere di cucchiai sulle sbarre, ora c’è uno strumento che suona, le voci che l’accompagnano.
Perché un paesaggio in cui l’umanità si muove è anche questo: un paesaggio sonoro. E l’elemento sonoro è un’altra componente fondamentale del documentario che, in alcuni precisi momenti, ci riporta al precedente lavoro di Canova, Il vicino.
Riabitare luoghi infernali (“qui ho visto l’inferno”, recita una delle testimonianze appese alle pareti), permette anche (per i “sopravvissuti” e per la memoria collettiva) la rielaborazione di un lutto: il lutto dei dimenticati, di ciò che prima faceva scarto, dei residui corporei, dei vecchi plichi ingialliti, dei frammenti di vita gettati nelle macerie. L’abbandono assoluto, l’uscita dalla scena del mondo.
“Vengo qui perché nel quartiere non abbiamo un campetto da calcio”, dice un bambino.
E come lui, nell’ex opg, oggi trova casa e senso comunitario chi altrove non riesce a costruirlo e a farne parte. L’ambulatorio medico, le aule d’insegnamento, il laboratorio di teatro, le “pizzicate”, la stanza dei violini, l’accoglienza ai migranti, le tavole rotonde, la passeggiata, lo scambio pieno della parola, il riconoscersi, l’appartenenza: una scena che esonda in fermento, che s’interroga sui nuovi significati e i vecchi significanti:
“Non è che sono pazzi, sono persone normali, soltanto che hanno un piccolo problema. Se tu ti spezzi una gamba ti devono chiamare zoppo?”
Nel ricordare è sempre e necessaria anche una “perdita di ricordo”, una dimenticanza : non significa rimozione, negazione, al contrario significa dimenticare qualcosa per poter far rivivere qualcosa di nuovo.
Se questo è quello che il collettivo Je so’ pazz ha fatto concretamente nei fatti, l’operazione del regista si sposta in una zona simbolica pur restando a stretto contatto con un Reale ustionante: nel documentario non si tratta solo di descrivere lo stato attuale delle cose, né solo di tenere a mente ciò che in un tempo straziante è stato: si tratta piuttosto di questo: raccontare il Possibile.
Non è quindi un’operazione che si limita a denunciare e svelare ciò che non è stato fatto, ciò che non doveva farsi, ma anche e soprattutto: ciò che si può fare, ciò che si può dire. Lì, come nei tanti altrove che ancora, sfortunatamente, permangono nel mutismo.
Come dichiara Werner Herzog “Per una civiltà così avanzata come la nostra, essere senza immagini che siano adeguate ad essa è un difetto così grave come l’essere senza memoria”.
Cuori di seppia
di Francesca Fiorletta
 Filippo De Matteis ha scritto un libro delicatissimo e struggente. Cuori di seppia, il suo esordio narrativo per Elliot Edizioni, è un improvviso viaggio a rebours nei meandri più reconditi di mente, corpo e anima, attraverso un soliloquio ininterrotto popolato da presenze misteriose, personaggi lugubri e inquietanti rivelazioni.
Filippo De Matteis ha scritto un libro delicatissimo e struggente. Cuori di seppia, il suo esordio narrativo per Elliot Edizioni, è un improvviso viaggio a rebours nei meandri più reconditi di mente, corpo e anima, attraverso un soliloquio ininterrotto popolato da presenze misteriose, personaggi lugubri e inquietanti rivelazioni.
Proprio di chi “va a fondo”, o quantomeno cerca di andare a fondo nelle situazioni, è il bisogno atavico, la spinta indomita che mette sempre l’uomo in contatto con la parte più oscura di sé. Ebbene, il “cuore di seppia” è proprio questa oscurità, è il più famoso “orrore” arguito negli occhi del Kurtz di Conrad, è il buio fitto in cui abitano le nostre fragilità, come l’ipocondria o la paura d’impazzire, e la palude stantia in cui proliferano i nostri più maniacali raccapricci, come la vergogna e la ripulsa verso un brutale omicidio.
La lingua scelta e qui utilizzata da Filippo De Matteis è musicalità leggera e spinta potente all’introspezione, e l’alternanza continua fra prosa e poesia ricalca bene, in ogni suo aspetto, il virtuosismo pericolante dell’esistenza che questo bel romanzo d’esordio racconta.
Di seguito, un estratto.
Un’altra scuola di Francoforte: gli anni Settanta di Jörg Fauser
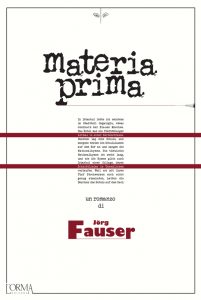 Di Daria Biagi
Di Daria Biagi
È il 17 luglio 1987 quando un uomo di quarantatré anni, poche ore dopo aver festeggiato il suo compleanno, viene travolto e ucciso da un camion lungo il tratto autostradale tra Feldkirchen e München-Riem, alla periferia di Monaco. Si tratta di uno scrittore francofortese noto per il momento più nell’ambiente delle forze dell’ordine che non nei circoli letterari: ad attirarlo fuori città, secondo alcuni, sarebbero stati presunti informatori con cui si era messo in contatto per un’indagine sui rapporti tra spaccio di droga e politica; secondo altri stava invece semplicemente barcollando verso casa, ubriaco come il personaggio di uno dei suoi libri. Le incertezze su questa strana morte avrebbero contribuito, negli anni successivi, ad alimentare il mito di Jörg Fauser, romanziere, poeta, giornalista, alcolista, testimone polemico della contestazione studentesca e di tutto quello che, in Germania e non solo, ne sarebbe conseguito.
Guerre di Spagna
di Daniele Comberiati
In giorni in cui la Spagna si interroga (e ci interroga) sulla persistenza degli stati-nazione, su nuovi e vecchi nazionalismi e sull’ambiguità di termini come “libertà”, “democrazia” e “indipendenza”, non è forse fuorviante riflettere su un libro di Luciano Curreri da poco uscito per i tipi di Quodlibet, all’interno di una nuova collana, “Elements”, che presenta brevi saggi di storia culturale scritti e pubblicati in diverse lingue, e per la quale da poco hanno visto la luce A che ora si mangia? di Alessandro Barbero, breve ma ricca analisi su come lo spostamento degli orari dei pasti abbia influito o sia stato influenzato dai cambiamenti sociali e politici, i lavori di Gabriele Fichera sul concetto di impegno in Pasolini, Kalisky, Sciascia e Mertens, e il bel saggio di David Becerra Mayor sul realismo sociale in Spagna.
Anche il libro in questione, Fiction, propagande, témoignage, réalité. Cinq micro-essais sur la réprésentation de la guerre civile espagnole en Italie, scritto in francese, è totalmente incentrato sulla Spagna e sulla sua guerra civile, che fin dall’inizio scrittori stranieri si accinsero a descrivere. Non fanno eccezione gli italiani, anche se, per la nota vicinanza ideologica fra Mussolini e Franco, saranno numerosi (e ben indagati nel primo capitolo del libro, 1936-1940. Roman, reportage, théâtre, cinéma, BD au service du fascisme italien) gli autori che elogiarono la liberazione dai rivoluzionari. Scrittori oggi dimenticati come Paolo Sghinolfi utilizzano termini ed espressioni come “orrore” e “tragica ora” per riferirsi all’avanzata delle truppe rivoluzionarie. D’altronde la guerra di Spagna si presenta fin dall’inizio (e a maggior ragione a posteriori) come archetipica: per Guernica, certo, primo bombardamento “moderno” che apre la strada a nuovi stratagemmi militari che di lì a poco sarebbero stati sperimentati nella Seconda guerra mondiale, ma anche per la sua “lunga” durata, che apparentemente può apparire un controsenso vista la comune cronologia 1936-1939. Eppure questa guerra, come molte guerre moderne, non finisce con la vittoria del franchismo, e forse neanche con la morte del generalisimo nel 1975. La guerra di Spagna è anche Madrid contro Euskadi, dalla costituzione dell’Eta fino alla recentissima deposizione delle armi consegnate all’esercito francese al di là della frontiera, e indirettamente i suoi effetti possono scorgersi persino nella gestione maldestra, da ambo le parti, del referendum catalano. Una guerra anche di lunga durata e bassa intensità, dunque, ma al tempo stesso una guerra che, dalla parte dei Repubblicani, doveva essere narrata perché per anni la storiografia ufficiale l’aveva del tutto deformata, come se ribelli e non franchisti fossero scomparsi dalle memorie dopo la sconfitta. Il libro si apre proprio con una domanda solo apparentemente retorica: esiste, è esistita la guerra di Spagna o è stata solo narrata? Il rapporto fra fiction e realtà indagato nel libro – che ci riporta a precedenti lavori di Curreri, primo fra tutti quel Le farfalle di Madrid, sull’Antimonio di Sciascia, che è apparso anche in spagnolo nel 2009 – parte proprio dalle possibili risposte a questa domanda. Ogni narrazione presenta un lato del conflitto spagnolo che, proprio per la sua natura “civile” e “interna”, ma al tempo stesso intrinsecamente internazionale (e l’autore ricorda il ruolo decisivo di italiani e tedeschi accanto a Franco, ma anche delle Brigate Internazionali), risulta ancora oggi un oggetto storico estremamente difficile da maneggiare.
Il cinema, pur non facendone un argomento ossessivo, non è stato certo a guardare: attraverso la panoramica esposta nel secondo capitolo, l’autore presenta L’assedio dell’Alcazar di Augusto Genina (lo stesso Genina de Lo squadrone bianco e Bengasi, due fra i principali film della propaganda coloniale in Libia), vincitore della Coppa Mussolini a Venezia nel 1940, come film paradigmatico per esporre le paure della destra e della chiesa sull’esito della guerra civile. I ruoli nel film di Genina sono rovesciati: all’interno di un intreccio melodrammatico, in cui fa da sfondo una storia d’amore, i falangisti resistono eroicamente all’assedio dei repubblicani a Toledo, fino all’arrivo liberatorio delle truppe di Franco. Diversi ovviamente sono i film usciti dopo il 1975, come Una vita venduta (1976) e Volontari per destinazione ignota (1977), entrambi prodotti dalla Rai ed entrambi attenti al rapporto del conflitto spagnolo con l’emigrazione meridionale italiana. Una vita venduta è tratta proprio dall’Antimonio sciasciano, e in generale il rapporto fra Italia e guerra di Spagna, nei due sensi (franchista e anti-franchista), è sempre stato costante a dispetto dell’intensità, come sottolinea una recente mostra del Museu d’Historia de Catalunya, a Barcelona, su “La visión del fascismo italiano sobre la guerra civil española”, in cui sono state presentate al pubblico, per la prima volta, alcune immagini inedite degli ottantamila legionari fascisti girate dalla Cinemateca dello Stato Maggiore del Regio Esercito. Uno sguardo verso la Spagna che, come l’autore nota, diviene anche un modo indiretto per riflettere sulla situazione e sulle scelte interne all’Italia.
È nelle conclusioni che l’apporto teorico del libro si fa particolarmente interessante. Curreri si interroga sulla possibile presenza di una “funzione” della Guerra di Spagna nella letteratura italiana, a partire da Elio Vittorini e Antonio Delfini che, benché costretti a nascondere le loro simpatie per i repubblicani, proprio durante il conflitto iberico maturarono le proprie convinzioni antifasciste. Certo, a parte Sciascia e Jovine, in altri scrittori (Brancati, Pavese, Dessì, Parise) le vicende di Barcellona e Madrid sono affrontate a latere, occupata, la nostra narrativa, in altre guerre e altri (post)fascismi. Eppure la ri-emergenza, a partire dagli anni Novanta, della guerra civile spagnola all’interno del romanzo neo-storico nostrano, pone altri interrogativi: perché d’un tratto lo scenario spagnolo torna ad essere così frequentato? Curreri invita a diffidare dai facili anniversari (il cinquantenario, la morte di Franco) e a ragionare su un aspetto più profondo: se quello spagnolo è stato, in Europa, il fascismo più recente, allora gli anni Novanta – periodo in cui il dibattito sul fascismo e sui (neo)fascismi in Italia è stato costante, dal punto di vista storico e politico – diventano il decennio in cui lo “spostamento” di scenario aiuta i nostri scrittori a riflettere anche sull’attualità italiana. Lucarelli, Tabucchi, Baldini, Cacucci, Arpaia, Ramondino (e ne dimentico molti) in modi e con risultati affatto diversi, si cimentano tutti con la guerra del 1936-1939. Certamente vi è un effetto a “rimorchio” dovuto al dibattito suscitato, anche in Italia, dal film Terra e libertà di Ken Loach, ma non si può negare la rinnovata centralità del conflitto spagnolo in queste narrative. Ma, anche qui tranne rare eccezioni, la Spagna potrebbe non essere altro che un pretesto: un modo per parlare e riflettere su noi stessi fingendo di parlar d’altro, senza essere costretti ogni volta a guardarci allo specchio. E il saggio in questione fa lo stesso effetto: parla della Spagna del 1936 ma sembra alludere anche a quella di oggi, nomina Franco e riporta ad un fascismo diverso e ancora più recente. Un libro estremamente attuale nella sua inattualità, si potrebbe concludere, così come la presunta marginalità della tematica spagnola nella narrativa e nel cinema italiani si è rivelata invece di grande utilità per affrontare e rappresentare dinamiche interne all’Italia.
Prove d’ascolto #14 – Simona Menicocci
da Il mare è pieno di pesci
esiste un tempo ideale
per pescare ciascuna specie
il precetto generale era che si effettuasse
all’alba al sorgere di Sirio
un problema che doveva essere risolto
era / per
la conservazione delle eccedenze
si usava il garum
composta di intestini
mescolati a pesci interi
lasciati
a macerare
al calore del sole
in ogni caso si raccomanda di togliere
le squame e le interiora
non servono
il punto di cottura ideale si raggiunge
quando gli occhi schizzano fuori
e la pelle si stacca
toccandola
si aprono margini
di miglioramento
ancora ignoti
tuttavia resistono differenze
assai marcate nella percezione
la congiuntura economica ha modificato le abitudini
i dati
li lasciano spirare lì
lasciano sperare
un’inversione
del trend
che ristabilisca l’abuso a livelli pre-crisi
*
ora le barriere sono corazzate
offrono il migliore esempio di quanto
sia la biodiversità a essere
il problema di fondo è il non essere
in superficie
il biologico è costoso
bisogna poterselo permettere
*
la risposta data dal procuratore è stata questi
pesci
non servono
il recupero non è utile
recupero vuol dire ricordare
qualcosa che è qualcuno che è
stato non riconosciuto
riemersione
a livello della consapevolezza
l’informazione
precedentemente archiviata
mediante richiamo
(recupero mnestico diretto senza stimoli di facilitazione)
o riconoscimento
(recupero mediato da uno stimolo associativo)
ci lasciano la pelle
in ricordo
*
ora i corpi sono dei
insignificanti flottanti
la caduta degli
non è la stessa
non è mai
libera è sempre
grava
su cosa è
la domanda da porsi
per andare fino in fondo
nel pensiero o nel mare
ci vuole coraggio o densità maggiore del mondo
*
(in fondo)
lo spostamento dei corpi dei pesci non è
un’emergenza è la regola
e la norma il modo il principio
il punto di non ritorno
questo non
suscita reazioni
il numero è andato
esponenzialmente aumentando
basta far di conto per capire che
non basta
gli appetiti gli interessi la lotta
(in fondo)
cioè alla base
di tutto
c’è un giro di liquidi incalcolabile
(questo non
si vede: non
basta)
che vengono dal mare
e vi restano
ora il corpo non solo
il suo concetto
ha trovato il suo fondamento
*
in teoria
l’acqua è composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno
in pratica
nell’acqua che si trova sulla terra sono disciolti innumerevoli
forme di vita
il grado di inquinamento del mare dipende dal grado di eterofobia
per determinarne la presenza
bisogna eseguire controlli biochimici
tanto più bassi sono i valori
ottenuti tanto più alta è la qualità
l’estrazione chimica o fisica di elementi inquinanti non purifica
né l’acqua
le informazioni negative rimangono memorizzate
solo nell’acqua
quindi il concetto di acqua
pura è un’illusione
con ogni sorso d’acqua oltre
agli atomi di idrogeno e ossigeno
entrano nel corpo anche una pluralità
che soltanto in rari casi
possono fungere da sostanze nutritive
nella maggior parte dei casi
questi elementi agiscono
sul corpo come stimoli
che provocano delle reazioni
perciò quando le sostanze non possono
venire decontaminate all’interno dell’organismo
ed espulse all’esterno
possono insorgere
quindi entrano anche quando non
entrano / proprio dentro
ad ogni sorso d’acqua
per sapere non basta
ingoiare / studiare ciò che c’è
di volta in volta / come
un volto diventa sorso
e perchè e per chi / cosa
altro / non sapere
ad esempio: il deserto del Sudan
*
l’acqua presente nell’essere
umano mostra differenze
secondo l’età il tipo di alimentazione
la costituzione
anche se violata
da giovani si è più ricchi
d’acqua soprattutto
nei tessuti molli nella pelle
nei tessuti connettivi e sottocutanei
crescendo il tenore d’acqua si riduce
del resto lo si vede:
il segno
di una pressione esercitata
sulla pelle rimane sulla pelle
visibile più a lungo
l’età biologica
della pelle di tutto
l’organismo si determina dal suo stato
di idratazione
ora stanno ringiovanendo
*
quando nel mare ci sono onde
si dice:
il mare è agitato
da corpi che si agitano
perché non vogliono
i pesci si agitano solo fuori
i corpi si agitano solo dentro
l’onda è una perturbazione
cioè energia che si muove che si propaga
attraverso la materia attraverso
i corpi senza spostare i corpi
le onde prodotte dalla caduta di un corpo
sono formate da creste
(dove l’acqua si alza)
e gole
(dove l’acqua si abbassa)
la superficie dell’acqua dondola
tra cresta e gola
c’è la lingua
le parole prodotte dalla caduta di un corpo
sono formate da creste
(dove la lingua si alza)
e gole
(dove la lingua si abbassa)
ora la lingua è l’acqua
che inghiotte acqua
ora l’acqua è la lingua
che dice lingua
l’evento è una cosa che accade
all’esterno all’interno del corpo
il corpo è una cosa che cade
all’esterno all’interno del mondo
(in fondo)
per capire per conoscere per sapere
bisogna andare
a fondo
eppure
non è possibile
quindi
bisogna immaginare
il fondo
è la parte più profonda più lontana
rispetto all’osservatore
all’inizio c’era ora c’è
ancora
acqua
vuol dire
non sempre
la natura non si ferma
mai
davanti a nulla
è facile spaventarsi
facile vuol dire umano
ora sono difficili
perché non vogliono
quindi sono
*
chi cerca trova
corpi
chi pesca pesca
pesci
ma anche il pesce è / ha
un corpo
si usa la stessa parola per dire
cose differenti
perché la lingua è imprecisa
perché ci sono sempre cose
in comune tra cose
differenti
ora sono riversati perché sono
diversi
ma se fossero diversi
non andrebbero / vanno
(in fondo)
come ogni altro
vengono dal mare
e vi restano
alcuni gli altri vengono
restati
(in fondo)
si possono costruire
fondi anche in superficie
per capire
non basta saper leggere
l’ultima sillaba
della superficie
serve a dire che è
peggio
di così si
muove
solo chi guarda
chi non guarda chiude a chi
fa acqua / parte dell’accadere
che fa acqua / parte del mondo
che si divide in fatti venne
diviso a tavolino
*
fuori dal mare
si può scegliere
dove andare / restare
ma non tutti
possono andarsene / ma tutti
prima o poi se ne vanno
se fare il bagno / un falò
prendere il sole / giocare
a beachvolley a racchettoni / giocare
è solo un modo per ammazzare
il tempo
è una capacità
del corpo di percepire / vedere
le bocche aperte
a squarciagola
se non c’è possibilità di parlare
per alcuni con alcuni
bisogna parlare
dell’impossibilità
di questi alcuni con alcuni
scrivere attorno a un non
stato liquido diluendo dentro
cosa causa cosa / perché / come
se il come è il cosa
ciò che non può uscire
dall’acqua deve essere
ripescato
dalla memoria nella memoria
anche se la memoria
non c’entra la falla
del ragionamento è troppo grande
è troppo debole la forza
del pensiero che non usa il pensiero
ma la forza
necessaria per respingere
un corpo ritenuto negativo può essere
calcolata solo a
partire da un luogo negativo
verso un luogo diversamente
negativo
dove i corpi ritenuti
vengono de
ora sono
finiti
dentro
altro
luogo / tempo / acqua / storia
paralleli coesistenti contigui
mondi perché non si toccano
si sfiorano
restano confinati
*
ora vengono
letti di sfuggita
sono fuggiti
neanche tutti
manca la pazienza
la capacità di tenere
il nome il numero
del corpo degli altri
è sempre troppo grande
i pesci non sanno
contare
verso l’infinito è oltre
la capacità di vedere
il totale
è come un pesce
non sta mai fermo
si muove / viene
mosso spostato
nel conteggio nel mare
il tempo il conto
avanza senza senza
non avanza nulla
cioè non resta
nulla se non
le cifre sono solo 10
le lettere sono: dipende dal sistema
variando l’ordine degli elementi
il risultato è l’infinito
cambiamento
l’aumento
dei corpi nel mare
indica una diminuizione
dei corpi fuori dal mare
il mancato
soccorso è determinato
determina il mancato
aumento è determinato
dalla mancata
immaginazione
o specchio nella testa
della maggior parte delle teste
che sono fuori solo
per caso
chiunque potrebbe essere chiunque
altro da ciò da chi da dove da quando
è e se è un privilegio il privilegio / il fuori
il potere è sempre atto
di minoranza su qualcosa di maggiore
quantità vuol dire tutto
ciò che può essere misurato
dentro è privo
in sé
in fondo
i diritti vanno inseriti
da fuori indentro
uno per uno per ogni
sono senza parole
*
non avendo potuto
salvare altro d’altro
si può:
fare il conto
alla rovescia anche del rovesciato
salvare il solvibile
al meno
anche con le date / i dati
mancanti
alla rovescia vuol dire al contrario
di come dovrebbe
essere / a ritroso vuol dire contrario
di diritto cioè senza
anche i pesci piangono / infatti fanno
un suono non regolare o rumore bifonico
che produce due diverse onde simultanee
il suono bifonico è una tecnica diffusa
anche fuori dal mare ad esempio
fra i volatili e viene spesso utilizzata nel cinema
per provocare forti emozioni o paura o reazioni
significative nello spettatore come il pianto
ma nel mare è inutile
piangere nel mare / è inutile
piangere anche
fuori dal mare bisogna fare
far corrispondere ad ogni
goccia un suono non regolare
ora sono non sono / vengono
chiamati non chiamati
irregolari
anche i suoni
*
Sulla poesia grammaticale. Una lettura ravvicinata di Il mare è pieno di pesci di Simona Menicocci
di Andrea Inglese
Il problema di Simona Menicocci è quello di molti di noi, che scrivono poesia diffidando della poesia, non credendo nella poesia, ma anche avendo letto delle poesie che mostrano vie possibili, che suscitano desiderio di, e infondono forza per per scrivere delle nuove poesie nonostante tutto. Prima della ricerca, prima delle scritture, delle pratiche molteplici, delle strategie offensive e difensive, dev’esserci comunque stato, per molti di noi, forse anche per Simona Menicocci, un desiderio di poesia proprio perché era poesia, per una fede nel verso, nell’espressione individuale, nel discorso elaborato per distinguere colui che ne è l’autore, locutore non ordinario, speciale. Ma Simona Menicocci ha fatto un suo percorso che le permettesse di non scrivere poesie, confidando in una sorta di assodata, familiare, tranquillizzante ideologia, per cui l’individuo ha qualcosa d’inconfondibile da esprimere, e quello che esprime è in realtà una universale risonanza con il mondo. Potremmo definire questa ideologia paradigma espressivistico, anche per darle una profondità storica e uno spessore teorico che vanno ben al di là delle vicende più ristrette e tutto sommato tempestose dell’io lirico. L’io lirico è reso possibile dal paradigma espressivistico, ma anche manifestazioni poetiche radicalmente diverse dall’io lirico possono ovviamente rifarsi al paradigma in questione. (La migliore definizione di questo paradigma, su di piano sia filosofico che di storia delle idee, è probabilmente rintracciabile in Charles Taylor). Simona Menicocci non crede in questo passaggio per un’interiorità individuale, deposito di emozioni intense, ricordi fondamentali, idee eccezionali, schegge di narrazioni autobiografiche, deposito che, ovviamente, un lavoro di espressione linguistica dovrebbe valorizzare, in modo da estrarre da esso una qualche autentica significazione generale, o un qualche ipersignificato che dovrebbe soppiantare i significati generali ormai inautentici, usurati, vuoti. Il problema, più volte ricordato fin dagli inizi del novecento e penso in particolare ai dadaisti, è che il lavoro espressivo individuale è innanzitutto un lavoro di distinzione sociale. La poesia, nei secoli dei secoli, e nei giorni di tutti i giorni, è anche una pratica di distinzione sociale, una pratica per non dire le cose così come sono dette quotidianamente nei diversi contesti d’enunciazione, e per dirle invece in modo più potente, efficace, per far sì che il poeta-locutore possa affermare la sua superiorità rispetto alla massa dei locutori che impiegano la lingua passivamente e in modo approssimativo. Questa pretesa di distinzione ha però un suo esito paradossale di cui Simona Menicocci è ben consapevole: la parola poetica rischia di diventare la parola eufemistica per eccellenza. Volendo a tutti i costi affascinare, ammaliare, il suo destinatario, essa è spinta a travestire tutto ciò che è ripetitivo, monco, aspro, idiota, insignificante. La poesia non sarebbe, allora, il discorso intransitivo tanto caro da certi formalisti fino a Barthes, ma un sistema di parafrasi rovesciato, un discorso come quello burocratico, di sostituzione del semplice e comune con il raro e ricercato. Questa critica del dire poetico è implicita nel testo di Simona Menicocci e probabilmente ne è addirittura uno dei motori. Ma non si tratta di una critica “fatta dall’interno”, come spesso è avvenuto nelle avanguardie o nelle neo-avanguardie. Non si tratta di sostituire un repertorio lessicale ormai vintage, in bianco e nero sfumato, con uno all’ultimo grido, tutto colori saturati e contrasti. (Mossa d’impatto, ma anche di corto respiro, dai futuristi ai poeti neo-pop degli anni Novanta in Italia, che disseminavano nel verso marche di oggetti di consumo come Pascoli nomi specifici d’alberi e uccelli). Neppure è sufficiente l’opzione a-grammaticale, che include diverse azioni di dissesto del dire poetico, tutte però tese a conservarne in qualche modo il prestigio. La poesia di Simona Menicocci è invece, mi sembra, risolutamente grammaticale, perché vuol bene alla grammatica, con un affetto filosofico, ovviamente, e da secondo Wittgenstein, quello che si è ormai convinto che il linguaggio non vada riformato, ma solo adeguatamente descritto. Nel testo Il mare è pieno di pesci la grammatica viene rispettata, in quanto essa porta il mondo, e lo porta in modo plurale, perché qui stiamo parlando della grammatica dei giochi linguistici, ossia della irriducibile pluralità del linguaggio e della sua architettura, che rispecchia d’altra parte la pluralità delle pratiche e degli agganci di mondo che esse costituiscono. Essendo grammaticale, la poesia di Simona Menicocci, è anche oggettivista, per rimandare a una categoria oggi beneamata e che fa tendenza, anche se risale agli anni Trenta del secolo scorso e a una piccola cerchia di poeti statunitensi. Ma in realtà noi usiamo una simile categoria non in modo filologico, ma per indicare un’opzione di fondo, per rivendicare la materialità del mondo prima delle fantasmagorie della lingua. La lingua, lo sappiamo, è anch’essa mondo, una parte di esso, e alcuni autori preferiscono la lingua-oggetto al mondo-oggetto. Non è il caso di questo testo, dove il lavoro non è fatto a livello di cellula micro-testuale, tale per cui la parola diventa un elemento opaco, una sorta di cifra archeologica, sganciata dai tessuti sintattici e grammaticali che dovrebbero fornirle trasparenza e valore di rinvio (qui penso, ad esempio, a certa produzione poetica di Marco Giovenale). Il lavoro di Menicocci, invece, si realizza nella disgiunzione e congiunzione di piani discorsivi, che normalmente viaggiano separati, in quanto delimitano ambiti d’intelligibilità radicalmente diversi. Questo permette al lavoro di Simona Menicocci di penetrare nei tessuti delle pratiche umane in maniera vasta e trasversale, ampliando la nozione di oggettivismo, e non limitandolo alla sedimentazione del segno linguistico ormai avulso dai suoi contesti d’enunciazione. Il mare è pieno di pesci è un testo che parla di mare, di pesci, di pesca, di modi di cucinare il pesce, degli ecosistemi marini, dei mercati mondiali del pesce. Non siamo ovviamente in un poema didattico settecentesco neppure però in un’operazione di puro straniamento manualistico, come quello messo in opera, ad esempio, da Michele Zaffarano in un libro come Cinque testi tra cui gli alberi (più uno). Le operazioni attuate da Il mare è pieno di pesci sono almeno di quattro tipi: la trasposizione di discorsi ordinari nella forma spezzata del verso libero, l’interferenza tra diversi ordini del discorso, le ambiguità semantiche che si costituiscono tra le estremità di questi discorsi, un discorso implicito, che funge da intruso e da estraneo nelle pieghe dei discorsi manifesti.
Operazione del primo tipo:
in ogni caso si raccomanda
di togliere le squame e le interiora
non servono
il punto di cottura ideale si raggiunge
quando gli occhi schizzano fuori
e la pelle si stacca
toccandola
Il taglio del verso e l’incolonnamento verticale hanno contribuito a un fenomeno di semplice straniamento rispetto a un materiale linguistico assai familiare come quello relativo a una ricetta di cucina. Ad accentuare il fenomeno, il buco o salto sintattico tra i due blocchi di versi. Già questa semplice operazione susciterebbe una serie di considerazioni. Essa è inscritta in una traduzione novecentesca, ma può assumere diversi significati. Il prelievo di frammenti dalla lingua comune, non-letteraria, può essere fatto in modo da esaltare il contesto letterario (stilistico) all’interno del quale avviene l’innesto (paradigma poundiano) oppure per interrogare criticamente questo contesto (paradigma neoavanguardista). In Menicocci, il gesto manifesta intanto un tranquilla consapevolezza che la presa sulle cose e sul mondo non è prerogativa della speciale lingua poetica, della lingua letteraria, ma è inscritta inevitabilmente nella lingua d’uso, che ancora una volta si differenzia secondo le faglie molteplici delle pratiche umane. Una ricetta di cucina veicola una conoscenza specifica del mondo, di quella parte del mondo che l’uomo trasforma per renderla gradevolmente commestibile. L’obiettivo qui è duplice: parlare di pesci per non parlare di uomini annegati, ma parlare di pesci parlando propriamente di pesci, ossia inserendo quegli apporti della lingua comune che fanno presa su quella sfera di mondo. E il prelievo, inoltre, permette o favorisce un riconoscimento della ricchezza cognitiva della lingua comune, del suo carattere appropriato e ben funzionante.
Veniamo alla seconda operazione. L’interferenza tra ambiti discorsivi diversi avviene nel macrotesto ed è grosso modo scandita dalle sequenze di testo separate dagli asterischi. Il tema esplicito, “i pesci e il loro ambiente naturale”, rimane lo stesso solo in apparenza, in quanto slitta costantemente verso direzioni più specifiche, che possono riguardare l’inquinamento o il tasso di acqua presente nell’organismo umano. Ciò produce un fenomeno di “sorpresa”, che costituisce tradizionalmente uno dei criteri del poetico, ma tale sorpresa non è affidata al potenziamento dello stile (ricercatezza lessicale, incremento di figure retoriche), bensì al montaggio discorsivo della lingua d’uso. Montaggio che, è bene ricordare, non funziona solo in termini negativi e critici, ma anche in termini positivi e conoscitivi. L’interferenza, però, può avvenire e con grande efficacia anche a livello microtestuale, come questi due blocchi di versi mostrano.
la superficie dell’acqua dondola
tra cresta e gola
c’è la lingua
le parole prodotte dalla caduta di un corpo
sono formate da creste
(dove la lingua si alza)
e gole
(dove la lingua si abbassa)
Qui abbiamo un esempio d’invenzione poetica, che nessun prelievo, montaggio, cut-up può sostituire; si tratta di un montaggio orientato, di un’interpolazione calcolata al millimetro. Il testo produce una nuova tipologia d’oggetto, un inedito meccanismo ondulatorio, una sorta di “enunciazione-onda”. E tale tipologia produce i suoi effetti semantici particolari, che si aggiungono a cascata a quelli già prodotti dalle interferenze macro-testuali.
Terza operazione, che deriva direttamente dalla precedente. Leggiamo questo passaggio che chiude una delle sequenze testuali tra asterischi.
l’età biologica
della pelle di tutto
l’organismo si determina dal suo stato
di idratazione
ora stanno ringiovanendo
Qui non abbiamo semplicemente un oggetto ibrido da un punto di vista semantico, ma una ben calcolata ambiguità, un’oscillazione semantica tra il penultimo blocco di testo e il verso finale. Il penultimo blocco di testo è la continuazione di un inserto di discorso scientifico, che evoca la correlazione tra processo d’invecchiamento e disidratazione dell’organismo umano. Bisogna dunque comprendere come questa legge di natura possa essere associata alla descrizione di un fenomeno innaturale e apparentemente assurdo: “ora stanno ringiovanendo”. La soppressione del soggetto rende dubbia sia l’attribuzione dell’atto di ringiovanire sia il significato di questo atto. Il lettore è costretto qui a sospendere la sua lettura, la sua lettura di coscienza tranquilla, per interrogarsi su quale sia la strategia implicita che organizza il testo che sta leggendo. Capisce, insomma, che i conti non tornano, che vi è un dato mancante, e questo buco nel testo getta comunque un ombra, che finisce per essere decifrabile, come accade in un processo di comprensione indiziario. E siamo giunti alla quarta operazione, che è quella del significato “intruso” e “velato”. Esso potrebbe essere espresso dal titolo implicito che sovverte quello esplicito, e determina l’architettura globale dell’intero testo, ossia Il mare è pieno di (esseri umani) annegati. In nessuna parte del testo si parla in modo esplicito di migranti, di barconi, di scafisti, di stragi del mare. Eppure il testo di Simona Menicocci parla proprio di questo, di questo tema d’attualità, di questo tema di cronaca giornalistica, di questo tema politico, che sta caratterizzando il profilo storico di un’istituzione interstatale come l’Unione Europea e, nel contempo, il profilo etico delle popolazioni che ne fanno parte.
La comprensione avviene qui in controtempo rispetto ad ogni evocazione patetica. Simona Menicocci si permette semmai dello humour noir, evocando il “ringiovanimento” dei corpi annegati e invasi d’acqua. Più in generale, il tema degli annegamenti dei migranti che tentano di raggiungere l’Europa via mare appare come i contenuto rimossi dall’inconscio, per intrusioni impreviste, per lapsus. E potremmo ben dire che tutto il tema manifesto dei “pesci nel mare” è costantemente, quale che sia il versante discorsivo da cui lo si abborda, minacciato, minato, da un significato nascosto, che si legge appunto tra le righe, nei buchi semantici del testo, nelle sue impreviste e sorprendenti ambiguità. Il tema che la deliberazione politica esorcizza, e che la coscienza collettiva rimuove, finisce per circolare come disturbo in ogni ramificazione discorsiva che riguarda l’incruento e pacifico tema dei pesci e del mare. Fondamentalmente Simona Menicocci non vuole scrivere una “poesia civile”, una poesia di denuncia, ma neppure vuole rinunciare a parlare di questo mondo, del mondo storicamente determinato nel quale vive. Sarebbe importante comprendere le ragioni del rifiuto di “una poesia civile”, ma il discorso è troppo ampio per affrontarlo qui. Sospetto che ci si trovi di fronte a un vecchio dilemma, che perturba da capo a piedi tutta l’arte novecentesca fino a noi. Mettere in figura aiuta, permette la comprensione. Ma quanto una figura, mentre lo suscita, anche l’avvilisce, il moto di comprensione, mentre lo sollecita anche lo limita, lo svia, lo corrompe? La figura non fornisce uno specchio esatto e fedele del mondo, ma dei criteri di comprensione e interpretazione, criteri soggetti all’ideologia e all’usura, ad esempio. Nel nostro caso, scrivere una poesia civile significa operare all’interno di un quadro di figurazione già parzialmente dato, e che Simona Menicocci ritiene probabilmente inefficace. Piuttosto che mettere in figura una realtà poco conosciuta, meglio rifiutarsi alla figurazione. E costruire il proprio discorso poetico intorno a questo vuoto di figurazione. Lo dirò in termini ancora più chiari: il poeta che si pretende civile, che pretende di risvegliare le coscienze, che vuole denunciare fenomeni sociali gravi e scandalosi, si ritrova per altri versi sullo stesso terreno figurativo di tanti altri soggetti che denunciano, dai giornalisti agli stessi politici, ed è quindi invischiato negli stessi stereotipi, nei medesimi scorci narrativi, ipnotizzato dallo stesso repertorio d’immagini video. Mi sembra che Il mare è pieno di pesci si faccia carico consapevolmente di questo limite, che è un limite interno alla parola poetica. E nello stesso tempo, se ne faccia carico con spirito non semplicemente denigratorio e di rinuncia, ma appunto elabori forme di scrittura più consapevoli, dove il progresso conoscitivo risulta evidente nella capacità di rendere tema della propria scrittura simultaneamente il proprio oggetto storico e mondano, e le forme di descrizione e narrazione di cui culturalmente disponiamo per comprenderlo e rapportarci ad esso.
*
Prove d’ascolto è un progetto di Simona Menicocci e Fabio Teti
una rete di storie festa di Nazione Indiana 2017
 Nella sua storia lunga ormai ben 14 anni Nazione Indiana ha pubblicato più di 10.000 articoli di critica, racconti, poesia, traduzione di inediti e saggistica con quasi 150.000 commenti dei lettori, spesso in appassionate e agguerrite discussioni. La Redazione, composta attualmente da 25 membri, vivendo in uno spazio virtuale fra Italia, Francia, Inghilterra e America, dal 2010 ogni anno sente il bisogno di organizzare un evento festa-convegno, per calarsi nella realtà, guardarsi in faccia, sentire le voci, suscitare dibattiti dal vivo. Quest’anno ha scelto la moderna cornice della ⇨ Mediateca Montanari di Fano, che sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017 le ha aperto i suoi spazi con grande disponibilità. L’evento UNA RETE DI STORIE, realizzato grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Biblioteche del Comune di Fano e della Mediateca Montanari-Memo, storie raccontate in rete, che “fanno rete” tra di loro e con il mondo, si articotla fra appuntamenti più specificamente letterari e temi di attualità. Dei numerosi redattori parteciperanno Gianni Biondillo, Francesco Forlani, Andrea Inglese, Helena Janeczek, Renata Morresi, Orsola Puecher, Jan Reister, Giacomo Sartori, Antonio Sparzani, Maria Luisa Venuta.
Nella sua storia lunga ormai ben 14 anni Nazione Indiana ha pubblicato più di 10.000 articoli di critica, racconti, poesia, traduzione di inediti e saggistica con quasi 150.000 commenti dei lettori, spesso in appassionate e agguerrite discussioni. La Redazione, composta attualmente da 25 membri, vivendo in uno spazio virtuale fra Italia, Francia, Inghilterra e America, dal 2010 ogni anno sente il bisogno di organizzare un evento festa-convegno, per calarsi nella realtà, guardarsi in faccia, sentire le voci, suscitare dibattiti dal vivo. Quest’anno ha scelto la moderna cornice della ⇨ Mediateca Montanari di Fano, che sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017 le ha aperto i suoi spazi con grande disponibilità. L’evento UNA RETE DI STORIE, realizzato grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Biblioteche del Comune di Fano e della Mediateca Montanari-Memo, storie raccontate in rete, che “fanno rete” tra di loro e con il mondo, si articotla fra appuntamenti più specificamente letterari e temi di attualità. Dei numerosi redattori parteciperanno Gianni Biondillo, Francesco Forlani, Andrea Inglese, Helena Janeczek, Renata Morresi, Orsola Puecher, Jan Reister, Giacomo Sartori, Antonio Sparzani, Maria Luisa Venuta.
“Dare tempo al tempo”, un’antologia tematica della poesia novecentesca
 [Segnalo con colpevole ritardo questa iniziativa editoriale interessante. Alma Gattinoni e Giorgio Marchini hanno curato un’antologia dal titolo Dare tempo al tempo. Variazioni sul tema della poesia italiana del Novecento (Giulio Perrone editore, 2016). Nell’intento dei due curatori, che hanno una lunga esperienza d’insegnamento nella scuola secondaria, vi è senza dubbio anche un aspetto pedagogico. E un approccio alla poesia attraverso un tema fondamentale come quello del tempo risulta particolarmente fecondo.]
[Segnalo con colpevole ritardo questa iniziativa editoriale interessante. Alma Gattinoni e Giorgio Marchini hanno curato un’antologia dal titolo Dare tempo al tempo. Variazioni sul tema della poesia italiana del Novecento (Giulio Perrone editore, 2016). Nell’intento dei due curatori, che hanno una lunga esperienza d’insegnamento nella scuola secondaria, vi è senza dubbio anche un aspetto pedagogico. E un approccio alla poesia attraverso un tema fondamentale come quello del tempo risulta particolarmente fecondo.]
Dalla postfazione dei curatori, Per un alfabeto poetico del tempo.
Dare tempo al tempo raccoglie, intorno a un grande tema poetico, filosofico e umanissimo, come quello del Tempo, centotrenta autori italiani del Novecento (il più “vecchio è Pascoli, i più “giovani” sono nati oltre la metà degli anni Sessanta), rappresentati ciascuno da un solo testo e proposti in sequenza alfabetica.
Il mondo di Fiorino: autunno
di Antonio Sparzani

Erano i mesi dell’autunno nebbioso. La quarta ginnasio era passata e Fiorino frequentava la quinta con qualche difficoltà iniziale. Stranezze, pensava suo padre, non abituato a dover firmare brutti voti. Il fatto è che Fiorino perdeva tempo, talvolta come in trance, e poi usciva spesso e aveva cominciato a vedere degli amici nuovi, conosciuti tramite Ernesto. Susa era sparito ed Ernesto si portava dietro spesso un paio di altri ragazzi della sua età che parlavano diversamente e che, in particolare nei confronti di Fiorino, nettamente il più giovane del gruppo, mostravano una specie di affettato paternalismo. Si vedevano nei tardi pomeriggi, bighellonavano per le strade di San Bruno, sotto i portici, ma anche nelle stradette oltre il duomo, vicino al lungolago. Fiorino stava spesso zitto, ad ascoltare e a pensare; pensava qualche volta per conto suo e qualche volta a quel che dicevano gli altri; diceva cose convenzionali, forse per paura di sbagliare, non erano persone alle quali aprire l’animo, come a Franco o a Giancarlo. E tuttavia Fiorino amava la compagnia, quel chiacchierare fitto nella luce filtrata dell’autunno, quei passi che ogni tanto si fermavano per capire meglio cosa si stava dicendo. Non c’era il rumore delle auto nelle zone dove andavano, c’erano dei nuovi mondi di conoscenza che facevano finta di essere da grandi, che imitavano le mosse dei grandi discorsi senza averne lo spessore, che tuttavia qualcosa agitavano nella mente, come un rimestamento in un magma informe per far affiorare ogni tanto una forma definita.
Questi nuovi compagni di strada erano il Meme, piccoletto, sempre infagottato in un cappottino marrone a spina di pesce e poi Corrado, il maggiore d’età, più alto e con un soprabito grigio a doppio petto, sempre dritto sulla persona, spalle indietro, capelli tirati e radi sul biondo cenere, che parlava con un tono pacato e sicuro. Parlava però degli amorazzi che aveva sentito dire a San Bruno e di come fosse sfortunato tizio ad essersi imbattuto nella tale nel momento sbagliato. Quando qualche parola veniva detta, che qualcuno dei grandi pensava potesse offendere le orecchie ancor giovani di Fiorino, gli veniva chiesto scusa, così, quasi per vezzo. Fiorino sorrideva imbarazzato, assicurando che non si turbava per questo e non sapendo bene poi cosa dire, tanto gli sembravano poco naturali tali scuse.
Un pomeriggio, con già l’invito del crepuscolo, incontrarono un ragazzo più vecchio di tutti, Alberto, forse già sui venti, che non andava più a scuola, era impiegato in qualche ufficio. Era di quelli che parlavano fitto, un po’ tra i baffi neri e corti e faceva lunghi racconti. Era triste quella sera e spiegò a tutti perché. Era morto giovane un suo caro amico, che anche gli altri vagamente conoscevano di vista, era uno di San Bruno che girava nell’ambiente della parrocchia. Quel che in particolare sconvolgeva Alberto era che solo poche sere prima di quell’avvenimento erano stati a chiacchierare e l’amico gli aveva parlato della vita e della morte, così, come spesso si faceva allora a vent’anni, con una sorta di tranquillo turbamento, come se fosse una cosa naturale; e veramente lo era, si disse Fiorino che quel pensiero l’aveva spesso. Fiorino in realtà credeva di essere lui un po’ strano a pensare così spesso alla morte e a tutto quello che la circonda, ma scoprì in pochi momenti che non era poi tanto strano. Si dipanò subito un discorso tra tutti, su quest’argomento così insolito, nel quale alcuni ruoli della piccola compagnia vennero rovesciati. Corrado aveva poco da dire, Ernesto parlò invece della sua nonna e di come l’aveva trovata una mattina dolcemente addormentata; il Meme si accalorò sulla questione dell’al di là e di dove si sarebbe poi andati e Fiorino, che aveva la triste esperienza della sua mamma che se n’era andata da pochi anni, arrivò a raccontare dei pensieri che quasi mai aveva raccontato perfino a se stesso. Pensieri sulla tristezza di vedere quelle casse, con quel che contenevano, nascondersi un po’ alla volta in terra, o infilarsi in un loculo di quella pietra che sembra sempre bianca e sporca dei cimiteri, ma anche pensieri di comunicazione con i “propri morti” – così egli li chiamava dentro di sé – come con dei mediatori di un dialogo con se stesso che trovava così uno sbocco più scorrevole. Questa possibilità che quella sera gli venne casualmente offerta di tirar fuori un grumo di riflessioni assai raramente comunicate fu vissuta da Fiorino come una affermazione di sé e della propria identità, di cui, più nascostamente ma anche più testardamente di altri, sempre andava in cerca.
Si sentì esistente; pensò se stesso pensante – usò dentro di sé questa formula appena appresa da qualche insegnante filosofo – e fece un altro passo dentro la vita. La luce dei lampioni di San Bruno, di solito così fioca, sembrava più invitante, la nebbia più amica e Fiorino propose, inauditamente, di entrare in un caffè, pensando con tremore che le poche monete che tastava con le dita in tasca sarebbero forse state sufficienti per un caffè macchiato.
Gli amici, vagamente stupiti, accettarono e trovarono un tavolo intorno al quale potersi sedere, per scaldarsi e raccontarsela il più a lungo possibile. Si sentivano più uguali quella sera, la morte, che già rende uguali dopo, aveva operato la stessa cosa anche prima, bastava parlarne tirando fuori quei pensieri fissi che, senza che normalmente apparisse, ognuno aveva.
Quando uscirono dal caffè, nelle stradette illuminate dalla nebbiolina del crepuscolo che saliva dal lago, si rimisero a camminare, scambiando solo poche battute, ognuno assorbito da quel giro di discorsi che erano emersi anch’essi forse dal lago. Alberto, che aveva innescato la discussione, pareva imbarazzato per l’interesse che i suoi racconti avevano risvegliato, mentre il Meme ruminava tra sé e sé poche incomprensibili parole. Neppure Ernesto riusciva a sfoggiare qualche pensiero chiaro e distinto.
Fiorino rifletteva inorridito che la morte di sua madre gli aveva permesso ora un ruolo insolitamente alto nella discussione con gli amici; che poi tanto amici non si potevano neppur dire – Fiorino stava sempre molto attento all’uso di quella parola – tranne Ernesto, s’intende. Gli altri erano come interlocutori che avevano però il pregio di schermare la presenza talvolta ingombrante di Ernesto, e di creare un contesto nel quale Fiorino s’era sentito libero, e anzi spinto, a mostrarsi.
Era ora di andare a casa per Fiorino, che doveva rispettare orari un po’ più rigidi degli altri. Si congedò con maggior sicurezza del solito e si avviò per la salita con un passo più certo.
Tu se sai dire dillo 2017. VI edizione

TU SE SAI DIRE DILLO 2017
VI EDIZIONE
5, 6 e 7 ottobre
Rassegna a cura di Biagio Cepollaro
La VI edizione di Tu se sai dire dillo si svolgerà presso la Libreria Popolare di via Tadino e si articolerà intorno ai temi: “La poesia di Giuliano Mesa”; “Il lavoro delle riviste il Verri e L’ulisse“; “La poesia di Giulia Niccolai”; “Le collane editoriali ‘Autoriale’ e ‘Perigeion’ della Dot.com Press”; “La questione della drammaturgia poetica e della creazione politica”; “La mostra di pittura di Biagio Cepollaro Piccola Fabrica con una nota di Dorino Iemmi”
Giovedi 5 ottobre 2017
ore 18.30
Inaugurazione della Mostra di pittura di Biagio Cepollaro Piccola fabrica dedicata a Giuliano Mesa
Biagio Cepollaro e Gianni Montieri leggono Giuliano Mesa
Italo Testa e Stefano Salvi: la rivista Ulisse
Legge Giulia Niccolai
La rivista il Verri
Con interventi di Paolo Zublena e Angelo Petrella
Venerdi 6 ottobre 2017
ore 18.30
Creazioni politiche
A cura di Pino Tripodi e Jacopo Galimberti
Chi è l’autore
Giuseppe Carrara e Giovanni Renzi
La Collana Perigeion: Nino Iacovella, Christian Tito, Giusi Drago in conversazione con Luigi Metropoli
I racconti di Giorgio Mascitelli
Sabato 7 ottobre 2017
ore 18,30
La rivista Levania
A cura di Eugenio Lucrezi
Carmine de Falco,Bruno di Pietro, Emmanuel di Tommaso , Paola Nasti, Marisa Papa Ruggiero
Antonio Perrone, Enzo Rega e Enza Sivestrini.
La collana Autoriale
Andrea Inglese: l’autoantologia.
Peli di Francesco Forlani , Fefè, 2017 –
Drammaturgia poetica
a cura di Laura Di Corcia e Vincenzo Frungillo.
Horacio Quiroga: la vita come un crimine
di Mauro F. Minervino
 Esiste su Horacio Quiroga un giudizio lapidario, e forse un po’ malevolo, formulato da J.L. Borges nel 1945: «Ha scritto racconti che aveva scritto meglio Kipling». Non esattamente una riduzione, però. Essere secondi a Kipling non avrebbe dovuto offendere il talento letterario di nessuno, specie se una simile graduatoria fosse stata stilata da un genio della letteratura universale come Borges.
Esiste su Horacio Quiroga un giudizio lapidario, e forse un po’ malevolo, formulato da J.L. Borges nel 1945: «Ha scritto racconti che aveva scritto meglio Kipling». Non esattamente una riduzione, però. Essere secondi a Kipling non avrebbe dovuto offendere il talento letterario di nessuno, specie se una simile graduatoria fosse stata stilata da un genio della letteratura universale come Borges.
In realtà già il «New York Times», in un articolo del 25 ottobre 1925, salutava Quiroga come ´il Kipling sudamericano». Si trattava, quindi, anche per lo stesso Quiroga, di un riconoscimento ben più che gradito. Infatti Kipling, assieme a Poe, Maupassant e Čechov, sono esplicitamente, il lettore ne troverà conferma anche leggendo queste sue pagine di racconti, i maestri amatissimi («come Dio stesso») che Quiroga richiama puntualmente in pagina in tutti i suoi racconti. Tuttavia, Quiroga, tutt’altro che un epigono, rivolta a suo modo i modelli di questi narratori e li adatta al suo mondo, alla geografia e alla temperatura sentimentale e morale del Nuovo Mondo, ai rigori e ai misteri animistici e ribelli delle foreste tropicali e delle pampe umide. A dire la verità Conrad con i suoi racconti di epica marinara sta agli oceani, all’epopea del mare e alla moralità della vecchia Europa coloniale, come Quiroga starà invece alla torrida e brutale natura del continente sud americano, alla mescola del sangue, agli intrichi vitali dei suoi popoli impulsivi e malinconici, alla vita indominabile delle insidiose e impenetrabili foreste pluviali, al fluire inarginabile dei grandi fiumi amazzonici come il Paraná. Quiroga – che una volta abbandonate Montevideo e Buenos Aires, vivrà buona parte della sua vita lontano dalle grandi città e a contatto con la selva –, capisce che si può prendere l’arte europea del racconto e spostarla di civiltà, trapiantandola e rimetterla con i piedi per terra nell’humus sfarzoso e venefico dell’altrove naturalistico e sociale rappresentato da una civiltà ibrida e ancora aurorale com’era quella dell’america ispanica. “Quiroga cerca l’altro, tanto nel fantastico e nell’orrore quanto nella vita di frontiera e della selva, nell’uomo e nelle belve, nella natura e in città. Sempre sul margine. All’esterno nel mondo, all’interno nel sentire e nello scrivere” (Ernesto Franco).
Non è certo un caso che, oramai a distanza di quasi un secolo da fatti e circostanze biografiche, il lascito letterario di Horacio Quiroga sia unanimemente riconosciuto come il patrimonio di un maestro maggiore della forma breve e del racconto metafisico; il narratore che più di chiunque altro ha influenzato intere generazioni di grandi scrittori sudamericani, da Juan Rulfo a Julio Cortázar.
Al di fuori della tradizione letteraria ispano-americana, è ancora oggi abbastanza inspiegabile come la sua opera sia stata finora così trascurata in un paese come l’Italia.
Questa raccolta magistralmente tradotta e curata da Marino Magliani e Luigi Marfè, e qui proposta nella collana Itaca da Pellegrini Editore, colma così finalmente una grave lacuna nel distratto panorama dell’editoria italiana, proponendo in volume i racconti che formano la silloge quiroghiana de Il delitto dell’altro.
Si tratta di racconti di una misura perfetta, intessuti di “amore, follia e morte”, in cui si alternano atmosfere decadenti e crepuscolari, balenanti fra delirio e incubo, le stesse esperienze ai confini della scienza, della natura e del mistero in cui Quiroga ha saputo dar forma ad altrettante, accurate, strutture letterarie tramate di passioni umane sfuggenti e di sentimenti perturbanti. Come la solitudine, il sentimento del tempo e il senso di morte, l’ironia amara, follia e l’incubo, l’esorbitanza delle forze naturali, inconciliabilità dell’eros (discretamente misogino, fu seduttore sempre sedotto da donne fatue, spesso troppo giovani e appariscenti).
Nel gioco funambolico di passioni e insanabili contrasti vitali di cui si nutrì – tradizionalista e conservatore ma innamorato della modernità e dell’esattezza scientifica, appassionato di cinema e di divi del cinema, fotografo dilettante e ciclista, sperimentatore di galvanoplastica, malinconico e fanatico della velocità di auto e motociclette sino al rischio della vita propria e altrui, collezionista di pelli di anaconda e misogino recluso in angolo primitivo alla selva amazzonica – nella biografia di Quiroga campeggia su tutto l’ombra sinistra della morte. Come accade per il racconto che dà il titolo a questa raccolta, Il delitto dell’altro, la vicenda stessa di Quiroga è quella di una vita disseminata di morti e di epiloghi spesso tragici e violenti. Nel 1902, Quiroga aveva ucciso, per errore, con un colpo di pistola partito accidentalmente, uno dei suoi migliori amici, lo scrittore Federico Ferrando. La sua vita, ne fu sconvolta, e sarebbe restata per sempre avvolta dalla semioscurità della tragedia e dal ripetersi luttuoso del caso.
Già di morte violenta, quando Quiroga aveva solo pochi mesi, era morto il padre, vittima di un altro fatale incidente con le armi da fuoco. Poi perderà anche il patrigno, che si spara un colpo in testa. La prima moglie Ana María, da cui ebbe due figli, nel 1915, dopo una lite furiosa, si avvelenò. Sbagliò il veleno, e morì dopo otto giorni di agonia. Infine, risposatosi in seconde nozze, a cinquant’anni sconta l’infelicità della relazione con una ragazza di vent’anni, mentre la figlia di primo letto, amica e coetanea di questa, gli muore suicida. Come se quella della tragedia nella vita di Quiroga fosse una porta sempre accostata sull’abisso.
Un epilogo tragico, e nel contempo araldico, a cui non sfugge il sigillo che lo stesso autore vorrà posare sul finale della sua vita: il 19 febbraio 1937, Quiroga, saputo di essere malato terminale di un cancro alla prostata, si uccide a Buenos Aires ingerendo una capsula di cianuro.
Non lasciò nessun commento, nessuna morale, o indizi, prove che potessero favorire alcuna interpretazione dall’esterno al gesto finale di quella sua vita condotta sul margine, sempre spericolata e triste.
Aveva già scritto prima tutto quello che c’era di scrivere; nulla tranne il suo stile: “la bellezza, e la farsa su noi stessi…, la facoltà di presentarsi a se stessi diversamente da ciò che si pensa, e ammettere che sia possibile”.
Quiroga sapeva bene che tutte le vite hanno lo stesso valore, e che in fondo ìla differenza fra gli umani e le tigri è solo una questione di cuore”.
NdR: questa è l’introduzione di Mauro F. Minervino alla traduzione della raccolta di racconti di Quiroga “Il delitto dell’altro”, a cura di Marino Magliani e Luigi Marfè, e pubblicata di recente da Pellegrini Editore, nella collana “Itaca Itaca”, diretta dallo stesso Minervino
La lingua non ha os ma rompe l’uossa: “Ottativo”, o della nosteoalgia
La terza prova poetica di Daniele Poletti, Ottativo (Prufrock, Bologna, 2016), è un poemetto in cui a una parola non di rado ricercata e complessa, ma in prevalenza metonimica e referenziale, sembra inizialmente corrispondere una paradossale oscurità – se non addirittura un insensato inceppamento della parola stessa – che è invece intensificazione e complessificazione metaforica del discorso scientifico e dei linguaggi settoriali che vi s’intrecciano e che ambiscono, appunto, a dire il mondo, piuttosto che a ritirarsi in una qualsiasi autoreferenzialità rinunciataria. Al di sotto del complesso intreccio di lacerti mnestici e anatomia, botanica, farmacologia, fisica, linguistica, zoologia, eccetera, di cui si sostanzia l’opera, vi è infatti una profonda riflessione sulla lingua, tradotta materialmente in un continuo scavo retorico, etimologico e fonico – poi semantico – che quella parola metonimica va a minare e sovvertire, trasformandola da segno trasparente in segno stratificato – e non oscuro – enormemente lievitato al di là della sua pura accezione terminologica e, pertanto, amplificato nelle sue potenzialità comunicative. Un segno che aspira dunque alla dicibilità e da essa muove, approdandovi però attraverso una sua articolata e lavorata negazione, in una sorta di “dettato non dettabile” (p. 20) che tuttavia non approda mai alla mancanza di significazione.
Prove d’ascolto #13 – Giulio Marzaioli
Il volo degli uccelli
Sine pennis volare hau facilest.
Tito Maccio Plauto, ‘Poenulus’
Lo studio del volo degli uccelli è stato trascurato.
Dal 1961 il volo spaziale occupa il primo posto nell’immaginario aereo collettivo, ma sono gli uccelli quanto di più elevato possa vantare il pianeta.
Lo studio del volo degli uccelli è stato trascurato, considerando che gli uccelli godono di maggior distacco.
Le penne sono leggere e molto elastiche. Il volo, non a caso, è sinonimo di leggerezza.
Le penne si distinguono in remiganti primarie, remiganti secondarie, penne di contorno, piume, semipiume, filopiume, plumule e vibrisse. Tutte concorrono al volo senza darlo a vedere.
Senza darlo a vedere si situava in una zona intermedia. Studiando il volo degli uccelli, gli obblighi dettati dalla quotidianità sembravano corollari alla legge di gravitazione, evocavano la forza peso.
Bisognerebbe badare alle faccende domestiche con maggior distacco e dedicarsi maggiormente al volo degli uccelli, non limitandosi ad osservarne le volute.
Studiava il volo degli uccelli e non badava, anche se una volta si prese cura di un passerotto caduto da un ramo.
In effetti non c’erano particolari motivi perché avesse iniziato a studiare il volo degli uccelli. Il passerotto era caduto da un ramo e lui decise di raccoglierlo. Se ne prese cura e il passerotto sembrava riconoscerlo, ma un giorno volò via e a lui non dispiacque. Il volo contava più del passerotto. Questo era scontato per il passerotto, ma altrettanto non poteva dirsi per lui che certamente era felice per la salute del passerotto e tuttavia non poteva, nel frattempo, non essersi affezionato.
Spesso le temute fratture ossee delle ali sono semplici lussazioni. Spesso le fratture sono solo lussazioni.
Presumibilmente la familiarità con l’elevazione in quota provoca un’attrazione per i pendii montuosi. In montagna occorre prestare attenzione per non incorrere in cadute e fratture. Non è tanto in salita il rischio di caduta, quanto nell’euforia della discesa, quando le gambe sembrano leggere e verrebbe da saltare ignorando la gravità.
Lo studio del volo degli uccelli non può essere considerato un lusso e per alcuni il suo studio diviene una necessità.
Qualche giorno di immobilizzo dell’ala è sufficiente per la formazione del callo osseo. Bisogna tuttavia manipolare il volatile con cura per non danneggiare ulteriormente l’ala o le penne. Danneggiare un’ala di un uccello è più che sconveniente, per coloro che hanno a cuore il volo degli uccelli. In ogni caso danneggiare un’ala è da ritenere un atto sconsiderato.
L’asse della penna è detto rachide. Ai due lati del rachide si presentano due espansioni che, nelle penne vere e proprie, sono una più larga, detta vessillo interno perché più vicino al corpo, e una più stretta, detta vessillo esterno.
Il rachide, al pari di qualsiasi elemento osseo, è strettamente legato al tempo e alla percezione che ne abbiamo, mentre i vessilli lasciano interdetti, essendo sempre pronti a scomporsi e a tornare in assetto, come se la regola del vento fosse impressa nella loro struttura autonomamente. Questo a riprova del fatto che il volo prescinde dall’essere in vita, come dimostra l’ondivago svolazzare di una piuma. Tuttavia soltanto un essere vivente può provare l’ebbrezza del volo.
Volare in aereo è deludente. Raramente gli capitò di prenderne. Dalla quota di volo di un aereo non si apprezza quanto valga la profondità. Tutto si appiattisce scontrato al suolo, pressato da un’indifferenza dominante. Per non parlare della postura. Non si avrebbe posizione orizzontale senza verticale e viceversa. La posizione seduta, invece, tende ad essere fine a se stessa.
Conquistare una parete rocciosa o anche soltanto risalire su una pista da sci dimostra come, differentemente dai volatili, per l’uomo l’elevazione sia strettamente connessa al rapporto con la materia su cui è posato il corpo, sia essa terra, roccia o neve.
Evitare di distruggere. Il contrario di distruggere è ricordare. Manipolare i volatili con cura.
Certamente avere iniziato ad interessarsi al volo degli uccelli pareva costituire ragione sufficiente a proseguirne lo studio.
Costruiva e conservava tutto ciò che gli serviva. Una volta prese un cartone vuoto che conteneva uova e lo trasformò in funivia, usando forbici e spago. Agli occhi di un bambino il marchingegno rappresentava egregiamente il volo, anche se il volo degli uccelli è, evidentemente, un’altra cosa.
Il volo degli uccelli non può essere in alcun modo considerato un lusso. Lo studio del volo degli uccelli non può essere in alcun modo considerato un lusso. I tentativi dell’uomo di costruire marchingegni che permettano il volo non possono essere considerati un lusso. I disegni di quei marchingegni sono stati necessari all’uomo più di qualsiasi opportunità di volare da un luogo ad altro luogo.
I disegni dei marchingegni di volo sono stati necessari fino a quando non hanno consentito realmente all’uomo di volare. Poi sono diventati utili.
Può sembrare facile, ma una cosa è disegnare il volo, altra cosa disegnarlo per volare e riuscire nell’intento.
Quando si conquista il cielo si perde la leggerezza racchiusa nel disegno e non c’è recupero nell’atterraggio, poiché si è mantenuto il peso. Tanto vale non illudere la gravità e rassegnarsi all’assenza di propulsione.
Nel battito d’ala la propulsione e’ provocata dai vessilli interni, più larghi di quelli esterni, nell’alternarsi delle battute verso l’alto e verso il basso affinché siano piegati i vessilli interni verso l’alto, nella semi-battuta dorso-ventre, e venga così spinta indietro l’aria; o verso il basso, nella semi-battuta ventre-dorso, per assicurare comunque la spinta indietro dell’aria. In tal modo il corpo dell’uccello è spinto in avanti. Osservando un uccello volare è innegabile che l’aria costituisca un elemento imprescindibile del volo stesso.
È noto che in alta quota la minor pressione rende più difficile la respirazione. La vetta costituisce l’apice dello sforzo polmonare ed il punto di massima resistenza alla tentazione del volo.
Nel suo caso l’aria costituiva una zona intermedia. Più esattamente l’espressione “a mezz’aria” indica lo spazio che nella sua vita quotidiana si era ritagliato in rapporto alla gravità.
D’altro canto l’espressione “rimanere con i piedi per terra” in taluni contesti può essere priva di senso e comunque è da considerare discutibile. Osservare un’aquila o qualsiasi altro rapace quando cammina ad ali piegate.
Gli uccelli non hanno bisogno di imparare la tecnica del volo e per questo volano con maggior naturalezza rispetto all’essere umano, che in millenni di esperimenti non ha mai veramente capito. Osservare da fermi il volo degli uccelli e fare esperimenti al riguardo senza provare a volare in prima persona. Osservare i disegni dei marchingegni di volo.
Il rischio connesso all’uso della prima persona si percepisce soprattutto grazie al volo, ai tentativi di riprodurre il volo degli uccelli.
A proposito della prima persona viene da chiedersi se sia maggiormente rappresentativo del volo quello in solitario, ad esempio dell’aquila, o quello in stormi, ad esempio delle anatre in migrazione. Ad un’osservazione superficiale si direbbe il volo in solitario, dal momento che il volo in stormi spesso riproduce forme geometriche e quindi riconduce a misure su un piano statico.
Il volo è strettamente connesso ad una falsa percezione del vuoto.
Il vuoto non sostiene. Per quanto variabile, l’aria vanta una densità il cui valore è determinante nella valutazione della portanza e di tale valore dovranno tenere ben conto i piloti d’aereo nelle fasi di decollo e atterraggio.
Disporre di fronte ad un ventilatore alcune piume così come posizionate su un’ala. Così facendo agitava le carte del suo studio.
Le articolazioni della spalla e del gomito hanno una limitata possibilità di rotazione lungo l’asse longitudinale dell’ala; più ampia quella del polso; sommando tuttavia tali possibilità la mano, dalla posizione del ventre rivolto verso terra, nel volo normale può ruotare il bordo esterno verso l’alto e poi indietro di quasi 180°, portando il ventre a guardare il cielo.
Lo studio del volo degli uccelli occupava lo spazio in cui viveva. Una corda annodava la vestaglia.
Faceva tentativi di memoria scrivendo su foglietti. Dormire. Menta mischiata a tabacco. Dormire sempre alla stessa ora e qualsiasi altra cosa accadesse attorno.
Nella stanza in cui studiava e sperimentava teorie sul volo degli uccelli l’aroma dominante era costituito dall’odore spiccato e amaro delle sigarette nazionali tagliate ciascuna in tre o quattro parti, che venivano poi fumate tramite bocchino. Quando andava a dormire rimaneva l’odore e tutta la stanza, impregnata dalla polvere della sua presenza, continuava, in sua assenza, a costruire immagini di volo.
La polvere è componente fondamentale dello studio sul volo degli uccelli. Senza polvere si perde equilibrio, non si ha niente da scambiare con l’aria e non si misura il tempo del volo e del tempo dedicato al volo.
Senza luce la polvere non si vedrebbe. Nella stanza trascorrevano mattine in cui il sole filtrato dalla finestra inquadrava il ferro ed i bulloni utilizzati per gli esperimenti. Gli strumenti utilizzati per dimostrare le teorie sul volo erano da lui ideati e costruiti.
Ammoniva:.in montagna salutarsi, soprattutto quando ci si incontra ad alta quota.
Soprattutto tornava sempre a disegnare le battute di volo, come se le precedenti, nel frattempo, potessero cambiare. In effetti il volo di un uccello non è mai uguale a se stesso.
Filmare il volo degli aironi e poi separare i fotogrammi. Disegnava su lucidi sovrapposti ai fotogrammi e poi li colorava. Diverse posizioni dell’ala in progressione. Nelle zone intermedie si impara a volare. Ad esempio un piano statico su cui si disegnano battute di volo.
Non era il brivido della velocità, non l’attrazione per il vuoto. Neanche l’ebbrezza del salto.
Saltando da un aereo si impara a cadere. Imparare a disegnare. Di Icaro non dispiace tanto la caduta, quanto lo scioglimento della cera, la rovina del progetto.
Era comunque importante dedicarsi ad un erbario fatto in casa, perché il volo non è tutto. Ogni foglia essiccata e fermata su una pagina con la propria descrizione. Soprattutto se inutile, qualsiasi occupazione deve essere svolta con precisione per esaurire con il massimo rispetto il tempo che contiene. E in ogni caso l’esercizio torna utile per studiare con attenzione il volo degli uccelli.
Rammentare sempre che il volo di un uccello è quanto mai imprevedibile. Peraltro occorre essere chiari: non può esserci alcun tipo di volo se non c’e’ movimento in avanti. Ciò è determinante in generale e ancor più in particolare se si riferiamo al fenomeno della portanza.
La portanza è quella forza che si oppone alla forza di gravità e grazie alla quale un uccello può sostenersi nel fluido aria. Ma, sia pure a parole, questo non è sufficiente.
Detto sinteticamente: allorché un corpo immobile viene lambito da una corrente d’aria, meglio detto vento relativo, se esso non è perfettamente simmetrico rispetto alla direzione del vento e presenta una curvatura, come accade quando il corpo in oggetto sia costituito da un profilo alare che presenta un dorso, nella sua parte alta, abbastanza curvo e un ventre piatto, il fascio che percorre detto dorso dovrà correre più velocemente di quanto non faccia il fascio che percorre il ventre, per riunirsi al fascio dorsale (si dice infatti che i fluidi hanno orrore del vuoto); questa accelerazione del fascio determina al dorso una depressione che è quella che risucchia l’ala verso l’alto e in definitiva determina la portanza.
La questione della portanza è fondamentale. Tuttavia dal 1961 il volo spaziale occupa il primo posto nell’immaginario aereo collettivo. Come uscirne?
Entrando nel suo studio troviamo:
– una tavola di legno appesa alla parete con l’impronta degli utensili disegnata laddove gli utensili sono riposti;
– un congegno elettronico smontato con la traccia dei circuiti segnata a penna;
– materiali per imbalsamare;
– alcuni esemplari di pipistrello conservati sotto formalina;
– vecchie grammatiche, vecchi giornali, scatole di varia dimensione in cui sono conservati piccoli oggetti divisi per ordine di appartenenza;
– strutture girevoli alle cui estremità sono fissate piume di airone;
– piccoli pesi per una bilancia di precisione;
– foto della città in cui vive, appese alla porta di ingresso;
– foto di una nota attrice da bambina, con il nome scritto a penna a fianco del volto;
– a fianco di ogni mensola, scritta sul muro, la data in cui la mensola è stata montata;
– su ogni mensola numerosi libri, tutti protetti da copertine di cartone su cui sono riportati titolo, autore, edizione, luogo e data di edizione. Prevalentemente:
– libri di fisica;
– libri di botanica;
– libri di idraulica;
– libri di meccanica quantistica;
– libri di zoologia;
– libri di grammatica di varie lingue;
– giocattoli di molti anni addietro;
– macchinari di vario tipo realizzati in casa e attinenti tutti allo studio del volo degli uccelli;
– scatole, scatoline, contenitori di minutaglia regolarmente etichettati ciascuno in relazione al contenuto;
– varie ed eventuali, tra cui penne remiganti in ordine sparso.
Tutte le penne remiganti primarie e secondarie sono disposte a persiana. Vale la giustificazione che si suole dare e cioè che questa disposizione ha per scopo di creare un efficace sistema portante.
Al di fuori di un vecchio e piccolissimo carillon a manovella, peraltro di grezza fattura, nel suo studio non è stato rilevato indizio alcuno di una passione o di un interesse per la musica.
I profili alari possono essere di vario tipo: piano-convessi, concavo convessi, sottili, spessi. ecc. Si noti che il dorso è sempre convesso.
Spesso gli uccelli volano per diletto e non è una novità che molte specie cantino per il gusto di cantare. Al contrario, era amante del silenzio. Tuttavia era determinante la pronuncia delle parole straniere.
Anche se in lingua da lui non parlata, correggeva la pronuncia nella dizione altrui. Era certo di detenere l’esattezza di ogni articolazione fonetica e forse era per questo, e per eccesso di zelo, che non si interessava ad altri suoni.
In vetta il suono più frequente è il sibilo del vento. Qualora la sorte accosti a quello il grido di un aquila, ci si sorprende la precisione con cui questo taglia gli strati di atmosfera che interferiscono con la sua onda e raggiunge puntualmente l’ascolto, nonostante l’alta quota del volo dei rapaci, laddove altri versi acuti, come quello della taccola, sembrano oltrepassare l’udito provocando una percezione di maggior distanza rispetto al volo più basso di tali passeriformi. Tale seconda tipologia di versi, non a caso, spesso induce a stati di malinconia.
L’osservazione del volo non è necessariamente correlata ad una prospettiva verso l’alto: guardando a terra, l’ombra del volo proiettata controluce. Oppure una piuma staccata dal marchingegno, conducendo esperimenti di aerodinamica. Tuttavia tale osservazione sarà priva dell’elemento di contorno, che poi è la componente fondamentale del volo, ovvero l’aria.
*
Nel “regime laminare” della scrittura – su “Il volo degli uccelli” di Giulio Marzaioli
di Daniele Bellomi
omnes prae sagum parvi futuros
(ascolto consigliato durante la lettura del testo: “Before Even After” dei Blind Idiot God, 2016)
Elevare al distacco
Allora è ciò che manca, a disegnare. È il vuoto che determina, scontrato. Verticale, sino al limite e non oltre. Oltre attacca, sulla schiena, oltre è un sogno. Là dove diserta attacca il volo. (G. Marzaioli, da “Quadranti”, pag.25)
Lo studio del volo degli uccelli è stato trascurato (G. Marzaioli, da “Il volo degli uccelli”, p.1)
La seconda frase è l’apertura de “Il volo degli uccelli” di Giulio Marzaioli: l’assunto, traslato dal contesto alla sua (mancata, e voluta in quanto tale) validazione storiografica, riesce già a dare una misura empirica circa la postura del discorso in atto, o meglio, sulle possibilità di una sua articolazione evidente, misurabile in gradi di torsione e in compressioni, trazioni e tagli innegabili rispetto alle sollecitazioni proposte dall’evoluzione delle costanti di materia trattata, sia in forma biomeccanica del movimento nel discorso che irrelata rispetto alle parti del discorso.
L’iterazione proposta dalla scrittura di Giulio Marzaioli, in questo frangente fortunato di prassi e didascalia, porta dalla trascuratezza al movimento costruttivo, dalla vera e propria manipolazione del volatile alla meccanizzazione del volo degli uccelli (e alla definizione tecnica, almeno al grado di superficie, dello studio del volo degli uccelli). In questo dipartimento di ricerca e sviluppo dedicato a preparativi di applicazione fluidodinamica, il risultato della scienza e della tecnica vive di un “solipsismo intermedio” fra le possibilità di articolazione del movimento (e del discorso) proposte e l’appartenenza naturale, geometrica, del volo in natura, e del volo di natura, che esclude qualsiasi possibile replicabilità (e reduplicabilità) del movimento. L’”errore di progettazione” non è quindi, nella scrittura di Marzaioli, una fase o quantomeno una prova di un processo creativo, ma la dimostrazione dell’impossibilità di associare il processo creativo ai processi di natura.
La fase di test, e quindi di verifica degli assunti, è scartata per incompletezza, successivamente allontanata e volontariamente diluita, però, nella creazione aneddotica a supporto di un’esperienza passiva del volo. In termini di convenienza, e anche di economia del discorso, l’espansione ottica si estende fra il passaggio in cui si dice che “[…] Dal 1961 il volo spaziale occupa il primo posto nell’immaginario aereo collettivo, ma sono gli uccelli quanto di più elevato possa vantare il pianeta.” e il minuzioso elenco degli oggetti presenti nello studio in ultima pagina. L’”impatto memoriale” che lo stesso discorso e la sua aneddotica hanno sul lavoro finale riporta alla prassi irrelata di cui si parlava al primo paragrafo: l’elevazione al distacco del volo (e il ruolo stesso che la suggestione del volo imprime alla poetica di questo autore, da In re ipsa, a Quadranti, allo stesso Arco rovescio uscito per Benway Series nel 2014) è il volo stesso. In questo senso possiamo dire che, nella scrittura e nel discorso portati avanti da Giulio Marzaioli nella sua attività di scrittura, l’approccio al tema del volo e la fascinazione nei confronti di questo stesso tema non abbiano subito mutazioni sostanziali nel corso degli anni.
“Là dove diserta, attacca il volo”: dove diserta la tassonomia, dove diserta la riproducibilità, oppure dove diserta il relato nel discorso?
Soggettività linguistica e volumi virtuali
Giulio Marzaioli stava passeggiando lungo un sentiero di montagna quando venne chiamato dal figlio. Il bambino si era fermato ad osservare una grande farfalla posata su una campanula, al bordo del sentiero. La farfalla teneva le ali spiegate. Dopo averla fotografata da diverse angolazioni, Giulio Marzaioli avvicinò lentamente l’indice alla farfalla e con suo grande stupore riuscì ripetutamente ad accarezzarne le ali, senza che la farfalla le ripiegasse o volasse via. Giulio Marzaioli pensò che la vanità fosse uno dei vizi più diffusi tra gli esseri viventi. Soltanto dopo molti giorni Giulio Marzaioli si ricordò che le ali di farfalla sono coperte da piccolissime squame che, nel momento in cui vengono toccate, si rompono, provocando instabilità o addirittura impedendo il volo. (da G. Marzaioli, Arco rovescio, Benway Series, 2014)
Il profilo alare, o meglio, la rampa aerodinamica su cui si muove la scrittura di Giulio Marzaioli in questo “il volo degli uccelli” serve da propagazione agli strati di fluido di cui si è parlato in precedenza: l’elevazione al distacco del volo rispetto al discorso, e la marca aneddotico-didascalico-manualistica (in senso tanto più lato quanto più questi tre elementi sono allontanati vicendevolmente dalle proprie differenze) che riporta il discorso al piano della norma e, a ritroso, alla sua progettazione cartacea: blocco bianco e penna a sfera.
Il volo degli uccelli, breve testo composto in grande prevalenza di prose brevilinee e brachilogiche, articola il proprio ragionare se stesso seguendo appunto una distinzione (o una distanziazione) dalla norma già acquisita. All’intento tassonomico (legato all’enumerazione delle parti di cui è composto il volatile) segue, a salti e riemersioni, la manipolazione stessa del volatile, prototipo stesso del volo, e la cura del volatile dalle lesioni subite, eventuali o possibili.
Arriva a questo punto in soccorso la definizione di flusso laminare [1], fenomeno che ben si attaglia alla scrittura de “Il volo degli uccelli”: proprio in questo caso gli strati di fluido in esame non causano turbolenze, ma si limitano a scorrere l’uno sull’altro, senza rimescolarsi fra di loro. In buona sostanza, questo fenomeno descrive adeguatamente quello che accade alla scrittura di questo testo, in cui la relazione fra i piani del discorso è tanto più efficace quanto più la contaminazione fra i piani del discorso è limitata al piano della virtualità.
La “bassa velocità” che l’andamento del discorso ha nella scrittura di Marzaioli è esattamente funzionale ad impedirne un rimescolamento inopportuno: in questo modo, il “volume virtuale” della scrittura non subisce alterazioni, o impedimenti. Non è molto diverso quello che accade nel passaggio citato poco sopra da “Arco rovescio”, dove la consapevolezza tecnica di un’alterazione biologica dettata dallo sfioramento delle ali della farfalla è temporalmente legata alla fase del ricordo posteriore e del gesto inavvertito, mentre la costruzione aneddotica del discorso e la validazione della vanità creaturale sono disposte in rapida sequenza, su un piano equivalente.
Nella “soggettività linguistica” di Giulio Marzaioli, pertanto, l’osservazione del volo è suo stesso auspicio (da avem spicere, appunto) e il discorso (e lo studio del discorso, equiparabile qui allo studio del volo) è confinato nel regime laminare della scrittura, dove compresenza non significa alterazione e dove la stessa scrittura prosegue e delinea il proprio flusso senza che vi siano turbolenze.
Nota
[1] Flusso il cui comportamento è determinato dalle forze di attrito interno. Nel flusso laminare, a differenza del flusso turbolento, gli strati infinitesimi di fluido scorrono dolcemente uno sopra l’altro, senza che avvenga alcun rimescolamento, neanche a livello microscopico. […] Il flusso laminare può essere osservato aggiungendo un fluido colorato a un fluido trasparente. Se la loro velocità è sufficientemente bassa (riferita alla viscosità) i due fluidi non si mescolano ma il primo resterà separato e confinato nel suo volume virtuale. […] All’aumentare della velocità si ha una prevalenza sempre maggiore dei fenomeni vorticosi (legati alle variazioni di velocità) rispetto a quelli viscosi, con conseguente rottura del parallelismo laminare. Il regime del fluido diventa così turbolento. […] La conoscenza del punto di transizione tra i due tipi di flusso risulta fondamentale in molti settori applicativi, per esempio nel caso della progettazione aerodinamica di veicoli e velivoli. (da “definizione di flusso laminare”, Enciclopedia della Scienza e della tecnica, 2008)
*
Prove d’ascolto è un progetto di Simona Menicocci e Fabio Teti
Consigli per scrittori di poche parole
di Domenico Talia
 Si può scrivere di un libro stagionato parlandone come fosse frutta fresca da gustare? Si può parlare di racconti rubando le parole a qualcuno premiato per essere autore di romanzi? Sia nel primo sia nel secondo caso, la risposta parrebbe essere negativa, ma con un po’ di volontà qualcosa di diverso si può tentare. Stessa risposta negativa si è tentati di dare a chi volesse provare a sintetizzare in poche frasi un libro di per sé già sintetico. Un po’ come tentare di spremere succo da un frutto siccagno. Eppure, anche in questo caso, si può anche provare a ribaltare la risposta e tentare una strada a prima vista impedita.
Si può scrivere di un libro stagionato parlandone come fosse frutta fresca da gustare? Si può parlare di racconti rubando le parole a qualcuno premiato per essere autore di romanzi? Sia nel primo sia nel secondo caso, la risposta parrebbe essere negativa, ma con un po’ di volontà qualcosa di diverso si può tentare. Stessa risposta negativa si è tentati di dare a chi volesse provare a sintetizzare in poche frasi un libro di per sé già sintetico. Un po’ come tentare di spremere succo da un frutto siccagno. Eppure, anche in questo caso, si può anche provare a ribaltare la risposta e tentare una strada a prima vista impedita.
Antique shop
di Daniele Ventre
L’antiquario svende un Egitto finto,
scarabei di carta e papiri a stampa,
cobra sulla maschera in similoro,
Iside a velo.
Chiusi fra le dune i fratelli in barba
e corano minano tombe e templi:
i villaggi al mare rimasti vuoti
cedono al rosso
del deserto. Resta al di là del tempo
Dhu’l Qarnayn e i suoi pezeteri d’ombra
e di polvere e la sua fiaba eterna
e le sue mura
ferree. Al fuoco i rotoli delle storie
crepitano in crolli di biblioteche
truppe in grigio e croci hanno acceso in piazza
roghi di libri,
fumi di carnai. Profezie di nulla
suonano da oroscopi di riviste:
se ne giova il traffico dei sultani
lungo il confine
fra la Siria e il buio. I colossi ciechi
svettano per principi senza volto,
senza corpo fra le colonne in fumo
e le macerie.
Si riduce al termine della storia
qualche figlio spurio di dèi minori
pronto per finzioni d’eroi, per scene
di decadenza.
Sul confine della ragione estinta
resta Dhu’l Qarnayn, l’orizzonte esterno
fermo sull’origine delle storie,
lungo la scia
fra le terre e l’orda. Ha sul volto vuoto
il sorriso arcaico e l’Egeo dei turchi
e dell’uomo in debito, senza voce,
senza memorie.
Resta all’orizzonte la marcia in stasi
fra la luce e l’ombra dell’antro opaco
e la statua erosa e il sintagma in lotta
contro la banca
nelle piazze in fiamme. Sul fiume eterno
sceso dagli dèi ci rimane l’uomo
con la sua ferocia di dogmi umani,
vittime a pezzi
per fecondità di regimi –un’orgia
d’impotenza stimola per tortura
qualche corpo elettrico senza canto,
senza vendetta.
L’eco dei proclami dal re degli ori
suona d’oro matto al confine incerto,
punta sull’estraneo e lo spia dal tappo
del cannocchiale,
sogna suoi nemici a serrare i ranghi:
ombre gli rispondono di riflesso
incondizionato, all’istinto cieco
sparso nel gregge.
L’antiquario intanto pesava i cuori
nella terra d’ombra, il bilancio scarno
delle azioni in perdita, il peso nullo
delle ragioni
asociali. Il vertice delle aziende
già dismesse segna le vie, le vite
senza verità, che ci incarti senso
pane stipendi
senza fine o termini di contratto.
Tutto si è bevuto e l’impero è chiuso
nel suo giro cinto di sfingi, ha gli occhi
vuoti del poi,
ciechi al prima. Al cardine della storia
qualche nuova incuria di dèi minori
si progamma ancora per messinscene
di sussistenza.
La piramide era incompiuta, il gioco
delle stelle smesso per troppo costo:
resta il cielo in vetro e l’Egitto finto
sul calendario.
Chiusi fra le rune stregoni in cappa
e grimorio mimano logge e templi:
i bilanci in vendita per incanto
cedono al rosso.
Sul confine della ragione estinta
resta Dhu’l Qarnayn, l’orizzonte esterno
nel suo giro cinto di sfingi ha gli occhi
vuoti del poi.
Chiusi nel debriefing, i vip in giacca
e finanze accismano leggi e tombe:
nello spazio lacero stelle e stringhe
cedono al rosso.
ballata della crepa (o dell’onestà)
di Francesca Genti
canto Kālī canto la crepa
che fa più ornata la porcellana
che fa pregiata la slogatura
che rende la caduta umana
canto l’errore e il disonore
canto ciò che non è edificante
canto la crepa che rende brillante
la giornata senza sole
il vortice canto e la big babol
l’energia di quella che vola
l’allegria di quella che scoppia
la risata che colora
la caduta e l’ipocondria
e ogni tipo di bugia
(quella detta per ferire
quella detta per guarire)
canto la crepa della faccia
la ruga che vince la vanità
il capillare che si incrina
lo scacco matto alla regina
canto il disordine canto la crepa
canto la bimba che se ne frega
canto la bimba oca giuliva
che fa le bolle con la saliva
la carie canto lo zucchero filato
tutto quello che è esagerato
quello che c’è tra cielo e terra
tutti i segni della guerra
canto quello che si rompe
canto i cocci dopo la festa
la paura del dentista
e i suicidi dalla finestra
il terremoto il temporale
la buca la scala il vicolo cieco
canto la crepa sopra il soffitto
e il gradino su cui inciampare
canto Kālī canto la crepa
che fa preziosa la porcellana
che rende onore all’incrinatura
che ti fa bella che ti fa umana.
come faccio senza te (3/3)
di Giacomo Sartori
vedi com’è
com’è la vita
la vita vissuta
nel chiuso di muri
taggati di ricordi
(frasi impiccate
penzolanti nel vuoto
e sorrisi fossili)
Storia di alberi e della loro terra: Matteo Melchiorre

di Francesca Fiorletta
In uscita per Marsilio il 28 settembre, Storia di alberi e della loro terra è un testo narrativo, tra autobiografia e non fiction, di Matteo Melchiorre [autore vincitore del Premio Rigoni Stern e del Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo, con il saggio La via di Schener] che racconta di una generazione sempre pericolosamente in bilico fra il radicamento e lo sradicamento delle comunità, e lo fa con un linguaggio fresco, pungente e vivo, proprio come la materia stessa delle sue elucubrazioni, la natura (umana).
Di seguito, un estratto.
Buona lettura