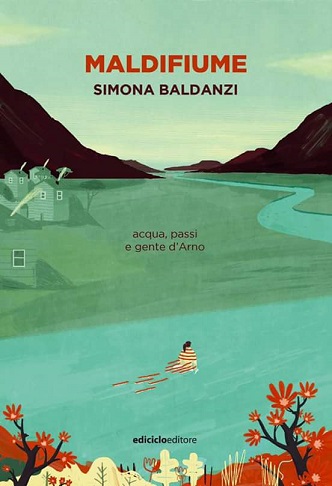Lisa Ginzburg risponde a Giacomo Sartori
GS “Per Amore” si ispira a una tua vicenda personale, ma poi molti elementi sono di invenzione, mi dicevi. Mi piacerebbe sapere con quali criteri, se ci sono, e se ti va ti rispondere, hai rispettato la “verità dei fatti”, e dove invece te ne sei allontanata. Non certo per scavare nella tua vita personale, ma per capire meglio la genesi e le motivazioni di questo lavoro.
LG La pulsione a romanzare qualcosa di (anche) privato si è innestata sulla necessità di costruire questo libro: due trazioni ugualmente forti. Non potevo scrivere la storia che ho poi raccontato, in altra forma che non fosse una in cui verità e invenzione potevano liberamente intrecciarsi, interagire sino a camuffarsi a vicenda, trasformandosi in un materiale ai miei stessi occhi inedito: non certo estraneo, ma “lavorabile” nel suo essere artefatto. Dall’inizio ho optato per la terza persona, senza più cambiare idea. Anziché dare alla protagonista un nome, l’ho battezzata “lei”. Una scelta che solleva domande tra i lettori. Rispondo loro che non è stata una presa di distanza, la mia. Piuttosto, ergere a nome un pronome ha significato aggirare il pericolo di un’adesione eccessiva a questo personaggio femminile. Evitare una deriva simbiotica che sarebbe andata a detrimento del racconto. La “spersonalizzazione” che un pronome comporta rispetto a un nome, è stato un criterio-faro per me, quello pure che durante le varie fasi del lavoro non è sbiadito. Sono tuttora convinta che l’interesse della storia stia nel suo comunicare qualcosa che la trascende, un senso più ampio dei singoli fatti, una frattura di portata maggiore rispetto al mero rendiconto di una sciagura privata.
L’invenzione di questa “lei”, così come della toponomastica brasiliana (tutta di fantasia, tranne per il caso di Rio de Janeiro e São Paulo), per me hanno funzionato da sponde. Anziché frantumare la storia, la densità della sua realtà, le invenzioni sono stati argini: hanno contenuto e foggiato questa materia mista di verità e finzione che avrebbe altrimenti rasentato l’informe.
La “verità dei fatti” è quella che la donna ricostruisce a partire dal trauma di una perdita e un lutto che la sconquassano. È una verità filtrata dal suo ricordare incessante, ossessivo. Una verità dunque del tutto soggettiva, non fosse che la donna è costretta a confrontarsi con altre verità, inimmaginate, ben più potenti del sentire di lei.
GS Una delle note fondamentali di questo testo mi sembra essere, indipendentemente dalla natura autobiografica o meno della vicenda, la volontà di scavare nell’intimità dei due personaggi principali. Da una parte la donna che ha perso il suo compagno pare mossa da una necessità per certi versi impellente, e dolorosa, di indagare il mistero di questo “altro” con il quale ha avuto un rapporto molto profondo, rapporto che dura anche dopo la sua scomparsa, e dall’altra pare avere un altrettanto sofferto bisogno di capire meglio se stessa, di aderire il più possibile ai fatti per trarne la loro verità più segreta. In altre parole il racconto sembra essere spinto da una sua necessità propria, più che procedere per assicurare il piacere della fruizione, o insomma per creare degli effetti per così dire codificati, che si ritrovano in tantissima narrativa contemporanea. Questo mi fa pensare a scrittrici nelle quali avverto una simile logica interna, e potrei citare qualche nome. Ma volevo chiedere a te se ti sei ispirata a qualche scrittrice o scrittore, o se insomma nella concezione e durante la scrittura avevi in mente dei testi che ti hanno accompagnata.
LG Io credo molto in quella che tu definisci “necessità propria” dei testi. È stata la necessità a guidarmi, nient’altro: e non quella di cercare un allevio nello scrivere un romanzo (diffido dell’idea di “scrittura terapeutica”), ma perché ho sentito si trattava di una storia che era necessario raccontare. Quanto alle letture, hanno contato molto per me quella de L’anno del pensiero magico di Joan Didion, e di Men we reaped di Jasmine Ward. Il primo libro lo avevo letto quando uscì in italiano, amandolo moltissimo. Non ci ho pensato in modo consapevole mentre lavoravo a Per amore, ma dopo ho capito quanto il ricordo di quella prosa così intensa, nuda, a spirale nel suo fedele ripercorrere un cammino à rebours sulle tracce interiori di un lutto traumatico, avesse agito carsicamente in me. L’altro libro, Men we reaped (un memoir dedicato a un fratello e a degli amici, persone tutte perdute a poca distanza di tempo l’una dall’altra) l’ho ricevuto in regalo una volta che ero a New York e già avevo incominciato a scrivere Per amore. Ho sentito subito una grande sintonia con il modo di raccontare di Jasmine Ward, piano, lucido, così veritiero nel dare forma al sentimento della perdita.
GS E poi volevo chiederti, visto che citi autrici non italiane, cosa rappresenta per te scrivere in italiano, tu che vivi fuori dall’Italia, frequenti altre lingue, e descrivi situazioni non italiane (anche nella tua ultima raccolta di racconti, “Spietati i mansueti”). Perché certo il romanzo è un organismo che vive in tanti paesi diversi, come i funghi, che hanno ife in un raggio enorme, tutte appartenenti a uno stesso organismo, e che da sottoterra si spingono fino alla cima degli alberi, però poi uno scrittore italiano si trova a scrivere in italiano, e lì il campo delle possibilità offerte dalla lingua stessa si restringe forse molto.
LG Può essere più difficile scrivere nella propria lingua, quando si raccontano mondi lontani “da casa”, e più ancora quando lontano “da casa” si vive. Il rapporto con le parole si fa più intenso nella misura in cui è solitario, non supportato dalle atmosfere circostanti. Nella narrativa italiana mi pare si dia eccessivo valore alla connotazione geografica della scrittura, come se origini “forti” da un punto di vista territoriale dessero maggiore forza e carattere allo stile. Io rivendico un diritto “cosmopolita” della lingua: che come per un rizoma, una stessa radice possa ramificarsi dando vita a contesti veri o immaginari non importa, ma diversi. Mi viene in mente John Berger, inglese di nascita i cui libri sono di impronta assolutamente transnazionale. Il futuro non è certo solo di narrative locali; né è necessario date atmosfere conoscerle dalla nascita, esserne biograficamente intrisi, per decidere di volerle raccontare. Se intendi come “restrizione del campo delle possibilità” una condizione di esilio della lingua dai suoi propri mondi, io aggiungerei che quella restrizione per la stessa lingua è anche un’opportunità, di misurarsi con se stessa, e di lì ampliarsi.
GS Certo, però l’italiano non è l’inglese, è una lingua relativamente recente, nella sua forma attuale, e che è stata usata relativamente poco per descrivere gli universi non italiani. E secondo me si porta dietro in qualche modo questa tendenziale limitazione dello sguardo, questa chiusura su se stessa. Tu mi sembra che ce ne esci molto bene, e questo dando alla tua lingua una grande essenzialità, che non è secchezza, ma pur sempre una estrema concisione, che impartisce alle tue frasi una tensione quasi vibrante di metallo sotto sforzo. Quasi l’impellenza di essere più precisa possibile non ammettesse nessuna sbavatura, nessuna aggiunta non strettamente necessaria. La forza della narrazione, e il valore del romanzo, mi sembrano venire da lì. Volevo chiederti se a questo risultato arrivi già con la prima stesura, o invece hai bisogno di lavorarci molto, passando per molte versioni.
LG Molto lavoro, moltissime riletture, varie stesure. Asciugare gli eccessi di uno stile rafforza la prosa, ne mette in risalto l’urgenza, il senso. Lo penso in assoluto, e nel caso di questo libro in particolare. Si trattava di una materia troppo incandescente, per non necessitare di venire controllata il più possibile dal punto di vista formale. Se uno scrittore riesce a dominare le possibili derive liriche della propria prosa, allora può nutrire più speranze di comunicare con i suoi eventuali lettori. Se invece per farsi sentire deve far leva sull’eccesso, o la ridondanza, o altri effetti “speciali”, allora si può presumere che qualcosa manchi a monte, che ci sia un vuoto all’origine del processo creativo. Al nucleo vero, allo strato di maggiore intima autenticità di una storia, si arriva per eliminazione, non adornando con scritture rutilanti una materia che di suo possiederebbe consistenza scarsa, poca luce.
GS Tornando al tuo romanzo, mi sembra che ci sia una lettura più di superficie, quella cioè dell’infatuazione amorosa, dell’estasi del corpo e di una comunanza totale, che si scontra poi con la dura realtà delle differenze culturali, di provenienza, di storia, di sesso, di tutto, e del tempo che passa, dell’inesorabile curva discendente di ogni amore. È una spiegazione che è presente nello stesso “Per amore”, e che ho letto in vari commenti al libro, ma che non mi soddisfa completamente, non foss’altro perché non mi sembra una molla sufficiente a tenere attaccata la protagonista a quel lungo calvario, certo anche con brevi istanti di gioia, però sostanzialmente molto doloroso. Perché non ci sono solo i momenti di insostenibilità assoluta, sopportati con una costanza autolesionista degna di un’eroina di Lars von Trier, quando si ritrova prigioniera della famiglia di lui, ma anche le parentesi della distanza sono in fondo intrise di infelicità. Io credo che la vera ragione del restare della protagonista nella relazione, anche quando questa è finita tragicamente, sia qualcosa di non detto, e che forse nemmeno lei sa, e che viene a coincidere con la sua testarda esigenza di capire, lavorando prima sui dati che via via accumula, e poi su quelli della memoria. Quasi la relazione totalizzante con l’altro, sia anche un modo per scendere in se stessa, per fare un viaggio interiore. Non so sei d’accordo con questa lettura, che mi sembra ricollegarsi a quanto dicevi prima, di un senso profondo che travalica i singoli fatti.
LG No, non credo che lei, la donna, resti al centro di tutto, che usi strumentalmente questo incontro per “viaggiare” dentro di sé. È la relazione, nelle sue complessità, a restare protagonista. La caparbietà, in una storia, si tratti pure di una relazione tra due esseri nati e cresciuti in identico ambiente, può esserne parte importantissima. Può esserci ostinazione nell’amare, o nel cercare una strada per sentirsi amati, o nel voler smontare (per ricostruire) una relazione. L’impegnarsi testardo non altera la natura dei sentimenti – né li potenzia, né li sminuisce. Piuttosto parlerei di una perseveranza che è consapevolezza (“che l’amore diventi coscienza dell’amore”, Pasolini diceva, ed è un buon modo di maturare, per un legame, la coscienza). Quel che conta, io credo, è che quell’ostinarsi, ai sentimenti non si sostituisca: che rimanga uno sfondo, una nota di accompagnamento. Forse ciò che accade, nella storia che ho raccontato, è questa sostituzione, da un certo punto in poi. Lo sforzo diviene preponderante sulla realtà che lo sforzo cerca di mantenere viva. Ma di costanze, autolesioniste o distruttive o sadiche o quant’altro, le relazioni profonde sono disseminate.
GS Capisco bene quanto dici, e sono d’accordo. Però nello stesso tempo il protagonista maschile è un iniziato, e ha un suo modo di vedere la realtà diverso da quello della razionalità occidentale, intuitivo. E finisce in certi momenti, grazie ai suoi poteri, per avere anche un ruolo di guida nei confronti della protagonista, che non ha queste facoltà, o comunque per opporle un qualcosa al quale lei non può accedere, del quale riconosce però il valore. Questa dimensione spirituale mi sembra fondamentale nel testo, perché se non fosse presente resteremmo nel dominio delle relazioni amorose classiche, quali sono state rappresentate e analizzate in tanti romanzi e racconti. E invece in qualche modo qui la passione ruota anche attorno a un mistero più profondo, di fronte al quale la razionalità, che è la sola arma di lei, resta impotente. Anche di qui mi sembra venire la sua attrazione, e il suo non esitare a sacrificarsi.
LG La sintonia più profonda tra Ramos e la donna, è di natura spirituale. Lui è più avanti quanto a consapevolezza delle proprie capacità intuitive: qualcosa da cui lei viene stregata, nella misura in cui si tratta di una ricerca, un percorso che già la interessano. Prima di tutto, a colpirla è la forza con cui Ramos comunica, danzando, la vibrazione di un mondo spirituale potente, l’olimpo degli Orixás del Candomblè afrobrasiliano. Un po’ come un medium a cavallo tra realtà e altre dimensioni più sottili: così le appare Ramos. Un canale di trasmissione tra terra e cielo – cielo affollato di figure archetipali, immagini simboliche di qualità e vizi dei viventi. Il talento di lui è un fiume che la travolge, accende il suo innamoramento. Lui anche però, Ramos, trova posto, si sente a casa nell’indole riflessiva di lei, nel suo osservare il mondo spesso provando a meditarlo, a meditare. Sono anime vicine, lui e lei, in questo pensare le cose come riflessi ed effetti di movimenti più forti, invisibili. Ed è la spiritualità la sola loro intesa davvero salda, consolidata, quella che neppure alla fine viene scalfita, quando morendo lui lascia comprendere a lei sino a che tragico punto si fosse spiritualmente smarrito.
NdR “Per amore” è pubblicato da Marsilio (2016), e su NI ne ha scritto qui Ornella Tajani; sempre su NI, qui Francesco Forlani parla invece della raccolta di racconti “Spietati i mansueti”, uscita successivamente con Gaffi (2016)



 43 poeti per scacciare la morte, per dar sfogo a una indignazione vitale. La poesia come una affermazione, sono qui, sono con te, sono per tutti. Dove tutti significa molte persone, tutte le vive, tutte le sparite, tutte le torturate, tutte le assassinate di questo Messico contemporaneo, immerso in una guerra contro i poveri, contro chi si sente sicuro di fare il proprio dovere, contro chi vuole essere libero. Molte di più dei 43 studenti desaparecidos dall’esercito, la polizia e i narcotrafficanti ad Iguala la notte tra il 26 e il 27 settembre 2014. Però quei 43 ragazzi risvegliano la poesia: sono stati trasformati dal desiderio popolare di mettere fine alla violenza di stato e della delinquenza (nessuno sa dove finisce una e comincia l’altra) in semi di speranza.
43 poeti per scacciare la morte, per dar sfogo a una indignazione vitale. La poesia come una affermazione, sono qui, sono con te, sono per tutti. Dove tutti significa molte persone, tutte le vive, tutte le sparite, tutte le torturate, tutte le assassinate di questo Messico contemporaneo, immerso in una guerra contro i poveri, contro chi si sente sicuro di fare il proprio dovere, contro chi vuole essere libero. Molte di più dei 43 studenti desaparecidos dall’esercito, la polizia e i narcotrafficanti ad Iguala la notte tra il 26 e il 27 settembre 2014. Però quei 43 ragazzi risvegliano la poesia: sono stati trasformati dal desiderio popolare di mettere fine alla violenza di stato e della delinquenza (nessuno sa dove finisce una e comincia l’altra) in semi di speranza.




 di Martina Germani Riccardi
di Martina Germani Riccardi






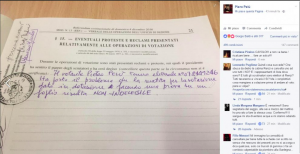




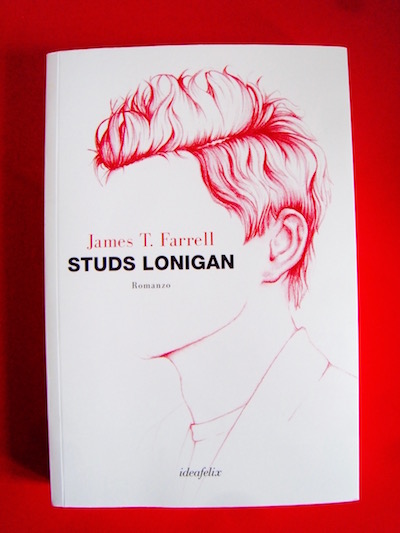
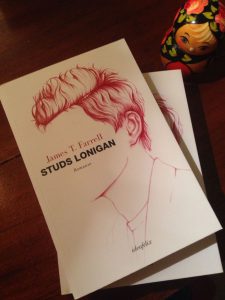 Sembra che i libri debbano darsi da fare. Non possono più accontentarsi di essere libri. Così, per restare nel mondo, i libri mutano. Alcuni perdono il potere della carta, e acquistano qualità digitali. Altri prendono la strada della socializzazione in Rete; capita in questi casi che il libro, che già di suo dovrebbe contenere tutte le storie possibili, divenga parte di una storia, o di uno storytelling intarsiato di status, post, video e immagini del quale il volume è solo l’innesco e poi appena un frammento. Altre mutazioni, le più frequenti, esulcerano nel protagonismo (virtuale, di network sociale) degli autori, che a volte aiuta il libro, a volte lo danneggia, a volte incoraggia i lettori ma può anche distrarli.
Sembra che i libri debbano darsi da fare. Non possono più accontentarsi di essere libri. Così, per restare nel mondo, i libri mutano. Alcuni perdono il potere della carta, e acquistano qualità digitali. Altri prendono la strada della socializzazione in Rete; capita in questi casi che il libro, che già di suo dovrebbe contenere tutte le storie possibili, divenga parte di una storia, o di uno storytelling intarsiato di status, post, video e immagini del quale il volume è solo l’innesco e poi appena un frammento. Altre mutazioni, le più frequenti, esulcerano nel protagonismo (virtuale, di network sociale) degli autori, che a volte aiuta il libro, a volte lo danneggia, a volte incoraggia i lettori ma può anche distrarli.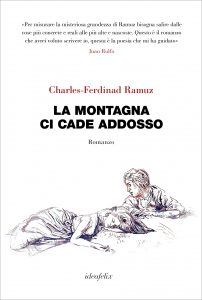
 (La biblioteca del viandante è una nuova collana diretta da
(La biblioteca del viandante è una nuova collana diretta da