 di Marco Rovelli
di Marco Rovelli
(Marco ci regala un estratto del suo nuovo libro. E’ appena uscito, come poterne fare a meno questa estate? G.B.)
All’osteria mi insegnarono il brindisi alla carrarina. Perché questa è un’osteria della campagna massese, sì, ma sta appena sotto le colline del Candia, e il Candia richiama anche i carrarini. Uno di loro mi ha preso per un braccio una sera che si cantava, “Vieni qui che ti offro un bicchiere”, e tu mica puoi dirgli che ce l’hai già sul tavolo e ne hai bevuto anche tanto, è buona educazione accettare. Beve, e alza il bicchiere, anzi il bicierin, il “goccio di vino” che si può scolare tutto d’un fiato. Brinda, e quel brindisi somiglia molto a un rito. Si leva il bicierin in alto, lo si fa digradare verso terra, poi lo si porta a sinistra e infine a destra: un segno della croce, insomma, e l’importante è che l’occhio non perda mai di vista il vino. Si salmodia nel gesto apotropaico: “ciar i è ciar – muss’lin a ni né – te ‘n t’l vo – te nemanc – al bev me” (chiaro è chiaro — moscerini non ce n’è — te non lo vuoi — te neanche — lo bevo io). Va da sé che si pronuncia l’ultimo verso levando il bicierin alla bocca per assimilare il Verbo.
“Sai qual è la frase migliore per definire il carrarino? Il contro in testa”.
Silvano veniva di tanto in tanto all’osteria, e mi diceva della differenza ontologica tra massese e carrarese.
“Il massese è molle. E’ rimasto sempre un contadino, servile. Il carrarino no, il carrarino non si piega, è fiero, schiena dritta. Ha il contro in testa il carrarino.”
“E che significa?”
“Per spaccare il marmo devi capire qual è la linea giusta, il suo verso. Se la segui, tagliarlo è facile. Se invece provi a tagliarlo diciamo al contrario, se vai contro il verso, non ci riesci: non c’è verso, proprio. E quello si chiama contro.
Ecco, i carrarini hanno il contro in testa, sono duri, resistono, e non c’è verso di scalfirli. Non c’è il verso, proprio.”
Il marmo è come la vita, morbido al verso e duro al contro.
“Solo che avere il contro in testa non è facile. E’ un bel fardello da portare. Che se ti trovi in periodi di piena va bene, sei un ribelle, ti unisci con gli altri e allora guai a chi vi tocca. Se Carrara è terra di anarchici ci sarà un motivo no? Ma in tempi di secca, quando nessuno ha speranze di trasformare questo mondo, allora avere il contro di testa non è bello, vai contro il tuo vicino, il tuo compagno, il tuo amico. Tutti a parlar male dell’altro, a farsi guerra l’un con l’altro. Non è bello.”
Silvano alzò il bicchiere e se lo scolò d’un sorso. Niente brindisi. “E’ un mondaccio questo. E mi sto stufando di questa terra.”
***
Silvano l’ho incontrato di nuovo dopo alcuni anni, tra le bandiere nere e rosse alla fine del corteo del primo maggio anarchico a Carrara. Un corteo di canti, una ritualità antica, corone di fiori rossi alle lapidi. Tante. Troppe, visto che dietro ognuna di quelle lapidi c’è una vittima da ricordare. Le vittime dei moti del 1894 alla caserma Dogali, Giordano Bruno in piazza del Duomo, Alberto Meschi storico sindacalista d’inizio novecento, e per finire i morti alle cave e Francisco Ferrer educatore anarchico, le due lapidi che stanno nella piazza dove arriva il corteo. La piazza ufficialmente si chiama piazza Alberica – dal duca Alberico I dei Cybo Malaspina, il sovrano che la volle nel Seicento -, ma per gli anarchici continua a essere piazza Gino Lucetti, l’anarchico che attentò a Mussolini e per un soffio lo mancò, in un tragico impeto di sfortuna: la bomba rimbalzò sul tetto della macchina del Testa di Morto, esplodendo solo toccando terra e ferendo sei persone plaudenti. Lucetti venne condannato all’ergastolo. Nel 1943, all’arrivo degli alleati, Lucetti fu liberato dal carcere di Santo Stefano, una delle isole ponziane, ma riuscì a vivere libero solo per pochi giorni: arrivato a Ischia, il 17 settembre morì sotto un bombardamento aereo tedesco.
A Lucetti venne dedicato il battaglione partigiano libertario sui monti apuani, a lui venne dedicata la piazza, che nel 1960 tornò all’antica denominazione per gli stradari ufficiali. Non per gli anarchici però, che nei loro manifesti di convocazione della giornata continuano a scrivere “piazza Gino Lucetti”.
[…]
Nel maggio del 1936 in tutta Italia si celebrava l’Impero. A Carrara la cerimonia di popolo si tenne in piazza Farini. Durante il discorso dell’oratore, in un angolo della piazza si sentì cantare l’Internazionale. Nove operai vennero arrestati.
E’ cosa buona e giusta che questa terra sia trasfigurata. La trasfigurazione le appartiene. Qui hanno proliferato visioni, e una visione è davvero tale quando ne suscita altre, in una catena interminata. Come quei nove operai che cantarono quel giorno sfidando i fascisti, e quel canto è arrivato fino a noi, e suscita altro canto.
Basta salire sulle montagne, in Apuania, e il paesaggio stesso si presta a essere scenario di visioni.
Che poi già il marmo è un brulichio di vite marine, sedimenti carbonatici prodotti in quelle che furono scogliere coralline, dov’erano alghe, spugne, coralli. Quegli strati, segnati da linee oblique e parallele, vene sottopelle che il lavoro millenario delle cave ha scoperto e portato in superficie, sbattendotelo in faccia – quegli strati di marmo sono vivi, profondamente vivi, e quel biancore che ti abbaglia è come un concentrato ipnotico di vita.
Il mare, qui, è già compreso nella montagna. Quello ancora liquido è come il suo specchio necessario, una distesa che si srotola per dar aria alla maestà della montagna.
Mentre sali su per le valli di Carrara – i tre bacini di Torano, Miseglia e Colonnata – la vista ti s’impiglia in una matassa di linee geometriche. Quelle irregolari ed eccedenti dei monti, con la loro tensione verticale e sfuggente, e le griglie regolari delle escavazioni, gabbie su gabbie, una metodica operazione per ridurre questa eccedenza a misura umana. Figure geometriche e ripetitive disegnate dalla volontà di appropriarsi dell’inappropriabile. Una smisurata mostruosità, che pure ha il suo fascino perverso, proprio di ogni tentativo faustiano.
In un’ascesa alla montagna, passando su ponti e viadotti e dentro gallerie, tra le innumeri cave di marmo tutt’intorno, il pezzo ideale è Astronomy Domine, il primo brano del primo lp dei Pink Floyd: psichedelia pura, viaggi interstellari. E’ l’introibo alle cavità spaziali della terra portate in superficie, a un’ostensione sacrificale che pare l’accesso a un mondo del rovescio.
Syd Barrett cantava e Camilla, seduta nel sedile di fianco, diceva che tutto quel bianco troppo esposto pareva ottenuto per corrosione, come fosse il resto di un millenario percolare, ottenuto per sottrazione, e non per un’addizione di colore. Era esattamente quel che vedevo anch’io: il rovescio, appunto, il fondo nascosto e terribile che appare alla fine di tutto. Alla fine dello scuoiamento, di un infinito sacrificio.
A far da costellazione, nel percorso, oltre a una fila infinita di blocchi e lastroni di marmo, ci sono macchine per l’escavazione e la lavorazione, cavi e carrucole arrugginite, caterpillar, come fossero tutte parti di un gigantesco scheletro di metallo che sembra uscito dalla prima rivoluzione industriale. “Ti par di vedere anche il vapore”, diceva la compagna di questa risalita. “E i ravaneti li trasfiguri come sabbia di clessidre gigantesche”. Uno sgretolio infinito, la terra che si sfracina, il divenir polvere di tutto ciò che è.
E’ un paesaggio inesploso, come una bomba ritrovata sottoterra, che ancora aspetta qualcuno che la disinneschi.
Capita allora, durante il percorso, di trovare caverne dove inoltrarsi, come a cercare di scovare il segreto della montagna. Caverne che sono poi cave scavate nella pancia dei monti, a strapparne le arterie più preziose. E dentro, se ti imbuchi un giorno in cui non si lavora, senti il sistema circolatorio della terra, gocciolii che formano pozze come cadendo da vene aperte, e fanno echi amplificati come nella più sacra delle cattedrali.
Se poi hai la fortuna di capitarci dentro in un giorno di lavoro, allora lo scopri il vero segreto di tutto questo: gli uomini-drago, quei cavatori che corrono da un’estremità all’altra della cava.
***
Il selciato di Carrara è ingombro di memorie. Non sai bene che farne. Da piazza Lucetti – e sì, continuiamo a chiamarla così nonostante lo stradario – si vedono le Apuane. E le Apuane ce l’hai sotto i piedi, nelle tarsie di marmo che la ricoprono per volere di Alberico, principe di Massa e marchese di Carrara, ce l’hai nel marmo del loggiato, ce l’hai nelle decorazioni degli edifici. Eppure, in quel troppo candore, può capitarti di vedere il rosso del sangue, quello sparso dai cavatori che lo hanno estratto nei secoli, e trasportato a valle con la lizzatura. “Chi costruì Tebe dalle Sette Porte? / Dentro i libri ci sono i nomi dei re. / I re hanno trascinato quei blocchi di pietra?”, scriveva Brecht. E qui, il nome del re è nella targa della piazza: Alberica. Nella targa invece non ci sono quei cavatori che i blocchi di marmo hanno trascinato. Il nome di Lucetti, marmista, poteva risarcire quegli assenti?
Dalla piazza saliamo col Taro verso il Duomo (ad essere precisi l’Insigne Collegiata Abbazia Mitrata di Sant’Andrea Apostolo). Meraviglioso il suo romanico-gotico (romanico portale e gotico rosone), ma si vede il sangue essudare anche da lì. Così torniamo nel luogo sacro dirimpetto, l’osteria di marmi e di Cynar. Ci facciamo altri due gocci di vino.
“E quindi stai insegnando al liceo? Io a scuola ho fatto la seconda media e poi non son più andato: tirai il calamaio al professore e lo presi in pieno. Sospeso tutto l’anno. A casa botte da mio padre, e non son più andato a scuola.” Gli racconto che in prima elementare fui sbattuto fuori dalla classe perché dissi “scema” alla suora. Ma poi rientrai nei ranghi. Il Taro ride, credo che insultare una suora non sia un peccato per lui. Gli chiedo, perché gli avevi tirato il calamaio? “A dir che mi ricordo ti direi una balla, ma era già un po’ che me la durava… Magari perché sapeva che i miei erano antifascisti, non lo so… e allora adesso basta, è ora di finirla, to’!” Accenna il gesto del lancio, ed è come un annuncio di vita. In guerra quel braccio avrebbe lanciato bombe ai tedeschi.
[…]
Mi piace sentire i racconti sui vecchi. Quegli uomini che non ci sono più, avvolti da aure eroiche, tempre che continui a cercare ma non trovi. Forgiati forse in altra materia.
“Elio, Mazzucchelli, li ho conosciuti tutti. Io ero col battaglione Lucetti, qui sulla Linea Gotica. Poi ci fu lo sganciamento: ci toccò andar via, di là dalla Linea Gotica, dove c’erano già gli americani, per evitare le rappresaglie dei tedeschi. Quando tornammo di qua la formazione prese il nome di Michele Schirru, un altro dei nostri, un sardo, che voleva uccidere Mussolini”. E già, solo gli anarchici in Italia avevano provato a uccidere il Duce. Schirru lo avevano ammazzato. “Il comandante della Lucetti era Elio. Un buon comandante, intelligente. E un uomo di fegato: in combattimento faceva una strage che guai, non lo fermava nessuno. Aveva vent’anni, pensa. Il padovano – Mariga, si chiamava – era il suo vice, ma quel che diceva lui era legge per tutti, anche per Elio. Aveva più autorità, anche perché era più vecchio, sulla quarantina, e nella guerra del 15-18 era stato premiato tre volte con la medaglia d’argento: segno che anche lui era un fegataccio, eh… Io avevo quindici anni, Mariga per me era un padre. Era bravissimo. Un carattere, una bontà… Ti curava, ti ascoltava, ti dava dei consigli – e te li dava buoni! Dopo la guerra gli volevano dare un’altra medaglia al valor militare, stavolta d’oro, ma la rifiutò. Era un anarchico vero, lui. In compenso gli fecero fare ventidue anni di galera, lo accusarono di aver giustiziato un fascista di Santo Stefano”. Nessuna amnistia per loro, solo per i fascisti. Mi viene in mente il generale Mario Roatta, responsabile di immani crimini di guerra in Jugoslavia. Lui, l’amnistia la ebbe.
[…]
“Non ce n’è più di uomini così, non ce n’è più. Oggi la gente è nata nel benessere. Punto e a capo. Promuove in quinta elementare e vuole la bicicletta, va in seconda media e vuole il motorino, mangiano bevono hanno soldi, il padre magari si priva lui per dare a loro, non hanno un’idea politica. Quegli altri uomini lì era differente: c’era la fame, e si ribellavano. Questi qui cosa vuoi che si ribellino che magari loro padre fa i debiti per prendergli la bicicletta? Sai quanta gente c’è, io li vedo, che dice sono anarchico: li hai mai visti qui, non so, a una riunione? Si vantano… uguale a quelli che dicono “sono comunista”, e non è vero… Non c’è paragone: dal giorno alla notte”.
Insomma Taro, dici che la differenza è che quelli erano nati in famiglie povere, di lavoro duro. “Eh, quando ce l’avevano il lavoro duro! I lizzatori, ché allora c’era la lizza per portare il marmo a valle, andavano sul ponte Baroncino, che lo chiamavano il ponte della Bugia, e aspettavano che li chiamassero a lavorare. “Oggi tocca a te, te e te”, gli altri se ne tornavano a casa, ed era fame… E’ questo il motivo, lavoro non ce n’era, e gli uomini si ribellavano… Se pensi che partivano da Carrara e andavano sul Canalgrande a piedi, lassù in cima, e lavoravano otto ore e ritornavano in giù sfondati… Sai quanti di quelli che andavano in cava passavano da Miseglia, dove ci sono le quattro fontane, mettevano sotto l’acqua un pezzo di pane, lo rincartavano, e a pranzo mangiavano pane e acqua…”
Taro, dimmi una cosa: per te il lavoro è un valore? “Per forza che è un valore, lo deve essere! Senza lavoro cosa fai? Sei obbligato a rubare, a ammazzare, a andare in galera. E il lavoro era un valore per tutti quegli uomini lì. Per questo a Carrara si è sviluppata così tanto l’anarchia: per il lavoro, per la fame! Senti ancora dei vecchi comunisti che ti dicono: Sono comunista ma la mia mentalità è anarchica!” Segno davvero di un altro tempo, questo: nessun anarchico di una generazione successiva ti risponderebbe mai che il lavoro è un valore. In quella società non c’era nemmeno la possibilità di pensare a una società in cui il lavoro non fosse un valore, tale era il grado di sfruttamento.
Taro, dimmi una cosa: se avessi chiesto a quei vecchi, cosa significa essere anarchico? “Pane, lavoro, niente galere, più giustizia fatta dal popolo. Non ne volevano sapere loro di quei lavori lì, governi e via discorrendo. Che è una man bassa di ladronismo. Altro che terzo mondo, il terzo mondo è qui! Se c’era ancora quella gente, secondo te succedeva così? Erano già andati a Roma ad ammazzarli! Ma con chi lo fai oggi come oggi quel lavoro lì? Qui? Con chi lo fai in Italia? Coi giovani? Non lo fai”.
Nelle parole del Taro c’è un mondo scomparso. “Quegli uomini lì” non possono tornare a essere. Sono consegnati definitivamente a un passato eroico, che non ha misura comune con il nostro tempo. Consegnati loro alla mitologia, a chi resta non è consentito sentirsi orfano. Si tratta di essere liberi, tocca esplorare il presente.
Cosa resta del padre, domanda l’analista, e risponde: la testimonianza. Che non è un universale, ma un esempio singolare – da uomo a uomo (e non, sia chiaro: da maschio a maschio). Oggi possiamo usarli, quei padri, proprio in ragione della loro distanza. Perché non è con i loro simboli e le loro pratiche che cambieremo il mondo, perché il mondo ha cambiato formato. L’esempio, però, la loro testimonianza – è questo ciò che resta. E che ci rende liberi.










 di Davide Orecchio
di Davide Orecchio L’assassino si nasconde tra le righe
L’assassino si nasconde tra le righe


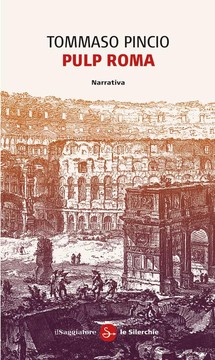
 di Marco Rovelli
di Marco Rovelli