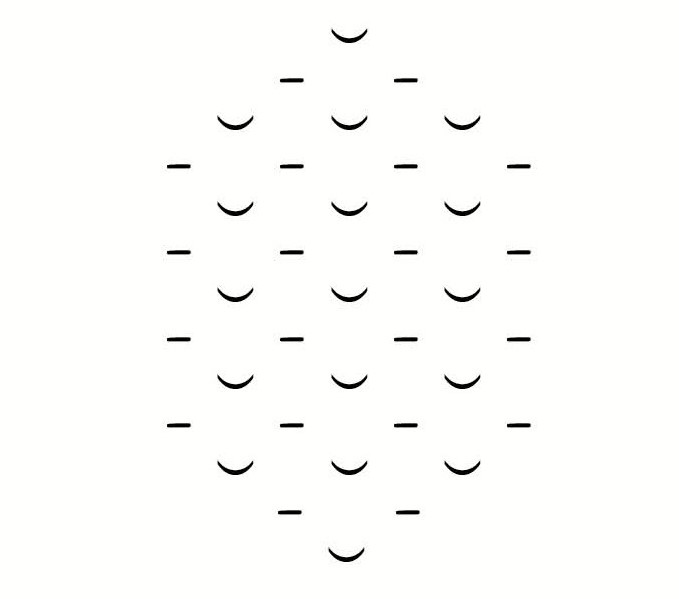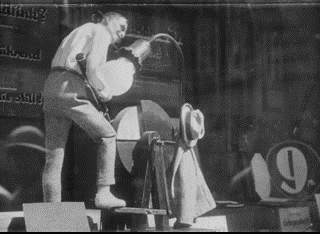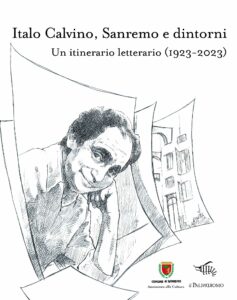
Pur senza dargli i natali, la città di Sanremo è centrale nella biografia di Italo Calvino perché vi trascorse gli anni fondamentali della sua formazione. «San Remo continua a saltar fuori nei miei libri, nei più vari scorci e prospettive» dichiarò lo scrittore in una celebre intervista. E proprio su questi scorci in cui si può riconoscere o intravedere Sanremo si articola l’itinerario proposto, poco più di quaranta tappe distribuite fra la città e l’entroterra. Mappa alla mano il lettore potrà seguire le tracce dell’opera calviniana, cercare il sentiero dei nidi di ragno e l’albero del barone rampante, ritrovare fra le strade di Sanremo le impalpabili città invisibili.
Il progetto di itinerario letterario è stato promosso dal Comune di Sanremo per celebrare il centenario della nascita dello scrittore (1923- 2023) e si è realizzato attraverso la collaborazione tra l’Università degli Studi di Genova, le scuole del territorio e l’Accademia di Belle Arti di Sanremo.
Questa guida è curata da Veronica Pesce e il progetto di itinerario è stato elaborato da Laura Guglielmi e Veronica Pesce. Il volume contiene in allegato la mappa letteraria della città con indicate le tappe della vita e dei riferimenti alle opere di Italo Calvino.
Prefazione al libro di Laura Guglielmi
I luoghi, le parole. Italo Calvino, Sanremo e dintorni
Italo Calvino ci ha insegnato a leggere con uno sguardo inedito il paesaggio di Sanremo e della Riviera Ligure. Ha scavato in profondità nelle pieghe del territorio e ci ha restituito pagine di straordinaria intensità. Il lavoro portato avanti dagli studenti dell’Università di Genova sotto la guida di Veronica Pesce e mia ha cercato di portare alla luce la stretta relazione tra i luoghi sanremesi e le opere dello scrittore. Calvino stesso ci autorizza a compiere questa operazione, in quel racconto paradigmatico che è la Strada di San Giovanni:
Ci vivevo in mezzo e volevo essere altrove. Di fronte alla natura restavoindifferente, riservato, a tratti ostile. E non sapevo che stavo anch’io cercando un rapporto, forse più fortunato di quello di mio padre, un rapporto che sarebbe stata la letteratura a darmi, restituendo significato a tutto, e d’un tratto ogni cosa sarebbe divenuta vera e tangibile e possedibile e perfetta, ogni cosa di quel mondo ormai perduto.
L’agronomo Mario Calvino, padre di Italo, d’estate obbligava i figli ad accompagnarlo nell’orto di proprietà a San Giovanni. Il giovane Italo avrebbe preferito fare tutt’altro. Era attratto dalla città «il resto era spazio bianco, senza significati; i segni del futuro mi aspettavo di decifrarli laggiù da quelle vie, da quelle luci notturne che non erano solo le vie e le luci della nostra piccola città appartata, ma la città uno spiraglio di tutte le città possibili».
Due strade che divergono, inconciliabili per il giovane Italo ma che, in seguito, si uniscono e trovano un’armonia narrativa. La campagna e la città sono due aspetti spesso presenti nella produzione dello scrittore e, ideando l’itinerario che troverete in questa guida letteraria, si è giocato a individuare, per me una volta di più, quali potessero essere le suggestioni visive depositate nel labirintico immaginario di Italo Calvino.
Azzarderei un’ipotesi: per Calvino non esiste una “terra madre”, ma una “terra padre”. Eva Mameli, la mamma dello scrittore, botanica di grande prestigio, era di origine sarda, mentre l’ambiente in cui si muove «lo scoiattolo della penna», come Cesare Pavese aveva soprannominato lo scrittore sanremese, è la Liguria di Ponente, che il padre conosceva a menadito e che avrebbe voluto i figli amassero quanto lui.
Passati gli anni adolescenziali, connotati da un forte contrasto con il papà Mario, che «del mondo vedeva solo le piante e ciò che aveva attinenza con le piante, e di ogni pianta diceva ad alta voce il nome, nel latino assurdo dei botanici», Calvino ormai adulto sente una intensa nostalgia per quello che non è più e mai potrà più essere. Il paesaggio di Sanremo, alla fine dell’Ottocento, uno dei più belli del nord del Mediterraneo, a partire dagli anni Cinquanta è stato devastato dalla speculazione edilizia, come racconta in uno dei suoi testi più militanti. E come scrive nel Barone rampante, gli umani «sono stati presi dalla furia della scure».
Quella vegetazione rigogliosa, quel bosco fitto di lecci, ulivi, aranceti, fichi, allori, dove Cosimo sceglie di trascorrere la sua vita, appollaiato sui rami, non esiste più. Ora è tutto «un sovrapporsi geometrico di parallelepipedi e poliedri, spigoli e lati di case, di qua e di là, tetti, finestre, muri ciechi per servitù contigue con solo i finestrini smerigliati dei gabinetti uno sopra l’altro» (La speculazione edilizia).
Se Mario Calvino non è riuscito a salvaguardare quel territorio che era stato la ragione della sua esistenza di scienziato, il figlio scrittore lo recupera e lo salva nel testo letterario. E la città, con il suo contesto geografico e naturale, diventa un variegato spazio linguistico non per questo meno vero. Tale trasposizione in parola e narrazione rivela uno dei compiti più importanti della scrittura per Italo Calvino: osservare, sondare e mappare la forma e la memoria di un territorio, riportando alla luce un mondo che non esiste più nella realtà, ma di cui si avverte ancora la presenza resistente nelle tracce disperse di una possibilità d’essere che è stata sistematicamente e brutalmente cancellata.
Nel 1999 ho portato alla New York University, in occasione delle celebrazioni che Giovanna Calvino aveva organizzato per ricordare il padre a New York, una mostra che metteva in risalto la Sanremo degli anni Trenta, attraverso foto d’epoca. Quelle immagini hanno attraversato l’Atlantico, solo perché accompagnate dai testi di Calvino. La mia ricerca iconografica non avrebbe destato alcun interesse senza la connessione con i luoghi dello scrittore.
Le descrizioni letterarie, quindi, sono ancora più necessarie delle immagini fotografiche perché rivelano la storia intima dei luoghi, lo scopo del loro esistere, e mettono in luce con chiarezza che la Storia avrebbe potuto seguire altri percorsi, che la Sanremo di oggi è solo una delle ipotesi possibili. La produzione dello scrittore, quindi, diventa anche un archivio che si stratifica e aiuta il lettore a decifrare lo spazio sociale, storico e geografico.
Tappa 28
via Roglio – Il sentiero dei nidi di ragno
Prima della copertura, il torrente San Francesco scorreva a valle della Pigna, parallelamente a via Porte Candelieri. Questa zona è oggi quasi irriconoscibile per l’opera di tombinatura dell’alveo del torrente. Occorre dunque un certo sforzo d’immaginazione, per rileggere questo passo del Sentiero dei nidi di ragno:
Pin va per i sentieri che girano intorno al torrente, posti scoscesi dove nessuno coltiva. Ci sono strade che lui solo conosce e gli altri ragazzi si struggerebbero di sapere: un posto, c’è, dove fanno il nido i ragni, e solo Pin lo sa ed è l’unico in tutta la vallata, forse in tutta la regione: mai nessun ragazzo ha saputo di ragni che facciano il nido, tranne Pin… […] Lì, tra l’erba, i ragni fanno delle tane, dei tunnel tappezzati d’un cemento d’erba secca; ma la cosa meravigliosa è che le tane hanno una porticina, pure di quella poltiglia secca d’erba, una porticina tonda che si può aprire e chiudere. (Il sentiero dei nidi di ragno)
Ma è vero che i ragni fanno il “nido”? Meglio parlare di “tane” o “cunicoli” che alcune specie di ragni fossori scavano nel terreno. Si tratta di ragni del genere Nemesia, che vivono all’interno di tane verticali scavate nel terreno e rivestite di tela, protette in superficie da una botola intessuta dal ragno stesso.
È notte: Pin ha scantonato fuori dal mucchio delle vecchie case, per le stradine che vanno tra orti e scoscendimenti ingombri di immondizie. Nel buio le retimetalliche che cintano i semenzai gettano una maglia d’ombre sulla terra grigiolunare […] È una scorciatoia sassosa che scende al torrente tra due pareti di terra ed erba. (Il sentiero dei nidi di ragno)
In questo posto segreto che solo lui conosce, Pin ha nascosto la pistola sottratta al soldato tedesco. Appena fuori dalla Pigna, Pin si muove fra «orti e scoscendimenti ingombri di immondizie». La descrizione non è dissimile da quella che si legge nella Strada di San Giovanni:
Al di là [del torrente San Francesco] si levava, come una quinta, – il torrente era nascosto giù in fondo, con le canne, le lavandaie, il lerciume dei rifiuti sotto il ponte del Roglio, – la riva di Porta Candelieri, dov’era uno scosceso terreno ortivo allora di nostra proprietà. (La strada di San Giovanni)
Difficile dire se Calvino abbia davvero visto qui i ragni che scavano queste tane, ma la descrizione offerta nel Sentiero, accanto a quella più riconoscibile nella Strada di San Giovanni, ci rinviano al torrente San Francesco che ancor oggi scorre, pur completamente coperto, sotto «la riva di Porta Candelieri», nell’attuale via San Francesco. Lo scenario calviniano è totalmente cancellato. Perduto alla vista il torrente, insieme con le scorciatoie scoscese, gli orti, il ponte del Roglio, fors’anche i ragni, con i loro “nidi”, ci resta soltanto (ma non pare poca cosa!) la straordinaria forza di una bellissima pagina della nostra letteratura.
→ Proseguire su via Roglio, rondò Volta e via Volta, svoltando poi a sinistra in via Meridiana
Tappa 29
via Meridiana – Villa Meridiana
Una spiegazione generale del mondo e della storia deve innanzitutto tenerconto di com’era situata casa nostra nella regione un tempo detta «punta di Francia», a mezza costa sotto la collina di San Pietro, come a frontiera tra due continenti. In giù, […] la città coi marciapiedi le vetrine i cartelloni dei cinema […] in su, bastava uscire dalla porta di cucina […] e subito si era in campagna, su per le mulattiere acciottolate, tra muri a secco e pali di vigne e il verde. (La strada di San Giovanni)
Quasi irriconoscibile rispetto alla forma che Mario Calvino a partire dal 1925 le aveva dato, facendone la sede della Stazione sperimentale di floricoltura «Orazio Raimondo», oggi Villa Meridiana si presenta soffocata dai palazzi e priva di quel parco che la rendeva unica con i suoi circa 3000 mq. di estensione e la presenza di oltre quattrocento varietà di piante tropicali.
Luogo essenziale nella biografia dell’autore, che l’abitò fino all’età di 22 anni, è l’origine prima del suo sguardo sul mondo «sempre come su un balcone, affacciato a una balaustra […] teatro il cui proscenio s’apre sul vuoto». La villa appare e riappare, senza soluzione di continuità, in tutta l’opera di Calvino, soprattutto la prima, più legata alle origini sanremesi.
È il caso del racconto Un pomeriggio,Adamo, che apre la raccolta Ultimo viene il corvo. La villa non è mai nominata, ma la riconoscibilità della figura di Libereso (cfr. tappa 36) e l’ambientazione nel giardino non lasciano dubbi: «Libereso si mise a girare tra le calle. Erano tutte sbocciate, le bianche trombe al cielo. Libereso guardava dentro ogni calla, ci frugava dentro con due dita e si nascondeva qualcosa nella mano stretta a pugno. […] Libereso schiuse le sue mani […] piene di cetonie, cetonie di tutti i colori. Le più belle erano le verdi, poi ce n’erano di rossicce e di nere, e una anche turchina» (Un pomeriggio Adamo).
Ha indubbie parentele con Villa Meridiana, pur nello slittamento diacronico, anche la villa
di Ombrosa, proprietà dei Baroni Piovasco di Rondò:
Fu il 15 di giugno del 1767 […] Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d’Ombrosa, le finestre inquadravano i folti rami del grande elce del parco. […] Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: ‒ Hodetto che non voglio e non voglio! ‒ e respinse il piatto di lumache. Mai s’era vista disubbidienza più grave. (Il barone rampante)
E forse ancor più della proprietà dei Piovasco di Rondò, guarda a Villa Meridiana il giardino della confinante proprietà dei Marchesi d’Ondariva. Lo sfoggio di presenze esotiche non può che richiamare l’attività di Mario Calvino presso la stazione di floricultura da lui diretta:
Infatti, digià il padre degli attuali Marchesi, discepolo di Linneo, avevamosso tutte le vaste parentele che la famiglia contava alle Corti di Francia e d’Inghilterra, per farsi mandare le più preziose rarità botaniche delle colonie, e per anni i bastimenti avevano sbarcato a Ombrosa sacchi di semi, fasci di talee,arbusti in vaso e perfino alberi interi. (Il barone rampante)
L’epilogo è tristemente noto: prima di essere venduta dopo la morte di Eva Mameli (1979) e totalmente trasfigurata, privata di quasi tutto il giardino, la villa aveva già subito una prima decurtazione alla morte del padre (1951) con l’edificazione di un condominio nella parte più bassa del giardino. La speculazione edilizia (pur senza mai nominare Sanremo né tantomeno Villa Meridiana) racconta proprio questo primo intervento, restituendo insieme con esso il clima generale di un’epoca con tutte le sue contraddizioni (cfr. tappa 17):
La frase: – Se tutti costruiscono perché non costruiamo anche noi? – che egli aveva buttato lì un giorno conversando con Ampelio in presenza della madre, e l’esclamazione di lei, a mani alzate verso le tempie: – Per carità! Povero il nostro giardino! – erano state il seme di una ormai lunga serie di discussioni, progetti, calcoli, ricerche, trattative. Ed ora, appunto, Quinto faceva ritorno alla sua città natale per intraprendervi una speculazione edilizia. (La speculazione edilizia)
→ Ritornare in via Volta e proseguire ancora in direzione levante




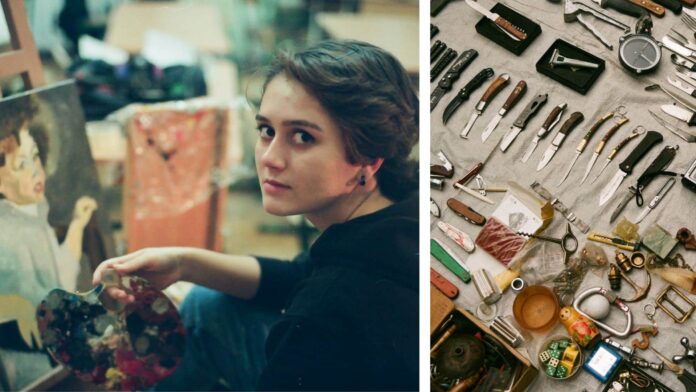
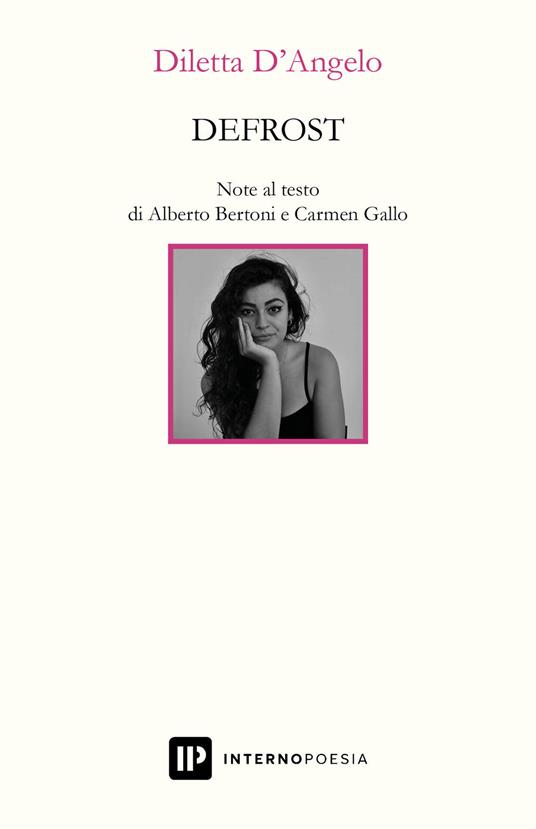
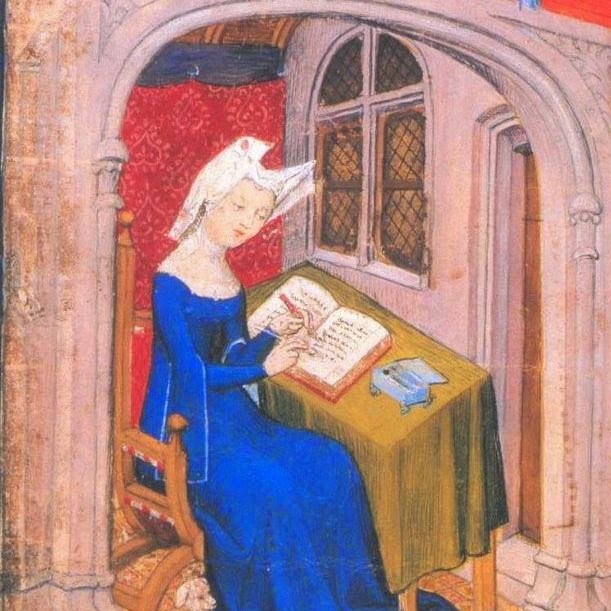







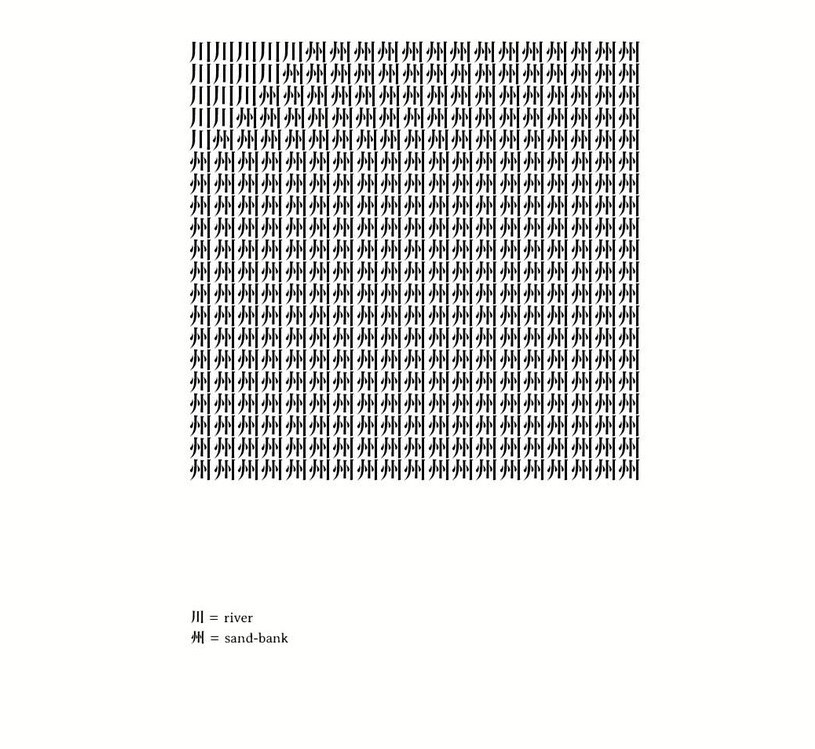
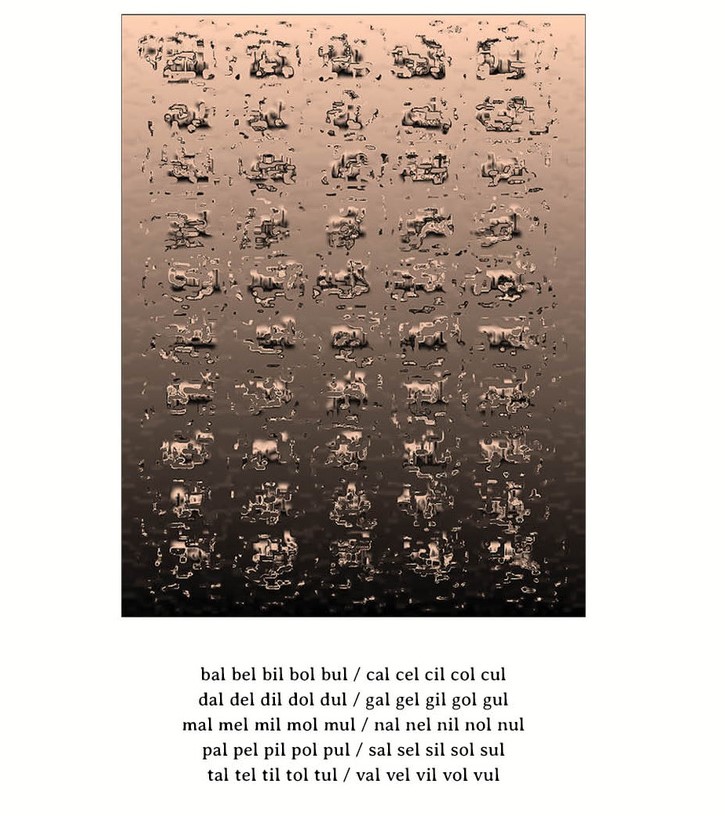


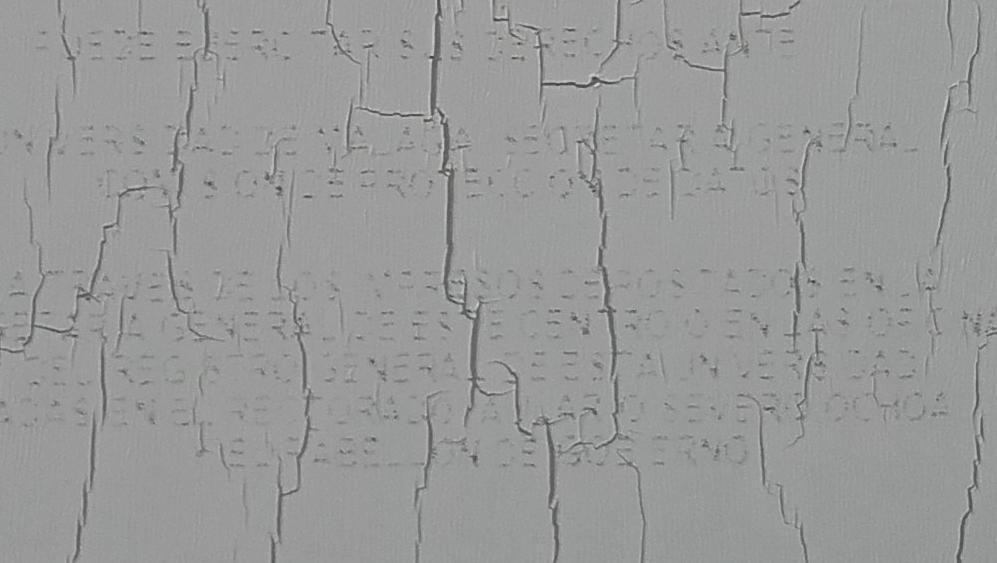

 Frutto della collaborazione tra l’Università di Bologna e l’Associazione Emilia-Romagna di Parigi, grazie al contributo dell’Assemblea legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, l’atelier tenutosi alla librairie italienne Tour de Babel è stato ideato e organizzato da Giulia Molinarolo (sua l’introduzione al dossier) per consentire la fruizione comunitaria di uno spazio libero, dialogico e formativo nel quale raccontarsi. Qui di seguito l’ouverture firmata da Wu Ming 2 che lo ha animato.Vi proponiamo a seguire gli incipit dei diversi racconti offrendo la possibilità a chi lo volesse di leggerli per intero nel pdf che è possibile scaricare
Frutto della collaborazione tra l’Università di Bologna e l’Associazione Emilia-Romagna di Parigi, grazie al contributo dell’Assemblea legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, l’atelier tenutosi alla librairie italienne Tour de Babel è stato ideato e organizzato da Giulia Molinarolo (sua l’introduzione al dossier) per consentire la fruizione comunitaria di uno spazio libero, dialogico e formativo nel quale raccontarsi. Qui di seguito l’ouverture firmata da Wu Ming 2 che lo ha animato.Vi proponiamo a seguire gli incipit dei diversi racconti offrendo la possibilità a chi lo volesse di leggerli per intero nel pdf che è possibile scaricare 









 di Valerio Paolo Mosco
di Valerio Paolo Mosco