 di Riccardo Ielmini
di Riccardo Ielmini
Nives Sartori fece un balzo giù dal Cruiser Toyota come una semi diminuita jazz scivolata via da una partitura neoclassica. Era scalza: gli autobloccanti della stazione di servizio trasudavano afa e sporcizia. Lei lo sentì subito e le passò la smania di fare la naïf: sbuffò, afferrò le espadrillas rosse da sotto il cruscotto, diede un colpo di mano alla pianta dei piedi e le indossò. Fredy era già sceso e armeggiava con la pistola del diesel: guardò Nives mettersi di trequarti allo specchio nel lunotto posteriore e darsi una controllata: mica che fosse gualcito lo splendore che a sua madre faceva venire in mente Liz Taylor. Fredy ricordò la volta che la vecchia aveva supplicato sua figlia: Nives amore mio, non finire gonfia come una Big Babol, non fare Lizzy in gara con Richard Burton a chi svuota per primo il frigobar di un hotel su Hollywood Boulevard. Il genere di sceneggiate à la Sartori che lo mettevano in imbarazzo. Comunque: Nives diede anche una tirata alla coda con la quale aveva raccolto i capelli e inforcò i Ray-Ban Jackie, infischiandosene che in una manciata di secondi sarebbe scoccata la mezzanotte. D’altra parte, se gliel’avessero fatto notare, che era buio pesto, firmamento stellato e tutto il resto, lei avrebbe indicato i grandi neon della stazione di servizio e avrebbe proclamato agli dei della giovinezza: «C’è questa luce accecante, cazzo. Voi non lo sentite il fastidio, mica?». Fredy, tornando dalla festa di matrimonio cui l’aveva trascinato lei, aveva giocato d’anticipo sulla spia della riserva e impostato il self su 50 euro. Era ancora mezzo ferito per le cose che si erano detti qualche chilometro prima, ma la ragazza era un animale umano meraviglioso e c’era poco da dire. Altro che quell’ubriacona di Lizzy Taylor.
«Eccoci» disse. «Dovrei indossare le maledette scarpette di cristallo, io. Mica quella sciacqua di Cenerentola. Invece eccomi qui con espadrillas scialbe da piedi gonfi, roba da vecchie contadine di Provenza imbalsamate nella lavanda». Inarcò la schiena sulla curva della scocca. Sbuffò come la gatta sul tetto. «No, no, mica. Io poi la odio, la Provenza. Sicuro roba da stronzi». Ogni volta che tirava in ballo gli stronzi, Fredy non lo capiva, a chi si riferisse di preciso. E non voleva saperlo, perché sotto sotto aveva il terrore di carezzarla pure lui, la grande landa degli stronzi, per via del suo lavoro in Borsa o per via che lui non era capace come lei di dare dello stronzo a qualcuno, un qualcuno qualunque là fuori.
«E la carrozza? E i lacchè? E il palazzo? Niente di niente. Manco il principe». Sbuffò di nuovo. «Dio, che luci! Accecano, cazzo!». Calcò forte su principe e cazzo, perché sapeva che Fredy, in mezzo a tutto il suo gorgheggio notturno, su quello avrebbe drizzato le antenne. Lei lo sapeva, cosa gli passava per la testa, a Fredy. Non si era inarcata sulla scocca mica per niente. Mica. Armeggiò con la borsetta e tirò fuori Zippo e un pacchetto di Dunhill. Ne tirò fuori una che fissò fra le labbra. Poi fece scattare lo Zippo una, due, tre, quattro volte, senza accendere: giusto perché lo schiocco metallico ci stava a puntino, sotto quella luce da astronave. Guardò verso il bosco che lambiva la stazione di servizio.
«Toh, forse il palazzo c’è, dopotutto». Era la sagoma di una grande villa, che sbucava come un gigantesco dolmen dal profilo frastagliato della boscaglia. Smise di far schioccare lo Zippo.
Mentre facevano i conti con il ticchettio del contatore del diesel che girava come una slot machine, una Bmw 320 cabrio planò sull’altro lato delle pompe. Scese un tizio, biondo, infilato in un paio di bermuda fiorati, una camicia di lino, aperta fino al terzo bottone e un paio di All Star sdrucite. Sventolò 20 euro che fece sparire nel self. Staccò la pistola, attaccò il rifornimento e disse: «Ciao, belli miei». Nives lo iscrisse dritto dritto nel girone dei figli di paparino, una sottomarca degli stronzi che a lei piaceva da matti stuzzicare per tirarne fuori il peggio, perché solo il peggio quelli si portavano appresso nelle scorribande sul pianeta. Riprese a far schioccare un paio di volte lo Zippo.
«Non si può fumare» disse Fredy all’improvviso. Non era un rimprovero: era un ragazzone di pace dietro i suoi browline. Lui non la rimproverava: le diceva che c’era una regola. Di tutta la vecchia compagnia dei tempi andati, giù, al bowling, Fredy era sempre stato così. E Nives questo lo sapeva, benché fosse arrivata quando la combriccola giù al bowling era già scoppiata da un pezzo e ognuno dei vecchi amici aveva preso più o meno la propria strada. Nives lo aveva saputo subito, che lui era il tipo da grande fortezza di regole, eccetera: da quando si erano annusati come cerbiatti in un campus estivo messo in piedi dall’Università in una valle walser. Nives lo aveva stanato come il prediletto, prima da lontano, dietro lo schermo notturno di un gigantesco falò; poi più da vicino, nelle sue interminabili chiacchierate di fine giornata; e infine da vicinissimo, in una sera che era stata la loro scintilla seminale. Per Nives era irresistibile che fossero atterrati a quel falò da galassie diversissime: Fredy silenzioso, puntuale, aveva bruciato economia magna cum laude, e poi dritto per dritto a ficcare il naso negli indici FTSE MIB per società di brokeraggio a caccia del grande slam; Nives chiassosa, irregolare, sparpagliata negli andirivieni delle Dunhill e di lunghe tirate sulla Storia delle Ingiustizie (un corso universitario che abitava solo nella sua testa), prima di decidersi a chiudere con la tesi sul priore di Barbiana e buttarsi su una cattedra di lettere nella stessa scuola cattolica in cui aveva imparato a fumare dieci anni prima. Gettò lo Zippo nella borsetta, si staccò dalla portiera del Cruiser, occhieggiò fra le pompe e decise che era il momento per accendere la sua blitzkrieg con il nuovo arrivato.
«Hai da accendere, mica?» gli chiese. Quello armeggiava con lo schermo del cellulare, ma disse: «Non si può fumare qui: l’ha detto anche lui, bella mia».
«Ah. Lui l’ha detto. Però si dà il caso che questa sia una Dunhill».
«Ah be’. Ho visto su YouTube un tizio che si accende una sigaretta alla stazione di servizio; allora il benzinaio carica un estintore da battaglia e glielo spruzza in faccia. Proprio sul muso. Swaash!».
«Non era mica per la sigaretta. È che non era Dunhill. Le Dunhill, con le istruzioni giuste le puoi fumare. Speciali. Foglie alte di tabacco. John Lennon. Giovanni Falcone. E io. Il club Dunhill».
«Con le istruzioni. Come no» fece quello.
«L’ha detto lui. Cos’è, vi siete messi d’accordo?».
«Come no».
Nives rigirò la sigaretta fra le dita e sbuffò. «Eri mica al matrimonio, tu?» domandò. Sapeva già la risposta, perché lei aveva una memoria infallibile e uno così mica se lo sarebbe scordato, anche se si fosse sbarazzato in fretta di un Armani blu navy per indossare quella paccottiglia da hawaiano. Con la coda dell’occhio vide che Fredy aveva quasi finito.
«Quale matrimonio?».
«Nella villa, sopra là» rispose Nives, indicando la massa tonda e buia della collina che sovrastava la Sp29.
«Ah. No, non c’ero. Fanculo i matrimoni, comunque».
«Ah, sì?».
«Gente che mangia e beve. Gente che si imbosca al cesso per una sveltina. Gente che si promette la grande menzogna».
«Mica siamo andati lì per la metà di quella roba».
«Infatti siete in fuga, belli miei».
Fredy e l’altro si avvicinarono alle colonnine a riagganciare la pistola. Avrebbe scelto Fredy per un altro milione di volte.
«Mica in fuga. No, no. Mica hai capito. Io adoro i matrimoni. Io li adoro». Ma con quella frase parlava a Fredy, che la sentisse forte e chiaro.
«Ah, sì? Non mi sembrate granché allegri, però, belli miei».
Nives pensò che belli miei impreziosiva il vuoto della sua gang al giro di birra, al rollo di un paio di canne e al catalogo di ragazze che si sarebbero ripassate alla prima festa di turno. Lo avrebbe incendiato con una vampa di Zippo se quello non avesse fatto un saluto fasullo da cowboy per risalire sulla cabrio.
«Ma vaffanculo» disse Nives ad alta voce, mentre quello era già sulla Sp29. Voleva che Fredy la sentisse bene. Vaffanculo i belli miei scollati dalla bacheca della tua camera bambocciona, vaffanculo te e la sciacqua pescata su misura per te (che per Nives voleva dire una tizia per tirare a campare, comprando cose inutili, girando gastronomie per trovare tutto pronto, infischiandosene della Storia delle Ingiustizie, eccetera). Gridò forte perché sapeva che anche Fredy disprezzava quella roba perché gli ricordava suo padre e sua madre, gli imperdonabili che avevano fatto a pezzi la sua infanzia. Nives guardò verso la villa. Arrivava un rumore arruffato, un ronzio umano che aveva qualcosa di sinistro. Un brusìo da demoni. Fredy non lo sentì. Riagganciata la pistola, fece due passi infilando le mani in tasca. Spasimava per i notturni nelle stazioni di servizio: una silenziosa costellazione di porti sicuri. Una sera, quando aveva tredici, quattordici anni e si era buttato a leggere orribili romanzi di fantascienza, steso sul letto, aveva immaginato di collegare tutte le stazioni di servizio accese nella notte. La mappa degli allarmi agli attacchi alieni, la grande fortezza dove andare a parare quando la sua testa precipitava nello sfacelo dei ricordi, cioè l’inferno che era stata la sua infanzia: le urla e le mani addosso e il gelo negli anni in cui lui e suoi fratelli avevano vissuto con gli imperdonabili. Poi si fermò, si aggiustò i browline al naso e tornò indietro. Guardò intorno. Si accorse di un viottolo di terra battuta che dava alla grande villa. Fredy pensò che era esattamente il tipo di strada che a Nives sarebbe piaciuto infilare, una pancia di buio caldo: sarebbe piaciuto anche a lui, ma ogni volta che pensava di proporre qualcosa di fuoriserie, aveva paura di fare la figura del coglione, e così non diceva niente. Guardò la sagoma della villa: vide un paio di luci accese e stavolta lo sentì anche lui, il ronzio umano. Una portafinestra al primo piano si aprì e un’ombra sgattaiolò fuori, con una sigaretta accesa: lo si capiva dal puntino rosso nel nero della notte. Farfugliava qualcosa. Il brillo del puntino rosso faceva su e giù. La villa non era in pace e Fredy per certe cose non sbagliava. Più di tutto, desiderò appoggiarsi vicino a Nives e aspettare che lei si accendesse quella maledetta sigaretta, regole o non regole. Perché lui era un uomo di pace e non voleva pensarci più, a quello che si erano detti durante il viaggio. Nives, intanto, accese la Dunhill.
«Noi mica finiremo come quelli lì. Mica?» aveva detto una mezz’ora prima, appena venuti via dal matrimonio, all’imbocco della Sp29. «Oddio, forse siamo già così, cazzo». Aveva tirato giù il frangisole e si era guardata nello specchietto: «No, no. Per ora tutto in regola. Mica come quelli lì». Nives si riferiva ai «quattro stronzi» con i quali le era toccato dividere il tavolo durante il banchetto, una claque in perpetua trafila di letti, aperitivi, business, shopping: uguali uguali alla noia di una coda di almeno sei chilometri.
«Potresti non dire “cazzo” ogni volta?» aveva risposto Fredy. E aveva aggiunto, sistemando i browline al naso: «Per favore».
«Uffa. Stai tranquillo, non ne ho detto nemmeno uno quando te la sei svignata dal tavolo per andare chissà dove. Anzi. Sei tu che non devi dirmi “per favore”. Mi dà sui nervi. Se vuoi litigare con qualcuno, non gli chiedi mica “per favore”. Io non lo faccio, mica». Si era aggiustata la coda. «No, non glielo chiedi mica, a uno con cui vuoi litigare». Aveva appoggiato il gomito sulla portiera e la guancia sul palmo della mano. «E non hai risposto alla mia domanda. Finiremo mica come quelli. Ma tu non rispondi, mai». A Fredy la parola mai faceva paura, come la parola sempre. Lui era per i titoli in piazza Affari: non ce n’era uno che durasse sempre, non ce n’era uno che non crollasse mai. Con i quasi potevi controllare le cose, non sbavare, stare a galla.
«Non siamo come quelli lì. Penso di no. E non ci diventeremo. A meno che tu non voglia. Io non voglio». Fredy in quelli ci rivedeva suo padre e sua madre che avevano pensato solo alle reciproche dichiarazioni di guerra, infischiandosene di lui e dei suoi fratelli.
«Rassicurante».
«Perché ogni volta devi fare così».
«Ogni volta perché ogni volta è come se non avessi fatto la volta precedente. Tu non ti smuovi mai».
«Io vedo le cose come sono. Non credo diventeremo così. Io non diventerò così».
«Ecco. Tu non ci diventerai, mica. E io? Sai cosa penso? Penso che non ti fidi di me. Sicuro l’avrai pensato: chissà se a lei va bene starsene seduta in mezzo a quelli là, mica?».
«Smettila. Qualunque cosa io dica, non ti andrebbe bene».
«No, senti. La verità è che ho la sensazione che sia io a non andarti bene. Ho l’impressione che io non vada bene. Che non sono abbastanza. Abbastanza cosa, poi. Cosa? Come quella là, la tua Frida?». Nives sapeva che tirare in ballo la Frida, morta e sepolta prima che loro due si incontrassero lo avrebbe fatto saltare per aria: ma la Sp29 le era parso il posto giusto per il bum-crash! fra di loro. «Io mica sono come lei. E lei è bell’e che morta. Io no. Io sono qui, arrivata al momento giusto, e sono il meglio. Cazzo se sono il meglio». Nives era venuta su irregolare negli scadenzari delle cose di questo mondo, ma robusta nelle cose degli esseri ultraterreni, quelle che il tempo non si azzarda a farci la guerra. Quando diceva che era il meglio del tempo di Fredy, sapeva il suo destino e basta: essere per Fredy. Essere la migliore per lui nei tempi dei tempi.
«Cosa c’entra la Frida. Non toccare le mie cose. E smettila di dire “cazzo”». Nives aveva annotato nel suo block-notes aereo che lui non diceva “piantala”: diceva “smettila”. Che è più delicato. Era per questi particolari che Nives lo considerava il migliore per lei nei tempi dei tempi.
«Secondo me la Frida lo diceva. Lo diceva eccome: cazzo di qui, cazzo di là». Si era stesa di tre quarti sul sedile, guardando fuori dal finestrino. «Quindi noi non diventiamo come quelli là. Ok» aveva sussurrato. Sembrava implorasse il bum-crash! dell’ultima conferma.
«No. Noi no».
«Noi o tu?».
«Noi due. Passami una cicca, per favore».
«E da quando tieni delle cicche? Fanno male. E dove?».
«Lì. Sotto. Ho la bocca secca».
Scovato il pacchetto nel vano porta oggetti, ne aveva presa una e gliel’aveva messa sul palmo della mano, come una particola o un pegno per l’aldilà. «Quindi noi non facciamo il brodo tiepido che stai insieme a qualcuno, ci scopi e ci fai le vacanze e vai a vedere autosaloni e vasi di cristallo per il soggiorno. Noi la nostra vita è semplice-semplice ed è questa: che ci amiamo. Poi ci sposiamo. Poi ci amiamo. Poi facciamo quattro figli. Li amiamo e loro ci amano. Poi ci odiano e noi loro. Ma poi ancora ci amiamo e li amiamo. Poi preghiamo di morire prima di loro. Poi moriamo prima di loro. E dovunque finiamo, abbiamo un segno di riconoscimento. E ci ritroviamo. Io non voglio meno di questo, Fredy». Poi aveva cambiato tono e aveva detto: «Dio che strazio queste scarpe!». Si era chinata, aveva sciolto il laccio che avvolgeva la caviglia e si era tolta le scarpe.
«Quattro figli. E se diventassero come quelli là? Quattro figli che finiscono nel tuo girone degli stronzi?» aveva detto Fredy.
«Fatti loro. Noi ci abbiamo provato. Li abbiamo desiderati diversi. Poi, fatti loro».
Fredy aveva visto i suoi fratelli più grandi diventare congegni affamati sempre di qualcosa che li arrapasse e che tappasse il gigantesco buco allargato sotto le loro vite di figli abbandonati. Se lui non era così, se non sarebbe mai diventato così, era solo perché aveva dato retta a sua nonna, la povera vecchia che li aveva tirati fuori dall’inferno.
«Allora?».
«Non lo so».
«Cosa, non sai?».
«Boh. Mettermi alle strette così».
«Qualcuno deve farlo, bello mio». Nives aveva teso la corda sul vuoto, e non conosceva altri modi di campare se non camminarci sopra. Da qualche tempo aveva messo a fuoco il desiderio, e sapeva che il desiderio è di una materia che non va su e giù come dannatissimi indici di borsa. Sta sempre lassù nel suo zenit, il desiderio. Fredy era esausto ed era entrato in una palude di silenzio. Poi era arrivata l’asticella bassa del serbatoio, e la stazione di servizio.
Ora erano sotto i grandi neon e Fredy la guardava. Si abbarbicò ad immaginare un flash di futuro: Nives a piedi nudi che indossa una sua camicia, lui mezzo steso sul divano con una bambina che gli respira addosso. Una fantasia che spazzava via le porcate di senso comune con cui si era schiantato al tavolo del matrimonio. Lo facevano commuovere, i bastioni della gioia prefigurata in quella scena. Però poi: una che diceva “cazzo” ogni mezza frase, poteva tirare su quattro figli? Una che lo braccava con tutto quel gran teatro, poteva far durare quel suo impareggiabile progetto di vita semplice-semplice? Fredy ingaggiò il corpo a corpo con la gioia che aveva provato, perché se le ricordava, le liti furibonde dei suoi, che facevano a botte e latravano come Schutzstaffel. Lui aveva provato a dimenticare la notte in cui sua nonna aveva trascinato lui e i suoi fratelli fuori da quella casa perbene dove sarebbero stati perduti per sempre. Lui ci provava a venirne fuori, dal portone della sua infanzia, ma testa e cuore sembravano intrappolati fra le quattro mura di quella gattabuia.
Nives intanto si era staccata dal Cruiser e aveva fatto una decina di passi verso il bosco. Era alla sterrata che portava alla villa, già oltre la linea di luce della stazione di servizio. Fredy la guardò: una gatta flessuosa come Lizzy Taylor all’apice del suo incanto. La guardò scivolare sulle espadrillas, entrare nel semibuio con la scia di fumo della sigaretta che segnava il suo cammino come i sassolini di Hansel e Gretel. Poteva starci davvero un destino fuori categoria, la vita semplice-semplice da matrimonio e quattro figli e tutto il resto? La guardò e si lasciò gioire, perché la ragzza non era una capace di fumare Dunhill seduta su 35 metri cubi di combustibile, pensando solo a un destino da Cenerentola, lei? Mica era una così, lei? Mica c’era da perdersi un’occasione così, mica?
Nives si fermò e si girò verso di lui: «Ssst! Senti…senti!».
Fred aggiustò gli occhiali sul naso. Prima gli arrivarono le grida. Poi, uscendo anche lui dal cono dei neon, piantò gli occhi sulle luci accese al primo piano. Vide le tende che si muovevano alla brezza estiva, e poi cominciò a sentire distintamente le grida, gli insulti, i colpi e rimase lì, fermo, piantato, con il solo desiderio che Nives tornasse indietro, che lui non avesse fatto rifornimento, che non fossero mai stati al matrimonio. Ma Nives aveva già messo in cantiere altri dieci passi in avanti, e ormai era dentro il viottolo sterrato. E in quel momento tutti e due la videro arrivare: un’ombra minuscola, frenetica, che via via prendeva la forma miracolosa di una bambina, scalza e con indosso un pigiamino corto. Era una bambina in corsa. Una bambina che piangeva. Nives guardò ancora indietro, verso Fredy. Aveva ancora i Ray-ban e li levò veloce. Nella penombra Fredy non poteva vederle gli occhi, ma lo sapeva, che cosa avrebbero deciso, quegli occhi. Nives corse incontro alla piccola, mentre le grida si facevano più tremende dei rumori di cose e corpi che cadevano e si perdevano per sempre. Fredy guardò Nives che prendeva in braccio la bambina e sentì che le chiedeva: «Come ti chiami?». Quindi tornò indietro con la piccola in braccio e gli disse: «Non possiamo lasciarla qui, mica?» e gli passò fra le dita la sua Dunhill ancora accesa. Fredy prese la sigaretta e sentì la mano libera di Nives stringersi al suo braccio, mentre passava e si dirigeva correndo verso il Cruiser: in un attimo era già rientrata nel bagliore dei neon. Prima di fare ciò che doveva, per un secondo Fredy rimase lì, la Dunhill fra le dita, elegante, guardando verso la villa e lasciando che ad ogni urlo, ad ogni tonfo il suo cuore rimettesse piede nello sfacelo. Gli tornò in mente che in quell’altra tremenda notte, nel trambusto di sua nonna che li caricava su una vecchia Volvo rossa per tirarli fuori dal disastro, in quella notte non era riuscito a portarsi dietro i pesciolini rossi, e non ne aveva saputo più niente. Forse Nives, se fosse stata con lui, sarebbe tornata indietro. Anzi, sarebbe tornata indietro di certo. Mica si può lasciarli lì, i pesciolini rossi delle mie brame, mica si può, no? L’avrebbe vista venir fuori dall’inferno, con la Dunhill penzolante sulle labbra, la boccia di vetro sottobraccio, con dentro l’acqua e i pesciolini rossi e tutto il resto della sua infanzia.



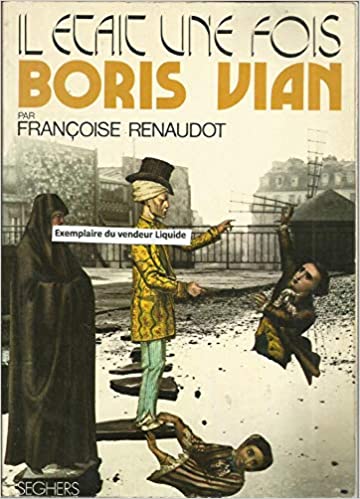
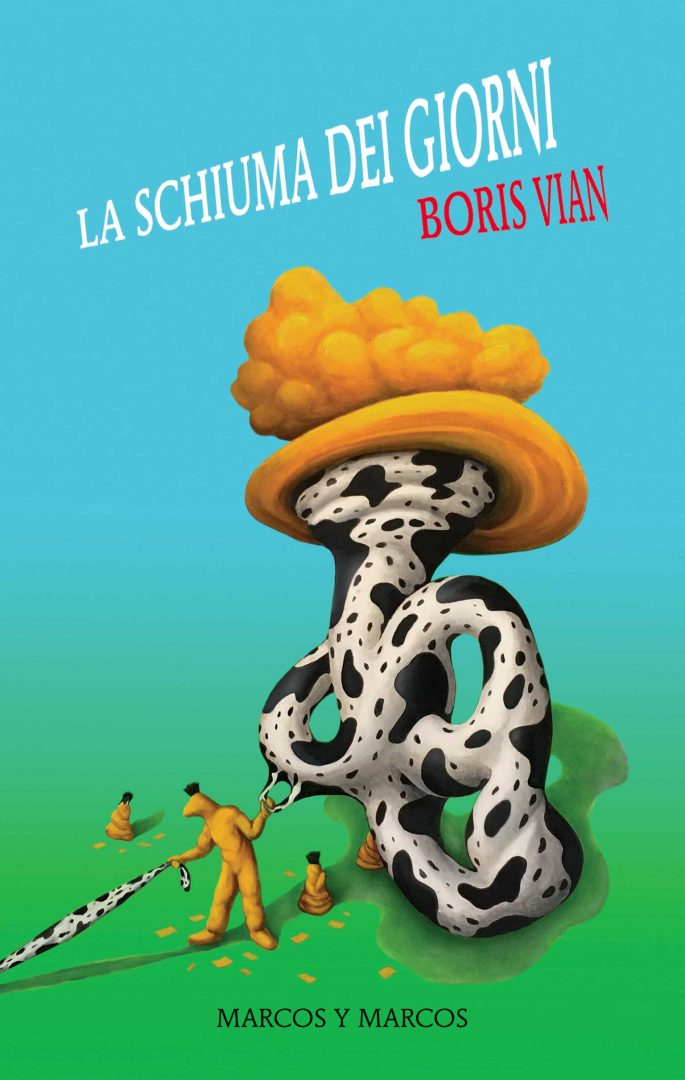















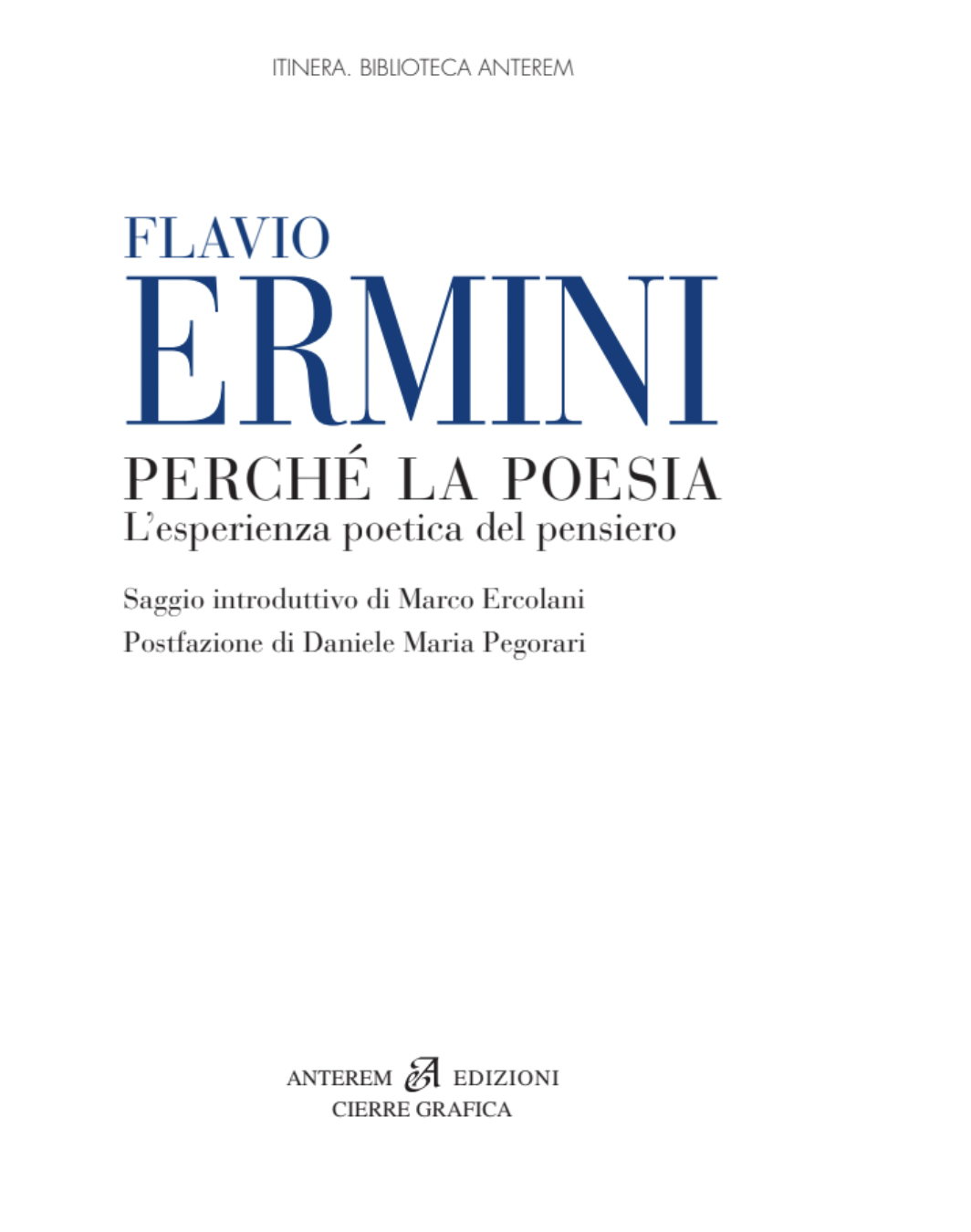
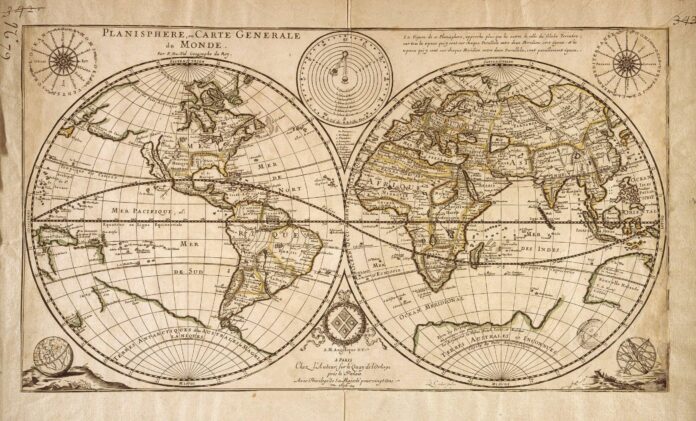

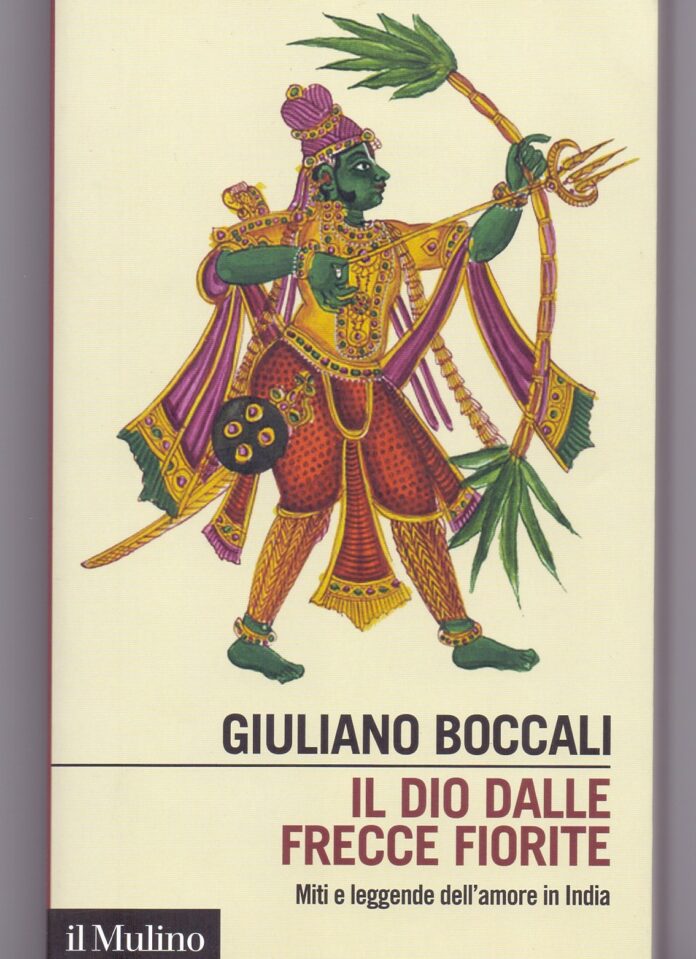

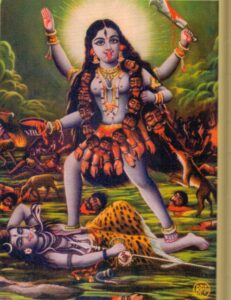


 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi

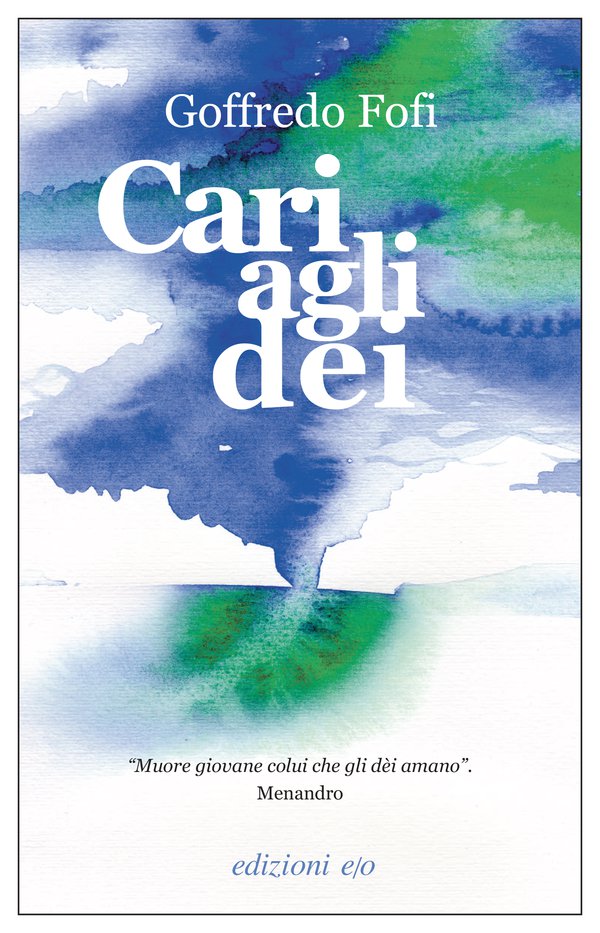


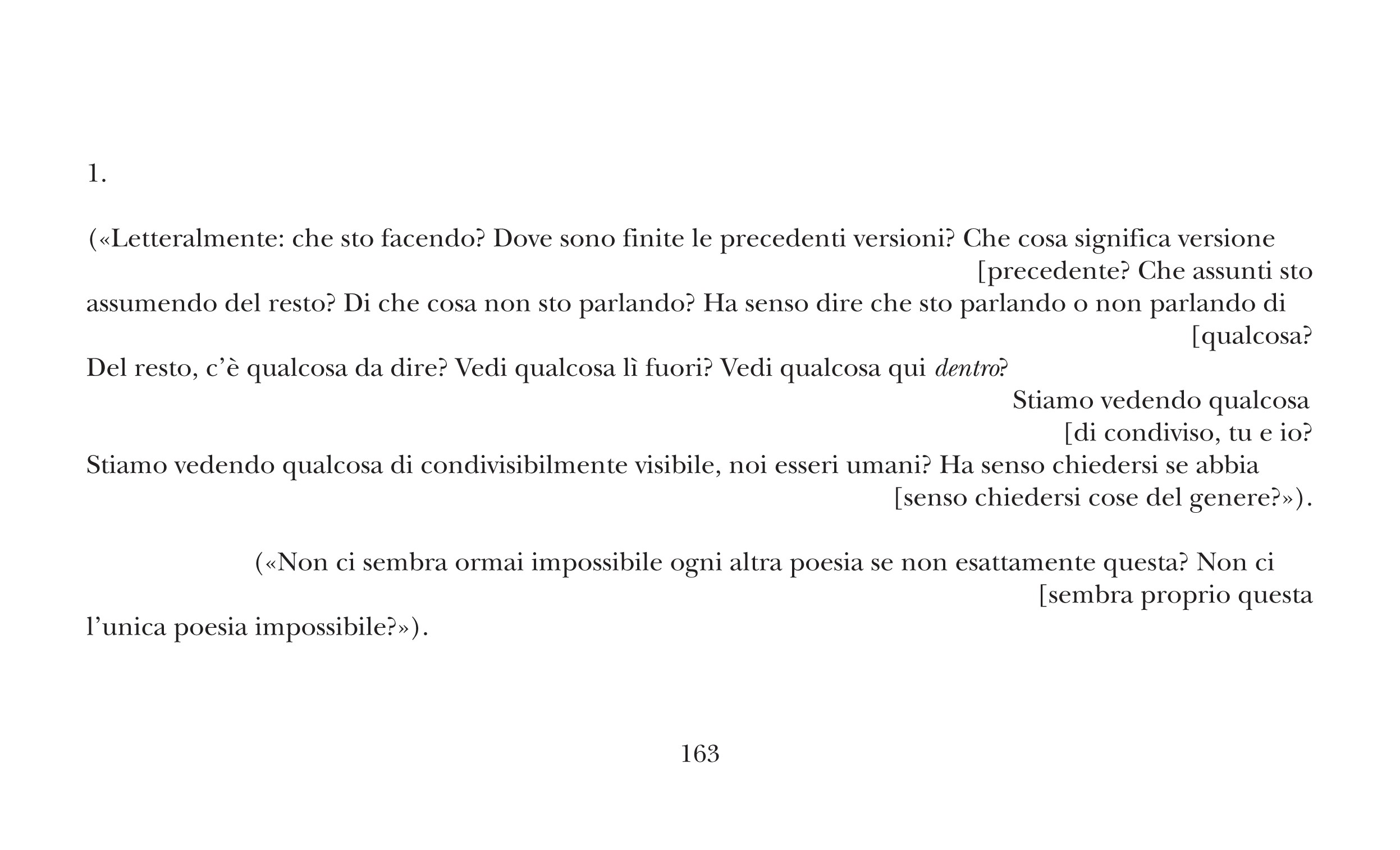
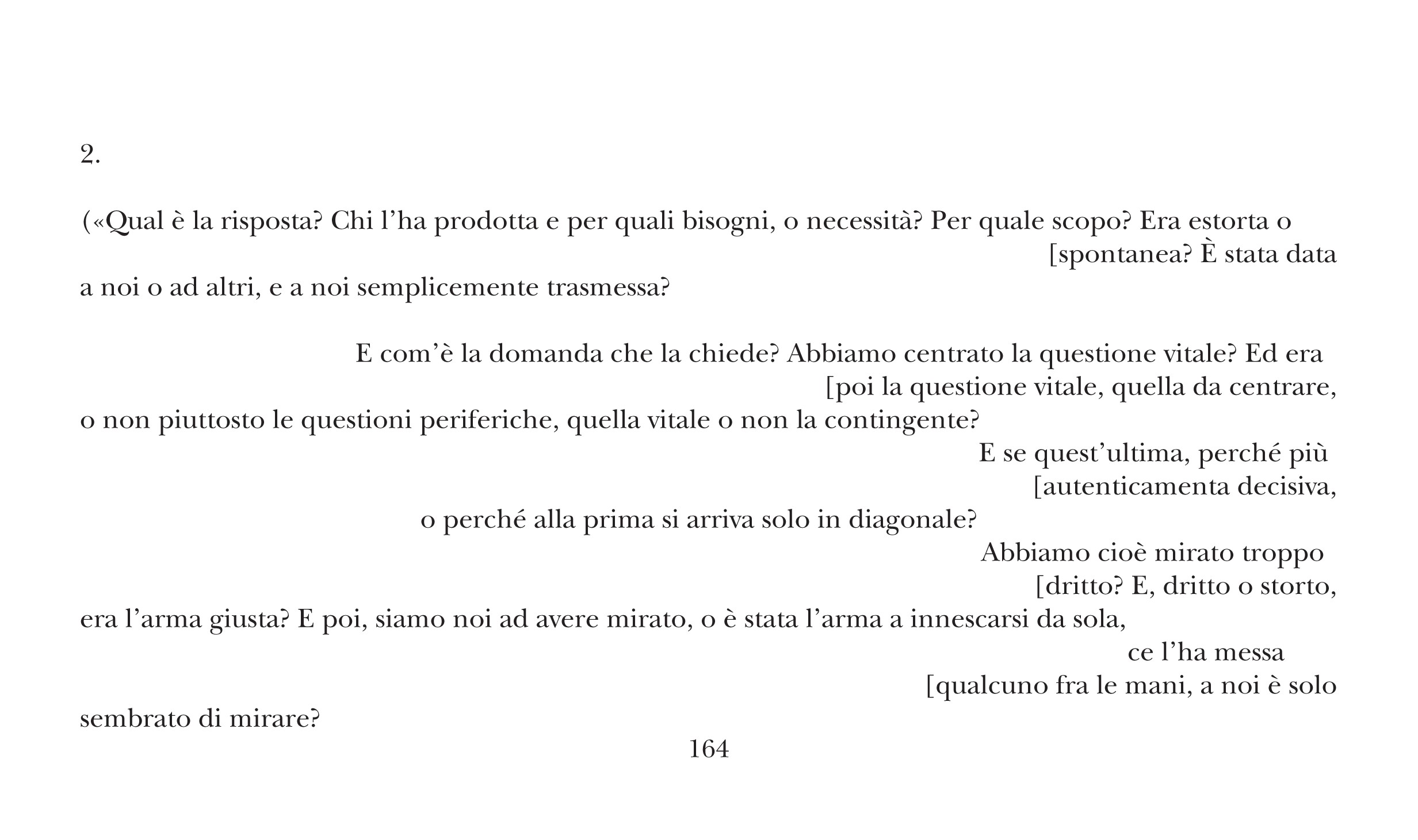
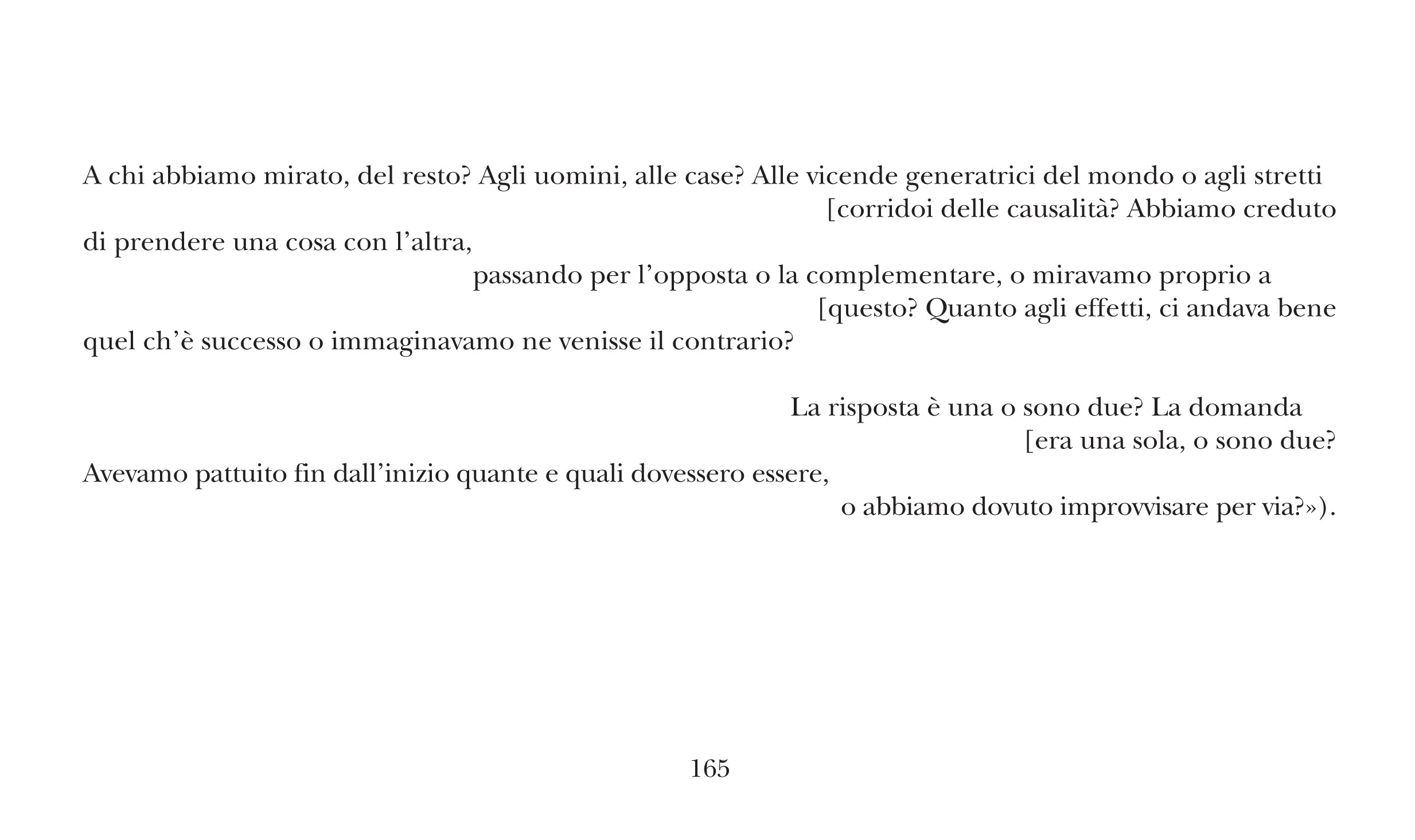
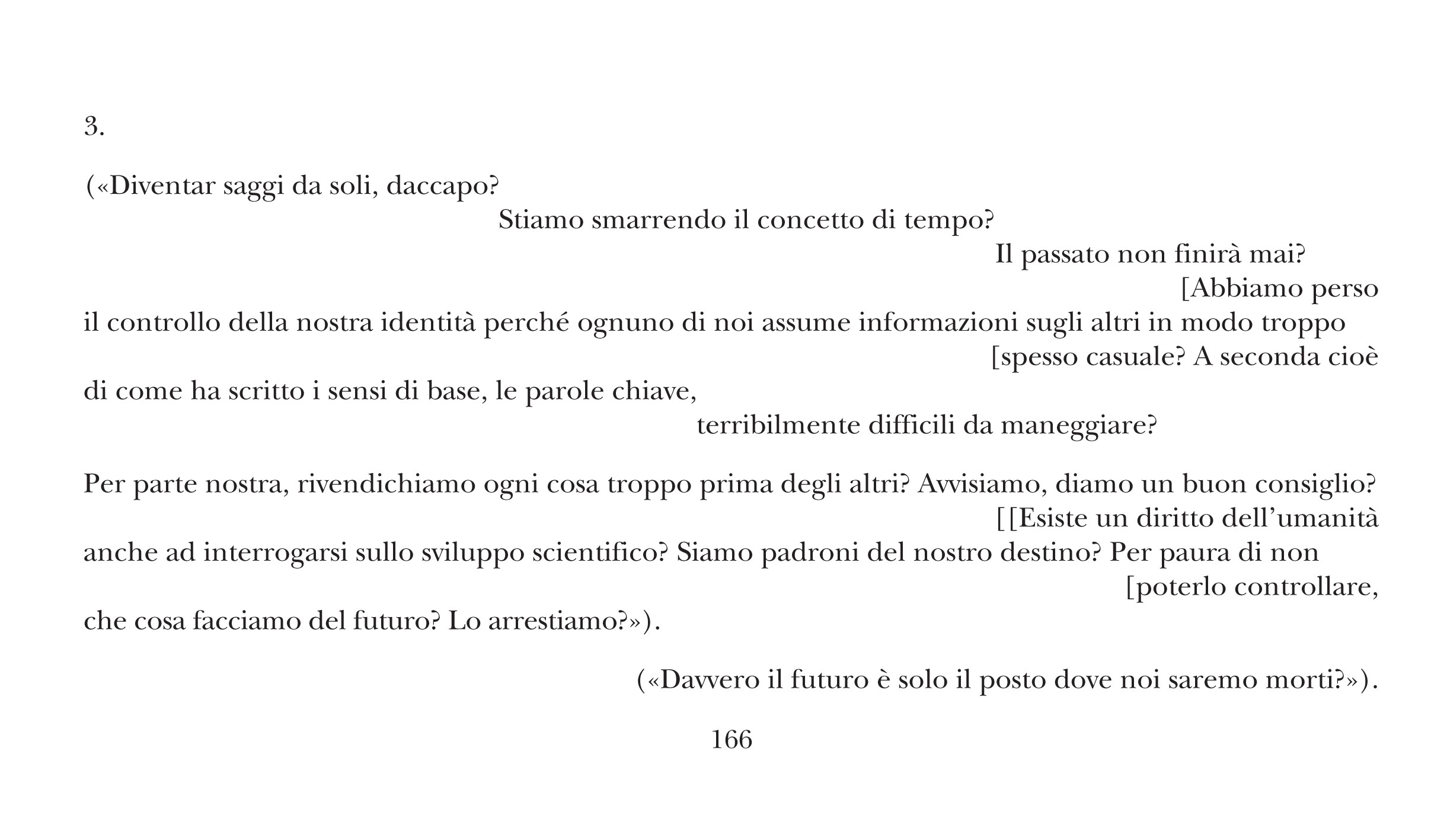





 Nota sui classici
Nota sui classici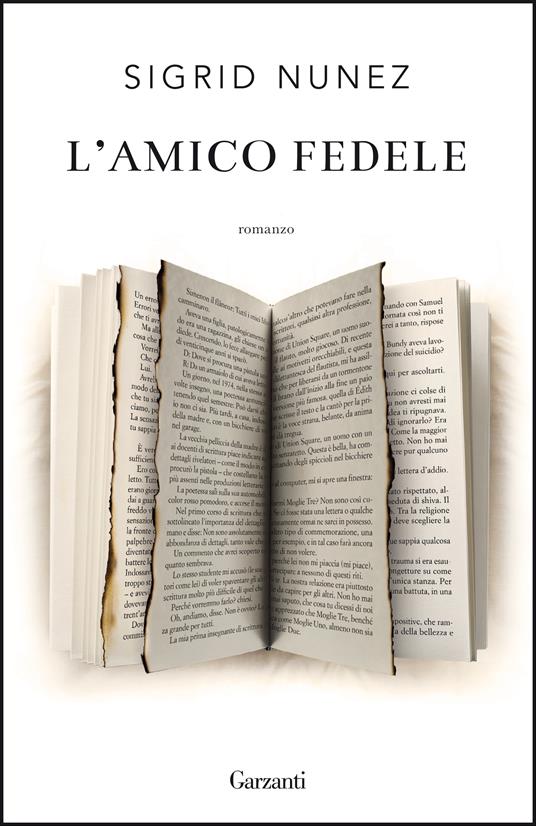
 Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda, 281 pagine, traduzione di Monica Corbetta
Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda, 281 pagine, traduzione di Monica Corbetta David Grossman, La vita gioca con me, 289 pagine, Mondadori, 2019, traduzione di Alessandra Shomroni
David Grossman, La vita gioca con me, 289 pagine, Mondadori, 2019, traduzione di Alessandra Shomroni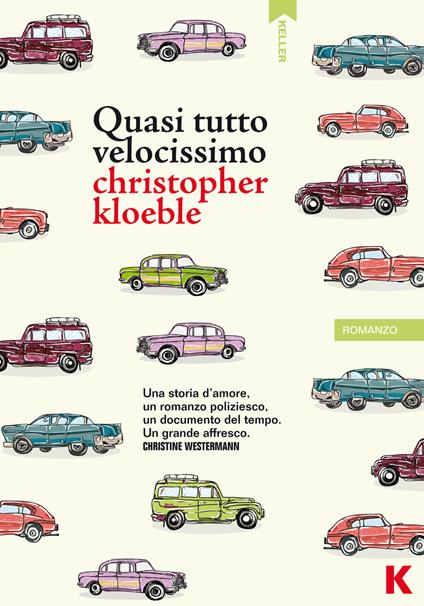 Christopher Kloeble, Quasi tutto velocissimo, Keller editore, 2019, 382 pagine, traduzione di Scilla Forti
Christopher Kloeble, Quasi tutto velocissimo, Keller editore, 2019, 382 pagine, traduzione di Scilla Forti