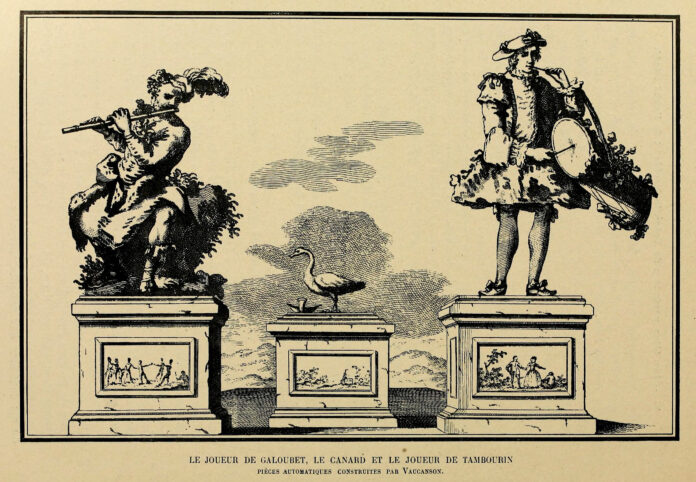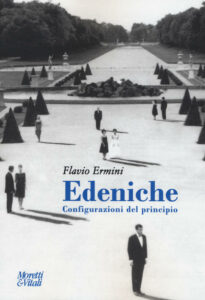 di Bruno di Pietro
di Bruno di Pietro
“Un pensatore lo si onora pensando” (E.Jünger)
1. Il tramonto della luna
Giunge a compimento con “Edeniche” (Moretti & Vitali, 2019) – il nuovo lavoro poetico di Flavio Ermini – un progetto che ha radici antiche. “Edeniche” copre quasi dieci anni di scrittura poetica ma rimanda ad una parola-chiave nella evoluzione del pensiero e della poesia di Ermini : la parola “anterem” (che è anche il nome della Rivista cui Ermini, che la fondò nel 1976, ha legato gran parte della propria attività intellettuale).
“Anterem” . Ciò che viene prima delle cose. Un percorso “verso la lingua primigenia dell’umanità, verso la parola originaria, ante-rem” come ci dice nella premessa lo stesso Ermini. Un percorso esattamente e rigorosamente segnato come lo descrive sempre l’Autore in una intervista concessa a Luigi Nacci nel Gennaio 2007 : “Mi piace pensare a una parola originaria, che nascendo nomina e nominando non è subito fagocitata dalla cosa che le si pone di fronte. Mi piace pensare a una parola che nomina e nominando indica il percorso percettivo che la conduce verso la cosa. (…) una parola in cui torni a vivere quel rapporto originario con la natura di cui ci hanno parlato Hölderlin, Celan, Benn …A questo proposito aggiungo che non è sbagliata l’idea di Novalis quando indica che le nostra parole si dovrebbero muovere nel mondo come un polline…” [1] .
Esaminando il lessico di Edeniche nel suo insieme la prima cosa che colpisce è l’assenza della parola “luna”: in tutto il testo non c’è, mai.
Proviamo a ragionare sul perché di tale assenza per avere una “chiave di accesso”. Mi torna alla memoria Cicerone “supra lunam sunt aeterna omnia” [2] Ciò che si trova sopra la luna trascende il divenire, è sub speciae aeternitatis. Ora, il sole resta sempre se stesso, senza alcun divenire. La luna è un astro che cresce, cala, sparisce. La normativa della luna è il divenire, la nascita e la morte. Così come l’uomo la luna ha una “storia”.
Solo che la luna rinasce: “la luna nuova”. Una periodicità senza fine che è la legge del tempo ciclico. Così la luna governa il ritmo delle acque, della vegetazione, della fertilità: le maree, le stagioni, il flusso mestruale. La luna rivela un tempo concreto, diverso da quello spazialmente misurabile, il tempo degli orologi e dei cronometri.
In Edeniche vi è una chiara, netta distanza dalla Storia. Non è una osservazione sorprendente poiché risponde esattamente a quanto Ermini ci dice proprio all’inizio di una sua precedente opera (indefinibile saggio-poetico) e cioè “Il giardino conteso” la cui premessa è intitolata proprio “L’antistoria” e in cui si legge “I nascenti prendono vita, si fanno incontro alla parola, la interpellano nella precarietà, nell’incalcolabilità. Non seguiranno “una storia” – l’hystoria dove si consuma il deturpamento del principio- , ma la “vera storia” propriamente un’ antistoria . I nascenti sono già da sempre estranei al divenire storico, ancorati come sono alla parola originaria”. [3] Per inciso qui è abbastanza chiara l’influenza del pensiero di Heidegger che ritiene tutta la metafisica occidentale un progressivo corrompere e perdere il senso dell’Essere cui è prossima la parola aurorale.
Ma per ora fissiamo che il tempo ciclico non si appartiene all’orizzonte di Edeniche. Ma, come di qui a poco vedremo, neanche il tempo escatologico della tradizione giudaico-cristiana può dirsi appartenere a Edeniche. Vedremo infine se questa assenza del tempo, del divenire, della storia abbiano qualche altro esito magari uscendo dalle categorie del pensiero occidentale. Come, sia detto sempre per inciso, sembra accada all’ultimo Heidegger.
Assistiamo in Ermini a un tramonto (definitivo) della luna.
Giacomo Leopardi dedica al “tramonto della luna” l’ultima poesia scritta fino a pochi giorni prima di morire. Riporto qui l’ultima strofa
Voi, collinette e piagge,
Caduto lo splendor che all’occidente
Inargentava della notte il velo,
Orfane ancor gran tempo
Non resterete; che dall’altra parte
Tosto vedrete il cielo
Imbiancar novamente, e sorger l’alba:
Alla qual poscia seguitando il sole,
E folgorando intorno
Con sue fiamme possenti,
Di lucidi torrenti
Inonderà con voi gli eterei campi.
Ma la vita mortal, poi che la bella
Giovinezza sparì, non si colora
D’altra luce giammai, né d’altra aurora.
Vedova è insino al fine; ed alla notte
Che l’altre etadi oscura,
Segno poser gli Dei la sepoltura.
Nel pessimismo radicale di Leopardi qui il destino dell’essere umano è delineato: il Nulla prima, il Nulla dopo. Eppure…..proviamo a leggere la strofa senza gli ultimi sei versi, che sono quelli poi che nell’autografo originale non recano la grafia del Poeta ma quella dell’amico Ranieri (e sia chiaro che qui non è in discussione la fedeltà del testo al dettato del Poeta). Ma, obliati per un solo attimo quei sei versi, a noi appare nitido, nella più “spersonalizzata” lirica di Leopardi, il “dire di ciò che è generato” che “inonderà …gli eterei campi” secondo l’eterno susseguirsi del divenire di cui luna è legge. La Luna è la risorsa del Leopardi morente.
E ora la domanda è: vi è in Edeniche uno spiraglio? Una speranza? Una risorsa? E inoltre. Poiché fra ogni Fine e ogni Inizio c’è sempre e comunque un “nel frattempo” (che poi è nel dominio del Dover-Essere) cosa Ermini designa e destina a questo segmento spazio-temporale? E ritorna la domanda posta all’interno del precedente lavoro poetico di Ermini “Il compito terreno dei mortali”.
2. L’aurora e la risacca
“Edeniche” ci parla dell’aurora. L’aurora della vita terrena. Ci parla di quell’attimo in cui veniamo al mondo terreno separandoci dal Tutto Indistinto/Infinito cui, secondo Ermini, apparteniamo. E quindi ci parla di un “dire aurorale” aperto e volto a permanere “insieme alle sue caduche e molteplici gemmazioni, tra enigmi e contraddizioni, tenebre ed ineluttabilità, precipizi e roseti” [4]
Ma la “condizione edenica”, molto lontana dalla idea di una “età dell’oro” è immediatamente, in Ermini, investita dalla “notizia” della “finitezza”, dalla consapevolezza che al “sorgere” seguirà ineluttabilmente un “tramontare” in una lunga interminabile notte, una notte senza mattino. Incombe immediatamente la “notizia”, nonostante tutte le lusinghe delle “apparenze”, di quell’evento “scandaloso” che è la morte. Tutto il tessuto, anche stilisticamente compatto, di “Edeniche”, è lacerato, devastato da questa dialettica Finito/Infinito, Vita/Morte.
Anche il verso in “Edeniche”, al di là della apparente compattezza, sembra attraversato da questa lacerazione assumendo un moto che molti hanno assimilato alle onde del mare e che io, accettando la assimilazione ampliandola, assimilerei alla “risacca” nello scontrarsi dell’onda che volge al lido con quella di ritorno che spinge verso il largo. Una poesia, quella di Ermini, che ha sostanza filosofica. “Una poesia, dunque, in cui l’utilizzo costante del lessico della filosofia occidentale, dei suoi lemmi fondanti, viene però sottoposto a uno straniamento poetico, nel quale insieme perde e acquista sensi. Perde la specificità tecnica, la designazione, l’attribuzione a un soggetto; acquista un’eco, una risonanza, un’ampiezza d’onda, una vasta impersonalità che si vuole quasi archetipica”. [5]
3. Le tinte scure di un incalcolabile solstizio d’inverno
Sono prevalenti in “Edeniche” le tinte scure di un incalcolabile solstizio invernale (la “bruma” spesso presente nella parte iniziale del libro)- Tinte già presenti nei precedenti lavori in poesia e saggistica di Ermini apparsi nel decennio di composizione di “Edeniche” :“Il compito terreno dei mortali” (in poesia), “Il secondo bene”, “Il giardino conteso” (in saggistica) ma che si accentuano in particolare in “Della fine” (edito nel 2016) . Lavori che non possono essere ignorati per un approccio corretto a “Edeniche” anche perché apparsi nel decennio di composizione del libro. E sia detto qui , e non per inciso, che quando parliamo di poesia e prosa saggistica operiamo una forzatura poiché la scrittura di Ermini rifugge “programmaticamente” da questa distinzione.
4. Fra supremo dolore e suprema speranza
Se si dovesse ricorrere a un pensiero filosofico che dia conto della lacerazione profonda che attraversa la trama di “Edeniche” ben si potrebbe, a la Nietzsche, definire “eroico” il tentativo messo in opera da Ermini. “268. Che cosa rende eroici? Muovere incontro al proprio supremo dolore e insieme alla propria suprema speranza” [6]
Fra supremo dolore e suprema speranza leggiamo in “Edeniche”
si manifesta con un piccolo grido l’essere umano
nel suo quieto svanire dietro la superficie terrena
proprio sul lato che del cielo rimane impensato
malgrado il tempo che testimonia la sostanza
per cui sogno e azzurrità sono connessi
per un sovvertimento illimitato dei sensi
atto a gloriare in terra i sepolti nell’antro dei cieli
sui quali minacciosa la casa natale si erge
dove l’essere per la morte anela alla vita [7]
L’essere per la morte anela alla vita. Come si può non pensare a un filosofo che non è citato ma chiaramente “evocato” per quella terribile pagina iniziale di “La stella della redenzione” opera che apre e segna l’intero pensiero filosofico del secolo scorso. Nella prima pagina della Introduzione a “La Stella della Redenzione” Franz Rosenzweig così dice : “Dalla morte, dal timore della morte prende inizio e si eleva ogni conoscenza circa il Tutto. (…) Tutto quanto è mortale vive in questa paura della morte, ogni nuova nascita aggiunge nuovo motivo di paura perché accresce il numero di ciò che deve morire. Senza posa il grembo instancabile della terra partorisce il nuovo e ciascuno è indefettibilmente votato alla morte, ciascuno attende con timore e tremore il giorno del suo viaggio nelle tenebre. L’uomo (…) senta violentemente, inevitabilmente senta quanto altrimenti non avrebbe mai percepito: che se mai morisse, il suo io sarebbe soltanto un illud e perciò, con tutta la voce che gli resta in gola urli, urli ancora il suo io in faccia all’implacabile che lo minaccia di un così inconcepibile annientamento. (…) Perché l’uomo non vuole affatto sottrarsi a chissà quali catene, vuol rimanere, vuole vivere”. [8]
Il vivente vuole vivere e oppone strenua resistenza di fronte all’evento morte.
nel suo cieco avanzare nell’inerzia del cielo
combatte fieramente l’orda d’oro del figlio
quale avamposto dell’ingannevole apparenza
che nella lotta ci ammalia contro la morte
cui oppongono gli uomini strenua resistenza
nell’ultimo fortilizio che resta da presidiare [9]
Ma è in una poesia che è essenziale nell’economia di “Edeniche” che tale urlo di protesta, di resistenza strenua alla morte appare con grande ed efficace potenza poetica : “Il borgo dei sassi” [10]
compie un gesto di sfida risoluto il vivente
ergendosi tra la morte e la sua rappresentazione
pur se la luce lo rende ancor più sanguinante
ferendolo così come ferisce l’arco mortalmente
là dove tornano indistinti i contorni delle cose
e oppone resistenza nel borgo dei sassi il figlio
all’ordine imperioso che al mattino lo attende
Tutto ciò che vive inclina all’esistere. Anche il fiore di campo di cui al notissimo passo del Vangelo.[11] Inclina a vivere e urla questo anelito in viso a quell’inaudito evento che è la fine, la morte (la “propria” morte). E naturalmente e quotidianamente si interroga sul consistere dell’ esperire “la soglia” “il ciglio della vita” “la Porta” (per scomodare nuovamente Rosenzweigh) . Su ciò che lo aspetta “dopo”. Ed è qui che la interrogazione diventa radicale e si rivolge a ciò che c’è “prima” (ante-rem), all’origine, all’aurora del proprio vivere, agli stadi iniziali dell’esistere
sono elementi sfuggiti all’indistinto
le relazioni che espongono i giusti all’aurora
in quel fragile grado d’intendere consentito
così come per celarsi sfuggono al cielo i viventi
che si portano agli stadi iniziali dell’esistere
guidati dalla creatura insensibile al tatto
se non più fioriscono gli alberi per errore [12]
5. Andarsi incontro a ritroso
Seguiamo quindi Ermini in questo suo percorso, questo “andarsi incontro a ritroso” (per usare una bella immagine di Leonardo Sinisgalli).
“Ogni grande cosa può avere solo un grande inizio. Il suo inizio è sempre la cosa più grande”. Così dice Martin Heidegger nella sua Introduzione alla Metafisica . Facendo esplicito riferimento alla filosofia greca degli albori che dà inizio al pensiero occidentale (segnando anche la distinzione/separazione fra mythos e logos).
“La parola di Anassimandro è il più antico lasciar parlare le cose, di cui ci sia giunta notizia, e perciò è la prima parola della filosofia” [13]
E da questa muove Ermini in Edeniche che nell’ esergo rimanda subito al notissimo frammento di Anassimandro siccome derivante dalla testimonianza di Simplicio . [14]
Anassimandro fra tutti i monisti sarebbe il primo ad aver utilizzato il termine archè e ad averlo identificato come elemento degli enti. Esso non è né acqua, né nessun elemento materiale, ma una natura infinita da cui traggono origine tutti i cieli e il mondo esistente secondo l’ordine del tempo.
Il milesio avendo notato la trasformazione dei quattro elementi, e non riuscendo ad individuare in nessuno di essi il sostrato ( hypokeimenon ) pensò a qualcosa di al di là degli elementi stessi. Rispetto ai precedenti physiologoi con Anassimandro l’ archè smette di essere un che di elementare ma allude a qualcosa prima e al di là dell’elemento. È ciò che Anassimandro chiama apeiron il quale “contiene la causa della generazione dell’universo e della sua dissoluzione” .[15]
Apeiron in greco antico è “ciò che è senza limite, illimitato, infinito”. In Ermini lo troviamo come “Indistinto”. Il frammento quindi dice “ Ciò da cui proviene la generazione delle cose che sono, peraltro, è ciò verso cui si sviluppa anche la rovina, secondo necessità: le cose che sono , infatti, pagano l’una all’altra la pena e l’espiazione dell’ingiustizia, secondo l’ordine del tempo”. [16]
Le cose hanno inizio e fine nell’Illimitato. La stessa esistenza delle cose che sono è ingiusta, colpevole e perciò destinata alla rovina e al male, alla sciagura di vivere espiando la colpa di essere. Il male è l’esistenza di per sé stessa colpevole, la quale non può consistere in altro che nella pena di una morte vivente e di una vita morente. L’esistenza individuale è una colpa perché infrange l’unità cosmica originaria.
Così in Ermini :
l’indistinto si disvela in molteplici organismi
senza che vantaggio alcuno ne tragga l’uomo
volto com’è ai luoghi da cui può giungere il nemico
là dove noi vorremmo invece assistere all’incontro
con la sorella dedita al padre prossimo alla morte [17]
e ancora
su questa terra malamente calpestata
nessun medicamento può essere apportato
alla devastazione che subiamo nascendo
per cui patisce ogni pena il vivente
a ogni bagliore che diventa incendio
in una confusa visione del reale
che ai morti induce a dare forma
tra impensate pluralità di frammenti [18]
Chiara, negli ultimi testi citati, la influenza del pensiero di Emil Cioran :
“Noi non corriamo verso la morte, fuggiamo la catastrofe della nascita, ci affanniamo, superstiti che cercano di dimenticarla. La paura della morte è solo la proiezione nel futuro di una paura che risale al nostro primo istante. Ci ripugna, certo, considerare la nascita un flagello: non ci è stato forse inculcato che era il bene supremo, che il peggio era posto alla fine e non all’inizio della nostra traiettoria? Il male, il vero male è però dietro, non davanti a noi” [19]
A me sembra molto interessante, poiché di “inizio” stiamo parlando, confrontare gli esiti poetici di Ermini con quanto è detto in un’opera di notevole peso e rilievo sull’argomento : cioè quella di Massimo Cacciari “Dell’inizio” [20]
La tesi di fondo è la pura Indifferenza dell’Inizio. In Cacciari l’Inizio è pura Indifferenza che comprende ogni mondo possibile. E qui una certa consonanza con l’idea dell’Indistinto che regge Edeniche appare possibile. In Cacciari questa radicale indifferenza scava un abisso fra l’Inizio e l’Origine: quest’ultima appartiene già alla catena delle cause, è prigioniera dell’ “al di qua” e perciò si lascia raggiungere e dire. L’Inizio sta invece altrove come sovrana dimora dell’ Uno : “L’Uno indica il problema… del non-posto del pensiero- e dunque, in quanto non-posto del pensiero, semplice, incontaminato, non contraddittorio” [21].
Ma in Cacciari, e qui Ermini se ne distacca, l’incidenza di questo Inizio nelle forme del tempo e del fare proietta la radicale Indifferenza in direzione dell’ éschaton [22]. Cosa che in Ermini non accade traducendosi invece in una infinità a-temporale. O in un “altro tempo” come vedremo in seguito.
incede senza uno scopo definito
il mortale che ciecamente si consuma
nel fondare il mondo sulla ragione
cui la sorella del sonno si nega
quale testimone dell’oscurità che si cela
nell’impreciso vuoto del presente [23]
Ma il percorso “dall’Indistinto all’Indistinto” non ci dice qualcosa che rammemora ciò che è ciclico? E se il ritorno all’Indistinto fosse una “nuova nascita” , “un altro inizio” ?. E se dietro “la Porta” ci fosse “la Vita” (Rosenzweig) ?
Sono tutti scenari che agitano il lettore di Edeniche che in questo si rivela un libro che, più che rispondere, domanda. E che ne rendono la lettura come guida all’esercizio del pensiero.
6. “Il primo giorno”
La nascita, per separazione dall’ Indistinto, avviene ed è sempre “il primo giorno” (immagine cara a Merleau-Ponty ) e ciò che è generato ( physis o natura) si dispiega nel molteplice che così dall’Uno ha origine ancora ignaro del destino di finitezza che lo ricondurrà, al termine del percorso, nell’Indistinto.
Lo scenario che accoglie il vivente è acquatico. Fin dal terzo verso del primo testo in cui si dice “….del mondo abitato/ che dalle acque creaturali viene circoscritto” (pag.16) e nella sezione finale (la XVI) di Edeniche “Le terre dell’acqua”. All’inizio e alla fine, si badi. Tutto il viaggio del vivente è concepito come un viaggio per mare che ha come destino il naufragio. Nello svolgersi rigoroso del pensiero e della poesia di Ermini tutto questo riporta a “Il compito terreno dei mortali” (laddove il nucleo essenziale è sul “dover – essere” – “il compito terreno”) che evolve verso la detta approssimazione all’ Essere che è il progetto di “Edeniche”.
Qui è tutta la potenza del tentativo di Ermini nella distanza da tutte le cosmogonie acquatiche e nel suo sforzo di approssimarsi al senso dell’Essere. La tradizione delle acque primordiali, da dove hanno origine i mondi, si trova in quasi tutte le varianti delle cosmogonie arcaiche e primitive. Le scritture dell’origine recano quasi tutte il richiamo all’acqua. Questo nella tradizione indiana, babilonese e fino alla tradizione giudaico-cristiana in Genesi “1 In principio Dio creò il cielo e la terra. 2 La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”. [24].
La nascita “getta nel mondo” il vivente, dove “l’ingannevole apparenza” lo “ammalia contro la morte” [25] e qui incontriamo una delle immagini più care e significative per Ermini : “il giardino conteso”
su questa terra palmo a palmo depredata
implacabilmente il tempo ci aggredisce
in un devastante potere di annientamento
tumulandoci sotto strati spessi di macerie
che l’epoca sottrae alle aule del cielo
nel far sì che l’umano essere sia sostituito
da un susseguirsi ininterrotto di simulazioni [26]
Qui il vivente subisce la irruzione del tempo e “le corrosioni che il tempo produce” [27]. Prende notizia della ineludibilità del proprio esser destinato alla fine. E ciò nonostante la maestosa immagine delle “stelle fisse dell’indistinto” e della “luce originaria” che fa pensare a una possibile salvezza
fa pensare alla salvezza la luce originaria
capace com’è di minare ogni nostra persuasione
grazie alla geometrica perfezione dei suoi raggi
cui fa riscontro il sorgere delle stelle
nelle forme elementari del soffio e del respiro
così come il divino si dà soltanto a lampi e tuoni
quando a poco a poco stende sulle più innocenti prede
la rete avvolgente di un’opaca sostanza mortale
che diventa l’aula di un altro occultamento
nel restituire all’indistinto ogni singolo vivente [28]
Abbiamo già detto che Edeniche più che essere un libro che risponde è un libro che domanda. E qui le domande sgorgano : è possibile immaginare un “altro tempo” ? è possibile immaginare un “altro inizio”?
7. “L’essenza delle piante e del vento è la stessa”. La cosa è il poeta.
Cominciamo , e proviamo a cercare una prima risposta agli interrogativi posti all’inizio. Cosa connota quel “nel frattempo” che c’è tra ogni “inizio” e ogni “fine”? È vero che Ermini molto ci dice (e ci torneremo) ne “Il compito terreno dei mortali” e nel successivo saggio “Il secondo bene”, ma qui ne esaminiamo gli esiti in “Edeniche”.
Nella Prefazione [29] Ermini ci dice “Una comune origine designa la fratellanza fra tutti gli esseri del mondo. Tale origine implica la cura dell’uno con l’altro: del mortale con gli animali e le piante, del figlio della terra con le nuvole e il vento.(….) Il rapporto soggetto-oggetto non può essere concepito in termini di separazione. L’essenza delle piante e del vento è la stessa. Nel processo di una natura che si autogenera e si distrugge nuvole e mortale sono organicamente connessi. È possibile parlare della loro comune origine costitutiva solo sottraendola alla superstizione e al mito, solo affidandosi al pensare autentico , un pensare, ci ricorda Heidegger «in cui l’uomo si lascia portare dalla lucentezza e dall’odore della terra» [30]
“ Le Edeniche sono il cammino descrittivo-argomentativo che conduce alla primordiale simbiosi fra interiorità e esteriorità, tra soggetto e natura, a quello stato aurorale in cui l’uno non è distinguibile dall’altro; sono l’insopprimibile esigenza di riscoprire la primitività del mondo che permane nel nostro vissuto percettivo o precategoriale sotteso alle contraddizioni, ai contrasti, alle conflittuali ‘ingiustizie’ del vissuto quotidiano” [31]. Delogu trova in questa simbiosi con la Natura, con tutto ciò che è generato, la traccia del desiderio di infinito. E questo stato simbiotico si appartiene più al pittore o al poeta che non allo scienziato che oggettiva per separazione. In ciò stabilendo un fertile contatto con la fenomenologia di Merleau-Ponty.
Pertanto: “Il divino non è altro che una perpetua annunciazione del dolore, al quale cerchiamo di sfuggire traverso lo stordimento di una quotidianità linguisticamente alienata; gli umani, definiti ora i “consapevoli di morte”, ora gli “esuli”, sono chiamati a un cambiamento di prospettiva, dall’antropocentrismo che li determina a una visione in cui si può registrare “il movimento ondoso che precede la dimensione verbale”.[32]
In un simile contesto è naturale la assenza del soggetto, dell ‘ “io poetico” nel testo. Il seme vitale è lo scambio e la fusione con le elementarità naturali. Ultima meta è la parificazione nel tutto-nulla in cui “la cosa è il poeta” nella mutua avventura della “parola”. Il soggetto poetico risulta incapsulato, non perduto, per mezzo dell’identificazione esatta dell’essere con una sorta di “mondità” heideggeriana intesa non come categoria ma come dimensione esistenziale del mondo eseguita nell’atto poetico.
E qui mi consento di appuntare un distico straordinario di un Poeta-Pittore (non è un caso) a me carissimo: Alfonso Gatto. Il quale in “Rime di viaggio per la terra dipinta” ci dà la sua “Idea del creato”:[33]
C’è sempre un giorno che il creato crea
se stesso e gli occhi e il modo di guardare.
8. “il tempo a-venire”. E l’avventura dell’apparizione inizia nuovamente…
Abbiamo visto prima come in Ermini non operi il tempo dell’ éschaton della tradizione giudaico-cristiana. Abbiamo anche detto all’inizio che a Ermini non appartiene il tempo ciclico, del divenire, della Storia. Non c’è un nascere/rinascere di cui è proprio della luna di cui abbiamo segnalato l’assenza in Edeniche.
Eppure… E se vi fosse un’ “altra nascita” ? Se vi fosse un “altro Inizio” ?
Partiamo da lontano e precisamente da “Il giardino conteso”. Ed è qui che si manifesta la “parola poetica” come la risorsa salvifica di Ermini. La parola poetica ha la possibilità di ripetere quell’inizio che ci ha estraniati dal tutto. “ La parola, ripetendo l’estraneità dell’annuncio, riprende tutto – il tutto – da capo; essa, facendo i conti con il fondamento, nel suo dire, dà perenne origine al mondo E, in questo inizio ritrovato, noi abbiamo la possibilità di accedere alla salvezza; nella consapevolezza che ogni inizio, se è vero, porta con sé l’ineluttabilità della disfatta. Da cui si genera, grazie al dire poetico come originaria contra-dizione, la giustificazione di ogni dolore. “Soltanto all’alba i custodi/sulle macerie del greto riaprono le porte della casa natale/ in cui serbano i vecchissimi il diagramma del cielo” [34]. E l’avventura dell’apparizione inizia nuovamente…” [35]
“*il sentiero che si disperde nel bosco
al manifestarsi del secondo inizio
è in cammino l’uomo sulla stretta via
che con molta ignoranza da tempo percorre
nel cieco errare che ancora gli è proprio
spinto com’è sulla terra mattinale
verso uno stato di totale abbandono
cui porta il sentiero che si disperde nel bosco
nel diventare tutt’uno con il cantiere e i roseti
al loro incessante sfiorire e sfiorire [36]
Siamo qui prossimi alla assunzione della nozione di Ereignis ( tempo a-venire) in cui Hiedegger individua la possibilità di superare definitivamente il pensiero metafisico, portandosi al di lèà della stessa questione dell’Essere. Il tempo che viene , a-venire ( Ereignis), apre un nuovo cammino di pensiero lungo il quale è possibile pensare un altro tempo , istantaneo, discontinuo ed incommensurabile il cui a-venire si manifesta come effrazione del tempo cronologico: il tempo che viene…
La stessa finitezza non va pensata come mancanza ma come abissale ricchezza e profondità e può essere accostata alla figura cairologica della maturazione del tempo. Mentre infatti l’infinità rimanda all’idea di compimento e di eternità, la finitezza inscrive l’essere nell’ orizzonte eventuale della Lichtung . Solo nella finitezza l’esserci può approssimarsi alla verità dell’essere. Cito qui un passaggio prezioso da un bel libro di Sandro Gorgone che credo molto bene ci dica qualcosa sulla poesia di Ermini in Edeniche . “L’ Ereignis si avvale dell’uomo per far sorgere, attraverso di lui, la via che conduce il dire originario alla parola; lungo questa via esso risuona come invisibile armonia e celata “fuga” dell’essere che intona ogni ente ….Tale risuonare è quello stesso suono senza suono della quiete con cui il dire originario si mostra nel linguaggio ed a cui il silenzio soltanto riesce a corrispondere, nel muto gesto di saluto e di accoglienza con cui l’uomo si rivolge all’ a- venire. Il modo in cui l’ Ereignis fa risuonare il suo appello è il venire alla parola del dire originario che, però, non si manifesta in nessuna modalità linguistica: l’ Ereignis parla agli uomini non attraverso le parole, ma come melos, come il canto che dice cantando”. [37]
La risorsa salvifica in Edeniche (per Ermini in tutto ciò che ha scritto) è la “parola poetica”. Il poeta che si incammina, a passi lenti, su oscuri sentieri entro il tramonto, nella notte che sopraggiunge è l’unico in grado di dire l’Ereignis il tempo a-venire. Come il poeta che si inoltra nella oscurità crescente della notte, anche il pensatore deve restare in cammino verso l’essenza nascosta del linguaggio se vuole esperire il tempo a-venire; soltanto nell’ascolto del dire originario esso può essere esperito come ciò che concede essere e tempo, come quel luogo aurorale da cui sorgono tutte le differenze e le contrapposizioni ma che può essere raggiunto, conquistato solo dal poeta.
La parola , nel farsi esperienza poetica – così in Ermini – “apre il linguaggio all’accadere dell’essere e – facendosi largo fra le apparenze – offre al pensiero quell’inizialità che consente all’essere umano di portare a compimento il primo inizio e di prepararsi all’altro inizio; là dove il dire può trovarsi a contatto strettissimo con il tutto indiviso. Seguirne la via impone di orientarsi nel groviglio, di familiarizzare con le schegge e col frammento: una folata di vento, il moto del sole, il rumore di una pietra che cade. Seguirne il cammino impone di dire poeticamente quel medesimo che, manifestatosi nella physis, si è poi ritirato nel nascondimento”. [38]
NOTE
[1] “Le parole come polline” (intervista a Luigi Nacci) in AbsoluteVille 15.1.2007
[2] Cicerone, De Rep. VI , 17,17
[3] F.Ermini “Il Giardino conteso” pagg. 9-10
[4] Laura Caccia. Su “Edeniche” . in Trasversale, 20.7.2019
[5] Susanna Mati, “Edeniche.Configurazioni del principio” in “L’Indice” febbraio 2021
[6] F.Nietzsche, “La Gaia Scienza” Lib.III af. 268
[7] F.Ermini, Edeniche pag. 17
[8] F. Rosenzweig “La Stella della Redenzione” pagg. 3-4
[9] Edeniche cit. pag.45
[10] Edeniche, cit. pag.72.
[11] Matteo, 6, 24-36
[12] Edeniche, cit. pag. 69
[13] E. Severino “ Essenza del nichilismo” (Milano,2010)
[14] I presocratici. Testimonianze e frammenti DK B1 cfr.A9 Simplicio, phis. 24,13
[15] I presocratici ,cit. DK A 10.
[16] Non è questo il luogo dove discutere della tesi di Giovanni Semerano, peraltro apprezzatissima da Emanuele Severino. Semerano mostra come la parola ápeiron abbia come lontana origine il semitico ‘apar (polvere, terra), accadico eperu, biblico ‘afar, e ricorda che in greco epeiros, dorico apeiros, eolico aperros, indica la terra, il fango. Tali termini, secondo il filologo fiorentino, corrispondono ad ápeiron, «al quale fu premesso il neutro tò, segno della confusione.». Il frammento di Anassimandro, che è sempre stato tradotto «…principio è l’infinito …», andrebbe invece letto «principio delle cose è la terra… ecc.». Insomma, tutte le cose provengono dalla polvere e ad essa fanno ritorno. Un concetto che rievoca il messaggio biblico, laddove in Genesi, Dio dice all’uomo: tu sei polvere e
polvere ritornerai. Vedi, G.Semerano L’infinito è un equivoco millenario (Mondadori 2001)
[17] Edeniche,cit. pag. 50
[18] Edeniche ,pag. 55
[19] E. M. Cioran L’inconveniente di essere nati pag. 10 (Adelphi, 1991)
[20] M. Cacciari, Dell’Inizio , Adelphi 1990
[21] M.Cacciari , cit. pag.83
[22] M. Cacciari ,cit. cfr. pagg. 572-573
[23] Edeniche, cit. pag. 118
[24] Cfr. su “Le acque e il simbolismo acquatico” nonché sulle cosmogonie acquatiche le meravigliose pagine di Mircea Eliade in Trattato di Storia delle Religioni, Torino 1976 Pagg. 169 e ss.
[25] Edeniche, cit. pag. 45
[26] Edeniche, cit. pag. 46
[27] Edeniche,cit. pag. 47
[28] Edeniche , cit. pag.21
[29] Ermini, La poesia è una grazia, in “Edeniche” pag.10
[30] M. Heidegger , La poesia di Hölderlin (Adelphi ,1988)
[31] A. Delogu, “Flavio Ermini: Edeniche” in Nazione Indiana 1.8.2019
[32] E. Fobo in Lankenauta 21.7.2019
[33] A. Gatto, in Tutte le poesie , Milano 2005, pag.518
[34] F.Ermini , Il giardino conteso , 225.
[35] G. Cuozzo Il giardino conteso. L’essere e l’ingannevole apparire. In “Filosofia” Anno LXI pag. 243
[36] F.Ermini , Edeniche , pag.98
[37] Sandro Gorgone. Il tempo che viene. Napoli 2005 pag. 218
[38] F. Ermini, Il giardino conteso pag.15
 [Volentieri presento il XV Quaderno di poesia italiana contemporanea (Marcos y Marcos, 2021) con la prefazione di Franco Buffoni e una selezione di testi a cura di Francesco Ottonello, che ringrazio. a.r.]
[Volentieri presento il XV Quaderno di poesia italiana contemporanea (Marcos y Marcos, 2021) con la prefazione di Franco Buffoni e una selezione di testi a cura di Francesco Ottonello, che ringrazio. a.r.]









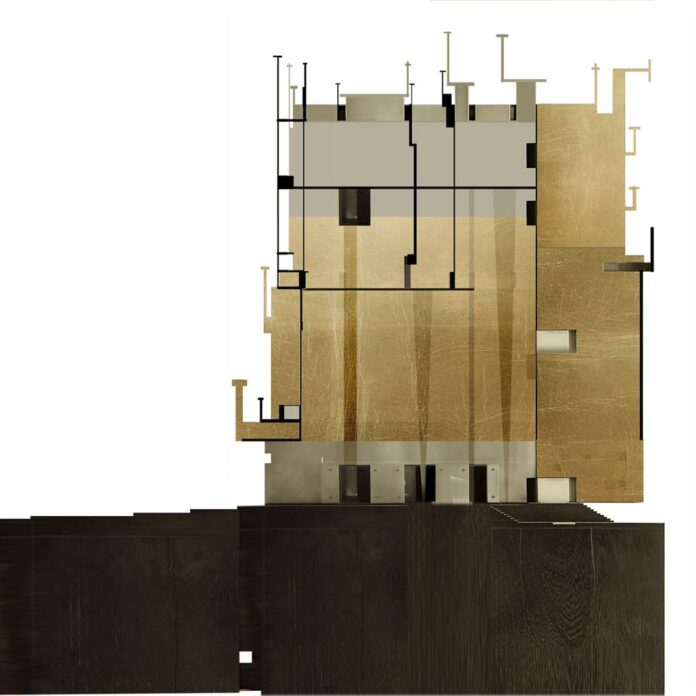

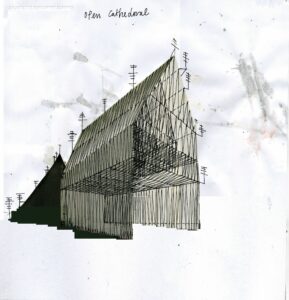

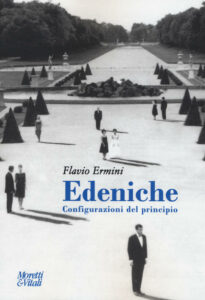 di Bruno di Pietro
di Bruno di Pietro






 C’è poi, nel saggio, un’interessante riflessione sugli intellettuali e sulla dissoluzione della loro funzione politica e sociale. È tramontata l’epoca che Derrida definiva della “tentazione di Siracusa”, che è la stessa dei Lumi che, presso le corti settecentesche, consentivano importanti riforme e avanzamenti sociali. Tra gli altri, Ocone e Patella, opportunamente convocati da Saviani, ci mostrano il servilismo degli intellettuali odierni verso il potere di turno e la loro irrilevanza sui processi decisionali della società.
C’è poi, nel saggio, un’interessante riflessione sugli intellettuali e sulla dissoluzione della loro funzione politica e sociale. È tramontata l’epoca che Derrida definiva della “tentazione di Siracusa”, che è la stessa dei Lumi che, presso le corti settecentesche, consentivano importanti riforme e avanzamenti sociali. Tra gli altri, Ocone e Patella, opportunamente convocati da Saviani, ci mostrano il servilismo degli intellettuali odierni verso il potere di turno e la loro irrilevanza sui processi decisionali della società. Il saggio presenta anche alcune riflessioni tratte da una lezione alla Galleria La Nuova Pesa di Roma sul mito di Orfeo, con preziose citazioni di Rilke e Blanchot.
Il saggio presenta anche alcune riflessioni tratte da una lezione alla Galleria La Nuova Pesa di Roma sul mito di Orfeo, con preziose citazioni di Rilke e Blanchot.












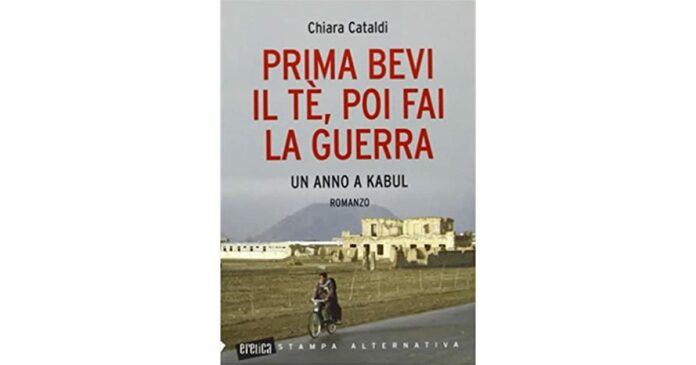
 di
di