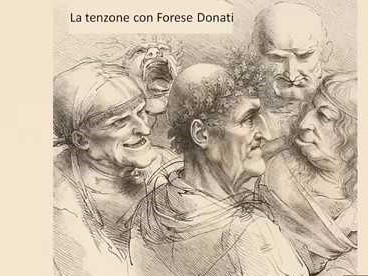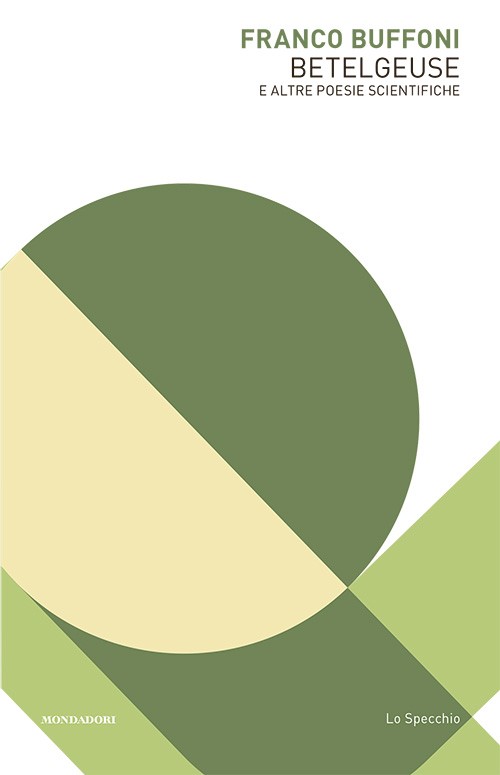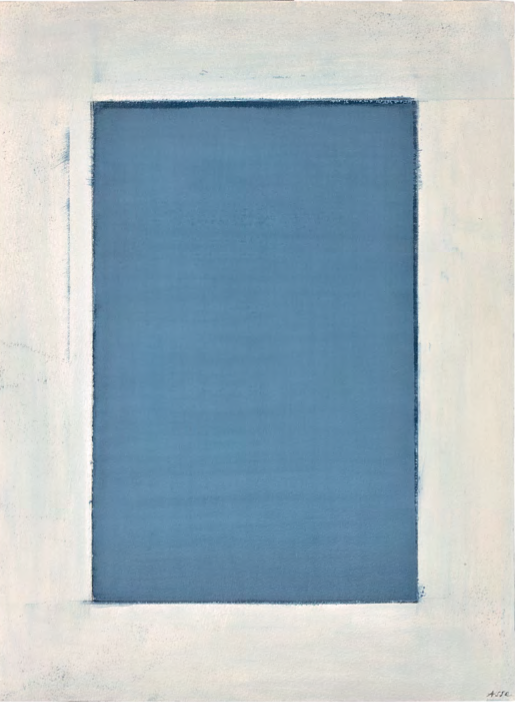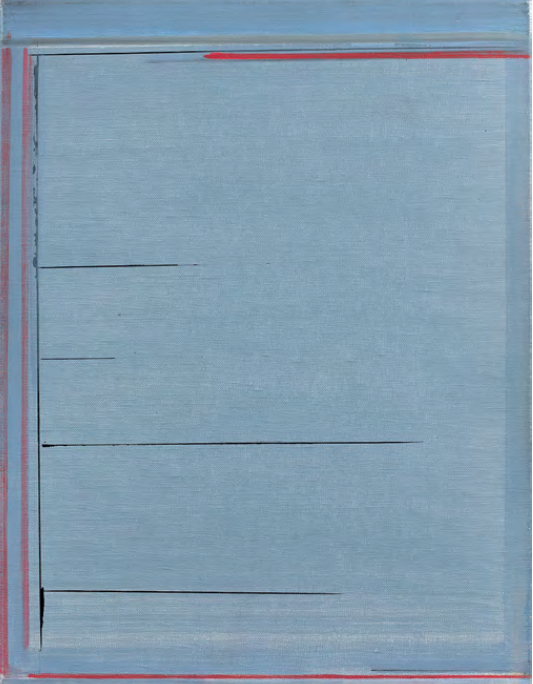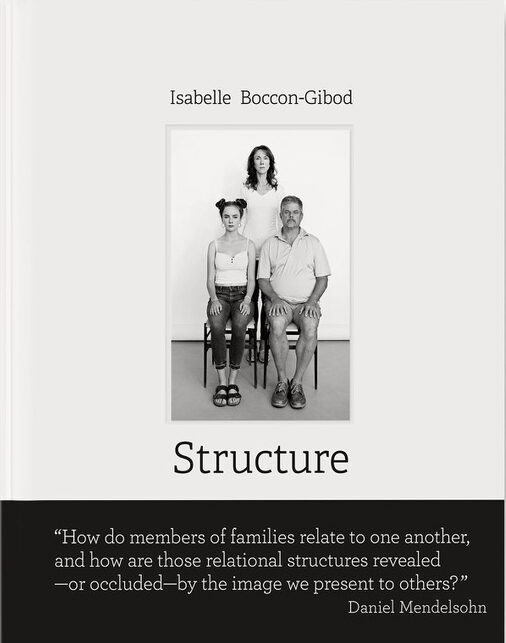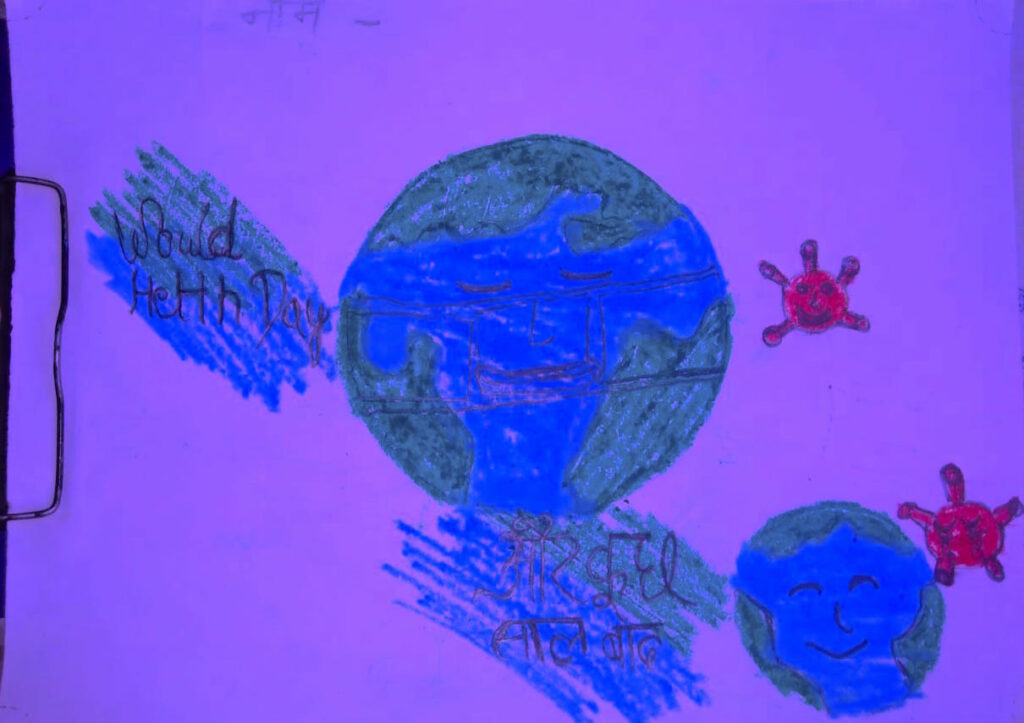di Lorenzo Mari
Ci sono molti libri che fanno problema: scriverne è, tutto sommato, un esercizio facile e piacevole; talvolta, poi, la recensione può portare a un aumento, per quanto limitato ed effimero, del capitale simbolico dell’autore o dell’autrice, e anche di chi ne ha scritto. Ci sono poi alcuni libri che sono problema: nominandolo e agendolo, mettono in crisi le dinamiche stesse dell’accumulazione e dello scambio del capitale simbolico, liberando, così, energie che si possono dirigere altrove.
Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero (Tamu/Archive Books ed., 2021) di Fred Moten e Stefano Harney entra di diritto nella seconda categoria: questa raccolta di saggi e interventi – che trae origine da un articolo apparso nel 2004 su Social Text[1] e che testimonia un lavoro collaborativo e cooperativo più che decennale, e non ancora terminato, per quanto infine approdato alla forma-libro, in inglese, nel 2013 – espone un programma culturale e politico che si estende a tutto campo, partendo dall’incontro-scontro tra la tradizione radicale nera e l’operaismo/post-operaismo/neo-operaismo italiano e giungendo a ridefinire alcune questioni fondamentali tanto per la produzione culturale – in ambito accademico, in particolar modo – quanto per la militanza.
Questioni che potrebbero forse essere riassunte sommariamente così: “non solo e non tanto dentro e contro l’università, bensì anche con e per gli undercommons”. La prima parte rinvia direttamente alle famose parole di Mario Tronti, con la sostituzione dell’“università” alla “società” presente nella formulazione originaria (e questo, secondo Moten e Harney, non tanto perché l’università sia il prodotto diretto di più ampi processi socio-economici, quanto perché la stessa divisione del lavoro accademico può anticipare e prefigurare quei processi). La seconda parte, invece, porta al cuore dello specifico dei contributi di Moten e Harney, ovvero a quegli undercommons[2] che offrono ulteriore articolazione all’ormai lunga tradizione di analisi e lavoro sui commons[3], evidenziando come nel processo di costruzione di questi ultimi siano sempre all’opera dinamiche di esclusione che sono riconducibili, in prima istanza, a una divisione del lavoro intimamente classista, fortemente razzializzata e rigidamente assestata secondo linee di genere.
Allo stesso tempo, però, Moten e Harney non si concentrano sui possibili sviluppi di quell’approccio intersezionale che potrebbe derivare in modo piuttosto immediato e coerente da quanto appena affermato, passando, invece, più direttamente, a delineare una possibile localizzazione culturale e politica degli undercommons (una localizzazione costitutivamente provvisoria, peraltro).
Rifacendosi en passant alla figura del “ladro di idee” e proto-hacker promossa da Félix Guattari[4], infatti, il saggio non mira alla sistematizzazione del concetto di undercommons, perché quest’ultima porterebbe unicamente a una sua legittimazione, politicamente ambivalente, entro i confini ambivalenti della “critica”: rielaborando alcune annotazioni sparse di Fredric Jameson e di Gayatri Chakravorty Spivak, Moten e Harney sottolineano come una critica, apparentemente progressista, che nasca in ambito accademico avrà sempre una serie di determinazioni di classe (di razza, di genere, etc.), nonché un rapporto con l’istituzione e la divisione del lavoro che ne limiteranno la portata e l’intervento politico.
Oltre a preferire l’utilizzo strumentale, militante e non di rado ludico – come ribadito nelle prime pagine del dialogo degli autori con Stevphen Shukaitis[5] – degli undercommons, se ne dà, piuttosto, una provvisoria localizzazione sociale: «Comunità maroon di insegnanti di scrittura, dottorande senza supervisore, storici marxisti a contratto, docenti di management dichiaratamente queer e omosessuali, dipartimenti di studi etnici di università statali, programmi di cinema rimossi, case editrici di riviste di studenti yemeniti con visto scaduto, sociologhe di università storicamente “nere” e ingegneri femministi»[6]. Con questo, Moten e Harney non intendono individuare una sorta di lumpenproletariat accademico che possa provare a emanciparsi dal punto di vista culturale e materiale, bensì presentare una rapida ricognizione sociologica dei luoghi degli undercommons: luoghi che esistono già ora – nonostante l’elenco possa funzionare soltanto da rapida e magari immaginifica esemplificazione – e che già ora complicano le dinamiche stesse di produzione della teoria[7].
In altre parole, all’interno di una scrittura che non disdegna e anzi pratica a pieni mani il linguaggio (uno dei possibili linguaggi) del post-strutturalismo – intersezione, questa, mai negata, da Moten e Harney, nella loro proposta teorica, più volte ribadita, di un incontro-scontro fra la tradizione radicale nera e l’operaismo/post-operaismo/neo-operaismo italiano – sono frequenti le “fotografie di realtà”, delle quali non si può dare conto qui in modo esaustivo, ma che di certo confermano e arricchiscono il percorso teorico del saggio. Sono, inoltre, la spia di una dimensione materiale che può ancora irrompere fortemente nella teoria, configurando lo snodo tra teoria e prassi in un modo già parzialmente diverso da quello della teoria che si auto-legittima (in attesa di una verifica storica, sempre lungi dall’arrivare nel momento in cui la teoria, nei luoghi stessi della sua produzione, si svincola dall’implicazione con le proprie strutture materiali) o, ancora, di quella divulgazione che, già nella propria strutturazione retorica, si vuole immediata traduzione “nella realtà delle cose”.
Di fronte a questo procedere magmatico e insieme per lampi e frammenti (simile all’improvvisazione musicale, nel jazz e oltre i confini del jazz), sembra qui inopportuno, inutile, forse impossibile, tentare di pervenire a considerazioni “critiche” di fondo – esse stesse sono problema, per Moten e Harney – ma, aderendo alla sostanza della loro proposta (pur nell’abbondanza delle note a piè di pagina, contrariamente a quanto proposto nel libro), si cercherà di proporre tre ulteriori frammenti che riprendano e rielaborino le energie che si disperdono a partire dal libro. Riguardano tre direttive fondamentali del libro: il general intellect e lo “studio nero”, la “pianificazione fuggitiva” e l’approccio culturalista (al rapporto tra musica, produzione teorica e militanza, in particolar modo).
1) Frammento sulle macchine (e sulle intellettuali sovversive).
Cosa intendono Moten e Harney per Black Study o “studio nero”? Non si tratta dei più comunemente noti Black Studies – sintomo, pur nella loro legittimità e importanza, di una compartimentalizzazione disciplinare che ha poco a che vedere con gli undercommons – bensì dello “studio” vero e proprio. Si rifugge così l’attuazione di quelle politiche identitarie così spesso imputate agli Studies: la blackness è intesa non come immodificabile attributo ontologico; al contrario, “studio nero” e “pianificazione fuggitiva” «sono rivolti al fare causa comune con la rottura dell’essere, una rottura […] che è anche nerezza, rimane nerezza, e che nonostante tutto rimarrà rotta e in rovina, perché questo libro non è una prescrizione per alcuna riparazione o risarcimento»[8]. In questo, non c’è apologia di quello che è stato storicamente rifiutato, ma “rifiuto del rifiuto”[9]: contro le aporie delle politiche identitarie, costitutivamente essenzialiste, ma anche contro quelle dell’anti-fondazionalismo, ad esempio anti-razzista, implicato nelle aporie di certo relativismo[10]. Tornando alla “carne” – già punto focale della riflessione teorica afroamericana[11] – si può sottolineare, invece, la permanenza di un «punto fisso di nessun punto fisso»[12] che sovverte l’intero discorso della logistica (dell’economia della logistica), ora diventato dominante, in quanto suo margine irriducibile, o “logisticalità”: «La logistica, in qualche modo, sa che non è vero che non sappiamo ancora cosa possa fare la carne. Esiste una capacità sociale di istanziare più e più volte l’esaustione del punto fisso come terreno sottocomune, che la logistica conosce come inconoscibile […] La logistica percepisce il senso di questa capacità come non mai – questo lascito storico inseorgente, questa storicità, questa logisticalità, delle vite rubate»[13].
Questo punto – definito da Christoph Brunner e Gerald Raunig come una forza che rifugge ogni mossa essenzializzante, anche strategica, mantenendo un certo appiglio (hold) perché il potenziale di radicalità sia ancora percepito e agito attraverso i corpi e gli spazi[14] – può forse costituire l’anticipazione, peraltro anch’essa sempre già presente, di un posizionamento. Oltre al posizionamento, tuttavia, è opportuno segnalare anche quello che implica, più concretamente, la promozione dello studio: né acquisizione di competenze professionalizzanti, né lavoro propedeutico all’esercizio della critica, lo studio è ciò che si ritrova ad eccedere continuamente i limiti dell’università neoliberale. Per quanto sia definito come «poco professionale» dalla stessa università – perché collocabile ai margini della divisione del lavoro accademico, essendo stato espulso dai suoi meccanismi di valutazione e selezione, che valgono tanto per le “studentesse” quanto per le “lavoratrici dell’università” – lo studio è un’attività già «più che professionale»[15], alla base della stessa definizione di Universitas e al tempo stesso suo continuo eccesso, mai del tutto normalizzabile.
Si tratta di un’apologia della studentessa fuori corso? Anche. Della ricercatrice incompetente? Anche. Se si dimentica per un attimo la celebrazione dello studio – della produzione e riproduzione delle comunità universitarie, ad esempio, come comunità interne, ai margini o anche esterne all’ambito accademico – che è stata contrapposta alle restrizioni imposte con la didattica a distanza, questa presa di posizione resta scandalosa, soprattutto se rapportata al dibattito italiano, dove da tempo si guarda con un certo disprezzo classista alle studentesse universitarie (come prodotto di una più generale “lotta di classe dall’alto” alla scuola[16]); può sembrare, in altre parole, una provocazione dai toni inutilmente massimalisti, tesi ad autolegittimare la mancanza di competenze e di professionalizzazione in nome di una sterile critica dell’«affermazione dell’individualismo borghese»[17].
Se si ammette invece la correttezza dell’argomento – con ogni probabilità, basta analizzare in modo approfondito i sistemi di valutazione dell’istruzione e della ricerca per concordare, almeno in parte – nasce un ulteriore interrogativo: il luogo di elezione per questa dialettica non resta forse l’università stessa? Se lo chiedono anche Moten e Harney, rispondendo: «essere un accademico critico all’interno dell’università significa essere contro l’università; ed essere contro l’università significa sempre riconoscerla e trarne riconoscimento; istituire la negligenza di quel fuori interiore, quel sottoterreno non assimilato, una negligenza di quello che è esattamente, dobbiamo insistere, la base delle professioni. […] L’università non riconoscerà questa indecisione e, di conseguenza, la professionalizzazione sarà formata esattamente da quello che non può riconoscere, il suo antagonismo interno, il suo lavoro imprevedibile, il suo surplus»[18]. La più alta professionalizzazione corrisponde alla più grande negligenza degli undercommons, nonché delle forze sociali che lo agitano e lo agiscono: di nuovo, l’intellettualità sovversiva non può essere ricompresa entro i limiti della produzione e riproduzione del sapere accademico, senza esserne neutralizzata; l’intellettualità sovversiva, come insistono sia Moten e Harney sia Jack Halberstam, nella sua prefazione, deve restatre prerogativa del general intellect.
Questo non è, però, un general intellect che discenda in linea diretta dal Frammento sulle macchine dei Grundrisse di Karl Marx, riferendosi piuttosto alla tradizione post-operaista/neo-operaista italiana, con la sua ricerca di un’automazione progressiva che sostenga il rifiuto del lavoro e con i suoi frequenti intrecci del general intellect marxiano con la concezione spinoziana del social brain[19]. Tuttavia, nel suo “rifiuto del rifiuto”, la componente principale di questo intelletto generale resta paradossalmente assimilabile a quel pensiero astratto e “senza portatore” che già per Marx era il «pilastro generale della produzione della ricchezza» in quanto parte del «processo vitale stesso della società»[20]. L’intelletto generale resta slegato da una prospettiva antagonista o emancipazionista; continua invece a “pianificare”, in modo incessante e “non competente”, in eccesso rispetto a ogni tentativo di policy – sempre estremamente “competente”, pur nella sua inefficienza, o nel suo autoritarismo normalizzante – ma anche in alternativa a ogni prospettiva rivoluzionaria, considerata, nelle parole introduttive di Jack Halberstam, nient’altro che un «impeto mascolino o uno scontro armato»[21].
Si pianifica, in altre parole, restando esclusivamente all’interno di una dimensione eminentement6e culturale e cercando di praticarvi quella distinzione tra “generazione di conoscenza” e “generazione di comportamenti” già evidenziata da Andrea Fumagalli, dove la prima può, forse, perpetuarsi felicemente nello studio, mentre la seconda rischia sempre di «diventare veicolo e opportunità di nuovo profitto privato, nel momento stesso in cui i nuovi comportamenti, inizialmente e necessariamente alternativi, vengono incapsulati nel fenomeno della moda intesa come ulteriore (e potenziato) feticismo della merce»[22]. Come sia possibile distinguere attivamente la “generazione di conoscenza” dalla “generazione di comportamenti” resta imprecisato, nel testo di Moten e Harney, così come la sottrazione della “generazione di conoscenza” da un processo di semplice messa a valore capitalistica degli undercommons.
Se questo resta “lavoro da fare” – o meglio, un’opzione che resta, ancora, radicalmente aperta – allo scopo di evitare una culturalizzazione dell’intelletto generale che ne sopprima ancora una volta la dimensione antagonista, appropriata dal capitale[23], vi è anche un’altra possibile complicazione materiale dello studio: come si può, sostenere quel debito che contraggono gli studenti – specialmente, ma non solo, nel sistema universitario statunitense – mantenendolo nei termini paradossali e sempre eccedenti del “debito illimitato”, che non può essere “riparato” né “risarcito”? Come segnalano Moten e Harney, la giustizia riparativa ha certamente i suoi limiti, in quanto non cancella l’impronta del credito, ma, davanti alla stretta materiale e coercitiva di un “debito illimitato”, come si può garantire la riproduzione stessa dello “studio”?
2) Frammento di Pistola (o della manager in fuga)
La risposta di Moten e Harney è che lo studio si riproduce soltanto nella “pianificazione fuggitiva”. «Tornerò all’università e lì vivrò di furto» è la soluzione proposta da Moten e Harney, con un’opportuna misquotation e dislocazione dell’originario monologo di Pistola nell’Enrico V di Shakespeare[24]: «Questa è oggi l’unica relazione possibile con l’università statunitense e potrebbe valere per ogni università, in ogni parte del mondo. Potrebbe essere vero per l’università in generale. Ma, certamente, è tanto più vero negli Stati Uniti: non si può negare che l’università sia un luogo di rifugio e non si può accettare che sia un luogo di rivelazione illuminista. Alla luce di tali condizioni, non si può entrare nell’università se non furtivamente e, una volta dentro, rubare tutto il possibile. Abusare della sua ospitalità, ostacolare la sua missione per unirsi alla colonia di profughi, di rifugiate, al suo campo nomade, per essere nell’università ma non dell’università – questo è il percorso dell’intellettuale sovversiva nell’università moderna»[25].
La relazione con l’università, dunque, può essere soltanto “furtiva” e, di conseguenza, “fuggitiva”: non si tratta soltanto di un “esproprio proletario” in una sua nuova, ed estremamente problematica, versione culturale[26], ma della rivendicazione di un’intera dimensione politica sottratta alle dinamiche del possesso e dello spossessamento con la quale Moten e Harney – prescindendo, di nuovo, dalla più classica prospettiva emancipazionista, basata sui processi di autocoscienza e di lotta di classe all’interno di una specifica divisione del lavoro, e ricorrendo invece alla memoria della “conquista”, e cioè di quel lungo dominio a carattere schiavista che ha segnato, in modo particolare ma non esclusivo, la storia degli Stati Uniti – identificano più volte la politica stessa[27].
Davanti alla mancanza di alternative propalata dal realismo capitalista – Fisher continua a tornare, in controluce – si potrebbe parafrasare che “la pianificazione del cambiamento è già essa stessa cambiamento”. Continuare a pianificare, con e per gli undercommons, consente di continuare la fuga, che è ancora, mutatis mutandis, quella delle schiave e degli schiavi in fuga dalle piantagioni; non si ricerca una strategia controegemonica, che si segnala già in partenza come fallimentare, ma si mantiene la memoria della “conquista” e della stiva della nave del Middle Passage per uno scopo che è, innanzitutto, di «preservazione militante»[28].
Se questa posizione può sembrare eccessivamente difensiva, o anche auto-legittimante, ciò non lo si deve, tuttavia, a un giudizio morale, “critico” e nemmeno “politico” – nelle due accezioni, almeno, rifiutate da Moten e Harney – ma alle conseguenze stesse della posizione che assume la “pianificazione fuggitiva” rispetto alla questione manageriale della policy, cui Moten e Harney dedicano una sostanziale operazione decostruttiva[29], ma che resterebbe, in ultima istanza, immodificata da una strategia di “preservazione militante”.
Se è senz’altro vero, come scrivono Moten e Harney, che «ci sono persone che vogliono gestire le cose, e ci sono cose che vogliono scappare»[30], ancora una volta, però, all’opzione della fuga è utile contrapporre un’altra strategia, sempre suggerita da Mark Fisher – il quale torna ad essere, ancora una volta, utile cartina da tornasole, per la lettura di Undercommons – in uno dei suoi ultimi scritti, che è quella di “accelerare il management”[31]. Resta possibile, infatti, un tentativo di accelerare il management fino a svincolarlo dalla sua appropriazione neoliberale – «What is a communist society if not a managed society?»[32], si chiede Fisher (non senza una punta di candore, che Moten e Harney, potrebbero fiutare e rifiutare) – e rimetterlo, così al servizio di un’agency collettiva.
Ora, mentre l’articolo di Fisher si chiude con un paio di richieste a una nuova managerialità del lavoro culturale che sembrano limitare di molto la portata della sua proposta – manager che non portino a paradigma la loro dipendenza tossica dal lavoro, imponendo carichi di lavoro eccessivi ai loro dipendenti; manager che non soverchino i dipendenti di tante micro-mansioni (non di rado, di natura burocratica e burocratizzante), ma di uno “spazio per pensare”, ecc.[33] – è qui utile osservare come l’accelerazione del management invocata da Fisher sia, in realtà, permeata dal desiderio di ritorno a quei corpi intermedi, dal partito al sindacato, che la folk politics di sinistra – così com’è stata esemplificata, nel mondo anglosassone, da un movimento come Occupy (riferimento che, in certo modo, oscura esperienze simili e precedenti) – ha inteso abbandonare in favore di una logica neo-orizzontalista[34].
Com’è noto, Fisher è molto attento a non lasciarsi invischiare nelle forme melancoliche di una politica della nostalgia: anche per lui, si tratta di re-immaginare un mondo. Anche per lui, si tratta di guardare a un’altra citazione shakespeariana proposta da Moten e Harney – « Pazzo, amante, poeta: tutti e tre sono composti sol di fantasia», da Un sogno di una notte di mezza estate (Atto V, Scena 1) – dove, se Moten e Harney suggeriscono di sostituire al poeta (un’elisione bizzarra, ma, in fondo, non troppo, in un testo, come Undercommons, che non di rado sconfina, di fatto, nei territori della poesia) la «guerriglia anticoloniale»[35], Fisher potrebbe chiedere di aggiungervi il “militante del desiderio post-capitalista”, se non, addirittura, un “sindacalista” (una nuova forma di sindacalismo, almeno).
3) Frammento dell’eschaton discacciato e cantato a ritmo di scat (o del party clandestino)
Re-immaginare il mondo non vuol dire accelerarne la fine all’insegna del “tanto peggio tanto meglio” – su questo punto, anche l’accelerazionismo, nell’accezione datagli da Mark Fisher, sembra piuttosto chiaro[36]. Moten e Harney si mantengono al di là delle interpretazioni escatologiche (e anche anti-escatologiche, intendendo rifuggire anche questo ulteriore binarismo) che sono rifiorite, su altri versanti, in tempi di pandemia. Una delle loro formule più riuscite, ricordate anche da Jack Halberstam nella sua introduzione, è la celebrazione del «gioioso rumore dell’eschaton discacciato e cantato a ritmo di scat»[37], rifuggito e al tempo stesso portato altrove da una pratica musicale coerente con la storia culturale e politica della nerezza che permea il libro. Musica soul (Curtis Mayfield e Marvin Gaye su tutti) e jazz (Joe McPhee e Don Cherry, tra gli altri) restituiscono un percorso che flirta con le metodologie degli studi culturali, per poi portare a nuovi approdi. Si prenda, ad esempio, l’ascolto della struttura antifonale di Nation Time (1970) di Joe McPhee: «In un certo senso, sembra davvero che McPhee stia richiamando all’ordine, stia facendo la paternale al pubblico in una serie di domande e risposte: “What time is it?” “Nation Time”. Ma per altri versi, qualsiasi ordine impostato secondo quel richiamo all’ordine, se lo è, allora si spezza rapidamente o muta in qualcos’altro attraverso l’improvvisazione collettiva […] mi chiedevo come si possa allo stesso tempo richiamare all’ordine e richiamare al mutamento, o a una rottura, o forse a un genere diverso di ordine»[38]. Al che Fred Moten incalza: «Ho sempre pensato che l’enunciazione di Nation Time […] è davvero una sorta di annuncio dal tono internazionale e, oltre e attraverso di esso, anti-nazionale. A me sembra che il nazionalismo nero, come estensione del panafricanismo – che è resistenza a una data Africa all’interno dell’Africa, vista esattamente come una combinazione venale, amministrativa e accumulativa di accaparramento e spartizione – interrompa la nazione. […] Non solo è facile sbagliare l’origine, ma sbagliare proprio tutto, quando si pensa in termini di un’origine. Ma non penso che McPhee fosse o volesse essere originario. Forse c’è un modo segreto, rivelato da qualche parola unica e segreta, per muoversi attraverso queste organizzazioni e disorganizzazioni costanti della domanda, che prende la forma in deformazione di una sola voce che acconsente e richiede la sua moltiplicazione e divisione»[39]. Questa “forma in deformazione” data dall’“organizzazione e disorganizzazione della domanda” è presente anche nel brano “Trini To The Bone” (2003) di David Rudder – apparentemente una celebrazione nazionalista di Trinidad a ritmo di calypso e, in realtà, una disarticolazione e ri-articolazione di quel discorso attraverso la citazione puntualmente riportata da Moten e Harney: «How we vote is not how we party»[40].
Nella loro dimensione collettiva e ludica, gli undercommons sono, soprattutto, una festa, nella quale si esplica il “rifiuto del rifiuto” della tradizionale azione politica basata sui processi di autocoscienza attraverso una liberazione, già ora, dei corpi. Perché, allora, non aggiungere alla playlist, soprattutto soul e calypso, di Moten e Harney quella proposta da Matt Colquhun, in appendice a The Postcapitalist Desire (2020) di Mark Fisher, da lui curato[41], e che spazia da “Jobseeker” (2008) degli Sleaford Mods a “At Last I am Free” (1978) di Chic, passando per i Jam, gli Specials, ma anche “Can’t Stop Playing (Makes Me High)” (2015) di Dr Kucho! & Gregor Salt?
[La playlist per una festa futura è disponibile già ora. In fondo, come ha scritto Paolo Do in una recensione del libro, «che sia la stiva di una nave negriera, la sala caffè delle infermiere o degli insegnanti di un liceo, una qualsiasi cucina, portico, cantina, corridoio, panchina di un parco poco importa. È durante una qualsiasi “festa improvvisata di notte” che ci si incontra per decifrare la musicalità di questo testo e comprendere il ritmo dove tutti possono mettersi a insegnare e a imparare da tutti». Perché, una volta delineata una proposta di playlist, non re-immaginare già ora un luogo per questa festa, che sia anche un luogo di traduzione degli undercommons? Ha forse a che fare con la re-immaginazione di quei centri senza affiliazione, o ancora quei “centri sociali” che, nella tradizione italiana, hanno già da sempre costituito un luogo di espropriazione e riappropriazione dei saperi dall’università e di pianificazione fuggitiva? C’è ancora, ai margini della policy che riguarda la “didattica a distanza”, ma ogni “distanziamento”, in genere – finché ne perdura la qualità prettamente ideologica del “distanziamento sociale” – un modo per re-immaginare quei luoghi dove gli undercommons erano già all’opera, prima della pubblicazione di questo libro?]
[1] Cfr. F. Moten, S. Harney, “The University and the Undercommons: Seven Theses”, Social Text, 79, 2004, pp. 101–115.
[2] Nella traduzione italiana, “undercommons” è scritto in tondo, mentre qui si manterrà la grafia in corsivo, come scelta maggiormente straniante e più coerente con un dibattito culturale e politico che, fino almeno alla traduzione del libro da parte della casa editrice Tamu, in collaborazione con Archive Books, non aveva ancora accolto appieno la proposta teorico-politica di Moten e Harney. Si accolgono, invece, le altre scelte linguistiche adottate nel libro da Emanuela Maltese e spiegate nella nota all’introduzione firmata dalla Technoculture Research Unit, il collettivo che ha curato l’edizione italiana: «Traducendo dall’inglese, i limiti imposti dall’uso del maschile sovraesteso nella norma linguistica italiana generano un conflitto con la volontà degli autori e delle case editrici di rivolgersi a una comunità accogliente per le esperienze di dissidenza dei generi, come quelle trans e non binarie. Da tale esigenza viene la scelta editoriale di declinare il genere grammaticale utilizzando alternativamente sia il maschile che il femminile, e di introdurre in questo libro la schwa, vocale centrale dell’Alfabeto fonetico internazionale, presente in inglese ma anche in molti dialetti italiani» (Technoculture Research Unit, “La comunità fuggitiva dello studio nero”, in F. Moten, S. Harney, Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero, Tamu/Archive Books ed., Napoli, 2021, p. 11)
[3] Per una prospettiva divergente, ma di tutt’altro tipo, sui commons, si veda il lavoro di Angela Mitropoulos sul concetto di un/common nella genealogia dei commons, cfr. A. Mitropoulos, “The Commons” in Gender: Nature, a cura di Iris van der Tuin, Macmillan, Farmington, 2016, pp. 165–81.
[4] Cfr. F. Guattari, R. Maggiori, “Petites et grandes machines à inventer la vie”, Libération, 28-29 giugno, 1980, in F. Guattari, Les années d’hiver (1980-1985), Les Prairies ordinaires, Parigi, 2009, pp. 165-179.
[5] F. Moten, S. Harney, Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero, cit., pp. 171 e passim.
[6] Id., pp. 66-67.
[7] Il già ora si contrappone decisamente anche a ogni teorizzazione politica “a venire”, come quelle che costellano, ad esempio, il pensiero di Jacques Derrida: «La falsa immaginazione e la sua critica minacciano il comune con la democrazia, che è sempre solo a venire, così che un giorno, che non avverrà mai, saremo più di quello che siamo. Ma lo siamo già. Siamo già qui, in movimento. Siamo stati nei dintorni. Siamo più della politica, più che insediati, più che democratiche» (F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 52).
[8] J. Halberstam, “L’oltre selvaggio: con e per gli undercommons” in F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 33.
[9] Id, p. 69: «…non […] un antifondazionalismo o un fondazionalismo in quanto entrambi sono usati l’uno contro l’altro per evitare il contatto con gli undercommons».
[10] Id, p. 95.
[11] Cfr. ad esempio H. Spillers, “Mama’s Baby, Papa’s Maybe: An American Grammar Book”, Diacritics, 17.2, pp. 64-81: https://people.ucsc.edu/~nmitchel/hortense_spillers_-_mamas_baby_papas_maybe.pdf
[12] F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 157.
[13] Ibidem.
[14] Cfr. C. Brunner, G. Rauning, “From Community to the Undercommons. Preindividual – Transindividual – Dividual – Condividual”, Commonist Aestethics, 2015: https://onlineopen.org/from-community-to-the-undercommons
[15] F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 67.
[16] Cfr. R. Mordenti, “La scuola, ovvero il luogo della lotta di classe “dall’alto’” (2018): http://raulmordenti.it/la-scuola-ovvero-il-luogo-della-lotta-di-classe-dallalto/
[17] F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 69.
[18] Id., pp. 68-69.
[19] Id,, Undercommons, cit., p. 175.
[20] K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Giulio Einaudi, Torino, 1977, p. 719.
[21] J. Halberstam, “L’oltre selvaggio, cit., p. 42. Il rifiuto della strategia rivoluzionaria ritorna con frequenza, all’interno di Undercommons, passando anche attraverso alcune ambigue equiparazioni tra fascismo e comunismo (p. 78), per approdare poi, sinteticamente, alla necessità di essere «comunistə nei confronti del comunismo» (p. 142).
[22] A. Fumagalli, Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione, Carocci, Roma, 2007, p. 198.
[23] Cfr. a questo proposito D. Mariscalco, “Sul divenire culturale del general intellect”, in Vita, politica, rappresentazione. A partire dall’Italian Theory, a cura di P. Maltese e D. Mariscalco, Ombre Corte, Verona, 2016, pp. 179-190.
[24] F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 69. Il riferimento è agli ultimi versi della prima scena del quinto atto dell’Enrico V, con i quali Pistola termina il suo monologo più importante (dai toni originariamente comici, ma che assume tutt’altra valenza per Moten e Harney): «Tornerò in Inghilterra furtivamente, per darmi al furto / mi applicherò delle bende sui segni delle legnate/ e giurerò che nelle guerre galliche me le son procurate».
[25] Ibidem.
[26] La problematicità di questo “esproprio proletario” di piccolo cabotaggio si rende già evidente sulla pagina di Moten e Harney, nella quale, alla descrizione di un possibile caso di esproprio – «Ma se l’accademico critico è semplicemente un professionista, perché perdere così tanto tempo con lui? Perché non rubare semplicemente i suoi libri, un mattino, e donarli a quelle studentesse non immatricolate e rinchiuse in un bar studentesco, stipato e fetido di birra – dove ha luogo il seminario su come squattare e scroccare?» – segue immediatamente una risposta che, inevitabilmente, allarga i confini della questione, chiamando indirettamente in causa strategie a più ampio spettro: «Eppure, dobbiamo parlare di questi accademici critici, perché si è scoperto che la negligenza è un grave crimine di stato» (F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 82).
[27] Id., pp. 50 e passim.
[28] Id., p. 132.
[29] Id., pp. 125-144.
[30] Id., p. 98.
[31] Cfr. M. Fisher, “Accelerate Management”, PARSE, n. 5, 2017: https://parsejournal.com/article/accelerate-management/
[32] Ibidem.
[33] Ibidem.
[34] Cfr. ad esempio: «The dominant mood of folk politics is neo-anarchist: it declares the age of the political party and the trade union to be over, embracing the self-organising and horizontal dynamics of the network against what it characterises as oppressive (and obsolete) hierarchical structures» (ibidem).
[35] F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 225.
[36] Per una definizione sintetica della differenza tra l’approccio all’accelerazionismo di Mark Fisher e quello – assimilabile, per semplificazione, allo slogan “tanto-peggio-tanto-meglio” – di Benjamin Noys (in B. Noys, The Persistence of the Negative: A Critique of Contemporary Continental Theory, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2010), cfr. M. Colquhoun, “Introduction: No More Miserable Monday Mornings”, in M. Fisher, Post-Capitalist Desire. The Final Lectures, a cura di M. Colquhoun, Repeater, Londra, 2021, pp. 22-25.
[37] J. Halberstam, “L’oltre selvaggio”, cit., p. 40.
[38] F. Moten, S. Harney, Undercommons, cit., p. 214.
[39] Id., pp. 215-216.
[40] Id., p. 164.
[41] M. Fisher, Post-Capitalist Desire, cit., pp. 219-220.