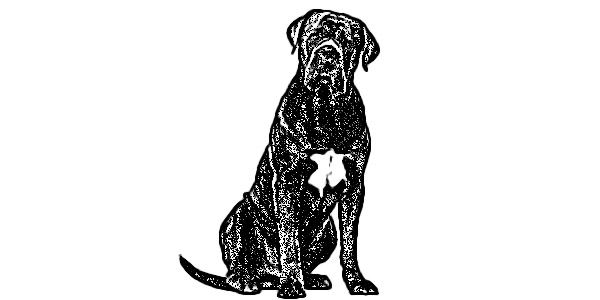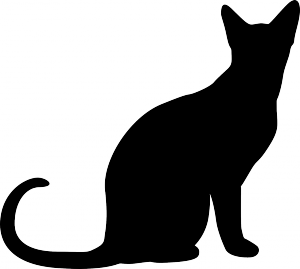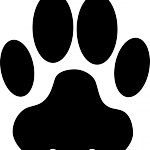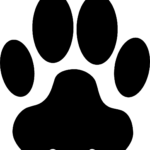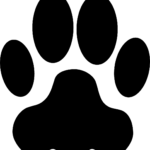di Enrica Maria Ferrara
Un uomo in là con gli anni, che a suo tempo è stato un famoso funambolo, si prepara ad affrontare un’ultima traversata. Mette a punto con precisione scientifica il suo piano che prevede un meticoloso studio delle condizioni atmosferiche, dell’equipaggiamento meccanico e delle leggi fisiche che ne permetteranno la realizzazione. Nelle settimane precedenti al Natale, il piccolo uomo magrissimo, con le giunture arrugginite, la prostata ingrossata e un sogno negli occhi, si solleverà su un cavo teso tra l’ultimo piano della vecchia biblioteca e il campanile della chiesa abbandonata a 175 metri di distanza. Partirà all’alba, un corpo sospeso in equilibrio precario sul sottile palcoscenico a cielo aperto, impugnando il suo bilanciere come uno scettro, pregustando la sorpresa del pubblico che di lì a poco si assembrerà sotto il filo ad osservarne le prodezze.
“Appoggiò la punta del piede e la fece scivolare in avanti con delicatezza, finché tutta la pianta aderì perfettamente al cavo. Molleggiò impercettibilmente sulle ginocchia; un dolore sordo si fece vivo nella zona del crociato. Spostò il peso del corpo sulla gamba destra. Con il piede sinistro disegnò un piccolissimo arco nell’aria. Lo riportò sul cavo, lo rattrappì e distese, lentamente, per trovare la presa più salda. Un grande bruco che avanza su un ramo.” (p. 11)
Non è chiara la ragione per cui l’uomo ha deciso di esibirsi in un gesto così estremo, donando ai concittadini uno spettacolo imprevisto che genererà un misto di sorpresa, sgomento, eccitazione, paura. Uno dopo l’altro, si avvicendano accanto e sotto al cavo vari personaggi che provano a interrogare il funambolo per dissuaderlo dall’impresa e smascherarne i motivi reconditi. Sfilano un pompiere, un poliziotto, la figlia dell’uomo scomparsa da tempo, la bibliotecaria, uno scienziato. A un certo punto compare anche una troupe televisiva che organizza una diretta per approfittare del fatto che presto l’acrobata si trasformerà in un “trend-topic”, in un hashtag dei social, facendo schizzare in alto la curva dei “rilevatori di audience”. Mentre l’Uomo dell’aria avanza con passo di lumaca, la domanda a cui tutti cercano di trovare risposta è: perché lo fa? Sarà un terrorista, il capo di un’organizzazione criminale o addirittura un medium che comunica con abitanti di altri mondi attraverso un tunnel spazio-temporale? E man mano che la storia va avanti abbiamo la netta sensazione che quell’interrogarsi sia l’obbiettivo cui la narrazione tende.
Da che ho finito di leggerlo, continuo a girarci intorno. In qualche modo l’Uomo dell’aria mi attende, mi fa cenno di seguirlo. Non riesco a liberarmi dell’immagine che Simona Baldelli ha messo in calce al libro, quella dell’Uomo dell’aria che “le si presentò un pomeriggio di ottobre, qualche anno fa” (p. 179). Nel corso di un’intervista alla radio, ho sentito la scrittrice confessare che un giorno, mentre stava lavorando ad un progetto di scrittura del quale non riusciva a venire a capo, il funambolo le si sedette accanto per parlarle di quell’ultima passeggiata di 175 metri, nella quale avrebbe voluto che lei lo accompagnasse raccontandola.
La concretezza di quell’immagine non dovrebbe stupirmi perché ad essa corrisponde la solidità del personaggio narrato, tutto nervi, prodezza fisica ed energia mentale, un uomo che investe nella sua impresa passione, immaginazione e conoscenza puntuale delle leggi che governano la gravità, il volo, lo stare sospesi. Vengono subito in mente i personaggi pirandelliani che fanno visita al suo autore, lo tormentano mentre lui sta scrivendo un’altra pièce, si calano di prepotenza nella sua creazione.
E della coincidenza non dobbiamo stupirci perché Baldelli è innanzitutto persona di teatro, la sua arte si è formata nello studio della voce, del gesto, della performance, è stata attrice e drammaturga prima di passare alla scrittura narrativa. Il suo funambolo è figura della tradizione “comica” e circense che da un lato si ricollega al teatro dell’avanspettacolo di Petrolini, Totò e Macario, dall’altro alla maschera melanconica e clownesca dei vagabondi chapliniani che popolano i film di Fellini, primo fra tutti La Strada (1954).
Ed è proprio al funambolo de La strada di Fellini, il Matto (interpretato da Richard Basehart) che compare per la prima volta nel film su un cavo altissimo teso fra il tetto della chiesa di Bagnoregio e l’attico del palazzo Barboux, che la mia mente è corsa quando ho sentito parlare dell’Uomo dell’aria di Simona Baldelli. Il Matto di Fellini avanza con la sua asta fra le mani, acclamato dal pubblico sottostante — prima fra tutti l’eterea Gelsomina/Giulietta Masina—che ne accompagna la traversata con schiamazzi e terrorizzati silenzi. A un certo punto l’acrobata si siede sul filo a mangiare un piatto di spaghetti, finge di capovolgersi e si rimette in piedi. La scena è commentata da una presentatrice che impugna un grosso microfono, progenitrice della giornalista che si accampa sul set della Fiaba di Natale per intervistare il pubblico, rovistare nel passato dell’Uomo dell’aria, rubarne l’anima e poi darla in pasto al mostro mediatico da cui siamo tutti assediati.
L’innocenza del Matto, la sua irriverenza e il principio di necessità che domina la sua natura—per cui, ad esempio, non può fare a meno di scagliarsi contro il bruto Zampanò—sono caratteristiche rintracciabili anche nell’Uomo dell’aria il quale non sa spiegare la vera ragione del suo bisogno di camminare sul filo. Nonostante i piani meticolosi da lui orditi, non sa fornire una motivazione che vada oltre l’elementare impulso ad assecondare la propria natura. Il funambolo, quello felliniano e quello baldelliano, ci esorta innanzitutto ad essere noi stessi, anche se questo significa spingersi al limite dell’immaginabile, sfidare le leggi della fisica, disegnare un tracciato mai concepito fino a quel momento, e farlo sotto gli occhi di tutti. L’utopia di un idealista, verrebbe da pensare, che ci propina la materia dei sogni e delle fiabe. Senza dubbio. Ed è questo il punto. O uno dei punti.
“Le fiabe sono vere”, diceva Italo Calvino nella memorabile introduzione alle Fiabe italiane. “Sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino […] dalla nascita […] alle prove per diventare adulto e poi maturo, per confermarsi come essere umano” (I. Calvino, “Introduzione”, in Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte in lingua italiana dai vari dialetti, Torino, Einaudi, 1956, Vol. I, p. xviii).
Se c’è un insegnamento calviniano di cui Simona Baldelli, finalista al Premio Calvino 2013 (e poi vincitrice del Premio John Fante) con il romanzo magico-realista Evelina e le fate (Giunti), sembra aver fatto tesoro, è proprio questo. La casistica ripetitiva e tipizzante delle fiabe—con i re, le regine, gli eroi, i mostri da sconfiggere, le donzelle in pericolo, i ricchi e i mendicanti—adempie al suo ruolo di rassicurante catalogo che si può rimescolare per creare una storia imprevista, un nuovo tassello nella giostra universale dello storytelling. Questa scheggia colorata e inattesa è appunto l’Uomo dell’aria, un “essere”—prendo ancora in prestito le parole di Calvino—“determinato da forze complesse e sconosciute”, dominato dal dovere elementare di “autodeterminarsi” e “liberare gli altri”, consapevole che è impossibile liberarsi da soli ma che bisogna “liberarsi liberando” (Ivi, p. xviii).
La prova cui si sottopone l’eroe della Fiaba di Natale, e sul cui significato si interrogano gli astanti, potrebbe essere dettata da un capriccio senile, un disperato bisogno di esibirsi, o anche solo dall’urgenza di sentirsi vivi esercitando il corpo, strappandosi alla vita sedentaria—sentimento che alla generazione passata per le restrizioni della libertà di movimento imposte nel 2020 sarà estremamente familiare. Potrebbe anche essere la risposta automatica al richiamo della propria natura, intesa non come insieme di qualità essenziali ma come tensione alla realizzazione di un’identità centrata sul principio di autodeterminazione—e in tal senso, oltre al funambolo felliniano, l’Uomo dell’Aria ci riporta alla mente il suo illustre antenato sospeso, il barone rampante Cosimo Piovasco di Rondò, che per nessuna ragione apparente saltò sugli alberi del bosco di Ombrosa all’età di 12 anni e lì rimase fino alla fine dei suoi giorni.
Ma c’è di più nell’universo baldelliano.
All’illuministico e razionalissimo sforzo del giovane barone arboricolo che pare essere sorretto sulla cima degli alberi da un mero impulso volontaristico—metafora, come si sa, di un’aspirazione ad un modo diverso di essere intellettuale che consente di far parte per se stesso pur mantenendosi coerente con le proprie ideologie e la propria formazione—Simona Baldelli contrappone un omino apparentemente gracile, semi-pensionato, la cui impresa è resa possibile da un misto di resilienza, allenamento del corpo, consapevolezza (oggi diremmo mindfulness) e studio approfondito di coordinate, equazioni fisico-matematiche, carrucole e ventature.
La performatività del gesto del funambolo, l’aver camminato tante volte su quel filo in passato e il conoscere le regole di uno spettacolo apprezzato dal pubblico, ne garantirà il successo. Uscendo fuor di metafora, l’artista incarnato dall’Uomo dell’aria conosce a fondo i ferri del mestiere, le leggi anche non scritte della disciplina di cui si occupa, i rischi che le opinioni dello spettatore e i tentativi di manipolazione da parte dei media comportano, e sa che il suo ruolo è quello di perseguire ostinatamente il compito che si è prefisso tenendo gli occhi puntati sul traguardo: 175 metri, non uno di più non uno di meno. L’arte è pozione alchemica fatta di numero, studio ed estro.
Ma anche questo non è sufficiente. Non bastano il talento, l’abilità, il calcolo matematico dei passi da compiere, il computo dell’attrito, della resistenza, degli ostacoli naturali e sociali che bisognerà affrontare. C’è un elemento in più che Simona Baldelli ci propone nei panni di un’apparizione magica, parente delle fate che popolano il suo primo romanzo, della nuvola d’oro che accompagna la protagonista doppia Caterina-Antonio de La vita a rovescio (Giunti, 2016) e della piccola ombra che precede l’altra protagonista doppia, Clelia-Amalia, de Il vicolo dell’immaginario (Sellerio, 2019). È uno spiritello che compare sul filo un giorno che il funambolo si sta esibendo in uno dei suoi numeri più arditi, un simulacro formato dall’addensarsi granuloso di puntini luminosi e colorati: “L’Uomo a colori gli venne incontro danzando, poi fece un balzo, aprì le gambe e cadde in una spaccata perfetta.” (p. 42)
Stupito dalla nuova presenza e consapevole che l’Uomo a colori è visibile solo a lui, l’acrobata ne osserva i movimenti e comprende che la figura magica lo esorta ad imitarne i gesti: “L’altro sollevò il cappello blu e fece un inchino, poi con la mano disegnò un movimento rotatorio all’indietro, imitando la piroetta eseguita poc’anzi.” (p. 43). Così, replicando mosse che solo lui può vedere, l’Uomo dell’aria riesce per la prima volta a fare la capriola sul filo, senza la rete di protezione, davanti al pubblico sbalordito ed esultante.
Abbiamo la netta sensazione che Baldelli ci stia indicando l’esistenza di un mondo di possibili che esiste parallelamente al nostro e che viene in essere grazie alla nostra capacità di vederlo come se già esistesse, perché esso, di fatto, già esiste in realtà. Si tratta di un universo altro da quello che riusciamo a percepire con i nostri cinque sensi e seguendo il principio causa-effetto della logica aristotelica e della fisica newtoniana. È piuttosto il mondo dell’infinitamente piccolo, governato dai principi di indeterminazione e probabilità della meccanica quantistica, dove gli elettroni possono comportarsi di volta in volta come particelle ed onde a seconda dell’interazione con l’osservatore e con la strumentazione adoperata per osservarli. Non starò qui ad addentrarmi nei minuti dettagli della questione, ricostruita mirabilmente da Carlo Rovelli nel suo Helgoland (Adelphi, 2020). Quello che importa è che la presenza del folletto di luce—e di tutte le entità cosiddette magiche nei romanzi di Simona Baldelli—può essere interpretata come elemento visionario e fantastico (nella prospettiva newtoniana) o come elemento realistico (nell’ottica quantistica), nei termini di un realismo che è stato definito “performativo” o “agenziale” (Karen Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, 2007). Se optiamo per la seconda ipotesi, allora accettiamo che la realtà già esista in diversi possibili stati (il gatto vivo e morto di Schrödinger) e che l’Uomo a colori non sia altri che l’Uomo dell’aria, la forma di se stesso con la quale il funambolo aspira a ricongiungersi: ci riesce, appunto, compiendo il tragitto di 175 metri.
Se dunque uno degli ingredienti fondamentali dell’identità performativa, dell’artista o semplicemente dell’homo faber, rivelataci dal funambolo di Simona Baldelli consiste nel visualizzare se stessi in una forma che già esiste e che dobbiamo semplicemente attualizzare fra le tante forme possibili, ciò non vuol dire che possiamo metterci passivamente in posizione di attesa. Dovremo infatti approntare la scena, affilare i ferri del mestiere, allenare la mente e il corpo, e perseguire un obbiettivo misurabile che agli altri potrebbe apparire velleitario ma che per chi lo sceglie è in fin dei conti la strada della libertà.
Liberando se stesso nella performance alata della sua autodeterminazione quantistica, l’uomo della Fiaba di Natale diventa l’eroe di una fiaba tutta contemporanea che apre il cammino ad una nuova dimensione fisica ed etica.

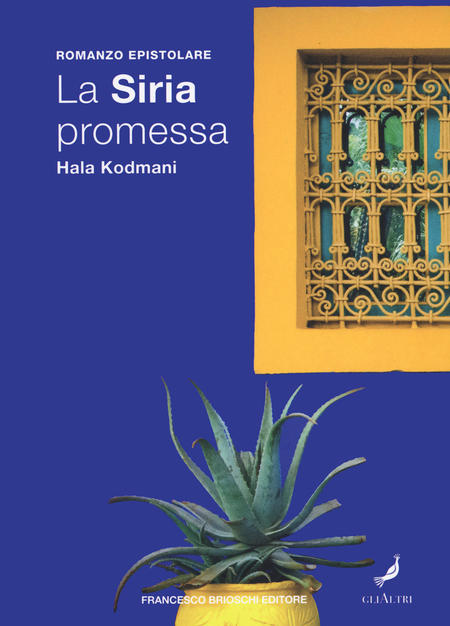




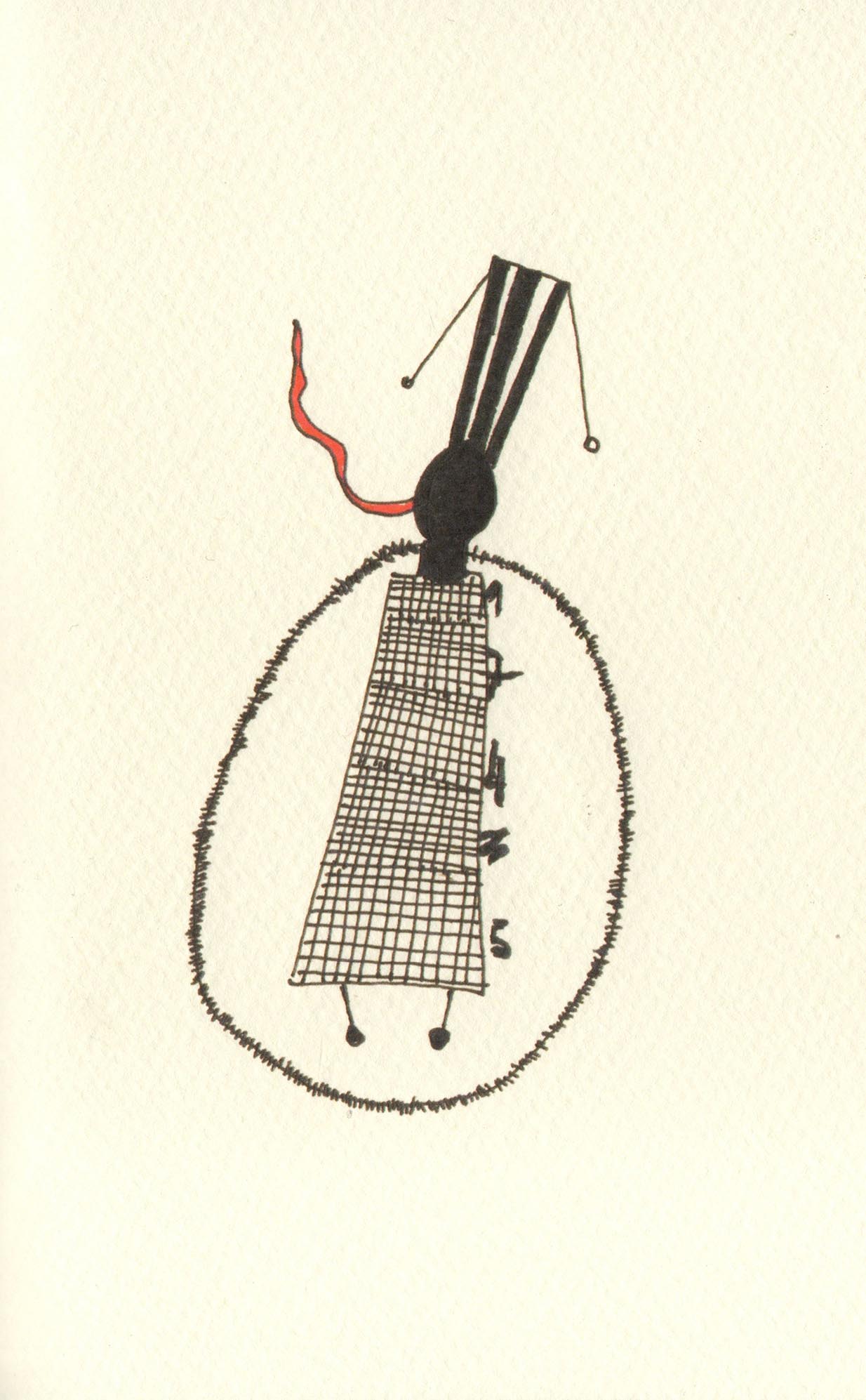
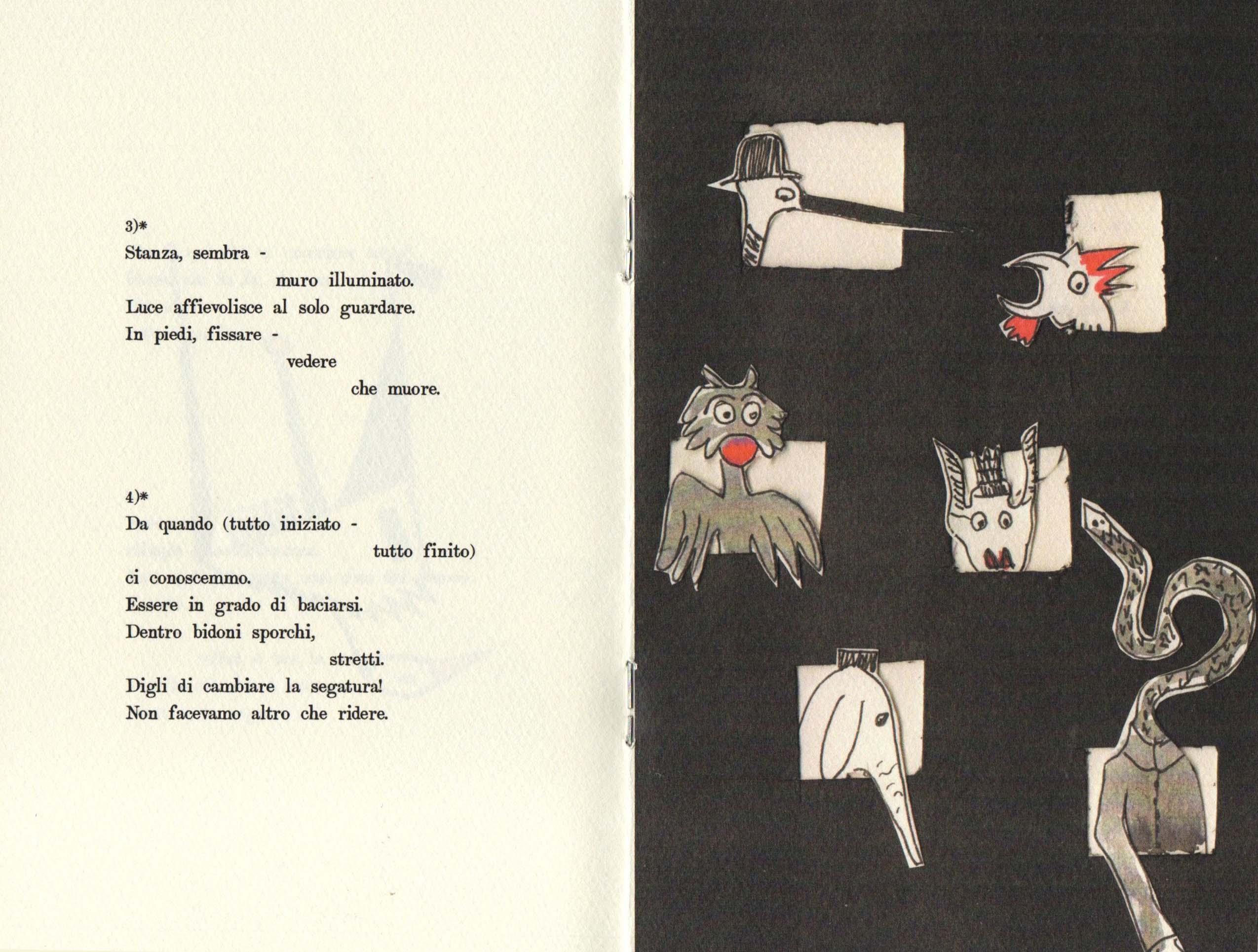
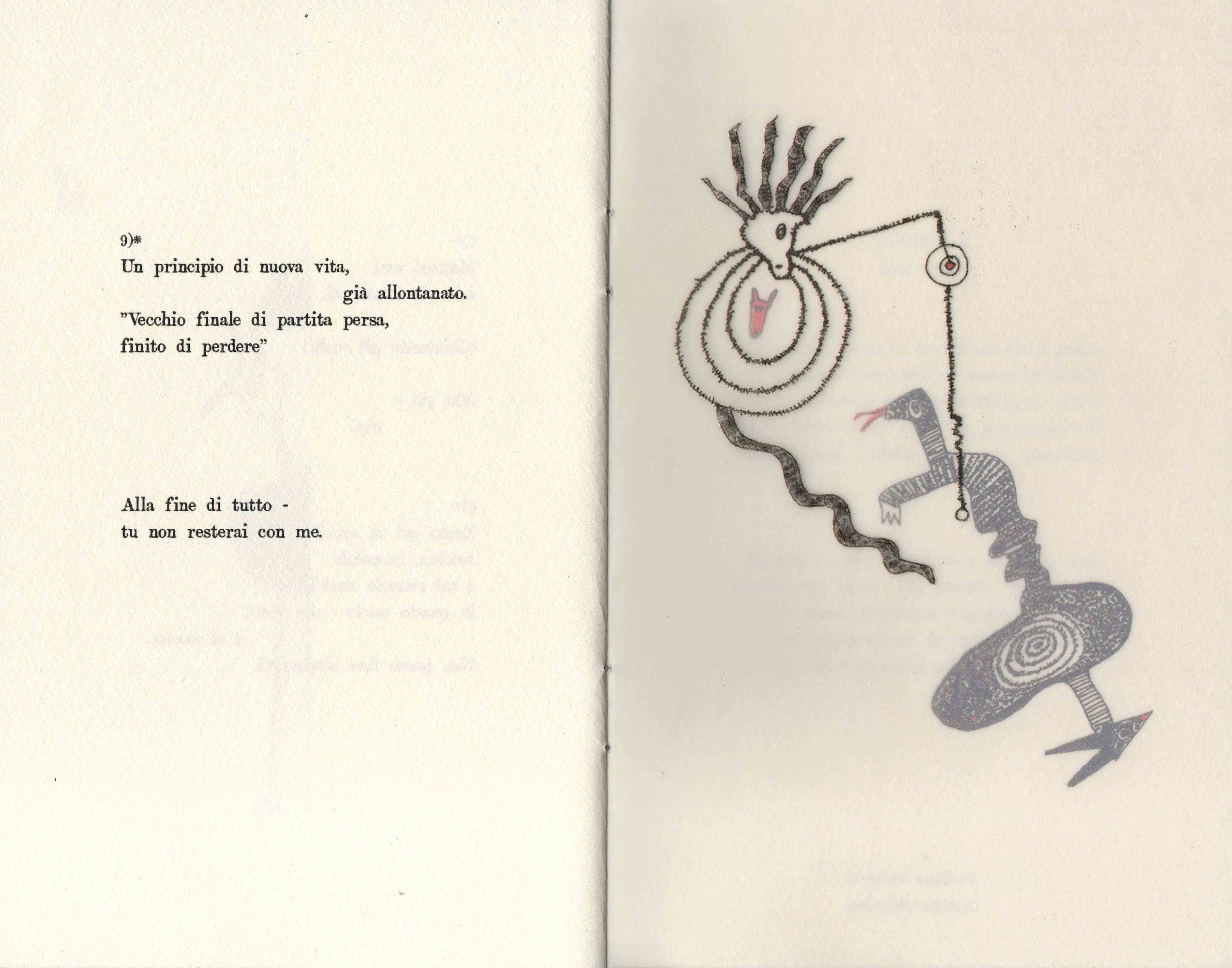


 Ezio Puglia (1982) fa parte di quella che vorrei chiamare la “scuola bolognese” del fantastico. Perché è un dato di fatto che, da un quarto di secolo a questa parte, i migliori libri sulla letteratura fantastica – e sul fantastico italiano – pubblicati in Italia siano venuti tutti da studiosi che o si sono formati a Bologna, o vi hanno lavorato per lunghi periodi, o entrambe le cose. L’elenco non è lungo, e vale la pena di compilarlo: penso ai nomi di Remo Ceserani (Il fantastico, Bologna, il Mulino, 1996), Vittorio Roda (I fantasmi della ragione. Fantastico, scienza e fantascienza nella letteratura italiana fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1996; Studi sul fantastico, Bologna, CLUEB, 2009), Ferdinando Amigoni (Fantasmi nel Novecento, Torino, Bollati Boringhieri, 2004), Angelo M. Mangini (Letteratura come anamorfosi. Teoria e prassi del fantastico nell’Italia del primo Novecento, Bologna, Bononia University Press, 2007), Luigi Weber (curatore insieme a Mangini dell’opera collettiva Il visionario, il fantastico, il meraviglioso tra Otto e Novecento, Ravenna, Allori, 2004 e poi 2006). Ho citato libri che risplendono di fulgida luce nel campo degli studi sul fantastico; alla lista viene ora ad aggiungersi Il lato oscuro delle cose. Archeologia del fantastico e dei suoi oggetti di Puglia (postfazione di Angelo M. Mangini, Modena, Mucchi, 2020, pp. 320), degno erede di quella che può essere descritta, per l’appunto, come una tradizione di studi consolidata e caratterizzata da tratti comuni – uno fra tutti, il rigore storico, teorico, metodologico.
Ezio Puglia (1982) fa parte di quella che vorrei chiamare la “scuola bolognese” del fantastico. Perché è un dato di fatto che, da un quarto di secolo a questa parte, i migliori libri sulla letteratura fantastica – e sul fantastico italiano – pubblicati in Italia siano venuti tutti da studiosi che o si sono formati a Bologna, o vi hanno lavorato per lunghi periodi, o entrambe le cose. L’elenco non è lungo, e vale la pena di compilarlo: penso ai nomi di Remo Ceserani (Il fantastico, Bologna, il Mulino, 1996), Vittorio Roda (I fantasmi della ragione. Fantastico, scienza e fantascienza nella letteratura italiana fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1996; Studi sul fantastico, Bologna, CLUEB, 2009), Ferdinando Amigoni (Fantasmi nel Novecento, Torino, Bollati Boringhieri, 2004), Angelo M. Mangini (Letteratura come anamorfosi. Teoria e prassi del fantastico nell’Italia del primo Novecento, Bologna, Bononia University Press, 2007), Luigi Weber (curatore insieme a Mangini dell’opera collettiva Il visionario, il fantastico, il meraviglioso tra Otto e Novecento, Ravenna, Allori, 2004 e poi 2006). Ho citato libri che risplendono di fulgida luce nel campo degli studi sul fantastico; alla lista viene ora ad aggiungersi Il lato oscuro delle cose. Archeologia del fantastico e dei suoi oggetti di Puglia (postfazione di Angelo M. Mangini, Modena, Mucchi, 2020, pp. 320), degno erede di quella che può essere descritta, per l’appunto, come una tradizione di studi consolidata e caratterizzata da tratti comuni – uno fra tutti, il rigore storico, teorico, metodologico. radicalmente il senso e a volte lo capovolge. Di seguito, esaminerò alcuni esempi di quanto vado affermando.
radicalmente il senso e a volte lo capovolge. Di seguito, esaminerò alcuni esempi di quanto vado affermando.
 La volontà di rimanere solidamente ancorato alla storia del fantastico otto-novecentesco induce inoltre Puglia a ridiscutere il canone del genere, al quale apporta leggere ma significative modifiche: nel campo della letteratura italiana, ad esempio, Papini si guadagna un posto di assoluto rilievo, che non molti studiosi erano stati finora disposti a riconoscergli (cfr. pp. 229-233). Una delle modifiche di cui sopra, del resto, non è tanto leggera, anzi; la torsione impressa da Puglia alle categorie precedentemente ammesse fa vacillare sul suo piedestallo nientemeno che l’autore considerato da generazioni di colleghi scrittori e poi di studiosi come il fondatore, o per lo meno il primo indiscusso maestro, del fantastico ottocentesco: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Per Puglia, Hoffmann non è fantastico: un’asserzione sorprendente, che merita qualche parola di spiegazione. Cominciamo col sottolineare che questa opinione di Puglia ne riecheggia un’altra, famosa e controversa: quella di Todorov secondo cui Edgar Allan Poe, alter ego di Hoffmann e inquilino anch’egli del cuore bifronte del canone ottocentesco, non sarebbe, in realtà, un autore fantastico. “D’une manière générale”, aveva rilevato il teorico franco-bulgaro, “on ne trouve pas dans l’œuvre de Poe de contes fantastiques, au sens strict, à l’exception peut-être des Souvenirs de M. Bedloe et du Chat noir. Ses nouvelles relèvent presque toutes de l’étrange, et quelques-unes, du merveilleux” (Tz. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, cit., p. 54). In nome della storia, Puglia capovolge intenzionalmente – e con piena ragione – l’opinione di Todorov: “Poe, un autore spinoso per tutti coloro che hanno cercato di elaborare una definizione teorica del fantastico […], al genere storico può essere aggregato senza problemi” (pp. 10-11). Ma poi, sempre in nome della storia (e però con un ragionamento che il recensore non si sente di approvare), lo stesso Puglia mette al bando, come si è detto, il grande predecessore dell’americano: “A rigore, la letteratura di Hoffmann, compresi quei testi che di solito vengono riconosciuti come l’incarnazione più pura del fantastico, non può essere inclusa all’interno del genere storico. La ragione è banale: il fantastico non esisteva ancora al tempo in cui Hoffmann scriveva quelle opere che erano destinate a diventare prototipi di una nuova tipologia narrativa” (p. 10). È, mi sembra, un bel paradosso: a forza di storicizzare, Puglia finisce con il raggiungere gli esiti aporetici di chi invece, della storia letteraria, faceva “cavalièrement litière”, almeno se sottoscriviamo le accuse che a Todorov rivolge il solito Finné (J. Finné, La littérature fantastique, cit., p. 34). Laddove Todorov, cedendo a “cet enchantement que procure la radicalité” (Tz. Todorov, Devoirs et délices. Une vie de passeur, entretiens avec C. Portevin, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 112), aveva decretato l’espulsione di Poe dal canone, il giustissimo scrupolo di Puglia per i contesti storici della letteratura spinge lo studioso italiano a staccare dal muro, nella galleria di ritratti del fantastico europeo, quello che riproduce le fattezze di Hoffmann: seguendo percorsi diversi e anzi opposti, lo strutturalista e lo storicista finiscono per convergere nell’ostracismo ai danni di uno dei due maestri unanimemente riconosciuti del secolo d’oro del fantastico. Non sarebbe più sensato – questo il parere di chi scrive – lasciare entrambi al loro posto, visto che non abbiamo argomenti davvero decisivi per rettificare il giudizio di un paio di secoli di letteratura e di critica? A chiudere il cerchio del paradosso, annoto qui che il più volte citato Finné – acerrimo fustigatore, come si è visto, di Todorov, ma da una postazione di fatto interna allo strutturalismo – aveva anticipato l’opinione di Puglia su Hoffmann, definendo quest’ultimo “le moins fantastique de tous les conteurs allemands” (J. Finné, La littérature fantastique, cit., p. 185): in altri termini, il medesimo amor di storia persuade Puglia a dissentire su Poe dallo strutturalista Todorov e, viceversa, a consentire (credo inconsapevolmente) su Hoffmann con lo strutturalista Finné; i casi strani della teoria del fantastico!
La volontà di rimanere solidamente ancorato alla storia del fantastico otto-novecentesco induce inoltre Puglia a ridiscutere il canone del genere, al quale apporta leggere ma significative modifiche: nel campo della letteratura italiana, ad esempio, Papini si guadagna un posto di assoluto rilievo, che non molti studiosi erano stati finora disposti a riconoscergli (cfr. pp. 229-233). Una delle modifiche di cui sopra, del resto, non è tanto leggera, anzi; la torsione impressa da Puglia alle categorie precedentemente ammesse fa vacillare sul suo piedestallo nientemeno che l’autore considerato da generazioni di colleghi scrittori e poi di studiosi come il fondatore, o per lo meno il primo indiscusso maestro, del fantastico ottocentesco: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Per Puglia, Hoffmann non è fantastico: un’asserzione sorprendente, che merita qualche parola di spiegazione. Cominciamo col sottolineare che questa opinione di Puglia ne riecheggia un’altra, famosa e controversa: quella di Todorov secondo cui Edgar Allan Poe, alter ego di Hoffmann e inquilino anch’egli del cuore bifronte del canone ottocentesco, non sarebbe, in realtà, un autore fantastico. “D’une manière générale”, aveva rilevato il teorico franco-bulgaro, “on ne trouve pas dans l’œuvre de Poe de contes fantastiques, au sens strict, à l’exception peut-être des Souvenirs de M. Bedloe et du Chat noir. Ses nouvelles relèvent presque toutes de l’étrange, et quelques-unes, du merveilleux” (Tz. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, cit., p. 54). In nome della storia, Puglia capovolge intenzionalmente – e con piena ragione – l’opinione di Todorov: “Poe, un autore spinoso per tutti coloro che hanno cercato di elaborare una definizione teorica del fantastico […], al genere storico può essere aggregato senza problemi” (pp. 10-11). Ma poi, sempre in nome della storia (e però con un ragionamento che il recensore non si sente di approvare), lo stesso Puglia mette al bando, come si è detto, il grande predecessore dell’americano: “A rigore, la letteratura di Hoffmann, compresi quei testi che di solito vengono riconosciuti come l’incarnazione più pura del fantastico, non può essere inclusa all’interno del genere storico. La ragione è banale: il fantastico non esisteva ancora al tempo in cui Hoffmann scriveva quelle opere che erano destinate a diventare prototipi di una nuova tipologia narrativa” (p. 10). È, mi sembra, un bel paradosso: a forza di storicizzare, Puglia finisce con il raggiungere gli esiti aporetici di chi invece, della storia letteraria, faceva “cavalièrement litière”, almeno se sottoscriviamo le accuse che a Todorov rivolge il solito Finné (J. Finné, La littérature fantastique, cit., p. 34). Laddove Todorov, cedendo a “cet enchantement que procure la radicalité” (Tz. Todorov, Devoirs et délices. Une vie de passeur, entretiens avec C. Portevin, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 112), aveva decretato l’espulsione di Poe dal canone, il giustissimo scrupolo di Puglia per i contesti storici della letteratura spinge lo studioso italiano a staccare dal muro, nella galleria di ritratti del fantastico europeo, quello che riproduce le fattezze di Hoffmann: seguendo percorsi diversi e anzi opposti, lo strutturalista e lo storicista finiscono per convergere nell’ostracismo ai danni di uno dei due maestri unanimemente riconosciuti del secolo d’oro del fantastico. Non sarebbe più sensato – questo il parere di chi scrive – lasciare entrambi al loro posto, visto che non abbiamo argomenti davvero decisivi per rettificare il giudizio di un paio di secoli di letteratura e di critica? A chiudere il cerchio del paradosso, annoto qui che il più volte citato Finné – acerrimo fustigatore, come si è visto, di Todorov, ma da una postazione di fatto interna allo strutturalismo – aveva anticipato l’opinione di Puglia su Hoffmann, definendo quest’ultimo “le moins fantastique de tous les conteurs allemands” (J. Finné, La littérature fantastique, cit., p. 185): in altri termini, il medesimo amor di storia persuade Puglia a dissentire su Poe dallo strutturalista Todorov e, viceversa, a consentire (credo inconsapevolmente) su Hoffmann con lo strutturalista Finné; i casi strani della teoria del fantastico! bbe poco opportuno chiudere questo resoconto senza accennare a un altro aspetto fondamentale e innovatore del libro di Puglia: l’attenzione agli oggetti che lo pervade in ogni pagina. Finora si sapeva, sì, che l’oggettualità del fantastico era importantissima; ma lo si sapeva quasi esclusivamente grazie al saggio di Lucio Lugnani sugli oggetti mediatori e al volume di Francesco Orlando sugli oggetti desueti: ovvero due ricerche di grande valore e due topoi assolutamente decisivi, ma per l’appunto soltanto due (cfr. rispettivamente L. Lugnani, Verità e disordine: il dispositivo dell’oggetto mediatore, in R. Ceserani et alii, La narrazione fantastica, cit., pp. 177-288, e F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, Torino, Einaudi, 1993, seconda edizione riveduta e ampliata presso lo stesso editore nel 1994). Puglia invece – pur rifuggendo dalla casistica, e avvisando il lettore che nel suo libro non si troverà nessun “elenco esaustivo delle cose auratiche e spettrali del fantastico ottocentesco” (p. 12) – ci fa discernere e apprezzare i mille volti, spesso affascinanti, delle cose descritte nei racconti e nei romanzi fantastici: oggetti inquietanti, assurdi, erotici, da collezione; feticci, reliquie, indizi, rifiuti; oggetti surreali, alieni, spettrali e auratici (secondo la bipartizione principale, abbozzata alle pp. 11-12); e via di seguito. E grazie al punto di osservazione particolare – ed estremamente fecondo – costituito dalla rappresentazione letteraria degli oggetti, getta nuova luce su molti capolavori del fantastico otto-novecentesco che ci illudevamo di conoscere a menadito.
bbe poco opportuno chiudere questo resoconto senza accennare a un altro aspetto fondamentale e innovatore del libro di Puglia: l’attenzione agli oggetti che lo pervade in ogni pagina. Finora si sapeva, sì, che l’oggettualità del fantastico era importantissima; ma lo si sapeva quasi esclusivamente grazie al saggio di Lucio Lugnani sugli oggetti mediatori e al volume di Francesco Orlando sugli oggetti desueti: ovvero due ricerche di grande valore e due topoi assolutamente decisivi, ma per l’appunto soltanto due (cfr. rispettivamente L. Lugnani, Verità e disordine: il dispositivo dell’oggetto mediatore, in R. Ceserani et alii, La narrazione fantastica, cit., pp. 177-288, e F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, Torino, Einaudi, 1993, seconda edizione riveduta e ampliata presso lo stesso editore nel 1994). Puglia invece – pur rifuggendo dalla casistica, e avvisando il lettore che nel suo libro non si troverà nessun “elenco esaustivo delle cose auratiche e spettrali del fantastico ottocentesco” (p. 12) – ci fa discernere e apprezzare i mille volti, spesso affascinanti, delle cose descritte nei racconti e nei romanzi fantastici: oggetti inquietanti, assurdi, erotici, da collezione; feticci, reliquie, indizi, rifiuti; oggetti surreali, alieni, spettrali e auratici (secondo la bipartizione principale, abbozzata alle pp. 11-12); e via di seguito. E grazie al punto di osservazione particolare – ed estremamente fecondo – costituito dalla rappresentazione letteraria degli oggetti, getta nuova luce su molti capolavori del fantastico otto-novecentesco che ci illudevamo di conoscere a menadito.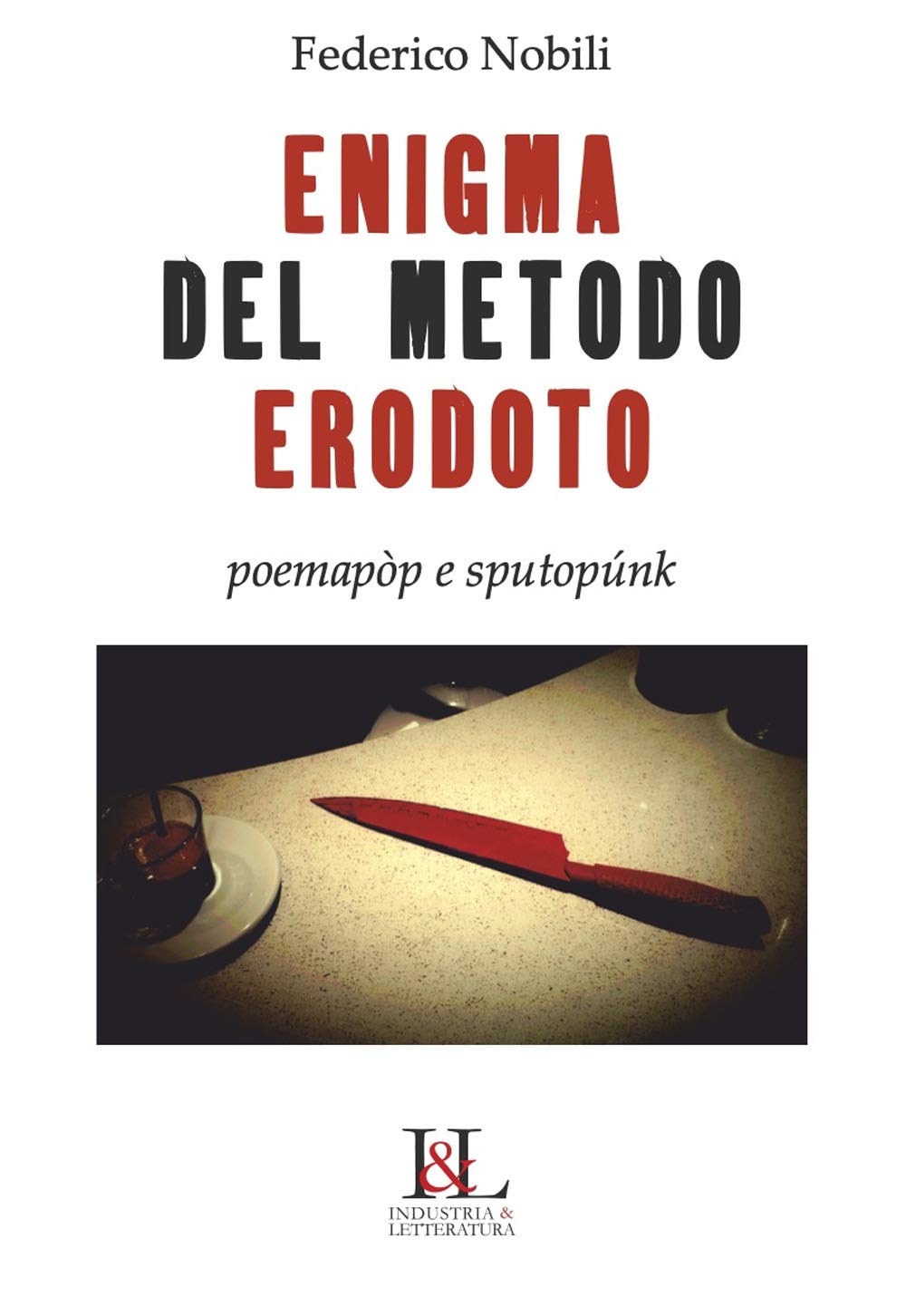
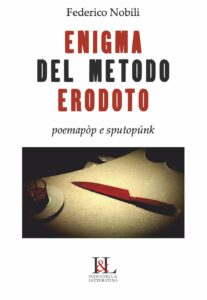 odoto
odoto
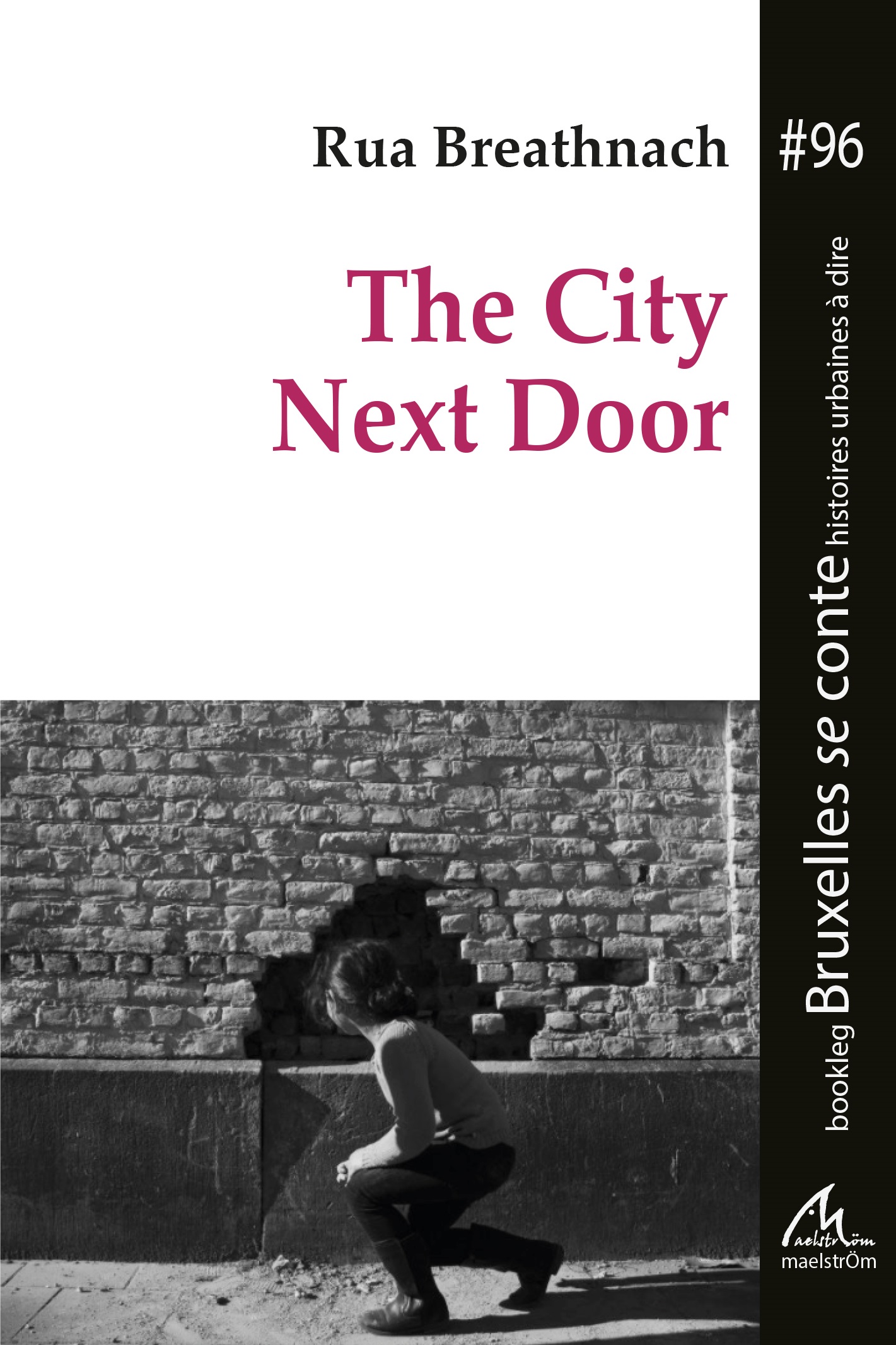
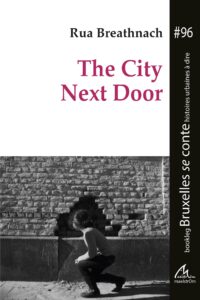 Nota dell’autore
Nota dell’autore

 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi