di Davide Orecchio
(Piccola storia per l’anno che va e per l’anno che viene)
Alberto e il signor Gilberto vivono assieme e si prendono cura l’uno dell’altro. Quando se lo ricorda, il signor Gilberto fa la spesa e cucina, paga le bollette, bada a che in casa non manchi nulla. La pensione del signor Gilberto basta appena perché i due ne possano vivere, e Alberto ricambia col suo affetto e calore. Il corpo di Alberto è caldo e accudisce più di qualsiasi coperta o cappotto. La sera, quando nel condominio i termosifoni si spengono e dalle mura umide, e sotto agli infissi negletti, entra il freddo dell’inverno, al signor Gilberto non resta che il tepore di Alberto, e nelle sue coccole sente anche il suo cuore che batte. Un cuore che batte riscalda più di qualsiasi coperta o cappotto, pensa il signor Gilberto seduto sul divano, mentre nelle sue gambe stanche torna a scorrere il sangue. Alberto lo guarda, poi chiude gli occhi. Il signor Gilberto ha bisogno di calore e riposo, perché ha ottant’anni d’età. Alberto, che sonnecchia sulle sue cosce, invece ne ha compiuti nove da poco, è nel fiore maturo della propria vita. Ma sono mai stati problemi, questi, tra un gatto e un essere umano? No, è la risposta. Gatti e uomini possono andare d’accordo a tutte le età, e Alberto e il signor Gilberto ne sono la prova.
*
In città avviene qualcosa di strano. La città è cambiata. Dal davanzale Alberto scruta la strada e la vede deserta. Nessuno cammina sui marciapiedi. Non passano né bambini né adulti degli esseri umani. Di rado, qualche automobile più veloce del solito. Il cielo è colmo di gabbiani che lo popolano anche quando cala la notte, e lo riempiono di bianco, di grigio e di strida. Alberto miagola verso il signor Gilberto, gli chiede cosa ne sappia ma l’uomo – e questo non accade mai – non gli dà retta, sta lì sul divano e sembra più stanco del solito, respira male, tossisce, si lamenta, dice che è la volta che muore, ripete che è davvero la volta che muore. Con le forze che gli restano il signor Gilberto prende il telefono per chiedere aiuto, poi si lascia cadere sul divano ansimando. Alberto si avvicina, miagola ancora, cosa può fare per lui?, gli serve calore?, vuole che salga e si accucci sulla sua pancia? Ma il signor Gilberto non gli dà retta. E questo non accade mai.
Qualcuno scardina la porta, entra in casa. Che frastuono. Che paura. Alberto si nasconde sotto al divano. Vede a malapena i piedi degli infermieri, e le ruote e le aste di alluminio della barella. Sente le loro parole, il silenzio del signor Gilberto e il suo respiro pesante. Cosa fanno? Lo portano via? Alberto, preoccupato, esce dal rifugio e trova il signor Gilberto legato sopra al lettino, una maschera di gomma sul naso e la bocca. Gli infermieri, protetti dalla testa ai piedi con caschi, tute e visiere, spingono fuori il signor Gilberto e Alberto li segue. Gli infermieri chiudono la porta di casa e scendono le scale, per fortuna solo mezza rampa, e Alberto li segue. Gli infermieri caricano il signor Gilberto sull’ambulanza e partono con la sirena. Alberto corre dietro al signor Gilberto. Vuole sapere dove lo portano. Vuole andarci anche lui. Alberto è un gatto sano e forte, nel fiore maturo degli anni, va veloce sulla strada deserta, schiva tombini e pneumatici. L’ambulanza frena, curva, svolta, va di qua e va di là, e Alberto la segue, non la perde di vista. Ma, quando raggiunge una strada più grande, rettilinea e interminabile, l’ambulanza accelera, si fa più lontana e più piccola finché Alberto non la vede più e, esausto, si ferma con la lingua di fuori. Addio signor Gilberto. Anzi arrivederci. Non smetterò di cercarti.
Ma qui cosa succede? Perché non c’è nessuno? E dove mi trovo? Non ero mai arrivato così lontano, in un posto così largo e pauroso. Qui è troppo aperto e non ci si può nascondere. Qui non va bene per niente.

Alberto vaga per la città. Sale e scende dai marciapiedi. Si acquatta sotto le auto. Non sa più dove stia andando. Non sa se debba proseguire o tornare. Ma non saprebbe tornare, perché ha perso la strada di casa. Si ritrova in una piazza troppo grande per le sue abitudini. Al centro, gli angeli di pietra di una fontana gettano acqua dalle bocche e dai nasi, e sorridono eternamente. Sui loro capi, sulle ali e sulle braccia riposano decine di gabbiani reali. Anche sui bordi della fontana, al di qua della vasca dove brulica l’acqua, riposano decine di altri gabbiani. Alberto li osserva e riflette. Forse non stanno riposando. Forse controllano. Forse aspettano prede. Decine e decine di gabbiani in silenzio. Alberto, che non può tornare indietro perché ha perso la strada di casa, può solo avanzare e decide di farlo. Pensa che, nero com’è, nel buio i gabbiani non lo vedranno.
Inizia a attraversare la piazza, piega le gambe e con la pancia sfiora l’asfalto. Com’è bravo. Com’è scaltro e elegante. Ma è difficile battere i gabbiani in scaltrezza. I gabbiani non si distraggono da te. I gabbiani ti vedono sempre. Alberto è arrivato solo a metà del suo attraversare e quelli sono già in volo e stridono, decine di gabbiani, tutti contro di lui, tutti verso di lui. Alberto, che è un gatto forte, nel fiore dei suoi anni maturi, fugge e scantona, si volta sulla schiena e soffia ai gabbiani. Più veloce del tuono o del fulmine, Alberto estrae le unghie e graffia i gabbiani che gli picchiano addosso. Ancora scappa sotto alle auto e fra la spazzatura. Salta su dalle buste, combatte i gabbiani, geme versi terribili. Alberto è diventato un guerriero, lotta per la propria vita. I gabbiani, però, sono troppi. Decine di gabbiani affamati. Lo circondano in volo. Scendono, risalgono, non gli danno tregua. Alberto ora è stanco. Non può difendersi da tanti gabbiani. Tra poco uno di loro lo trafiggerà e sarà tutto finito. Signor Gilberto, era addio e non arrivederci, non ce l’ho fatta a trovarti. Mi dispiace, signor Gilberto. Spero che tu guarisca e stia bene. Adesso mi arrendo. Adesso io chiudo gli occhi e…
Chi urla così forte? A chi appartiene questo grido di guerra? A una creatura grande, dagli occhi gialli. Abbaia e tuona. Si scaglia contro i gabbiani. Li attacca, ne morde uno e poi un altro. Li mette in fuga. I gabbiani si alzano da terra impauriti. È un cane alto e terribile. Ha salvato Alberto e lo guarda. Presto, seguimi in quel vicolo, per un po’ gli uccelli ci lasciano in pace, ma solo per poco. E Alberto lo segue.
La viuzza dove si rifugiano è un culo di sacco. Termina in una parete di mattoni alta. Da qui non si esce che per una strada, il ritorno alla piazza dove i gabbiani hanno il covo.
Riposiamo un momento. Ritardiamo la guerra. Tu, cane, io ti ringrazio, ma chi sei?
Io, gatto, sono il più coraggioso, il più forte cane corso della città. Io sono Antonio. Ti sei perso? Non ti ho mai visto quaggiù.
Mi sono perso e non so più tornare né proseguire. Correvo dietro al signor Gilberto, mio essere umano, che s’è improvvisamente ammalato, non respirava più bene, l’hanno portato via ma non so dove ed eccomi qui.
Da qualche tempo gli esseri umani si ammalano tutti. Anche il mio si è ammalato. Anche l’essere umano di Lisa si è ammalato e lei ora lo cerca.
Lisa chi è?
Sono io, Lisa.
Dalla costa di un bidone affiora un muso bianco. Nel buio del vicolo. Una gatta bianca, priva di macchie. Avanza timida, poi con poco più di certezza. Ha il pelo umido della propria lingua. Si è leccata ferite finora? Anche lei preda dei gabbiani e colpita? Lisa guarda Alberto negli occhi. Nessuno dei due, creature smarrite, dimenticherà mai questi sguardi.
Lei anche l’ho salvata dai gabbiani, rievoca Antonio, oggi non salvo che gatti, un paladino, questo sono diventato, cos’altro aggiungere?
Ti ascoltavo, dice Lisa a Alberto, hai perso il tuo essere umano e io, come te, ho perso la signora Bianca, mio essere umano. L’hanno portata via, respirava poco e dolorosamente, li ho seguiti finché ho potuto e poi li ho persi sulla strada grande, qualcuno sa dove portano gli esseri umani ammalati?
Antonio lo sa. Il posto si chiama ospedale. L’essere umano di Antonio l’hanno portato laggiù e Antonio li ha seguiti sino alla fine. Antonio ha visto dove tengono gli esseri umani e mostra il percorso ai due gatti: la strada grande, il fiume, un ponte da varcare e si è arrivati, ma bisogna passare per la piazza dove i gabbiani hanno il covo, non c’è alternativa. Davvero vogliono andare e rischiare la morte? Non preferiscono restare qui nel rifugio e aspettare che i gabbiani volino via?
No, rispondono Alberto e Lisa, non vogliamo restare, vogliamo ritrovare i nostri compagni di vita.
Perché si ammalano tutti, gli esseri umani?, chiede Lisa e Antonio china la testa, proprio non lo so, un giorno stanno bene e il giorno dopo crollano esausti, è un grande mistero. Alberto, nel ricordare la tosse del signor Gilberto, ripete col cane corso che sì, la malattia degli esseri umani è un grande mistero.
Ora Antonio spiega che dovranno correre forte dentro e oltre la piazza, Lisa al suo fianco destro e Alberto a sinistra. Al di là della piazza troveranno il ponte e salvezza, perché laggiù vive una tribù folta di corvi e i gabbiani non vi si avventurano. Siete pronti?, al mio via?, e i gatti annuiscono. Antonio si dà lo slancio piegando le zampe posteriori e flettendo quelle davanti, spalanca gli occhi gialli verso la piazza e la guarda con odio. I gabbiani riposano sulla fontana, macchie grigie e bianche che sporcano il buio. Il cane dice adesso e si lancia. Lisa e Alberto lo seguono subito. Occhi gialli e occhi verdi contro i gabbiani. Occhi risoluti, musi come frecce e trabucchi. Sboccano nella piazza, il cane e i due gatti, con la forza che non ha retroguardia né ritirata. I gabbiani li avvistano, si sollevano in coro, urlano in coro. Quante strida. Che affronto. Mammiferi insulsi. Dove correte? Volete la guerra? E guerra sia. Si precipitano su di loro alla pesca. Vogliono sangue, carne, ossa da spolpare, bulbi da succhiare. Versi assordanti. Decine di gabbiani, assordanti e proietti. Loro, un cane e due gatti, corrono fissando gli uccelli che scendono, uno abbaia e due soffiano. Un gabbiano plana verso Lisa, prova a ghermirla ma la gatta gli graffia l’addome, e quello urla e si ferma. Due gabbiani sigillano i becchi per trafiggere Lisa, ma Antonio li prende entrambi in due morsi, spezza il collo del primo, sbrana un’ala al secondo e lo getta per terra. Alberto salta verso un gabbiano, salta più di due metri, con le unghie stacca un occhio al nemico. Antonio li esorta, correte!, resistete!, adesso non fermatevi più!, e loro veloci saettano al di là della piazza, e raggiungono l’imbocco del ponte, sopra di loro i gabbiani reali, decine di gabbiani arrabbiati e affamati, una coperta di piume e di becchi che cade dal cielo.
Ma l’occasione dei gabbiani è perduta. Qui, dove il ponte inizia, ci sono già i corvi. Centinaia di corvi appollaiati sulle ringhiere e sui cavi, sui lampioni e sui parapetti. Non hanno bisogno di scomodarsi nel volo, alla guerra. Si volgono ai gabbiani e li fissano, se possedessero sorrisi di scherno li esprimerebbero, già il loro silenzio è una beffa e ha deterrenza, non occorre lo sforzo di un solo gracchiare. I gabbiani al contrario urlano versi violenti e sconfitti, si fermano prima del ponte, lasciano che trascorra un minuto, il tempo dell’odio e dell’appuntamento, ci rivedremo, torneremo a combattere, poi volano indietro alla piazza.
Il cane e i due gatti varcano il ponte. Nella condiscendenza dei corvi che restano fermi. Adesso il loro silenzio è forse un rispetto. Il cane corso fa strada, un passo indietro i due gatti, la bianca a destra e il nero a sinistra. Sotto scorre un fiume deserto e noioso quanto la città. Nessun battello lo solca. Nessuna luce gioca sui riflessi dell’acqua. Antonio, con Alberto e Lisa al suo fianco, raggiunge la sponda di là, attraversa una strada e poi un’altra, poi un’altra ancora tra palazzi che non irradiano luci, dove non vive nessuno, ed ecco che ne appare uno luminosissimo invece, indaffarato di ambulanze che entrano ed escono, ed è l’ospedale, e Antonio fa cenno ai due di seguirlo, sa come entrare senza che nessuno li veda.
Attraversano corridoi e sotterranei, salgono lungo rampe di scale. Entrano in un reparto pieno di luce. Camminano. Nella luce. Non sono invisibili. Un cane corso e due gatti. Ma nessun essere umano si accorge di loro.
Questo è un altro mistero, osserva Alberto, dovrebbero vederci ma non ci vedono.
Hanno molto da fare, risponde Antonio, qui è dove curano la malattia nuova, forse non hanno occhi né tempo per noi. Ora salite sulla mia schiena e affacciatevi su questa parete di vetro. Se il signor Gilberto e la signora Bianca sono qui, li vedrete.
Tu, chiede Lisa, resti sotto?, non cerchi il tuo essere umano?
Il mio essere umano non è più qui e non è a casa, non so dove l’hanno portato, risponde Antonio e si piega.
Alberto e Lisa salgono sulla schiena del cane, si alzano sulle due zampe, appoggiano le altre due contro il vetro, avvicinano i musi e scrutano dentro. C’è una corsia di esseri umani nei letti. Indossano scafandri di plastica trafitti da tubi. Sembrano tristi, però sono vivi.
Ora Lisa grida, ecco lì la signora Bianca!, e Bianca dal suo letto la vede, una gatta bianca eretta sui piedi, i polpastrelli schiacciati sul vetro, gli occhi sgranati che non si chiudono mai. Dopo lo stupore, la signora Bianca alza un braccio per salutare la gatta e sorride.
Ora Alberto grida, ecco laggiù il signor Gilberto!, ma il signor Gilberto non può vederlo perché ha gli occhi chiusi e riposa, sembra sereno, pensa Alberto, sembra che si stia riprendendo, non tossisce e non si lamenta, coraggio signor Gilberto, io sono qui, ti ho ritrovato, non ti abbandonerò mai.
Le ore passano e viene la notte, quando suonano le campane e qualche botto detona. Forse un anno umano è finito, forse ne inizia uno nuovo. Ma ai due gatti, ritti sul dorso di Antonio, non interessa granché. Il loro calendario non è il calendario degli uomini. Lisa e Alberto non hanno fretta, non hanno pazienza, non hanno speranza né nostalgia. Ma non si levano dalla parete di vetro. È valsa la pena di correre fuori, rischiare la vita e fare la guerra. Sulla schiena del cane, i due gatti vegliano i signori Bianca e Gilberto finché saranno guariti.
Presto torniamo a casa.
Ma non torniamo senza di voi.
Immagine di copertina di kropekk_pl da Pixabay


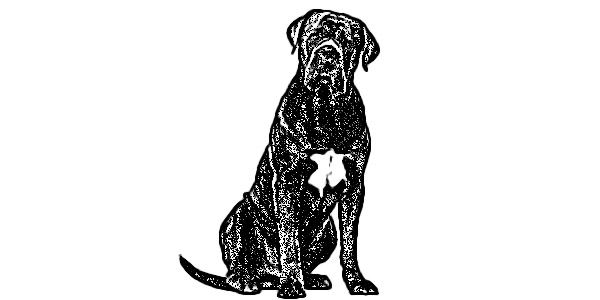
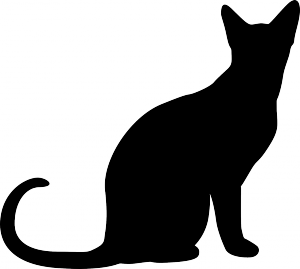
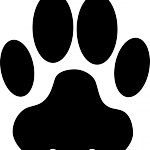
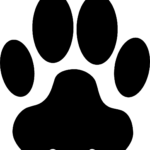

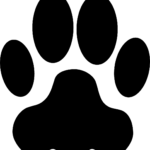


 di
di Roland Barthes vi ha dedicato un saggio molto interessante nei suoi Essais critiques, formulando alcune possibili risposte a quella strana curiosità morbosa che ci spinge ad attardarci sulle pagine di cronaca come quando si rallenta in autostrada davanti a una scena d’incidente. Scrive Barthes:
Roland Barthes vi ha dedicato un saggio molto interessante nei suoi Essais critiques, formulando alcune possibili risposte a quella strana curiosità morbosa che ci spinge ad attardarci sulle pagine di cronaca come quando si rallenta in autostrada davanti a una scena d’incidente. Scrive Barthes: A differenza delle intercettazioni, articoli di giornale, dichiarazioni, sentenze, la parte del leone, seppure da tastiera, nella ricerca delle fonti, qui la giocano gli sms, i thread su facebook, tutto quel materiale immateriale che definisce oggi quello che siamo e soprattutto quello che non vorremmo essere. Ecco che il motore di tutto il libro, la ricerca della verità di una vicenda che sfugge al nesso di causalità centrale in un delitto, ovvero il suo movente, gira a vuoto creando un rumore di fondo assordante. Ripercorrendo le pagine di una narrazione sapientemente costruita, nella successione di coro e protagonisti di quella triste vicenda ho ripensato a un altro efferato delitto, quello di Marta Russo del 1997, di fatto rimasto sospeso alle imprecise sentenze, noto alle cronache come
A differenza delle intercettazioni, articoli di giornale, dichiarazioni, sentenze, la parte del leone, seppure da tastiera, nella ricerca delle fonti, qui la giocano gli sms, i thread su facebook, tutto quel materiale immateriale che definisce oggi quello che siamo e soprattutto quello che non vorremmo essere. Ecco che il motore di tutto il libro, la ricerca della verità di una vicenda che sfugge al nesso di causalità centrale in un delitto, ovvero il suo movente, gira a vuoto creando un rumore di fondo assordante. Ripercorrendo le pagine di una narrazione sapientemente costruita, nella successione di coro e protagonisti di quella triste vicenda ho ripensato a un altro efferato delitto, quello di Marta Russo del 1997, di fatto rimasto sospeso alle imprecise sentenze, noto alle cronache come 



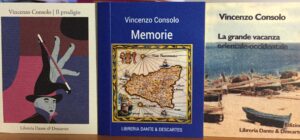




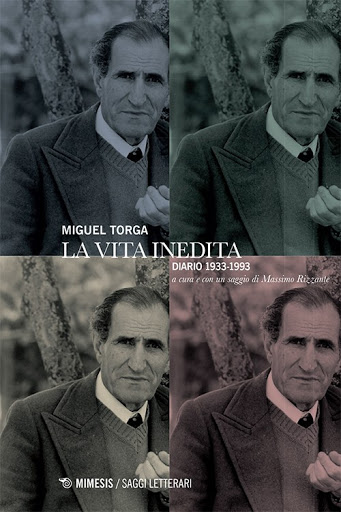

 Il libro di Bruno Vespa e la “mucca sacra” dal latte avvelenato
Il libro di Bruno Vespa e la “mucca sacra” dal latte avvelenato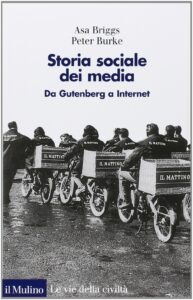 Negli ultimi decenni, gli studi sulla storia dell’editoria e della comunicazione hanno contribuito a complicare lo scenario, aiutandoci a comprendere come la fruizione degli scritti a stampa non debba essere necessariamente considerata come un fattore di emancipazione sociale, tanto nel passato quanto nel presente. Limitandoci all’analisi dello scenario europeo, siamo oggi in grado di osservare che la svolta tecnologica inaugurata da Gutenberg ebbe effetti discontinui e contradditori. La possibilità di riprodurre e diffondere in serie i testi contribuì, infatti, ad abbattere drasticamente i costi e coinvolgere una schiera di lettori molto più ampia. Ne conseguì un potenziamento del comune senso critico e una più intensa partecipazione ai dibattitti intorno a eventi sensazionali o a fenomeni di pubblico interesse, che in alcuni periodi si manifestò in maniera intermittente e in altri in maniera più costante (sul tema si veda il libro di Peter Burke e Asa Briggs, Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet, Il Mulino). Tuttavia, quella stessa capacità di penetrare in maniera ramificata il corpo sociale riuscì anche a stimolare nuove forme di adeguamento ai dettami delle autorità secolari o ecclesiastiche, dei potentati nobiliari, o degli interessi economici dei ceti dominanti. La stampa aveva quindi i suoi padroni e – seguendo le esigenze dei committenti o le logiche del profitto – riusciva anche a diventare una potente catalizzatrice di conformismo: in altre parole, suggeriva alle persone come comportarsi, cosa pensare, cosa comprare, di cosa fidarsi, di cosa aver paura (su questo versante, sono utili le considerazioni di Mario Infelise, I padroni dei libri, Laterza, e Sandro Landi, Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna, Il Mulino).
Negli ultimi decenni, gli studi sulla storia dell’editoria e della comunicazione hanno contribuito a complicare lo scenario, aiutandoci a comprendere come la fruizione degli scritti a stampa non debba essere necessariamente considerata come un fattore di emancipazione sociale, tanto nel passato quanto nel presente. Limitandoci all’analisi dello scenario europeo, siamo oggi in grado di osservare che la svolta tecnologica inaugurata da Gutenberg ebbe effetti discontinui e contradditori. La possibilità di riprodurre e diffondere in serie i testi contribuì, infatti, ad abbattere drasticamente i costi e coinvolgere una schiera di lettori molto più ampia. Ne conseguì un potenziamento del comune senso critico e una più intensa partecipazione ai dibattitti intorno a eventi sensazionali o a fenomeni di pubblico interesse, che in alcuni periodi si manifestò in maniera intermittente e in altri in maniera più costante (sul tema si veda il libro di Peter Burke e Asa Briggs, Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet, Il Mulino). Tuttavia, quella stessa capacità di penetrare in maniera ramificata il corpo sociale riuscì anche a stimolare nuove forme di adeguamento ai dettami delle autorità secolari o ecclesiastiche, dei potentati nobiliari, o degli interessi economici dei ceti dominanti. La stampa aveva quindi i suoi padroni e – seguendo le esigenze dei committenti o le logiche del profitto – riusciva anche a diventare una potente catalizzatrice di conformismo: in altre parole, suggeriva alle persone come comportarsi, cosa pensare, cosa comprare, di cosa fidarsi, di cosa aver paura (su questo versante, sono utili le considerazioni di Mario Infelise, I padroni dei libri, Laterza, e Sandro Landi, Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna, Il Mulino).








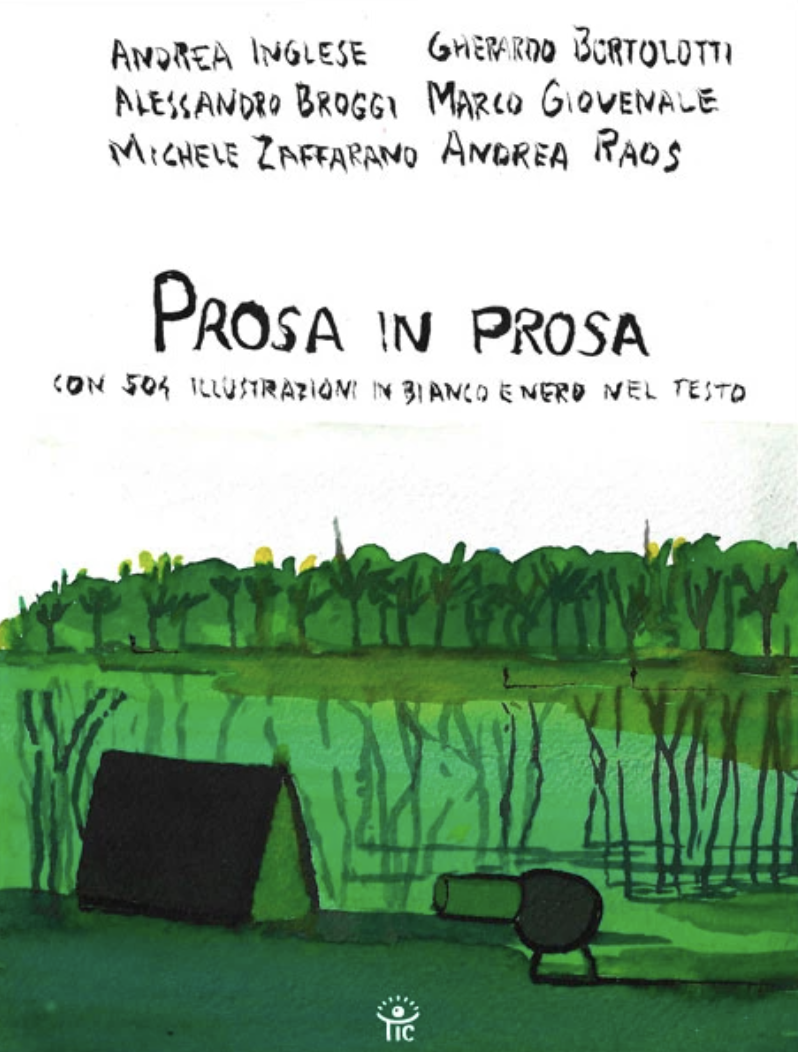


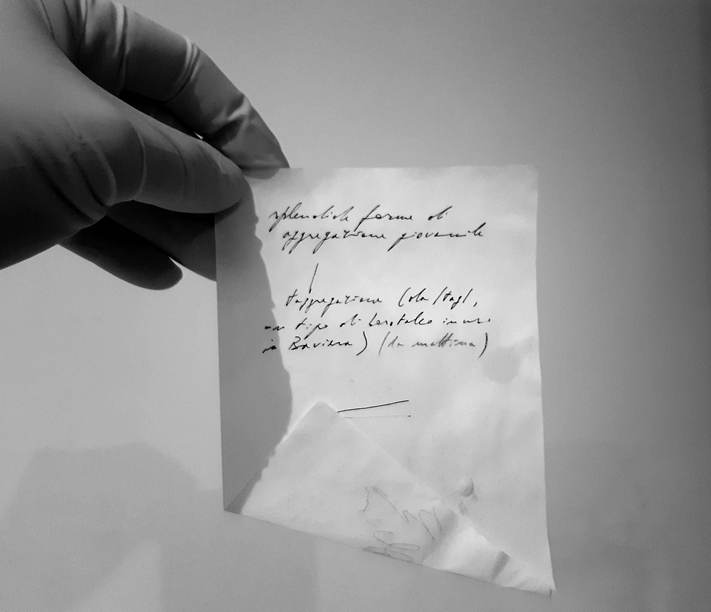

 C’è una scena dell’Amleto di Laforgue che mi viene sempre in mente quando si tratta di definire che cosa sia per me «poesia». Amleto si rivolge a Orazio, l’amico assoluto, e lo prega di precederlo, per dire in sua vece, entrando, quelle parole «che lo uccidono».
C’è una scena dell’Amleto di Laforgue che mi viene sempre in mente quando si tratta di definire che cosa sia per me «poesia». Amleto si rivolge a Orazio, l’amico assoluto, e lo prega di precederlo, per dire in sua vece, entrando, quelle parole «che lo uccidono».


 Fine del gioco
Fine del gioco








