Una conversazione con Christian Raimo
a cura di Adriano Ercolani

La casa editrice Euridice si è presentata al mondo editoriale con un catalogo di tutto rispetto: nata durante il lockdown, sotto la direzione di Laura Ceccacci, si pone come intento il “lavoro di repêchage di classici più o meno dimenticati, di idee che non hanno raggiunto il grande pubblico, di autori poco letti, poco valorizzati, o fraintesi, ripresentati attraverso un linguaggio editoriale nuovo ed espressivo”, finora in formato esclusivamente digitale.
Uno dei titoli più interessanti finora pubblicati è un’antologia di scritti di Antonio Gramsci, intitolata Il metodo della libertà. Scritti sulla democrazia, il fascismo, la rivoluzione.
Si tratta di testi scritti durante gli anni dell’avvento del fascismo, dalla fine della prima guerra mondiale fino a prima della sua carcerazione del 1927.
I temi trattati, con la notoria lucidità, dal pensatore sardo, spaziano dal riformismo borghese al colonialismo, dalla critica al giolittismo all’analisi del sovversivismo reazionario, dalla lotta agraria alle origini del governo mussoliniano, dalla questione sarda alle società segrete.
Oltre a essere un formidabile strumento di analisi delle origini del Fascismo, molte delle riflessioni presenti in questi scritti rivelano una innegabile, e inquietante, attualità.
Come scrive Christian Raimo nella prefazione: “Il grande problema della ricezione pubblica di Gramsci è che non è solo un testimone, ma è soprattutto un interprete e la sua rilevanza dal punto di vista dell’elaborazione teorica sovrasta persino la sua estrema testimonianza esistenziale”.
Molto interessante è la postfazione di Guido Liguori, Gramsci: gli anni della libertà, che ricostruisce con precisione le vicende esistenziali e intellettuali del pensatore, sgombrando il campo da ingannevoli manipolazioni recenti, soprattutto sottolineando la “lotta contro il fascismo, che il comunista e marxista sardo avrebbe combattuto con lo studio e la forza delle idee, scrivendo i Quaderni del carcere, grazie ai quali è oggi il saggista italiano più conosciuto, studiato, tradotto nel mondo dai tempi di Machiavelli.”.
Con un paradosso tipicamente nostrano, il saggista italiano più studiato nel mondo in Italia non è nemmeno inserito nel canone scolastico.
Anche da questo nasce l’esigenza di questa riproposta editoriale.
Ne abbiamo parlato con il curatore Christian Raimo.
Qual è stato il criterio di selezione degli scritti?
L’origine è un’antologia di scritti gramsciani pubblicata da Editori Riuniti, negli anni’70, che si chiamava Sul Fascismo, una selezione di interventi sia precedenti che successivi all’arresto da parte del regime, curata da Ezio Santarelli.
Ho sempre pensato che quel libro mancasse nel dibattito attuale su Gramsci in Italia, considerata anche la recente cooptazione del suo pensiero da parte rossobruna.
Andando a rivedere il volume, ho pensato che, di quella selezione originale, fosse più interessante ripubblicare i saggi precedenti all’affermazione del regime, ovvero quelli pubblicati fino all’inizio degli anni ’20.
Questo proprio perché credo sia interessante capire quale fosse il clima in quel preciso momento, quando il Fascismo ancora non aveva individuato in Gramsci un suo nemico, dunque c’era anche da parte sua una differente fluidità nella riflessione.
Il titolo, Il metodo della libertà, è proprio un’espressione gramsciana, lo abbiamo scelto poiché non si tratta solo di scritti sul Fascismo, ma anche sulla Rivoluzione bolscevica e, più in generale, sulla lotta di classe.
Al di là dell’urgente necessità di strappare Gramsci alle grossolane forzature della propaganda rossobruna, è innegabile la validità delle sue riflessioni per interpretare dinamiche contemporanee. Penso a frasi come l’”angusto di terrore e vendetta che caratterizza la borghesia attuale”, il “sentimento di paura folle” che ne anima la propaganda, i nazionalisti visti come “riformatori della borghesia”…
In questo senso, è molto interessante un brano su Il problema di Milano, sulla borghesia bottegaia e reazionaria di una città all’avanguardia solo dal punto di vista industriale.
Certo, dobbiamo renderci conto che Gramsci va storicizzato, quindi va letto nel contesto dei suoi anni. Non vogliamo certo un farne un guru profetico.
Però, allo stesso modo è errato contestualizzarlo per poi porlo in una prospettiva rossobruna, è davvero fargli un grave torto.
Non mi definisco uno studioso ma un lettore, informato e appassionato, di Gramsci.
Per questo motivo ho voluto che un esperto come Guido Liguori scrivesse una postfazione, proprio per fare pulizia di tutte le incrostazioni che negli anni si sono accumulate sul suo pensiero.
Mentre la mia prefazione è un invito a leggere Gramsci come autore popolare, da inserire nel canone scolastico, il testo di Liguori entra in maniera molto diretta nel dibattito attuale.
Il suo contributo inserisce con chiarezza questa edizione nel contesto dell’attuale “Gramsci Renaissance”.
Negli ultimi anni, infatti, Gramsci è tornato ad essere un pensatore centrale in varie tradizioni disciplinari: dagli studi letterari a quelli politici, da quelli storici a quelli pedagogici.
Questo da un lato rivela la sua importanza come interprete dei suoi anni, ma d’altra parte non bisogna dimenticare il suo ruolo di testimone: la difesa delle sue idee e quello che, di fatto, è stato il suo martirio lo rendono uno dei più cristallini testimoni della stagione antifascista.
Per questo, fare proprio del suo pensiero una lettura a proprio uso e consumo è profondamente scorretto.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un goffo tentativo di demarxistizzazione di Gramsci, come se fosse un generico pensatore antiliberista e non un martire dell’antifascismo.
Questo è infamante.
Il paradosso è proprio vedere un martire dell’antifascismo, che in anticipo aveva previsto le dinamiche perverse del regime, essere usato come grimaldello dialettico da gente che scrive su blog “sovranisti”. Ogni riferimento a Diego Fusaro su Il Primato Nazionale è puramente voluto.
Ma infatti questo tentativo a Fusaro non è riuscito. L’operazione tentata nei suoi libri, che nelle ricostruzioni storiche hanno anche parti dignitose, di sottrarre Gramsci alla sua storia e alla sua interpretazione del marxismo è fallimentare.
D’altra parte, negare la forza della sua testimonianza antifascista è infamia.
Su quello non c’è campo di discussione, ma solo di battaglia.
Da anni è in atto quest’opera di appropriazione di icone della Sinistra storica da parte dell’Estrema Destra. A volte si tratta di fraintendimenti, a volte di forzature, a volte proprio di volgari provocazioni.
Per questo, penso ci sia bisogno di ritornare a leggere Gramsci come autore popolare, non quello in voga ultimamente, quello di “Odio gli indifferenti” e “Odio il Capodanno”, che è certo utile ma viene ridotto a un uso da maglietta.
Anni fa, ad esempio, Einaudi fece una serie di pubblicazioni antologiche in formato tascabile molto accurate e interessanti.
La nostra edizione mette nuovamente a disposizione dei testi importanti, anche se non semplici.
Sebbene Gramsci scrivesse molto bene, si tratta sempre di articoli scritti cento anni fa.
Eppure, ciò non costituisce un ostacolo alla lettura, infatti non abbiamo predisposto delle note critiche o esplicative.
Abbiamo affidato al lettore interessato il compito di ricostruire, facilmente, i passaggi e le coordinate storiche.
I due paratesti che corredano l’antologia, come detto, indicano la centralità dell’autore e la necessità di inserirlo nel canone scolastico.
Nonostante sia uno dei più importanti filosofi italiani, nei licei viene dedicato solo qualche minuto a Gramsci. Si tratta di proporre anche una riflessione anche sui parametri stessi del canone: pensiamo a un autore come Rosmini, negli anni precedenti molto presente nei programmi scolastici, e poi improvvisamente scomparso.
Gramsci è, di fatto, l’unico pensatore italiano del Novecento che ha una caratura internazionale.
Non è possibile andare all’università e incontrare, in qualsiasi disciplina umanistica, le categorie da lui coniate per la prima volta.
Categorie come quella di “egemonia”, il concetto di “nazionalpopolare”, la distinzione tra “riformisti” e “rivoluzionari” sono imprenscindibili quanto quelle coniate da Freud o Dewey.
Lo studio di Gramsci non può essere un’opzione.
Si può benissimo non essere un militante di sinistra, ma non si può prescindere dall’idea gramsciana di “egemonia”, ad esempio.
Non ci si può iscrivere all’università senza sapere queste cose.
Parlando di “egemonia culturale”, pare evidente che a sinistra si siano scordati cosa sia.
Secondo te è stata una miope assenza di strategia delle forze di sinistra o, al contrario, è stata più astuta e lungimirante l’Estrema Destra nel comprendere, ad esempio, le immense potenzialità della propaganda sui social network?
Credo che i social network siano un elemento che entra in gioco solo in un secondo momento.
Mi spiego.
Il cambio di paradigma nel contesto culturale è dato dal velenosissimo combinato disposto tra il disinvestimento decennale su scuola e università e l’operazione parallela sulla televisione pubblica, che ha lasciato completamente il campo all’ascesa di quella commerciale.
Per vent’anni l’educazione di massa è avvenuta attraverso una telelvisione spesso sciattissima, assurdamente antipedagogica.
In questo senso, è avvenuto un travaso di tempo: le ore che uno poteva immaginare in un contesto di accesso alla conoscenza, sotto varie forme (l’ascolto di un disco, la lettura di un libro, la frequentazione di un centro giovanile o di una biblioteca popolare) sono state passate davanti alla televisione.
I social network ricevono e sfruttano un contesto di consocenza che in Italia è stato preparato da vent’anni d’educazione televisiva.
Quindi, dopo venti anni di Uomini e Donne non si è più in grado di comprendere che il meme con le dichiarazioni antiitaliane di Laura Boldrini o Samuel L.. Jackson come immigrato che fa la bella vita sono evidenti menzogne, poiché si sono smarriti gli strumenti critici.
Quello è un aspetto importante ma è altrettanto importante notare che per venti anni almeno l’italiano medio per informarsi si politica si è rivolto alla televisione.
I social network, nella maggior parte dei casi, non producono conteuti ma veicolano e rilanciano contenuti mainstream prodotti in tv.
I meme che vediamo sono spesso estratti da trasmissione televisive, gli argomenti sono imposti dalla tv.
Un contenuto per divenire virale sui social network deve passare per la televisione.
Senza dubbio, ora sta cambiando qualcosa.
Cè una prima generazione di persone che non vedono la tv (magari ne fruiscono in altro modo, tramite YouTube) e quindi ne subiscono meno l’influenza.
Però è la prima generazione, siamo all’inizio del cambiamento.
La stragrande maggioranza degli italiani si informa ancora tramite la tv.
Anche qui, come vedi, serve l’intelligenza di Gramsci per comprendere profondamente cosa significa “nazionalpopolare”.





 di Francesca Caraceni
di Francesca Caraceni

 di Gilles Weinzaepflen
di Gilles Weinzaepflen




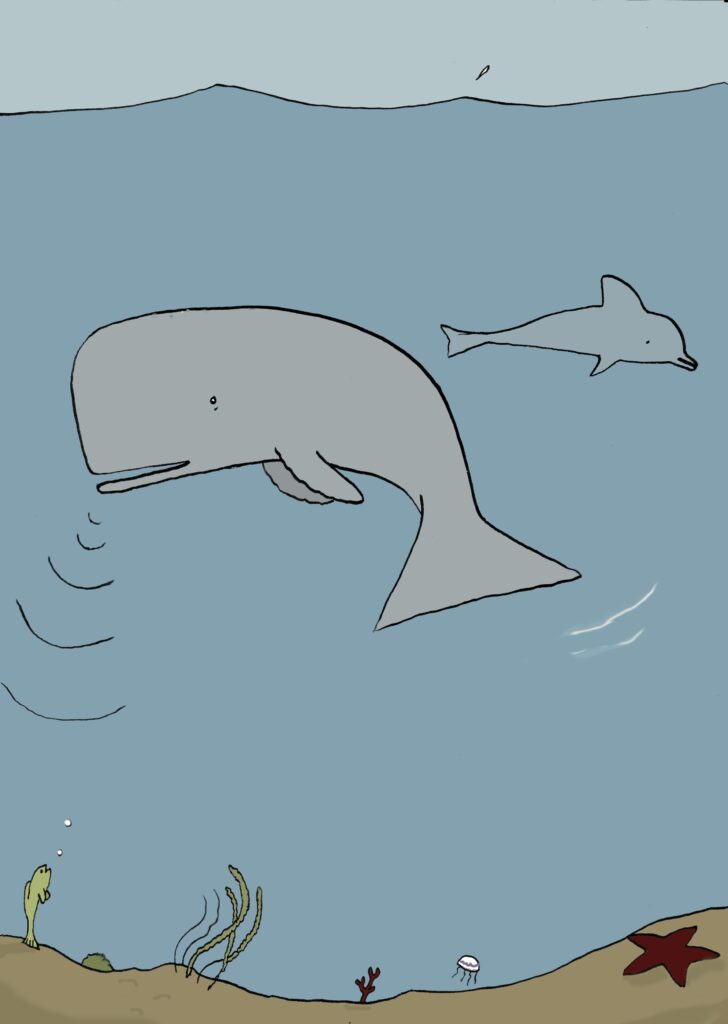







 Potrei definirlo un volume meritoriamente divulgativo, se non sapessi che la pratica della divulgazione necessita ancora di un aggettivo, alta, per poter essere ammessa nel sempre più ristretto empireo dell’accademia giudicante (non mancano esempi recenti nelle valutazioni per la docenza universitaria). La divulgazione senza aggettivi, invece, se è tale, è l’unico debito che la ricerca può pagare alla comunità che la sostiene, offrendo continuamente i risultati delle proprie acquisizioni in una forma e un linguaggio alla portata del maggior numero di lettori e lettrici. Soprattutto in un momento in cui la divulgazione che fanno giornali, reti televisive e social è spesso (spesso, non dico sempre) rovinata dalla fretta, dalle esigenze di audience, dalla sciatteria, dalla incompetenza di cattivi comunicatori. Col rischio, dunque, che alcuni utili risultati di ricerche, in tutti i campi, siano schiacciati fra circolazione elitaria e sofisticata e circolazione vasta e inefficace.
Potrei definirlo un volume meritoriamente divulgativo, se non sapessi che la pratica della divulgazione necessita ancora di un aggettivo, alta, per poter essere ammessa nel sempre più ristretto empireo dell’accademia giudicante (non mancano esempi recenti nelle valutazioni per la docenza universitaria). La divulgazione senza aggettivi, invece, se è tale, è l’unico debito che la ricerca può pagare alla comunità che la sostiene, offrendo continuamente i risultati delle proprie acquisizioni in una forma e un linguaggio alla portata del maggior numero di lettori e lettrici. Soprattutto in un momento in cui la divulgazione che fanno giornali, reti televisive e social è spesso (spesso, non dico sempre) rovinata dalla fretta, dalle esigenze di audience, dalla sciatteria, dalla incompetenza di cattivi comunicatori. Col rischio, dunque, che alcuni utili risultati di ricerche, in tutti i campi, siano schiacciati fra circolazione elitaria e sofisticata e circolazione vasta e inefficace.

 di Amandine André
di Amandine André