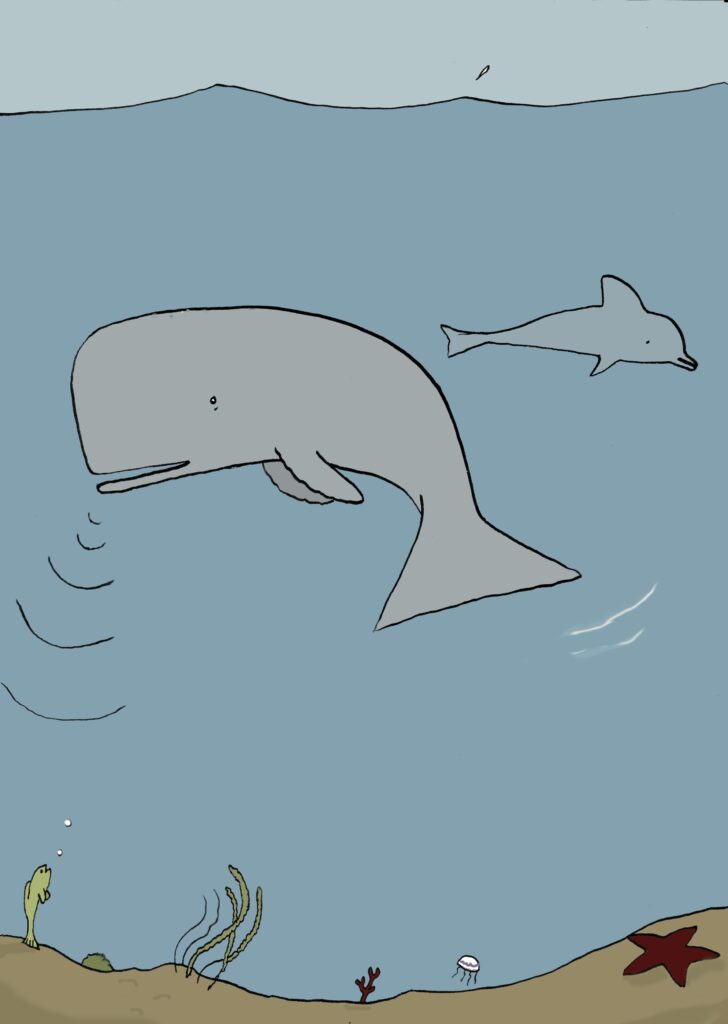Cinquanta meno uno congegni
Cinquanta meno uno congegni
di
Romano A. Fiocchi
“Orecchie nell’angolo di pagina, graffi in copertina, sedicesimi a stampa sghemba, sottolineature indelebili a penna, per non parlare delle glosse a bordo testo. Carla mal tollerava simili cose. Le davano gli incubi. Infatti, quando dopo la lettura de I topi di Buzzati, tra pagina 122 e 123, trovò la fascetta antitaccheggio nascosta in profondo, quasi nella rilegatura, trasalì”.
Ho trasalito anch’io. Ho interrotto la lettura e sono andato a recuperare il mio Meridiano con le opere scelte di Buzzati. E ho riletto I topi, che davvero non ricordavo più. Sì, era la chiave. Ogni libro ha una o più chiavi di lettura nascoste tra le righe. Piccole apocalissi ce l’ha in questa citazione di Buzzati e nell’invasione di topi che travolge il racconto stesso, dal titolo Antitaccheggio, per poi contaminare tutta la raccolta.
Piccole apocalissi è composto da quarantanove racconti, quarantanove come quelli di Hemingway (sarà anche questa una citazione?). Brevi però, brevissimi, se si considera che occupano solo settantadue pagine, una media di una pagina e mezzo ciascuno. In realtà variano da un minimo di due righe a un massimo di tre pagine. C’è anche un racconto che dà il titolo all’intera raccolta, ma che è – nello spirito di Santoro – volutamente fuorviante. Mentre quasi tutti i testi, per lunghi o brevi che siano, si risolvono in un finale costruito attraverso uno scoppio di immagini sorprendenti, un gioco di parole (Sesto senso), una pugnalata silenziosa data alle spalle (Il timore che qualcuno mi senta), uno sputo contenente centonovantasette miliardi di teschi (Stella cometa), e così via, nel racconto Piccole apocalissi il colpo di scena sfuma in una soluzione poetica: il bimbo protagonista rinuncia a vedere le stelle e preferisce “le particole di polvere” che gli sembrano più stelle delle stelle del cielo e si scontrano l’una con l’altra “come la fine di tutto l’universo”.
I topi, dunque. Perché ogni finale, come ho lasciato intendere, è un topo che guizza, un’epifania improvvisa che ti azzanna, una svolta vorace ed enorme che in poche battute inghiotte tutto il racconto in un buco nero. Piccole atroci apocalissi che ti fanno ricordare certe intuizioni crudeli di Roland Topor: penso, ad esempio, al celebre ritratto di Pinocchio che abbraccia la Fata turchina e le trafigge il viso con il naso di legno.
Il linguaggio di Santoro è forbito, aulico per scelta (il potamocero, le abbondanti grasce, l’usta del cinghiale, il mare all’occaso, le nere spelonche, e così via). Cerca l’eleganza, fonde forma e contenuto, a volte inseguendo suggestioni calviniane che hanno per riferimento città costruite e ricostruite in continuo (I nomadi del Farharhar), o città che diventano bellissime viste dall’alto, immerse nella luce dell’incendio che le sta divorando (Una città bellissima). Altre volte evoca scenari epici con una ricercatezza linguistica e un accavallarsi di miti, invenzioni letterarie alla Borges, come nell’immaginoso Stirpe di lupi. Altre volte ancora, smentisce quella stessa eleganza di luoghi e di parole per scendere nella volgarità (Meloscato). Che calza a pennello, in questo caso, poiché parla di un diavolo dai gusti davvero repellenti.
I racconti di Livio Santoro ti obbligano alla riflessione, alla scoperta del dettaglio, in un’analisi ossessivamente minuziosa della realtà in bilico tra la nevrosi e il sarcasmo. Esempio emblematico, il racconto dal titolo Perturbante, ovvero della mia gamba sinistra, testo di sole tre righe, che pertanto riporto qui per intero: “M’infilo sempre i pantaloni partendo dalla gamba destra. Stamattina, chissà perché, ho cominciato dalla sinistra”. Fine.
 Ma il racconto più bello credo che sia proprio Lo speranzoso accumulatore, permeato di realismo magico e di velata ironia. Protagonista è un collezionista compulsivo di barattoli di vetro trasparenti che Santoro ritrae indirettamente insistendo sulla descrizione del suo habitat, dove gli spazi vitali sono ridotti in minimi termini proprio per via dell’accumulo delle migliaia di barattoli di vetro che gli amici continuano incessantemente a portargli.
Ma il racconto più bello credo che sia proprio Lo speranzoso accumulatore, permeato di realismo magico e di velata ironia. Protagonista è un collezionista compulsivo di barattoli di vetro trasparenti che Santoro ritrae indirettamente insistendo sulla descrizione del suo habitat, dove gli spazi vitali sono ridotti in minimi termini proprio per via dell’accumulo delle migliaia di barattoli di vetro che gli amici continuano incessantemente a portargli.
Ma Santoro ama anche le elencazioni in stile Perec. Il racconto Dall’ultimo inventario è un’interminabile sequenza di immagini tratte da letture, scene mitologiche, eventi storici, figure di artisti, poeti, scrittori, filosofi, architetti. Un elenco che si apre con dei punti di sospensione ([…]) e si chiude con altri punti di sospensione. Come a dire che di questo inventario esiste una parte pregressa e una parte che prosegue e lo rende infinito, oppure circolare, con inizio e fine che si congiungono. Non per nulla le prime parole del racconto sono: “L’infinita morte del re estremo. Il ritorno agli archetipi di Borges”, e le ultime: “Il cancro alla gola di Robert Goddard, che aveva gridato il suo sogno alle stelle. Il saluto celeste di Jurij Gagarin, che le stelle le aveva invece viste da vicino”. Elenchi anche di fiabe (La paura del buio), come quelle di Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Cenerentola, compresse all’inverosimile e stravolte al punto da concludere che chi le avrebbe lette non avrebbe mai saputo nulla del lupo, della vecchia strega o della matrigna cattiva.
A comporre questa raccolta curiosa sono insomma piccoli congegni narrativi che portano in non-luoghi letterari e lasciano aperte infinite deduzioni sui motivi precisi di quelle forme. Come una collezione di strane concrezioni prodotte appunto da tante piccole apocalissi.
Due parole sull’editore, anche questo molto curioso. Edicola Ediciones si definisce una casa editrice “garibaldina”, che come l’eroe dei due mondi vive e pubblica tra Italia e Cile. Nata a Santiago a fine 2013, dal 2015 ha una sede anche a Ortona, proprio nell’edicola di famiglia dove tutto ha avuto inizio.


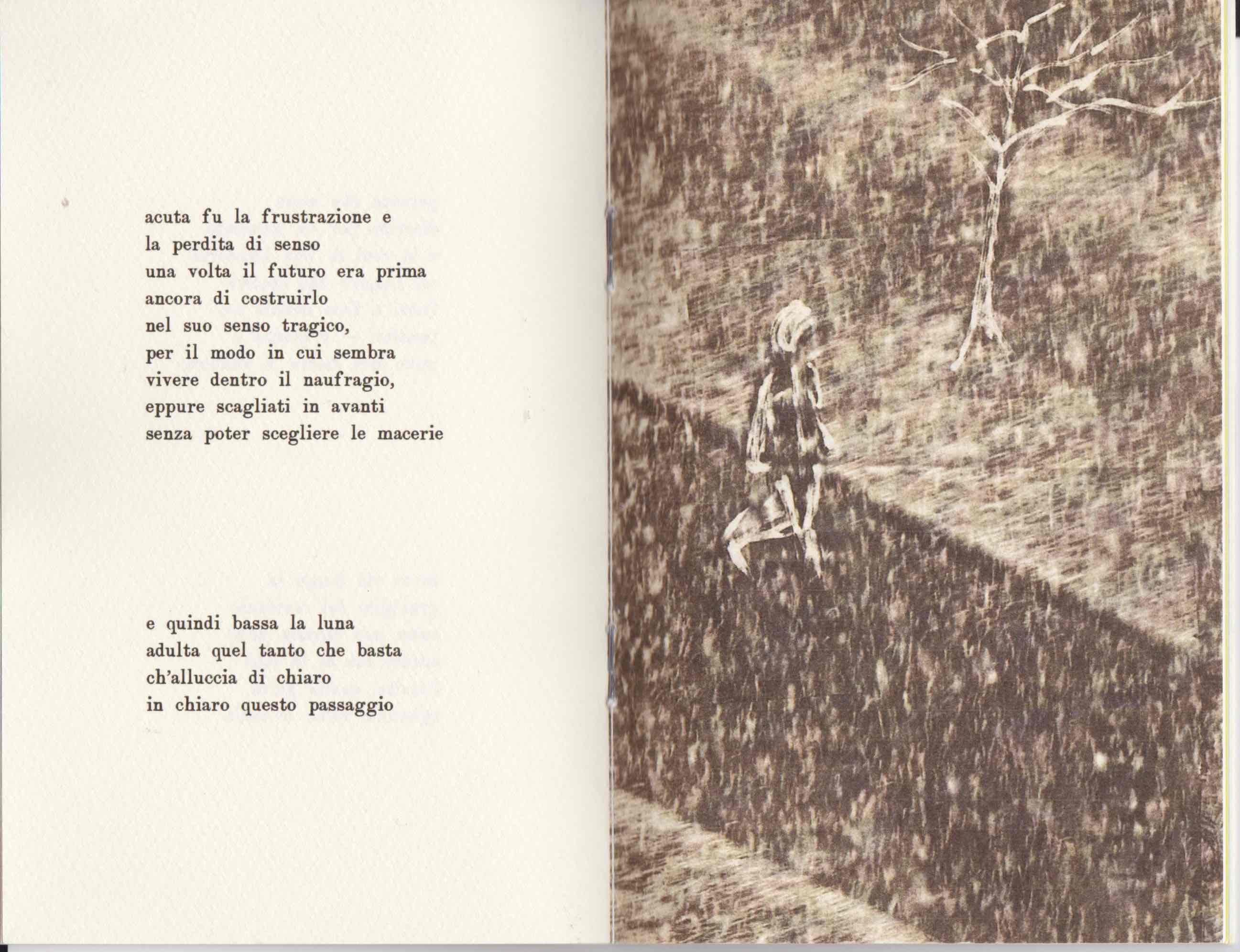

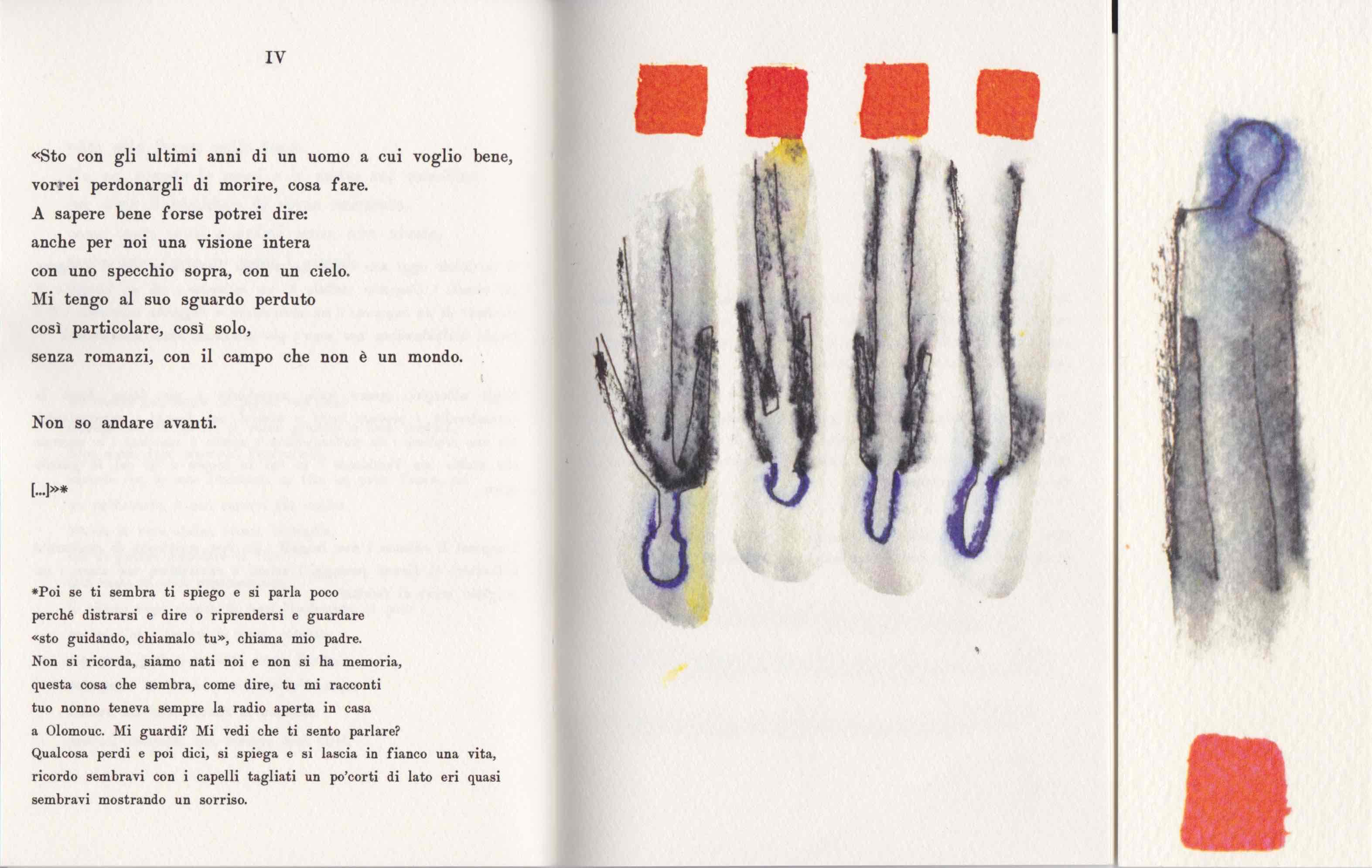
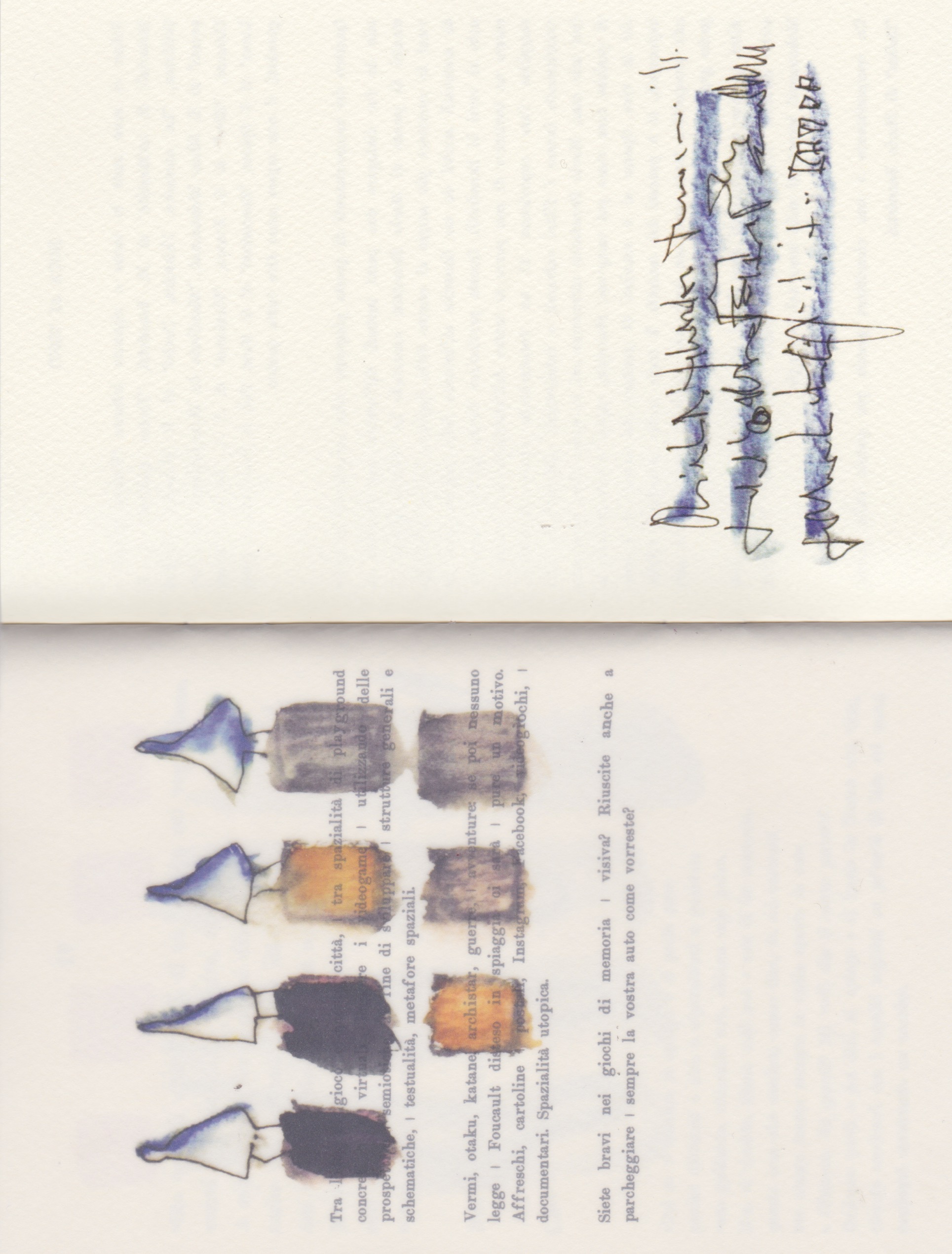

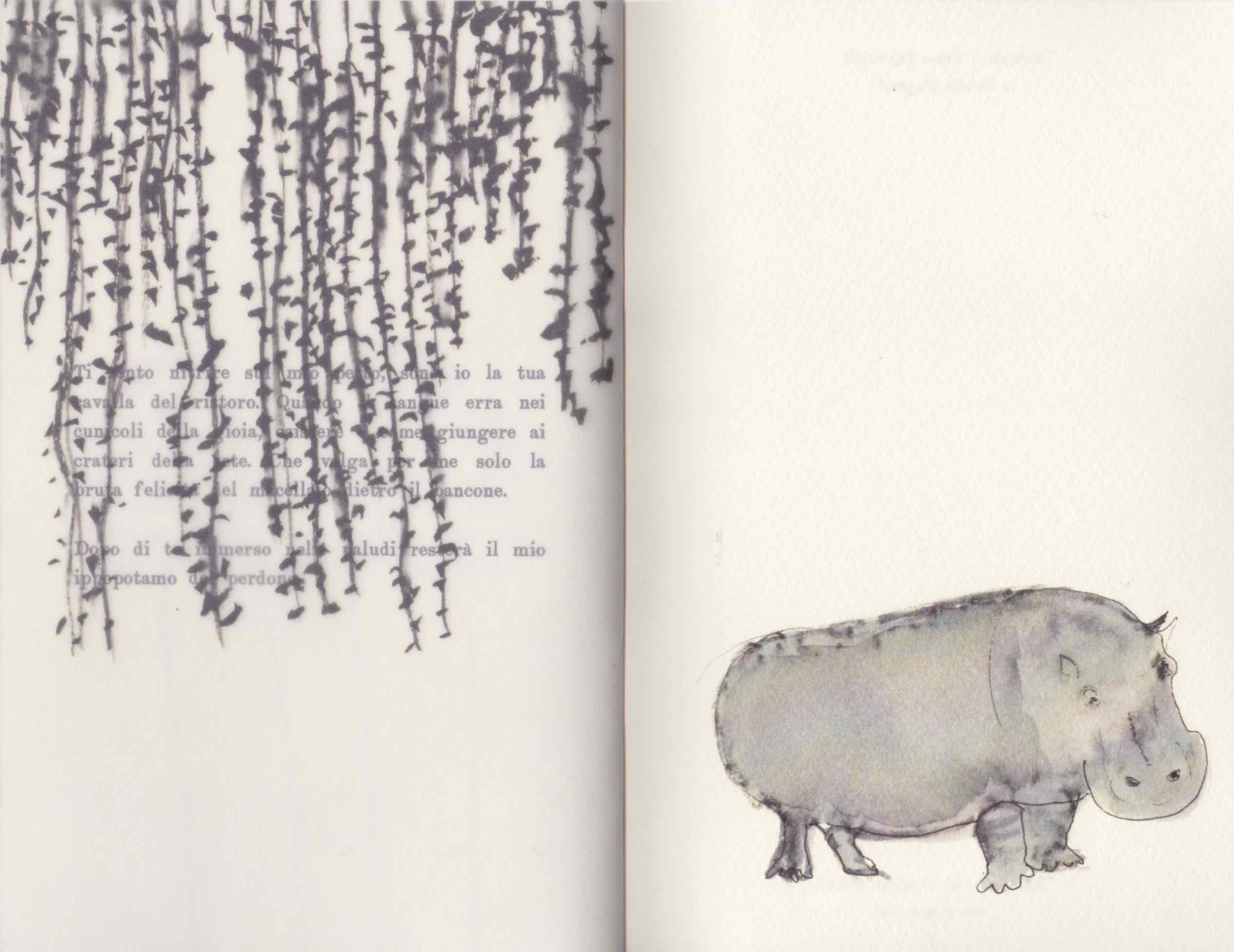

 di Ishikawa Takuboku
di Ishikawa Takuboku



 di Francesca Caraceni
di Francesca Caraceni

 di Gilles Weinzaepflen
di Gilles Weinzaepflen