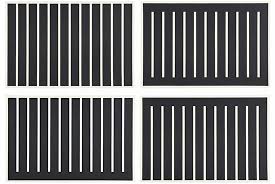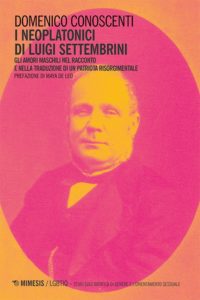di Cassandra

(Questo racconto contiene testi espliciti. Se ne sconsiglia la lettura a un pubblico non adulto, e a chiunque possa sentirsi offeso da temi e parole che riguardano la sessualità.)
AUTUNNO
– Di quando tutto sembrava un nuovo inizio
Che tu avessi adocchiato la mia collezione di Dylan Dog, me lo riferirono in anticipo: allora parlasti di te in grande, pareva tu fossi a capo di varie imprese, un noto regista, un accademico acclamato … ma a me, di quel resoconto, interessò soprattutto la parte dei fumetti.
La prima volta che t’incontrai stavo sdraiata sul divano, strabuzzando gli occhi per la luce troppo fioca di una veranda ancora isolata ed illuminata male: stavo leggendo Corto Maltese che, ora posso dirlo, fu una decisione fatale, ma pilotata: volevo sapere se avessi buoni gusti in generale, e, sapendo che saresti arrivato, giocai d’anticipo.
Lo ammetto, ti attendevo, ma tu riuscisti a sorprendermi comunque: non suonasti alla porta, non telefonasti per avvertire del tuo arrivo… sentii la porta sbattere e qualcuno salire le scale, ricordo che cominciai a tremare perché speravo fossi tu, nonostante non sapessi ancora chi saresti stato.
E tu lo notasti subito, Corto Maltese. Senza presentarti esclamasti felice d’aver portato un cofanetto contenente tutti i dvd con le animazioni di Corto, a me le animazioni non fanno impazzire perché preferisco sfogliare i fumetti, ma non smorzai il tuo entusiasmo (che era anche il mio, per averti scoperto estimatore di Corto Maltese, oltre che di Dylan Dog).
Allora mi alzai, guardandoti in faccia per la prima volta, strinsi la tua mano farfugliando il mio nome, domandandomi perché, gli altri, parlandomi di te e delle tue grandi imprese, si fossero dimenticati di menzionare la tua bellezza.
Tu mi guardasti negli occhi, che fossero da stronzo lo vidi subito anche se erano blu.
“Vino?” Chiedesti tu, estraendo una bottiglia da un sacco militare rattoppato. “Birra”? Domandai io porgendotene una.
Fingemmo un sacco, poi, quella sera. Tra fiumi di alcol e sigarette fumate a metà: tu raccontasti un sacco di stronzate e io non credetti a niente, però mi piacevi lo stesso.
La tua retorica, la tua dialettica, notai subito la tua mente brillante, che esisteva nonostante i tuoi racconti farlocchi … e poi Corto Maltese e Dylan Dog. Soprattutto Corto Maltese e Dylan Dog.
Ci limitammo ad un contatto fisico fugace: ti toccai il braccio e tu mi sfiorasti il ginocchio. Andai a dormire sola, nella mia nuova stanza – e tu nella tua, che però aveva, e per sempre ha avuto, soltanto un materasso per terra – sicuramente ubriaca, forse già innamorata.
Perché avevo una nuova casa, e credevo tu fossi il mio inizio.
*
– Di quando bevevamo vino e di quando ci siamo amati
Tu m’inibivi e io compravo il vino.
Accadde ogni sera, per settimane, o forse un intero mese.
Anche tu compravi il vino, e forse t’inibivo, ma non era il motivo per cui lo compravi, ma allora ancora non lo sapevo anche se lo intuivo.
Insieme lo tracannavamo volentieri, mentre l’autunno, pian piano, diventò imponente, e, nella nostra veranda ancora mal isolata era possibile restare solo con un mucchio di coperte.
Allora m’offrivi sempre l’ultima sigaretta, perché io le finivo sempre prima di te, e a te piaceva ancora fingerti generoso, la fumavamo sempre metà ciascuno e solo allora andavamo a dormire.
Esistevamo solo noi, in una casa di cinque persone e svariati animali. Esistevamo solo noi e il cane. E il vino.
E le sigarette. E la musica… e Corto Maltese e Dylan Dog.
Di giorno passeggiavamo, la sera improvvisavamo simposi in veranda, sempre accompagnati da fiumi di alcol e fumi di tutti i tipi: necessitavamo la mente inibita per poter stare insieme, era un bisogno reale. La mattina non esistevamo, l’uno per l’altra, diventavamo inseparabili dopo le quattro del pomeriggio.
In quei giorni scoprimmo l’isola: verdeggiante, solitaria, malinconica, così simile alle nostre anime.
Andare all’isola divenne un appuntamento fisso. Tacito, perché nessuno esplicitò mai all’altro la volontà d’incontrarlo lì: eppure c’incontrammo lì quasi quotidianamente, fino a che il tempo ce lo permise.
Una sera cominciammo a improvvisare danze tribali per scaldarci, con indosso coperte militari che c’ingombravano e coprivano completamente, nella nostra veranda era possibile stare solo raggelando e sudando allo stesso tempo. Non ricordo quale fu l’evento scatenante, ricordo che, ad un certo punto, ridemmo fino alle lacrime; poi io salii sul divano e ti dissi: “prendimi”, ma lo sapevo che m’avresti lasciata cadere.
Cademmo in due, e non come in un film, vis à vis, cademmo facendoci male, atterrando su di un’asse chiodata ed io mi ferii la gamba.
T’insultai un poco, perché non mi avevi presa apposta e farmi male non mi è mai piaciuto, ma non ti aspettavi che mi sarei lanciata davvero: col senno di poi direi che è cominciato tutto lì, il nostro squallido gioco d’orgogli, quando io, decisa a tenere il punto, mi buttai lo stesso vedendo che non mi avresti presa, e tu, deciso a non prendermi, mi guardasti gettarmi nel vuoto lo stesso, decidendoti a tendere le braccia solo quando, ormai, era troppo tardi.
Ti dissi che mi ero anche ferita, mi alzai per prendere qualcosa e tamponare il sangue, tu afferrasti il mio braccio all’improvviso, e, tenendolo ben saldo, mi obbligasti a rimanere a terra. Non so con quale impulso decidesti poi di versarmi della birra sulla ferita, facendomi urlare di dolore vero. A quel punto ti chinasti per leccare il mio sangue, e le mie unghie si conficcarono nella tua schiena.
Quella notte facemmo l’amore aiutati dal radiatore: ci addormentammo sfiniti nel tuo letto, ma quando mi svegliai tornai in camera mia. Perché non volevo darti l’impressione di tenerci troppo.
INVERNO
– Di quando impazzimmo
Fuori regnava il gelo, l’isola ricoperta di ghiaccio divenne inaccessibile. Cominciammo a passeggiare istericamente alla ricerca di un nuovo locus ameno: scegliemmo il tetto di un alambicco in mezzo ai filari, che noi chiamavamo comunale, ma probabilmente apparteneva a qualcuno e, forse, non si trattava nemmeno di un alambicco.
Il nostro amore diventò una sfida: più t’amavo e più cercavo di dimostrarti che non era vero, e più m’amavi e più cercavi di ferirmi. Ci facemmo del male e ne facemmo agli altri, per mesi usammo le persone come pedine per raggiungere i nostri scopi, e il nostro scopo ultimo era sempre il medesimo: ferirci.
Di noi non parlavamo mai, sfiorammo l’argomento una volta sola, e senza mai specificare che io stessi parlando di me, e tu di te, e che il discorso riguardasse noi. Ne parlammo ipoteticamente, ma nello specifico, e comunque non concludemmo niente. Fu l’unico attimo in cui ti confessai il mio amore e tu il tuo, ma presto tornammo ad essere quelli di sempre.
Per tutto il resto del tempo cercai di non darti mai l’illusione che fra noi ci fosse qualcosa che potesse evadere dalla sfera sessuale, e tu facesti altrettanto. Mi raccontasti ognuna delle tue cotte fugaci, io ti credetti ogni volta, soffrendo. In quel periodo tirammo fuori uno il peggio dell’altro, ancora non sapevamo che saremmo stati in grado di far peggio, perché ogni volta ci sembrava che il peggio l’avessimo già commesso.
Io, uscii con chiunque, per dimostrarti di non essere da meno, tu mi credesti ad ogni volta, soffrendo.
Cercasti di sedurre chiunque fosse di fronte a me, per poi vantarti della tua prestanza con me ed elencarmi innumerevoli pregi che altre avevano, ma non io. Non concludevi mai, è vero, forse più capace di me di non eccedere al gioco; ma a me sembrava sempre che l’avresti fatto, e, giocando d’anticipo, rincasavo ogni sera con qualcuno di diverso, costringendoti a sentire le mie urla al di là del muro.
La mia vita sessuale raramente fu attiva e variegata come negli anni in cui ti ho amato.
Un giorno ti trovai in cucina, furente, già ubriaco. Non ricordo le tue parole, ricordo che urlasti molto. Allora urlavamo spesso e finiva sempre con te che ne andavi ed io che non dormivo fino a che non tornavi a casa, quando sentivo la porta fingevo d’essere ancora sveglia per altri motivi, che non riguardavano te – mai – e solo in quel momento ci chiedevamo scusa. Sempre in cucina, alle due di notte, mentre io fingevo di essere sveglia per motivi che non riguardavano te e tu tornavi dalla tua ubriacatura solitaria in cui smaltivi la rabbia nei miei confronti.
Ma quel giorno fu diverso, eri seriamente arrabbiato, parlavi della casa, dell’affitto, delle spese, del fatto che io ti considerassi solo di fronte ai soldi. Io capii che mi stavi rimproverando altro e restai zitta a guardarti, quella volta non tentai di avere ragione perché avevo capito di aver vinto, ma mi sentii sconfitta. Non ti domandai perdono, perché non erano le due di notte e stavo aspettando che te ne andassi di casa sbattendo la porta. Rimanemmo lì, in silenzio, a lungo, poi io farfugliai qualcosa, che per me non valevi solo di fronte all’affitto da pagare, e tu fingesti d’avermi scusata.
Pensai che qualcosa fosse cambiato sino al momento della tua vendetta, che arrivò, puntualissima, il giorno seguente quando invitasti una donna a caso. Che l’avessi conosciuta da trenta secondi e l’avessi invitata unicamente per farmi impazzire lo capii solo molto tempo dopo, allora pensai fosse una delle tue cotte e mi arrabbiai nonostante non la trovassi né bella né intelligente. La mia vendetta arrivò all’istante con un biglietto sotto la tua porta in cui ti comunicavo da chi avrei dormito.
Il gioco di punizioni e vendette durò fin troppo, una stagione intera se non due, intervallato da brevi tregue, in cui entrambi, sfiniti, senza mai ammettere all’altro i propri sentimenti, tornavamo a rintanarci nei nostri cantucci segreti insieme, lasciandoci le nostre malefatte ed il mondo esterno alle spalle.
Soffrivamo, solo tu capivi la mia sofferenza perché eri tu a causarmela, e solo io capivo la tua. Questo ci giustificava e ci univa ancor più nel nostro gioco al massacro che, puntuale, ricominciava. Perdonarci, a vicenda, ci dava la possibilità di non ammettere mai i nostri errori, e così, finché fummo vicini, continuammo.
*
– Di quando rubammo al ristorante
Squattrinato e vagabondo, ma con grandi manie di splendore, m’invitasti a cena. Io ancora la ricordavo, l’ultima volta che mi avevi invitata a cena: quando ci eravamo trovati a dividere in due un piatto di riso al fine di poterci permettere un bicchiere di vino a testa. Quindi ti proposi di virare direttamente su di un aperitivo a buffet, e tu accettasti subito, perché ti andare a cena l’avresti fatto per me, che non ricordo cosa, ma sicuramente volevi farti perdonare qualche stronzata, mentre bere ti piaceva sempre. E a me, anche.
Quel giorno i soldi per pagare li avevamo pure, ma tu mi guardasti sorridendo, con un guizzo negli occhi di quelli che ti viene solo quando sei contento, e mi domandasti se ero pronta a scappare. Certa che tu non avresti avuto il coraggio, proposi di fingere di lasciare i soldi sul tavolo, per poi recarci all’uscita del ristorante con molta calma e iniziare a correre una volta arrivati in strada.
Tu ti alzasti, io pure, entrambi convinti che l’altro avrebbe ceduto prima o poi: alla fine lo facemmo davvero. Arrivammo all’uscita con il cuore in gola, e, una volta in strada prendemmo a correre all’impazzata sino al parco, poi fino al lago. Ci sdraiammo sull’erba umida, ancora carichi di adrenalina.
“Proporrai mai qualche cosa di normale?”. Domandai ancora ansimante
“Risponderai mai di no?”. Replicasti tu, ancora incredulo dalle nostre gesta.
PRIMAVERA
– Di quando venimmo scoperti
Le stagioni continuavano a cambiare e il tetto divenne meta fedele sostituendo l’isola quasi del tutto. Malgrado il tempo permettesse di nuovo di sostarci, l’isola rimase, per entrambi, la meta delle fughe in solitaria. Il tetto, come la notte, rappresentava i nostri momenti felici, quando lasciavamo cadere i nostri personaggi per essere semplicemente noi: più simili di quanto avremmo voluto.
Ancora non osavamo parlare a nessuno di noi, io non sospettai, mai, che qualcuno sapesse: allora mi sembrava importante, ora sorrido, pensando che l’unica cosa che stavo cercando di nascondere, con tentativi maldestri, era, a te, il mio amore per te.
Il primo a scoprirci fu il cane, si vendicò, geloso non so se di me o di te, o forse di entrambi, e noi lo trovammo divertente anche se, per la prima volta, sentimmo di dover render conto agli altri di quanto stava succedendo fra noi.
Non a noi stessi, questo mai. E io seppi tenere il mio segreto al sicuro, ma anche tu non te la cavasti male.
Negammo l’evidenza, agli altri e soprattutto a noi. Non c’accontentammo di toccare il fondo, ma ci scoprimmo, entrambi, capaci a scavare.
*
– Routine
Ad un certo punto fui seriamente spaventata, non mi piaceva l’idea d’essere ancora in grado i provare sentimenti per te. Nei mesi primaverili feci di tutto per costringermi a non amarti, e nulla funzionò.
Ti amavo anche quando gli occhi ti si accendevano di follia e urlavi. Quando gridavi e ti puzzava il fiato ed allora io gridavo più forte. Ti dicevo spesso che eri ridicolo, mentre tu, barcollando per la mia stanza, vomitavi livore e parole biascicate.
Di chi ti sei fatta
Dicevi
Di che ti sei fatto?
Ribadivo.
Dicevi cattiverie, io non le ascoltavo, ti chiudevo fuori dalla mia stanza, tu bussavi, io urlavo di andartene, poi uscivo, ti spingevo immaginandoti rotolare giù dalle scale.
Urlavo anche io, poi piangevo, tu con gli occhi ancora arrossati mi stringevi facendomi cadere a terra. Urlammo e piangemmo molto in quel periodo, passammo lunghe ore stesi sul pavimento del bagno a sentirci soli senza lasciarci soli.
*
– Di quando eravamo felici
Però l’abbiamo avuto anche noi, qualche momento felice.
Come quando la primavera esplose e noi andammo a passeggiare come i primi tempi, per poi tornare al tetto e decidere di fare merenda lassù.
E mentre addentavo una ciambella, tu, con il sole che ti obbligava a stropicciare gli occhi blu, mi domandasti se mi fosse mai capitato di sentirmi così leggera.
Non ricordo cosa risposi, probabilmente qualche cosa per darmi un tono, perché non ero sicura d’aver capito bene cosa intendessi dire, anche se sicuramente mi sentivo leggera e felice.
Poi scalammo una montagna, uniti dalla follia della stessa visione. Non ci sorprendemmo più di tanto quando in cima non vi trovammo niente: né castelli, né fortezze o cavalieri, come c’era apparso dal basso. Solo qualche filo d’erba piangente, ancora accarezzato dal sole.
Trovammo però un tramonto mozzafiato, e ce lo godemmo nonostante la temperatura che, con il morir del sole, cominciò ad abbassarsi drasticamente.
Siamo ancora più in alto, dicesti tu, con la fierezza d’un re che osserva il suo regno e la spensieratezza d’un bambino.
Ci sentimmo un po’ come coraggiosi esploratori che, affrontate le più temibili imprese, osservano il mondo dall’altro sentendosene padroni.
Guardammo il cielo esplodere di colori, passare dal giallo all’arancione e dall’arancione al viola, aspettammo che l’ultimo rintocco del campanile, prima di deciderci a scendere.
Vorrei che questa giornata non finisse mai.
Ti dissi io.
Ma poi la giornata finì.
ESTATE
– Di quando tutto pareva divertente
Fu un periodo di simbiosi in cui non litigammo quasi mai, io passavo i pomeriggi a guardarti arrovellarti mentre cercavi di mantenere civile il nostro giardino: non indossavi mai le mutande perché ti veniva voglia di curare il giardino solo dopo l’atto, e i pantaloni continuavano a caderti, e a me sembravi un po’ ridicolo.
Decidemmo di amarci in ogni giardino pubblico o privato del piccolo paese, ma soprattutto pubblico. Un pomeriggio, mentre le tue dita s’insinuavano sotto il mio vestito, c’accorgemmo di colpo d’essere attorniati da un centinaio di persone. Nessuno dei due seppe dire all’altro quando esse comparvero, ce ne accorgemmo solo ad un certo punto.
Ci ricomponemmo e tu andasti da loro a chiedere il cavatappi, ti rivelarono d’essere poliziotti e tu tornasti da me sbellicandoti dalle risate. Ci fece ridere l’idea d’aver sfiorato l’arresto e non c’impedì di continuare il nostro tour.
Un altro pomeriggio, nascosti nel giardino d’estate di una casa di vacanza, venimmo fiutati dal nostro cane: provò a raggiungerci e noi ci stringemmo, soffocando le risate, nudi, sperando ardentemente di non venir scoperti in una situazione così imbarazzante. Quando il cane, udendo il richiamo finale del nostro coinquilino, finalmente scomparve smettendo d’annusare il recinto, ci lasciammo andare, sentendo che quel che stavamo vivendo noi due, era speciale.
Quell’estate, per un breve periodo, la nostra storia andò talmente bene che tu t’ergesti a mio paladino difensore, il tuo orgoglio di uomo si fece prepotente: mi difendevi da tutto, tranne che da te stesso. Ti raccontai del nuovo arrivo in casa, anche se per poche settimane, una persona estremamente maschilista con cui avevo discusso più volte e non vedevo l’ora che se ne andasse. Tu lo trattasti male senza nemmeno presentarti, e a me fece ridere, il tuo piglio sicuro, anche se ti trovai abbastanza sgarbato e maleducato.
*
– Di quando avrebbe dovuto essere estate e invece pareva inverno
Pareva inverno, e tu sembravi scomparso. Che poi, per Dio, dove vai quando sparisci, un giorno vorrei davvero saperlo. Non c’era nessuno attorno a me. Solo io, svampita, a guardare le foglie degli alberi danzare al ritmo del vento. Il cielo era grigio, sopra il lago e sopra di me.
Il vento in un soffio le alzava, poi si placava, e loro scendevano, come se fossero stanche. Fsssht, ancora in alto e poi giù e poi fssht.
E le foglie mi sembrarono noi, nella nostra passionale danza mortale.
E su.
E giù.
E poi ffssht.
Mi domandai se le foglie avessero voglia di stare in aria per sempre, o se, ad un certo punto, fossero liete di ricadere, ovviamente pensavo alle foglie, ma pensavo a te. Apprezzai, in quel momento, la tua lontananza, pensai che danzare all’aria, eternamente, fosse meglio di una caduta.
Pensai alla vita, al fatto che tu sparisci e potresti anche non tornare, e la vita mi sembrò noiosa, senza la possibilità di un tuo ritorno.
Anche se poi torni sempre e queste parole non te le dico mai.
E si va su.
E si va giù.
E poi sssht.
UN ANNO DOPO
– Di quando sei partito veramente
La tua partenza, come il tuo arrivo, fu improvvisa. Comunicasti un giorno che te ne saresti andato, e poco dopo, partisti alla volta di un nuovo continente.
Allora ti conoscevo e capii perfettamente il tuo bisogno di lasciare un ricordo indelebile che non potesse essere scalfito dalla verità della quotidianità. Non mi sorprese la tua partenza, piuttosto la velocità e la capacità di fare tutto quasi di nascosto.
Non parlammo nemmeno al momento di salutarci davvero, passammo una serata insieme e ci concedemmo un lungo abbraccio che fu il nostro modo di dirci addio. La pioggia ci aveva inzuppati, ma nessuno dei due aveva voglia di tornare al bar, me ne andai salutandoti con la mano e senza voltarmi sentendo una forte fitta al petto. Andai a bere in un altro locale, sede dei nostri appuntamenti taciti serali, convinta che non mi avresti raggiunta eppure decisa a volerne avere la conferma: andare a casa, restando con l’idea che tu mi avresti ancora cercata in quella notte, senza trovarmi, non era un fatto che riuscivo ad accettare. Bevetti molto, e alle cinque del mattino tornai a casa. Sola.
Gestire la rapidità della tua partenza fu difficile, mi decisi a ripercorrere le tappe del nostro amore: l’isola, i vigneti, il tetto.
Passeggiando mi ricordai di quando ci andavi tu per primo e mi aspettavi là, dormicchiando, ma non troppo, perché la brezza là sopra è forte e tu la coperta non l’hai portata mai: e mi sentivi arrivare odorando l’aria, e riconoscendo il mio profumo come il cane.
Mi sorpresi a trovare spogli tronchi protendere le loro braccia verso di me, milioni di mani di strega con unghie affusolate carezzarmi le guance, con lo sfondo di un cielo incupito, tremolante quasi quanto me. Fui contenta di trovare, tra le tegole ricoperte di muschio, uno spiraglio: non ancora abbastanza grande per guardarci attraverso.
Mentre un brivido di gelo mi ghiacciava la schiena ricordandomi il motivo per cui odio l’inverno, guardai le nuvole in cielo immaginandoti in volo, tra tutti i tuoi timori. Pensai a come la tua incoerenza avesse portato proprio te, amante del sole, in un paese più freddo del nostro, raggiungibile solo tramite il mezzo che terrorizza.
Pensai a quanto fosse più serena la mia vita da dopo la tua partenza, e desiderai riuscire a non volere un tuo ritorno.
*
– Di quando decisi di spiare la tua vita su internet
Sentendo la notizia di un pazzo sparare addosso alle persone, là dove hai deciso di rifugiarti, ho temuto che fossi tu il pazzo; ma poi anche la tua morte.
Tornando a casa decisi di guardare la tua vita su internet.
Perché oggi si può, e, forse, nel tuo caso, la mera bugia del Social Network è più sincera della vita che ami raccontare. Sorridevi felice, elegante, arrogante, con un bicchiere in mano. Uno di quei bicchieri che hanno un nome particolare perché destinati a contenere solo liquidi pregiati, e fui certa che, anche tu, prendendolo in mano ti fossi chiesto se quel bicchiere avrebbe potuto contenere l’intera bottiglia.
Nella tua ipocrisia conformista, sembravi aver trovato te stesso.
Avrei voluto essere una persona migliore, e sorridere della tua nuova vita, invece provai rabbia e desiderai che tu ti perdessi di nuovo.
DUE ANNI DOPO
– Di quando ho maledetto quelli che dicevano che il tempo fosse l’unico rimedio e ho scoperto che il tempo non serve a niente
Chiunque mi giurò che le ferite passano solo con il tempo, a me il tempo non servì. Andai più volte al tetto, mi resi conto di star meglio solo quando, dopo una lunga pausa dalle mie passeggiate abituali, sbagliai strada.
Arrivai convinta d’aver preso il sentiero giusto ad una casupola rimodernata, niente muschi e rami pericolanti da evitare, scalini intatti e nessuna fessura. Di primo acchito pensai che i padroni del nostro tetto avessero deciso di rimodernarlo, e pensai fosse una metafora del nostro amore. T’immaginai sposato, rimodernato, senza più fessure né muschi a coprirti la pelle.
Mi domandai se la tua nuova vita fosse più calma, pensai alle nostre pazzie, alle notti di passione in cui non ci dicevamo mai di no, a tutte le prime sensazioni vissute con te.
Mi rattristai, perché ti avevo sempre immaginato proseguire la tua vita sgangherata rattoppando i buchi, più che costruendoti una nuova facciata; ma mi rassegnai in fretta. Il tetto era così alto che mi sembrò impossibile accederci, e d’altra parte me ne passò la voglia: pensai che ti conoscere la tua nuova facciata non m’interessava, essendomi già interessata a quella vecchia.
Mi resi conto d’aver sbagliato strada dopo molto, quando, per un caso fortuito, decisi di tornare a casa proseguendo per il sentiero in mezzo ai filari e di non tornare alla via principale, mi trovai sul sentiero giusto e capii che il nostro tetto fosse sempre là.
Sentii il cuore pulsare e lo riconobbi da lontano: distrutto, ancora mal concio, con il muschio che ormai lo copriva interamente e le scale completamente distrutte: mi sentii sollevata. Lo raggiunsi a corsa e, nonostante salirci mi parve più ostico del solito, vi salii contenta.
Pensai che tu eri sempre tu, e che non ti fossi nemmeno preoccupato di mettere le pezze.
*
– Di quando sei tornato e poi sei ripartito
Tornasti senza avvertire, come tua prassi, e ci ubriacammo nuovamente, felici di esserci ritrovati, ci ubriacammo talmente che tornati a casa c’addormentammo a terra.
Ti raccontai del tetto, sentendomi un po’ pazza ma sapendo che avresti capito, e così fu. Non parlammo di noi, della nostra vita privata senza l’altro. Mi dicesti solo di non aver voluto mantenere i contatti per scelta, e io finsi di capire la tua esigenza di tagliare i ponti con il passato.
Inevitabilmente incontrasti un mio spasimante, e, davvero, fu un gioco del destino, non lo invitai espressamente per ferirti. Non lo invitai del tutto. Mi prendesti in giro per la giovane età del ragazzo, io ribadii che la differenza d’età che correva tra me e lui fosse la stessa, identica, fra me e te. Iniziai una discussione su quanto fossi maschilista, tal volta, e tu diventasti volgare.
Finsi che non me ne importasse, traendo vantaggio da quella situazione imbarazzante: presi a giocare con l’altro, tu ti avvicinasti scontroso per farmi sapere che non avrei più vinto, ed io decisi di tornare a casa con te.
Solo allora mi rivelasti che il tuo ritorno sarebbe stato fugace come il resto della nostra storia, ma non mi pesò dirti addio quella mattina.
Non mi addormentai pensandoti, fu una sorpresa anche per me, al risveglio, capire d’averti sognato. Sognai di trovarti in una stazione, luogo immaginario perché non assomigliava a nessuna stazione da me conosciuta, non so per quale ragione decidemmo di fingere che le scale mobili fossero bloccate e deviare la gente verso una via alternativa, anche nel sogno non ci vedevamo da tempo, e il nostro primo incontro era così. Nel sogno avevo il ciclo, nella realtà no (e nemmeno ero in procinto d’averlo), ma tu, ad un certo punto, volevi assolutamente scopare e dunque andammo nei cessi pubblici. Mentre mi spogliavi ti dissi che avevo il ciclo e che avresti dovuto mettermelo nel culo. Proprio così. Eravamo, oniricamente, la versione volgare di una versione già volgare di noi.
Non ricordo i dettagli dell’atto, e poco importa, si trattava di un sogno, ma il sogno finiva con me che espellevo litri di cacca molle di fronte a te.
Al risveglio pensai fosse l’ennesima buona metafora della nostra storia: finita sepolta dalla merda.
Partii per un viaggio in solitaria, volevo camminare, io, che non sono affatto sportiva, decisi per i sentieri della costiera amalfitana e mi trovai a sostare nello squallore di Salerno dove venni scambiata per una puttana e fui costretta a scappare.
Avevo perso il conto di quanti mesi fossero passati dall’ultimo nostro incontro, forse avevamo superato l’anno, e io, in tal senso, mi sentivo quasi guarita.
Quando ti rividi poi, era passato del tempo anche se non ancora abbastanza, tu t’accingevi a sposarti mentre io stavo vivendo una nuova storia, mi domandasti una buona ragione per non sposarti che io non seppi darti, poi ci ricascammo.

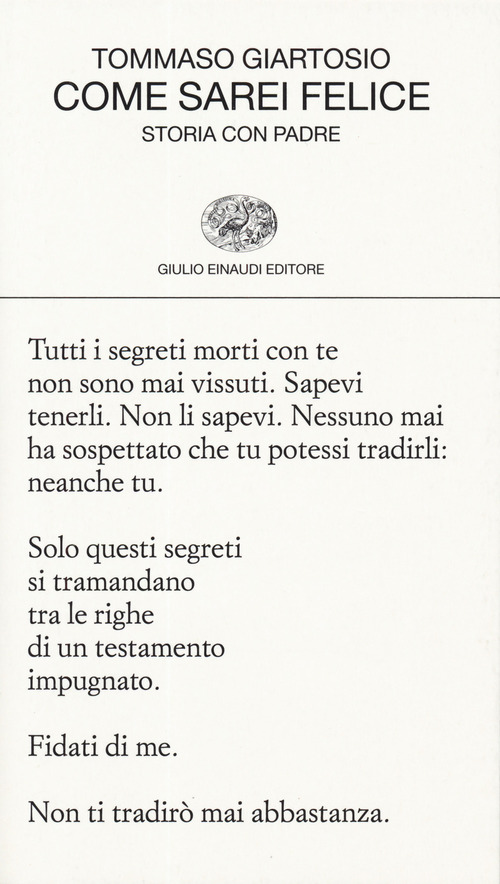

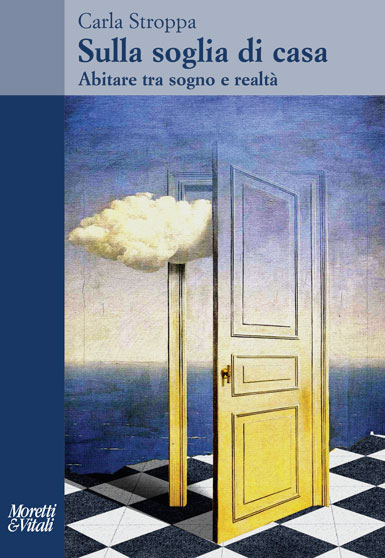

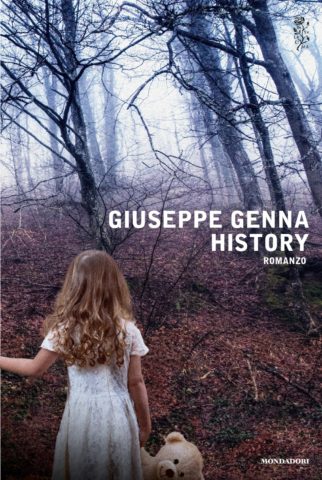
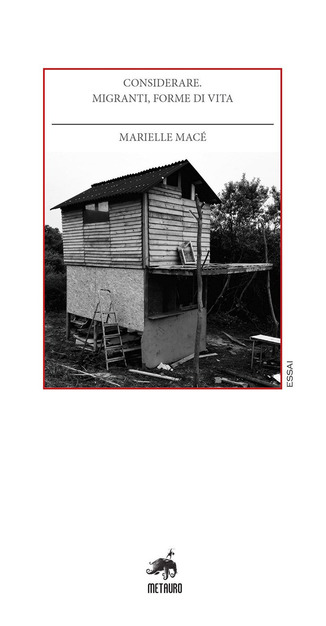
 di Marielle Macé
di Marielle Macé