di Benny Nonasky
(Si consiglia di leggere prima la poesia senza note. Oppure solo le note e poi la poesia. Terza e ultima opzione: leggere la poesia e le note, per poi rileggerla sola ad alta voce, anche agli amici e al bar)
In origine l’alba e la luce
l’alba e la luce
alba e luce
e ormai soltanto la notte
madre e padre
di ogni significato e colore
La notte.
I
Ci muoviamo dall’alto come Fetonti codarossa1
in transito sui venti oceanici del Pacifico.
Tu mi parli di una casa –
apro la porta: è una vastità azzurra,
lacrima del principio, lacrima e goccia,
lacrima d’Istar2 tra i piedi
dei continenti insanguinati e verdi.
È una vastità azzurra. Non percepisco confini.
Io – in questa casa: metà del respiro del mondo3.
Sulla superficie marina – io:
un giardino di batteri fotosintetici4:
fitoplancton come querce rosse secolari,
zooplancton per il piccolo Copepode5
e il Capodoglio6 solitario.
Un mantello sul quale si arreda la vita,
sul quale scende la morte.
Scende la morte e nell’acqua la morte
è aratura abissale, è soffocamento la morte
è ferita petrolifera, composto plastico;
un quadro che svanisce i colori.
Tu mi dici che abbiamo ucciso il mare
(dalla sorgente, dalla sorgente)
Tu mi dici
(sarebbe stato bello costruire un’altalena
sul mare e dondolando leggere poesie
di Taggart7, noi due, noi due,
gustandoci la siccità permanente,
whitout memory there is no protection8).
Io inseguo le correnti ascensionali –
un’opportunità ancora.
Io voglio immaginare il cielo parete, colonna
e arco ricoperte dalle maioliche di Iznik,
l’antica Nicea, della possente Moschea Blu9 –
sacralità per il cielo e lapislazzuli.
Io da questa immensità turchese
precipito nella purezza del Beluga10
e ritorno a casa.
II
Davanti l’entrata, un mobiletto.
Cosa sono madre
quel bianco zucchero e grazia?
Tre frammenti di corallo bianco11.
Tre frammenti di corallo morto.
Ne accarezzo lo scheletro ruvido:
sono una distesa bianca che avanza,
sono la fame12, l’acidificazione13,
l’insieme che regge il cerchio
e avanza14.
Tre frammenti di corallo bianco.
Tre frammenti di corallo morto.
C’è. C’è a largo della linea sabbiosa
del Queensland15 un terreno sterminato di colori.
È un mondo dentro un mondo che alimenta il mondo.
L’insieme: polipi come redini, polipi
come riparo e sostentamento come come un mondo.
Non è una rosa recisa per un letto di sposi:
è una primavera pelagica, qualcosa che determina
o il declino, che si propugna tra le voci;
quasi un sermone e già tre lapidi16.
Il nulla bianco.
C’è. A largo della linea sabbiosa
del Queensland l’acqua cercare ossigeno17.
Una processione di polvere e sofferenza
come un sudario tra i popoli del reef18.
S’infiammano e si spengono le Zooxanthelle19.
Nell’infinito sbiancamento di massa.
Il nulla.
A casa mia:
tre frammenti di corallo bianco,
tre frammenti di corallo morto.
III
Apro la finestra. Davanti ai miei occhi arrendevoli
quel campo azzurro solcato incessantemente
da cavalli bianchi che sconvolgono la riva.
Solo fino ad un certo punto la vita
può percorrere la prateria degli oceani.
Al di sotto cantano i demoni20; il sole si spezza
e il tutto si fa adattamento e silenzio.
In questo paesaggio nero
il Chaulidus21 è frammento d’ossidiana nell’universo,
vipera del mare che diviene stella per uccidere.
Il Regaleco22vola sinuoso nelle spirali vuote del tempo.
Le sue membra colpiscono gli estremi del mondo e
dalla sua bocca Giona23 prega Dio per ricevere ancora luce.
Luce.
Le Stenelle24 giocano e s’incrociano nell’infanzia del giorno.
Sono siluri che formano archi composti.
I funesti Tonni levigano la nostalgia nei pescatori.
Decolla e saetta e perfora l’aria un Exocoetidae25
a quattro ali argento.
Ricordo.
Avevo sette anni.
Il sole era ancora un frammento
sullo Jonio gravido e infame.
Si andava a pesca con mio padre e suo cugino.
Avevamo una barca blu striata di ruggine.
I Pesci Volanti ci attraversavano indifferenti.
Poi uno sbagliò traiettoria e mi colpì in volto.
Indolenzito, lo presi e lo ributtai in acqua.
Non era quello il modo di pescare.
Un colpo rapido e nel vento le lenze
e i pesci venivano su – surici alici sardi26.
Tornavamo a riva con la bacinella piena.
Ora al tramonto i pescherecci scavano il fondo27.
Le reti sono muri e prigioni e tradimento.
I fondali ribollono di strazio.
Non è questo il modo di pescare.
Non si vedono più pesci.
IV
Improvvisamente il bubble-feeding28, chiocciola
di bolle che cresce sul manto ceruleo del mare.
Ogni azione si compie nei meandri:
le prede avvolte, il soffio, il disegno
cilindrico e il rapido penetrarlo.
La salita: improvvisamente grattacieli
col rostro spalancato divorano e divorano.
È un caos magnifico.
Le Megattere29 sono massa alata che fluttua
e circumnaviga il firmamento marino; e sono madri.
Le Megattere hanno la gentilezza del giglio,
l’eleganza d’una colonna ionica; e sono madri.
Sono madri degli oceani e della memoria.
Memoria rappresentante la strage,
dove il buio si fa regola,
e la caccia30 e il suono d’una perforatrice
disorienta31 ed è morte sulla terra dell’uomo.
Memoria è il ritorno a casa,
la migrazione perfetta32;
plancton e l’uno che si moltiplica ed è vita
(una matriarca scivola sul manto ceruleo.
È geyser e pioggia,
è un terremoto sull’acqua
con la sua armatura colore notte e latte,
e un cucciolo gioca intorno
alla sua pinna caudale.
È l’uno che si moltiplica ed è memoria).
In questa città d’acqua e cristallo salino
prima madre e grembo e angelo degli abissi,
il primo canto tra i pianeti e i vulcani,
il primo volo, il breaching33 –
il cosmo che si erge dagli oceani primordiali.
Il Leviatano piroetta e il suo cadere
innalza al cielo lacrima e goccia.
Poi il lento disciogliersi, il fluking34
e il silenzio tragico di Dio.
V
Sul mio letto adolescenziale, i bagnanti
dormono sotto un diluvio di luce.
Il loro fisico è parte/è opera dello scenario.
Qui, dove ogni aggettivo si mescola.
Qui, dove ogni particella è
materiale plastico infinitesimale35.
I bagnanti amano la plastica.
Vivono su isole di plastica,
spiagge di plastica,
case di plastica
come eredità per la bambina e il Paguro36.
Io mi trovo disteso tra i bagnanti immobili
mentre il mondo mette in scena
il lamento dei Trichechi37, dei gommoni38,
mentre il ghiaccio si cancella nell’estate perenne39.
Forse ci hanno dilaniato le orecchie,
scavato gli occhi, giustificato ogni gesto.
Ti dico: non mi manca niente.
Anche se sono sempre più solo.
Ti dico:
dal fiume nasce e si sostiene la vita
e lungo il cammino il suo decesso40,
dighe e murature di poliestere.
Le mietitrici41 ingrassano la terra
ed è veleno che ingloba i contorni.
L’acqua si rannicchia nel dolore.
Cosa c’è di superiore a me?
VI
Adesso chiudo le persiane.
Giro e tolgo la chiave dalla serratura.
La notte ci afferra, facendo di noi
strutture iperboliche o ponteggi chilometrici
coi quali raggiungere nuovi corpi celesti.
Quale altro pianeta42?
Ho il potere di accartocciare il mondo.
Stringerlo nel pugno e annegare.
Non è quello che voglio.
Tu mi dici che abbiamo ucciso il mare,
che i bagnanti dormono, il Bimbo è arrabbiato43,
la Tartaruga Embricata44
incontra meduse di plastica e muore.
Non è quello che voglio.
Noi ci muoviamo dall’alto come Sterne codalunga45
in transito sui venti planetari.
Tu mi parli di una casa –
sfera blu che da significato al monocroma interstellare.
In questa casa io metto ordine;
il linguaggio si evolve nella pedoturbazione46,
nel mondo naturale – ancora.
Io ti guardo cullarti su un mantello dorato
tra gli arcipelaghi rosa del Mar dei Sargassi47.
T’innalzi sopra un’ecosistema variegato,
in cumulinembi48 che ti vestono di
lacrima e goccia / lacrima e goccia.
Io ti guardo diventare gabbiano
che rasenta l’oceano
al crepuscolo della vita terrestre.
Ecco il colpo d’ali che prelude la discesa
o il colpo d’ali che trafigge
il blu dell’aria in altezza.
In altezza ancora.
Ora merito la giustizia delle tue burrasche,
il lampo assassino del Falco predatore su di me.
Su di me io solo.
In una nuova era capovolta.
Anche se ancora sembra ieri.
Anche se non conosciamo digiuno.
È tutto meraviglia ancora.
NOTE AL TESTO
1 Il Fetonte codarossa, Phaethon rubricauda, è un uccello marino diffuso nelle aree tropicali dell’Oceano Indiano e Pacifico. Ha un colore candido, latteo. Il nome viene ripreso dalle sue lunghe penne timoniere che sono di colore vermiglio. Secondo la Red List dell’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) la specie non è in pericolo, ma stabile (LC).
2 Ištar è una delle più importanti divinità femminili della Mesopotamia, principalmente accado e sumera (dove viene chiamata col nome di Inanna). È la dea dell’amore e della fertilità, ma anche della guerra. Potremmo definirla una dea bipolare. Infatti alcune leggende parlano di lei come una donna amorevole, ma spietata e violenta sui campi di battaglia. Viene associata al pianeta Venere, stella ad otto punte ripresa anche dal Cristianesimo. L’animale sacro ad Ištar è il Leone, che ritroviamo su una delle otto splendide porte di Babilonia a lei dedicata. La sua città santa per eccellenza è Uruk (Warkah, in Iraq), dove era stato costruito un grande tempio assieme al dio del cielo, Anu. Quindi Ištar è la regina del firmamento e della terra, essendo insito in lei il simbolo di fecondità, di prosperità e futuro. Spesso è raffigurata con una veste, ornata da spighe di grano. Nei versi 6-7 cito la divinità per motivi riguardanti la terra e la sua vegetazione.
3 Secondo diversi studi pubblicati su Science nel 2015, ripresi dal lavoro svolto dalla goletta Tara che dal 2008 al 2013 ha solcato i mari facendo ricerca su 35 mila specie di microrganismi marini, gli oceani forniscono metà dell’ossigeno che respiriamo (l’altra metà è dovuta alle grandi e antiche foreste), assorbendo il novanta percento del calore prodotto dai gas serra e un quarto dell’anidride carbonica derivante dai combustibili fossili. L’aspirazione e il rilascio d’ossigeno avviene fondamentalmente grazie al plancton (lo vedremo tra poco). Effettivamente, i mari svolgono un grande processo di pulizia che aiuta la nostra specie a sopravvivere in condizioni permissibili e durature. Ma le dinamiche stanno mutando: nell’ultimo secolo e mezzo abbiamo immesso nell’aria una percentuale maggiore di combustibili fossili (circa il trenta percento in più dalla Rivoluzione industriale) che stanno sconvolgendo non solo il clima, ma anche gli oceani. Acidificazione (vedi nota 12), mutamento delle correnti marine, innalzamento dei mari (vedi nota 37), inquinamento plastico (vedi poesia V e nota 33), distruzione della biodiversità e degli ecosistemi marini (vedi poesia II e nota 11). Per non parlare degli stock ittici, l’impatto devastante della pesca sull’ambiente marino (vedi poesia III e nota 27). Tutti questi elementi comportano degli scompensi generali che vanno a corrompere e disgregare quel sistema ancestrale che ha permesso alla vita di formarsi e prodursi dall’Olocene ad oggi.
4 È un qualcosa di spettacolare pensare che esistano dei microrganismi sulle acque superficiali e poco profonde (massimo duecento metri), sia marine che d’acqua dolce, che fissano l’azoto gassoso dell’atmosfera e lo riconvertono in una nuova forma utile ad altre specie. È proprio come un giardino – che io intendo come spontaneo e selvaggio; qualcosa che si avvicina ad una foresta – ricco di diverse tipologie di piante che contribuiscono alla sopravvivenza di varie specie di animali, compresa la nostra. Tra le specie più importanti che riscontriamo in questo giardino acquatico, troviamo il plancton. Questi esseri microscopici sono alla base della catena alimentare del mare e, sempre leggendo le ricerche svolte dalla goletta Tara, scopriamo che sono formati da oltre quaranta milioni di geni. Noi esseri umani ne abbiamo solo venti mila. Come evidenzio nei versi 12-13, esistono varie specie di plancton: quelli batterici (Batterioplancton), quelli vegetali (Fitoplancton) e quelli animali (Zooplancton). Ricordiamoci che oltre a rilasciare ossigeno, sono l’alimento principale di molti esseri viventi (come citato nei versi 14-15) e la loro scomparsa potrebbe essere fatale non solo per noi, ma anche per molti cetacei e pesci. Diversi studi recenti dimostrano che il plancton ha una buona resistenza all’aumento di calore prodotto dal cambiamento climatico antropico. Ma è stato anche scoperto che non tutte le specie hanno lo stesso tipo di adattamento. Alcune migrano o muoiono. È questo diviene un grosso problema per gli animali acquatici che potrebbero non trovare più nel proprio areale il loro alimento base. Bisogna comprendere che è una catena. In modo tragico: se la punta si rompe, consegue la morte di ogni segmento, uno dopo l’altro.
5 I Copepodi sono una numerosa classe di crostacei di piccole dimensioni (dai due ai duecentocinquanta millimetri). Si trovano praticamente in tutti gli habitat acquatici terrestri. Possono avere colori variopinti e fosforescenti. Sulla superficie marina partecipano alla formazione del plancton e sono alimento principale di molti pesci e mammiferi marini. Si cibano anch’essi di plancton, ma anche di alghe e detriti organici. Alcuni di essi conducono una vita parassitaria sui pesci o altri animali acquatici.
6 Il Capodoglio è un mammifero marino incredibile e di dimensioni spettacolari (adulto: dodici metri). Ripreso in molte leggende religiose come mostro marino crudele, o in diversi saggi romanzati (il più famoso: Moby Dick, di Melville) mostrandolo sempre come un essere abominevole e assassino; il Physeter macrocephalus è un Odontoceto solitario ed unico. Ha una colossale testa squadrata e può immergersi a profondità proibitive, fino a tre chilometri sotto la superficie, dove caccia grandi Tetidi (molluschi senza conchiglia) sfruttando il suo organo dello spermaceti come strumento di ecolocalizzazione nel buio. Sono cosmopoliti. Cacciati barbaricamente nell’ottocento, come tutte le balene, per la carne e lo spermaceti (utilizzato per fabbricare le candele o come combustibile per le lampade ad olio), fino agli anni settanta se ne stimavano intorno ai due milioni d’esemplari. Recentemente solo trecento mila.
7 John Taggart è un grande poeta americano. Molto attento alla questione ambientale, la sua poetica è una commistione tra testo e musica, detto additive rhythm, tra gli andamenti del jazz e la musica minimalista, per citarne uno, di Philip Glass. La ripetitività di alcune parole o di interi versi, come dice lo stesso autore, servono a far penetrare il lettore in profondità nel testo, nella commistione tra suono e significato.
8 <<Senza memoria non c’è protezione>>, J. Taggart, dalla poesia “Museo dell’auto” (Pastorali, Vydia Editore)
9 La possente Sultanahmet camii, meglio nota come Moschea Blu, è una delle più importanti moschee presenti ad Istambul, Turchia. Costruita nel XVII secolo, è l’unica ad avere sei minareti, superata solo dalla mosche della Ka’ba, la Mecca, che ne ha sette. Viene definita Moschea Blu per via della presenza di ben 21.043 piastrelle di ceramica turchese provenienti da Iznik, l’antica Nicea, che compongono le pareti e la cupola dell’edificio. Per via di questa splendida colorazione, la inserisco come metafora sul cielo.
10 Il Beluga è il colore bianco fatto cetaceo. È un animale socievole, che vive in gruppo nei mari polari (Alto Artico) e si contraddistingue per la grande flessibilità del collo, della testa e delle labbra, e per le sue melodiose vocalizzazioni. Lo identifico con la purezza, essere paradisiaco, un qualcosa che ci offre calma e stupore. Inoltre, in questo caso, la purezza è vista anche come elemento di nitidezza del mare, un essere che col suo candore ripulisce la sporcizia accumulatasi nei decenni negli oceani di tutto il Pianeta, ridandogli enfasi al suo passaggio. Per via della loro socialità e della loro flessibile anatomia, vengo catturati e fatti esibire nei parchi acquatici; come avviene anche per i delfini e le orche. Negli ultimi anni, con una nuova sensibilizzazione da parte dei cittadini, gli scienziati e gli ambientalisti stanno cercando, insieme alle autorità, di liberare questi animali dal gioco dell’uomo. A giugno del 2019, in Russia (dove si concentra la maggioranza di questi esemplari in cattività), sono stati liberate due orche e sei Beluga. Sempre in Russia, nel 2017, è stato avvistato un Beluga che trasportava sul corpo un’imbracatura definita “un equipaggiamento militare”. Degli esperti sul Guardian hanno spiegato che la balena potrebbe far parte di un programma che usa i mammiferi marini come forza speciale o come arma nelle acque polari. Non sappiamo ancora se questa ipotesi sia vera. Fa comunque tristezza immaginarlo.
11 (Questa nota costituisce un racconto che comprende tutte le note della poesia II)
La stanza è collocata nell’ultimo piano dell’edificio. Non ce ne sono altre: il lungo corridoio evidenzia dei segni squadrati di altre porte ormai murate. In città si diceva che ci buttavano dentro i prigionieri, per poi murarli dentro. Doveva essere come un’espiazione, una stanza dove riflettere e concepire la morte. Una morte crudele, senza cibo e senza acqua – soprattutto ora che è tutto razionato. Spero che questa pratica punitiva non sia più in funzione, perché questo vorrebbe dire che è il mio turno. Io mi trovo nell’ultima stanza accessibile. Al fondo del corridoio. Non so come fossero composte le altre: qui dentro c’è una scrivania e due sedie; un sacco a pelo in un angolo. C’è un water e un lavandino in uno stanzino di cartongesso. Ma non c’è acqua. Da una finestra con le inferriate, si vede un cielo grigio e alcuni edifici colorati, ma sicuramente grigi anch’essi all’interno. Ormai non vive più nessuno in questo quartiere. Sono qui da due giorni. Dopo che mi hanno rinchiuso dentro, non ho visto persone né udito voci fino a questo momento. Ora davanti a me si trova un agente che dice di chiamarsi Tuma e che ha delle domande da pormi. Potevano anche farmele ieri o il giorno stesso del rapimento. Ora ho solo fame. Dice: Non abbiamo tempo da perdere. Siamo alla fine del processo. Vogliamo solo un disegno con i colori. Vogliamo ricordarne i colori. Sappiamo che lei è stato uno degli ultimi a vederli. Siamo disposti a pagarla bene. Pagarmi bene? Ormai sono un morto tra i morti di questo piano. Io so cosa vogliono. Il mondo è mutato. Sapevano l’anno e la data. Ma hanno comunque lasciato che tutto andasse a fanculo. Ora sono pentiti. Ora vivono in una condizione di perenne senso di colpa. E questa sensazione mette ansia e frustrazione. Non sanno dialogare. Ora vogliono risolvere tutto clonando; riforestare dentro a gigantesche serre (perché ormai chi ha il coraggio di respirare l’aria fuori?). E soprattutto vogliono zittire coloro che conoscono il passato. Le nuove generazioni devono crescere in questo mondo. Non ne è mai esistito un altro. Ma noi morti in questo piano siamo i reduci; o almeno lo eravamo. Io sono l’ultimo. Non ho provato a nascondermi. Avrei solo perso del tempo. Volevo ritrovarmi qui, esprimermi finalmente, dire come tutto è andato storto. Dico: Noi vi avevamo avvertiti che la lenta morte delle barriere coralline era un segnale. Un segnale per tutto il Pianeta. Quel bianco non era naturale (nota 11). Era morte. Morte di un’ecosistema e della biodiversità degli oceani. Ogni reef, come viene definita in termini tecnici e anglosassoni la barriera corallina (nota 18), è un’insieme di organismi viventi che tra i coralli trovano riparo e sostentamento (nota 14). L’annientamento di questo cerchio è la morte di un intero mondo. Eppure era chiaro fin dal principio: i coralli morivano per via del surriscaldamento climatico prodotto dall’uomo che innalzava le temperature marine troppo rapidamente. Le Zooxanthelle – le alghe simbionti dei coralli; la loro principale fonte di cibo (nota 19)- vanno in escandescenza, diventano tossiche e costringono i coralli ad espellerle. Questo determina lo sbiancamento dello scheletro, mettendoli a rischio di morire di fame (nota 12). Dal primo sbiancamento di massa avvenuto nel 1998, questo processo non si è mai fermato, provocandone un altro nel 2010 e uno ancora più lungo tra il 2014 e il 2017 (nota 16). Fino all’ultimo, quello definitivo. Inizialmente non tutti erano morti. Anzi, ci si era accorti che se acque calde più della media giungevano in modo altalenante, i coralli riuscivano a prepararsi, come se avessero una memoria, e riuscivano a proteggersi dalle ondate più aride e durature. Questo era successo pure nel Queensland, in Australia (nota 15), dove si trovava la più grande barriera corallina del Pianeta. Ma questo esercizio ha funzionato fin quando non è morto pure il mare. Bisogna capire quali furono i fattori conclusivi: le temperature vulcaniche che hanno soffocato ogni habitat, generando zone morte (assenza di ossigeno e, quindi, luogo inospitale per ogni forma animale) sempre più profonde (nota 17); la conseguente acidificazione (nota 13), dovuta all’aumento della Co2 assorbita che, a contatto con l’acqua, reagisce chimicamente producendo acido carbonico che abbassa il PH marino ed è declino per i coralli, i molluschi ed i crostacei; i rifiuti e la plastica soffocante e assassina; il disfacimento dell’ecosistema marino dovuto alla pesca eccessiva; e l’estinzione funzionale: non c’è nell’ambiente più il numero necessario di animali e piante per influire sul suo funzionamento. Finito. E ora lei vuole da me un bel disegnino della struttura dei coralli? Ho visto gli ologrammi dei delfini sul Mediterraneo. Ho mangiato le acciughe ricreate in laboratorio. Sono stato nel centro dove vengono ricreati meccanicamente tutti i cetacei e i predatori del mare. Ma non è la stessa cosa. Non può funzionare così. Lui non batte ciglio. Mi dice soltanto che vuole un disegno. Sì: loro vogliono portare il mare in ogni città. Che ogni scuola abbia un acquario con uno splendido Squalo Martello o un Pesce Luna. Certo, ora che gli oceani si sono innalzati e hanno inghiottito milioni di coste e di città, tutto è blindato e fuori gioco. Adesso è divertente essere Dio. Ma per noi che siamo nati con la complicità della natura, tutto questo è pura follia, totale umanizzazione del Pianeta. Un pianeta che sta per uccidere tutti. Viviamo dentro una bomba. Non sono sufficienti, ad esempio, gli apparecchi che assorbono l’inquinamento che i condizionatori accessi perennemente in ogni luogo abitato producono. Anche se siamo passati all’età della ceramica e del vetro, il cemento ormai ha fatto il suo corso. E così il petrolio, le guerre, i materiali di plastica sparsi ovunque. Siamo rimasti in pochi. Questo mondo non piace a nessuno. Ma che colpa hanno i giovani oggi? Ora che il passo è deceduto insieme alla coscienza e agli elefanti, cosa ne sanno i robot che insegnano in classe o che preparano la colazione agli orfani dei bassi ceti sociali? Dico: Ecco il suo disegno. Non lo faccio perché ho paura di morire. Lo faccio perché provo pietà per lei che non ha mai visto niente di così bello e così unico. Forse lei è uno di quelli che ha provato ad esplorare nuovi pianeti. Forse è uno di quelli che è rimasto deluso dal niente che ci circonda. Ma forse non sa neppure cos’è una foresta pluviale o un’insalata di polpo. Prende il foglio. Lo vedo guardare nostalgico e felice i miei disegni. Starà rimpiangendo qualcosa? Mi dice: Grazie. Gli dico: Non ho finito. Quello è solo l’estetica, la struttura interna è più complicata e va evidenziata in dettaglio. Mi dice: Non si preoccupi, a noi basta questo. Abbiamo creato una nuova attrezzatura che riesce a estrapolare il suo pensiero e, in questo caso, i suoi studi dal tratteggio del disegno. Ho un brivido. Conclude: Grazie ancora. Lei è libero. Dico: Libero? E perché? Mi risponde con un mezzo sorriso: Le ho già detto all’inizio che l’avrei pagata bene. Inoltre lei è l’ultimo rimasto. Non può avere alcuna influenza sulle persone e sul pianeta che stiamo progettando. Dicendo questo, apre la porta e mi lascia al mio posto. Sono indeciso. Suicidio? Aspettare che tutto crolli? Accettare quello che creeranno e andare avanti fino all’infinito? Voglio andare a vedere il mare. Quello vero. Quello che ho sempre amato. È quello che desidero. Anche se durerà poco. Anche se dopo la barriera l’aria mi brucerà la pelle. Voglio morire lì. Dove tutto è iniziato. Ed è finito.
20 Come noi esseri umani, anche gli animali respirano. E così i pesci e i microrganismi che compongono gli oceani. L’ossigeno in mare viene prodotto negli strati superficiali, soprattutto dall’attività fotosintetica delle alghe, e viene fatta circolare dalle correnti oceaniche. Quest’ultime sono molto importanti perché spostano l’ossigeno in zone molto profonde. È un processo lento, quindi è naturale trovare una maggior quantità di pesci vicino alla superficie (zona eufotica: ottima presenza di luce solare che aiuta la fotosintesi sia vegetale che batterica) che a migliaia di chilometri di profondità (zona afotica: mancanza di luce solare). In queste zone molto profonde vivono diversi pesci strani e “il tutto si fa adattamento e silenzio” (vedi nota 21). Come ho già anticipato nel racconto precedente, riguardante la poesia II, negli ultimi anni si sono autoprodotte delle zone morte sia nelle acque dolci che nelle acque marine, dovute all’aumento delle temperature e all’accumulo di Co2 nei mari di tutto il pianeta (più ne assorbono e più diventano acidi). Questo distrugge il ciclo naturale del processo di entrata ed uscita, portando ad uno scompenso generale, che sembra anche intaccare il movimento delle correnti oceaniche, modificando e indebolendo la loro stabile e stagionale circolazione.
21 Il Chaulidus è un pesce abbastanza brutto. Per il suo aspetto è definito vipera del mare. Vive nelle acque batiali (cioè profonde tra i duecento e i duemila metri; poi neanche tanto profonde visto che quella abissale è ancora più in profondità. Successivamente abbiamo quella adale, che si aggira intorno ai sei mila metri, e si conclude tutto con la fossa oceanica; la più profonda è quella delle Marianne, nell’Oceano Pacifico, dove il punto massimo, il Challenger, tocca gli undici mila metri). Nei versi riguardanti il Chaulidus dico: “diviene stella per uccidere”. Essendo una zona non raggiunta dal sole (vedi nota 20), questi pesci si sono dovuti adattare all’ambiente circostante, quindi sono diventati bioluminescenti, grazie ad organi fotofori (che producono luce) situati lungo il ventre.
22 Il Regaleco o Mostro abissale o Re delle aringhe, (secondo una leggenda marinara la sua presenza annunciava l’arrivo di banchi di aringhe), è un pesce osseo lungo anche dieci metri di un bel colore argenteo, con un ciuffo rosso fiammante sulla testa. Vive tra i cento e i mille metri (zona mesopelagica), principalmente tra l’Oceano Atlantico e quello Indiano. È un pesce migratorio e si ciba principalmente di Krill o piccoli molluschi.
23 Nella basilica di Aquileia, in Friuli-Venezia Giulia, fatta edificare dal vescovo Teodoro nel IV secolo d.C., nella quarta campata troviamo un mosaico raffigurante “Giona che viene sputato dal mostro”. Giona è un profeta ebraico dell’Antico Testamento, dove si trova il “Libro di Giona”. Secondo il testo Giona viene mandato da Dio a predicare a Ninive. Giona invece fugge verso Tarsis, ma questa disobbedienza comporta l’ira divina e durante il viaggio una tempesta sconvolge la nave e rischia di affondarla. Giona ammette il suo tradimento e i marinai decidono di buttarlo in mare. Una volta in acqua viene inghiottito da un mostro marino che, in base alle immagini raffiguranti la scena (come quella del mosaico della Basilica di Aquileia), sembra proprio un lungo Regaleco. Giona, dopo tre giorni al suo interno, viene rigurgitato vivo sulla spiaggia e va ad adempire al suo compito di predicazione. Questa scena è ricorrente nelle raffigurazioni cristiane, perché Giona viene resuscitato come Gesù dalla Croce. Quindi abbiamo il Regaleco e un Giona che chiede il perdono divino per vivere ancora (“chiedere luce”).
24 Le Stenelle dal lungo rostro, (anche se non specificato nella poesia, descrivo questa determinata specie), sono mammiferi marini della famiglia dei Delfini. Hanno un complesso livello tassonomico, con molte varianti tra le diverse popolazioni dell’Oceano Atlantico, Pacifico e Indiano. Sono difficili da identificare e studiare, ma si è notato che hanno tutti comportamenti acrobatici e che sono molto socievoli tra i vari gruppi. Sono gregari e capita talvolta di vederli nell’oceano in raggruppamenti di migliaia di individui. Si cibano principalmente di piccoli pesci mesopelagici.
25 Exocoetidae sono i pesci ossei che noi comunemente chiamiamo Pesci Volanti o Pesci Rondine.
26 Pesce pettine, Aringa e Sardina, in dialetto calabrese. Solo un piccolo commento per il Pesce pettine: è un pesce tipico della cucina calabrese. In effetti, questa specie è diffusa nel Mar Mediterraneo e nella zona centrale e alta dell’Oceano Atlantico. È di un colore giallo/cremisi con sezioni argentee. Mi è capitato spesso di vederlo nelle mie lunghe nuotate e immersioni. Da piccoli si cercava di prenderli a mani nude. Ma sono rapidi: restano immobili e appena allunghi la mano scompaiono, invisibili sul fondo sabbioso. Tornavo su sconfitto, non sapendo che invece erano lì, appiatti e mimetici, a guardarmi andare via. Ma questo sotterfugio non funziona con i pescherecci e le loro immense reti (vedi nota successiva). Da anni, nuotando, non ne vedo più.
27 È stata una strage veloce e che continua tutt’ora. Non c’è una mezza misura: nel mondo vengono pescati oltre novanta tonnellate di pesce all’anno. Secondo i dati FAO (2016) un terzo degli stock ittici sono eccessivamente sfruttati. Nel Mediterraneo, a casa nostra, si arriva a punte del novanta percento. Bisogna comprendere che la pesca contemporanea raccoglie un numero superiore di specie rispetto alla naturale capacità di riproduzione (capita di pulire del pesce e trovarci nel ventre delle uova o dei pesci minuscoli). Questa industrializzazione della pesca è violenta e indiscriminata. Per via delle reti a strascico, lunghe anche chilometri e che scavano i fondali distruggendo il benthos (gli organismi acquatici che vivono in contatto con il fondo, sia liberi o fissati a qualche roccia o substrato solido, come le barriere coralline), viene imprigionato e ucciso qualsiasi tipo di pesce e mammifero marino che si trova in quelle acque. Tutto questo sta portando all’estinzione di molti animali marini, come gli squali o i pesce spada. Un altro problema è la pesca d’allevamento. Un tonno ha bisogno di quindici chili di pesce al giorno per vivere. Ma questi quindici chili non vengono da pesci che solcano i mari, ma dal mangime. In Paesi dell’Africa occidentale come il Senegal, la pesca industriale di ingenti quantità di piccoli pesci pelagici serve a produrre farine e oli che finiscono nei mangimi per gli allevamenti intensivi. Quindi non sono più pesci per l’alimentazione della popolazione locale, ma polverina per l’industria mangimistica (trovate queste farine e questi oli anche nelle crocchette o nelle bustine del cibo destinato ai gatti). Inoltre, l’allevamento e la pesca non producono quel sistema dove la produzione si sviluppa in base alla domanda, ma si forma sui numeri, la quantità, e la concorrenza; questa dinamica mi fa venire in mente i boss della ‘Ndrangheta che invece di contare, pesano i soldi e cercano di ostacolare – fino alla morte – le famiglie concorrenti nei propri affari, senza badare a cosa tutto ciò comporta. Quindi: noi non mangiamo i delfini o gli squali martello, ma se finiscono uccisi nelle reti: a chi importa? Se gli africani restano senza pesci per sfamare le orate in gabbia nel tirrenico: a chi importa? Negli ultimi anni c’è stato un leggero ribasso nel numero del pescato, non per via di leggi comunitarie o per un’inversione di rotta dell’industria ittica, ma perché si è riscontrata una diminuzione del pesce globale. Si pesca meno pesce. Da diversi anni, al tramonto, vedo grandi imbarcazioni solcare il mare. Fanno avanti e indietro. Finiscono di tirare su e rientrano in porto. Una volta era bello svegliarsi presto e andare a pescare. Trafiggevi il verme con l’amo e lo lanciavi in acqua, e stavi lì a sentire i discorsi degli adulti. Io ho sempre cercato di prendere i Pesci Volanti al volo. Poi uno ha preso me. Ed è stata una scena esilarante. Dopo averlo messo in mare, l’ho visto scomparire nella luce del giorno che cominciava ad assorbire ogni ombra.
28 Il bubble-feeding (o bubble net) è una tecnica di caccia usata da diversi cetacei. Come descrivo nella poesia IV, (in questo caso) la Megattera si alimenta, da sola o in cooperazione, di krill o piccoli pesci che cattura con immersioni poco profonde, compiute a spirale sotto banchi di prede, avviluppandole in una “rete di bolle” larga fino a quarantacinque metri e inghiottita nuotandovi attraverso in velocità. Questo è il bubble-feeding.
29 La Megattera è l’animale che più ammiro, offrendomi un continuo sentimento di grandezza e tenerezza. Animali enormi (tra i sedici e i diciotto metri), compiono grandi acrobazie in superficie. Hanno delle pinne pettorali incredibilmente lunghe e una pinna caudale con bordo seghettato. Il bianco sul lato inferiore della coda è unico per ciascuno animale. Compiono delle migrazioni lunghissime e vivono fino a cinquant’anni. Spero un giorno di poterci nuotare accanto.
30 Come già abbiamo detto, i cetacei sono stati animali uccisi barbaramente e sistematicamente. Si è quasi arrivati all’estinzione di molte specie – e molte di esse non si sono mai riprese e sono tutt’ora in declino. A fine ottocento, si contavano oltre un milione di Megattere. Oggi la stima varia tra le trentatre e le trentacinque mila. Anche se sono protette dagli anni cinquanta, il problema per la loro sopravvivenza non è più la caccia ma le reti da pesca, la plastica, le grandi imbarcazioni e le perforazioni petrolifere in fondo al mare (vedi nota successiva).
31 1) Le reti da pesca, quando non sono più utilizzabili, vengono scaricate in mare. Questa noncuranza può far sì che una rete si arrotoli ad una pinna pettorale o a quella caudale, complicando il nuoto ad un mammifero marino; 2) negli ultimi anni sono stati trovati nello stomaco di balene spiaggiate, diversi chili di prodotti plastici, che in alcuni casi potrebbero aver provocato la loro morte; 3) le grandi imbarcazioni che a milioni, (vi consiglio di andare a vedere il sito Marinetraffic.com, che mostra in tempo reale tutte le navi presenti negli oceani del Pianeta), solcano le acque rilasciando in acqua spazzatura, reti, liquidi di scarico, benzina. Spesso collidono con le balene. Uccidendole. Ancora peggio il rumore che il motore produce e che va ad interferire con i canti dei cetacei e disturba la loro ecolocalizzazione. Disorientandoli e, in molti casi, spingendoli verso la riva, dove vanno a spiaggiarsi; 4) questo vale anche per le perforatrici che bucano i fondali con macchinari potenti e rumorosi alla ricerca di gas e petrolio.
32 Le Megattere compiono delle lunghissime migrazioni stagionali, fino a sedicimila chilometri: dalle acque fredde, dove si alimentano in primavera/estate, fino alle acque tropicali in cui nei mesi invernali si accoppiano, si riproducono e, in genere, non si nutrono. Nella poesia associo la migrazione alla memoria, all’incredibile capacità di ripercorrere lo stesso tracciato – andata e ritorno – tramandandolo, contro ogni intemperie naturale e antropica.
33 Il breaching è il comportamento di balene, delfini e alcune focene, che a volte si lanciano in aria con la testa in avanti e ricadono in acqua in un tuffo. Io lo interpreto come come un gesto di gioia.
34 Il fluking (o Fluke-up) è il sollevamento in aria della coda di un cetaceo per facilitare l’immersione in profondità.
35 La poesia V parla del mondo di plastica nel quale ci troviamo a vivere. Oggi sappiamo che non esiste luogo del pianeta non contaminato da questo materiale – che si frantuma e diventa sempre più piccolo, infinitesimale. Cominciamo a dire che noi produciamo globalmente ogni anno trecentotrenta milioni di tonnellate di plastica, delle quali solo il quindici percento viene riciclato, mentre un venticinque percento viene bruciato negli inceneritori e il restante sessanta percento finisce nelle discariche o bruciato all’aperto (dati OCSE). È un problema serio. Ogni hanno finiscono in mare tra gli otto e le quindici milioni di tonnellate di plastica. E se una bottiglia di plastica ci mette tra i quattrocento e i cinquecento anni per decomporsi, significa che ogni anno stiamo accumulando una quantità gigantesca di plastica che non scomparirà mai.
36 Alcune volte, mentre guardo immagini delle piramidi d’Egitto, mi capita di domandarmi che cosa stiamo lasciando ai bambini di domani. Non so perché mi succeda quando guardo le piramidi – sarà che sono lì da migliaia di anni? Sarà la loro grandezza e magnificenza? Comunque sono una dimostrazione della nostra Storia. E quando mi pongo questa domanda, se c’è qualcosa che veramente lasceremo ai prossimi millenni, la risposta è sempre la stessa: la plastica. Negli ultimi secoli non abbiamo prodotto nient’altro di così duraturo e persuasivo. La plastica è dappertutto: dai filtri delle sigarette, ai giocattoli dei bambini fino agli arredamenti o al computer che sto utilizzando per trascrivere dal quaderno questa poesia. Inoltre per via delle correnti marine, negli ultimi cinquant’anni si sono formate delle vere e proprie isole di plastica. La più grande è la Great Pacific Garbage Patch, le cui dimensioni equivalgono tre volte la Francia, contenendo oltre ottanta mila detriti di plastica. Di queste isole ne sono state ritrovate, di misura inferiore, anche nel Mediterraneo e nel Tirreno. Questi luoghi sono diventati delle vere discariche. Credo che tutti noi abbiamo visto almeno un video sulle tartarughe incastrate nell’anello di plastica di una confezione di lattine o interamente intrappolate dentro a delle reti da pesca fatte anch’esse di plastica. Sono scene direi violente per via della crudeltà inferta dall’incuranza e dalla maleducazione umana. Un danno ulteriore e maggiore è dovuto alle buste di plastica. Quando queste finiscono in mare, galleggiano, galleggiano a ridosso della superficie. E galleggiano in un modo spaventosamente simile al nuoto di una medusa. La medusa è il piatto preferito delle tartarughe. Molte tartarughe sono state trovate morte con il tratto intestinale bloccato dai sacchetti di plastica. È una fine oscena. Molti uccelli marini sono stati trovati morti con all’interno dello stomaco tappi di bottiglia o frammenti di plastica colorata. Scambiano tutto per cibo. O per casa. Il Paguro è un crostaceo con un addome molle. Per proteggerlo ha bisogno di una struttura che trova sparsa sulle spiagge di tutto il Pianeta: la conchiglia. Ma non più. Da alcuni anni si è riscontrato un aumento di Paguri che invece delle conchiglie, si vestono di tappi dei flaconi di plastica (a maggio del 2019 è stato avvistato un Paguro all’interno della testa di una bambola). Succede spesso che i bagnanti raccolgano le conchiglie per tenerle sul camino, lasciando i rifiuti sulla battigia. Oltre al danno, la beffa. Così i Paguri cercano casa tra la spazzatura. Una mutazione adattiva. Ecco un esempio di quel che lasceremo.
37 Come vedremo meglio più avanti, i ghiacciai – per via del surriscaldamento climatico – si stanno sciogliendo molto rapidamente. Questo drastico mutamento, oltre a innalzare il livello dei mari (i dati sono controversi visto i diversi fattori da misurare, le variabilità climatiche e antropiche; comunque la stima oscilla tra i novanta centimetri, dati NASA, e i duecento centimetri, dati IPCC, entro il 2100), destabilizza il clima e il paesaggio locale, disorientando e affamando la fauna presente in quei determinati habitat. La storia dei Trichechi è molto semplice e macabra. Iniziamo a dire che i Trichechi sono dei mammiferi marini pinnipedi con i baffi, due lunghe zanne e un peso che può arrivare ai due quintali. Sono animali possenti e gregari, che vivono nel mar Glaciale Artico e nei mari subartici dell’Emisfero Boreale. Nel periodo estivo si spostano verso la banchisa dove possono trovare molluschi e crostacei, alimenti base della loro dieta, prima di spostarsi nelle grandi placche di ghiaccio per partorire e allevare i cuccioli. Negli ultimi decenni però il paesaggio glaciale è molto cambiato. In estate la temperatura supera lo zero, riducendo la superficie ghiacciata, lasciandola scoperta. Quindi i trichechi hanno cominciato a spostarsi verso la scogliera, ammassandosi sulle rocce. Nei quattro anni voluti alla troupe di Netflix per girare il documentario Our Planet, gli scienziati e i cameraman hanno fatto una scoperta sconcertante: molti trichechi, per il poco spazio, erano costretti a spostarsi verso le creste più alte. La vista fuori dall’acqua per un Tricheco è scarsa e da quelle altezze è difficile comprendere le distanze. Però può percepire che sotto ci sono altri suoi simili. Quando un Tricheco comincia ad avere fame, per alimentarsi, deve tornare in acqua. Le immagini hanno ripreso centinaia di Trichechi lanciarsi dalla scogliera e morire sulle rocce. Si erano già visti casi del genere nel passato, ma mai un numero così elevato. Questo ha portato alcuni scienziati a dubitare che fossero episodi dovuti al cambiamento climatico. Sicuramente è certo che il ghiaccio si sta ritirando e che molti animali e umani (i Trichechi sono la dieta di molti popoli dell’Alaska e della Groenlandia) stanno subendo questo sconvolgimento sempre più lungo ed estremo.
38 Sulla questione migranti non voglio tirarla per le lunghe: ne ho già discusso in altre sedi e con diversi mezzi, sia testuali che fisici. È certo che ci stiamo comportando come delle bestie, cattivi per convenienza politica e volontaria ignoranza. Concludo subito riportando due dati: si stima che le morti accertate nel Mediterraneo oscillano intorno ai 35 mila e che per via del cambiamento climatico si muoveranno oltre centonovanta milioni di persone. Soprattutto dalle zone più povere. Non c’è alternativa all’accoglienza e alla condivisione.
39 Una delle conseguenze più importanti del cambiamento climatico è lo scioglimento dei ghiacciai. Questo avvenimento è dovuto alla concentrazione atmosferica di gas serra in aumento costante. Ciò è dovuto alla deforestazione e all’uso massiccio di combustibili fossili, ovvero carbone, petrolio e gas. L’aumento di gas serra provoca l’innalzamento della temperatura del Pianeta e lo scioglimento dei ghiacci. Il processo di scioglimento provoca e provocherà (si stima un’ulteriore aumento di due metri) un innalzamento di tutti gli oceani (dal 1910 è aumentato di venti centimetri). Inoltre ci sarà meno acqua dolce disponibile e di conseguenza più siccità e carestie soprattutto nel Sud del mondo con conseguente migrazione verso il Nord più ricco e con maggiori mezzi per mitigare i disagi. Quando parliamo di gas serra, intendiamo la concentrazione elevata di CO2 (Anidride Carbonica) e di altri elementi inquinanti come il Metano(CH4), il Diossido di Zolfo (SO2) o i Metalli Pesanti come il Piombo nell’atmosfera. Secondo l’ultimo dato riportato dalla NOAA (la National Oceanic and Atmospheric Administration), il 22 luglio abbiamo toccato le 411 ppm (parti per milioni). L’ultima volta che la Terra registrò simili livelli era il Pliocene, tra i tre e i cinque milioni di anni fa. Questa enorme concentrazione di agenti inquinanti nell’atmosfera, non venendo completamente assorbita dai vari elementi naturali del Pianeta (piante, mari e suolo), si accumula e surriscalda l’aria provocando l’innalzamento delle temperature. Perdere il permafrost o le vette innevate più alte significa morte per la fauna locale, minor apporto idrico per milioni di persone e per l’agricoltura, innalzamento dei mari e conseguente scomparsa dell’odierna linea costiera, migrazione forzata, guerre per accaparrarsi le ultime fonti d’acqua dolce. Questa è una spiegazione molto riduttiva, ma spero utile a comprendere il perché questo fenomeno avviene e perché è così rischioso per ogni forma di vita sulla terra.
40 Come ho già scritto, il materiale plastico si trova in ogni angolo della Terra. La maggior parte della plastica in mare arriva dai fiumi che percorrono i continenti (mentre un quinto della plastica è gettato in mare da pescatori, navi e piattaforme petrolifere). Uno studio intitolato Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea ha rivelato che delle 4 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno vengono trasportate dai fiumi al mare, fino al 95 per cento viene da appena dieci fiumi. Questi fiumi si trovano quasi tutti in Asia, tranne per il Nilo (Egitto, Africa) e il Niger (Golfo di Guinea, Africa). In Asia troviamo un’alta densità della popolazione e con una gestione dei rifiuti quasi inesistente. Inoltre, alcuni paesi asiatici (Cina, Malesia, India, Indonesia) sono stati per anni – e alcuni di essi continuano ad esserlo – il porto di approdo della plastica sporca (ad esempio, unta da olio di motore o vaschette d’asporto o residui di medicamento) o non suddivisa per tipo o rivestita da altro materiale. La plastica viene trasferita in questi paesi che dopo averla selezionata e pulita, dovrebbero ridurla in granuli per essere riciclata. Però non si sa bene se questo processo molto costoso venga effettuato correttamente. Da ricordare anche che il problema della plastica non è costituito solo da oggetti visibili come sacchetti, bottiglie e contenitori, ma anche da microframmenti, insieme alle microsfere contenute in esfolianti e altri cosmetici. Dai fiumi sgorga la vita come la morte. Se dalla sorgente l’acqua nasce limpida, nel suo percorso incontra dighe, canali artificiali, impianti idroelettrici, scarichi da industrie di vario genere e plastica, quintali di cannucce e bicchieri e pezzi di frigoriferi.
41 L’agricoltura del XX e del XXI secolo è stata principalmente un processo concentrato sulla monocoltura. Vasti terreni adibiti ad un solo tipo di cereale o arbusto. È una dinamica che continua a crescere: stiamo distruggendo intere foreste millenarie per la produzione di singoli elementi, usati a scopo foraggiero e alimentare. L’Amazzonia continua ad essere deforestata non solo per scavare miniere di carbone e diamanti, ma soprattutto per coltivare soia (ogni anno vengono distrutti oltre un milione e mezzo di ettari per produrre un cereale di cui il settantasei percento viene usato per l’alimentazione degli animali). L’industria dell’olio di palma è una altro dramma: solo in Indonesia, in dieci anni, si sono persi oltre sei milioni di ettari di foresta tropicale. Oltre al problema della deforestazione, per far sì che la produzione sia costante, dagli anni cinquanta in poi c’è stato un bombardamento costante di pesticidi e fertilizzanti. La terra ha bisogno di riposo e di nutrienti. Il continuo lavorarla la rende arida e sterile. Il paesaggio viene ucciso dal mais. Molti di questi pesticidi e fertilizzanti sono idrosolubili, penetrano in profondità nel terreno e raggiungono le acque sotterranee, dando forma a casi di inquinamento delle falde acquifere. Significa che l’acqua non è più potabile né utilizzabile per l’irrigazione. Molti pesticidi non sterminano solo i parassiti, ma possono essere anche nocivi per la fauna e l’uomo. Molti di essi sono volatili, vengono sospinti dal vento e si trascinano oltre i campi, divenendo un potenziale elemento nocivo per tutti i componenti della catena alimentare. Negli ultimi decenni si è evidenziato un processo simile in mare. I fertilizzanti utilizzati per nutrire il terreno, per via aerea o per via sotterranea, arrivano a mare diventando ulteriore nutrimento per le alghe che aumentano vertiginosamente di numero creando problemi sia alla fauna marina, sia alle spiagge e all’uomo che le frequenta (l’intossicazione può avvenire sia per via alimentare, mangiando crostacei o molluschi o pesci contaminati, che per via aerea: l’inalazione di aerosol contenente frammenti di cellule o tossine di alghe marine). Io so che a noi importa solo mangiare. Ma stiamo distruggendo ogni forma di biodiversità, sia animale che vegetale, per delle brioche al cioccolato, degli assemblaggi di merluzzo impanato o per mangiare carne, in diversi alimenti, almeno tre volte al giorno.
42 C’è stata e in alcuni ancora è presente l’idea che esista una soluzione B, un altro pianeta sul quale approdare e iniziare una nuova vita, abbandonando la nostra casa distrutta dalle nostre azioni – convinti di poter essere diversi, esseri migliori, imparare dai nostri errori. Non c’è nulla di questo a portata di mano. Nelle vicinanze siamo l’unica forma di vita presente nell’universo. E questo è l’unico Pianeta vivibile. Come scrisse Carl Sagan nel libro Pale Blue Dot (Pallido Puntino Azzurro) riguardo la fotografia della Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a sei miliardi di chilometri di distanza (di Sagan l’idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del sistema solare): “La Terra è l’unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c’è nessun altro posto, per lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Abitare, non ancora. Che vi piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l’astronomia è un’esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c’è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l’uno dell’altro, e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l’unica casa che abbiamo mai conosciuto.”
43 El Niño, il Bambino in lingua spagnola, è un fenomeno ciclico (casuale) climatico che si ripete una volta ogni tre/cinque anni ed è causato da un temporaneo indebolimento della fascia degli Alisei, venti costanti che soffiano da sud-est e che moderano la temperatura, provocando un aumento delle temperature nelle acque del Pacifico Tropicale. La pioggia segue l’acqua calda verso est, causando siccità in Indonesia, in Malesia e nel nord dell’Australia, e alterando il percorso della corrente a getto la quale a sua volta contribuisce a definire il tempo in Nord America. Esiste anche La Niña, la Bambina, un fenomeno che spesso segue temporalmente El Niño: quando l’acqua calda de El Niño ha occupato tutto il Pacifico tropicale, è sufficiente l’instaurarsi di alisei anche di bassa potenza per innescare il fenomeno inverso, con un raffreddamento delle temperature superficiali dell’Oceano Pacifico centrale ed orientale. El Niño è un importante fattore ambientale: la corrente calda che viene trasportata verso oriente è povera di alimenti nutritivi. Questa prende il sopravvento sulla corrente di Humboldt che attraverso la risalita spinge dalle profondità oceaniche il plancton, il quale assicura cibo a grandi quantità di pesci e mammiferi marini. Però c’è un problema. Per via del cambiamento climatico El Niño è diventato più frequente e duraturo. Ciò provoca grossi disagi alle popolazioni che vivono in quella fascia territoriale, perché si evidenziano periodi di siccità più lunghi nelle regioni che si affacciano sul Pacifico Occidentale e in Australia ed eventi piovosi estremi sulle coste occidentali del centro America. Inoltre crea uno stravolgimento nell’equilibrio faunistico marino, ripercuotendosi anche sulle popolazioni che vivono di pesca. Riassunto: impatti su rese agricole, carestia, necessità di riscaldare o raffreddare le abitazioni, rischi di incendio, sbiancamento dei coralli e condizioni meteorologiche estreme sono situazioni dovuti ad El Niño/ La Niña diventati più gravi negli ultimi 20 anni a causa dell’aumento della temperatura media terrestre.
44 La Tartaruga Embricata vive nelle acque tropicali degli Oceani Atlantico, Pacifico ed Indiano. Non amano le profondità marine, preferiscono gravitare intorno alle coste dove trovano le specie di Spugne di cui si cibano e dove possono trovare distese sabbiose per partorire. Compiono grandi migrazioni per spostarsi verso le zone di riproduzione. Quando sono giovani il loro carapace è a forma di cuore, e si allunga a mano a mano che crescono. Il loro colorato guscio è dentellato e ha delle spesse piastre ossee sovrapposte, somiglianti agli embrici di un tetto, dai quali deriva il nome. È una specie in via d’estinzione; livello Critico per la Red List dell’IUCN. La popolazione di questa specie è crollata dell’ottanta percento negli ultimi cento anni. Vengono uccise per il commercio del loro magnifico carapace (si stima che ne siano state ammazzate, in centocinquant’anni, sei milioni). In Giappone l’animale viene cacciato per le sue squame, impiegate per realizzare la montatura di occhiali e per i plettri dello Shamisen, uno strumento musicale del folklore nipponico. Infine la Tartaruga Embricata è minacciata dall’inquinamento marino e dalla distruzione del suo habitat. Si stima che nel mondo di femmine nidificanti ne siano rimaste meno di venticinque mila esemplari.
45 Le Sterne codalunga sono dei magnifici uccelli bianchi con un cappuccio nero sopra la testa. Hanno una coda biforcuta e piccole zampe. Si cibano di pesciolini e piccoli invertebrati acquatici, che catturano tuffandosi nell’acqua da altezze elevate. Hanno il record della migrazione più lunga: dall’Eurasia settentrionale, dove nidifica in estate, fino alle acque subantartiche e antartiche degli Oceani Atlantico, Pacifico ed Indiano. Ed è grazie a questa lunga migrazione che la inserisco come essere che collega il mondo da un estremo all’altro. L’unica minaccia sono i turisti che frequentano le zone di nidificazione. Essendo molto protettiva, la Sterna attacca chiunque provi ad avvicinarsi al nido, con picchiate rapide e beccando con forza, anche gli esseri umani.
46 La pedoturbazione è il processo di rimescolamento generale del suolo per via di terremoti, meteoriti, guerre, sconvolgimenti climatici, e che si divide in almeno undici categorie tra cui: l’aeroturbazione (gas, aria, vento), floraturbazione (piante), acquaturbazione (acqua), cristalturbazione(cristalli e minerali vari), eccetera. Uso questo termine per stabilire una forma di linguaggio basata sugli elementi che comprendono il mondo. Elementi che formano la vita sulla terra e che continuamente vengono destabilizzati dalle azioni umane. Il linguaggio usa questi processi del mondo naturale per farne un arma di conservazione e di ricostruzione. Non si può più parlare solo col cuore, serve anche un cervello che produca memoria e letteratura utili alla sopravvivenza del Pianeta. Potrei definirlo un romanticismo scientifico. Poeti e letterati che studiano e guardano la terra e ne fanno romanzi e poesia.
47 Il mar dei Sargassi si trova al centro dell’Oceano Atlantico settentrionale, tra gli arcipelaghi delle Azzorre e delle Antille, dove s’incontrano ammassi fluttuanti estesi di alghe, dette in portoghese sargaços (da qui il loro nome). Queste alghe di colore giallo/oro sono isolotti che si spostano in base all’influenza dei venti. Sono portatori di un’alta biodiversità, molti animali marini vengono tra queste foreste per riprodussi come le anguille femmine che dai fiumi europei compiono oltre sei mila chilometri per raggiungerle. Negli ultimi anni c’è stato un aumento di alghe che ha invaso le coste caraibiche. Molti biologi marini pensano che sia dovuto all’aumento di fertilizzanti in mare.
48 I Cumulinembi sono nubi ad elevato sviluppo verticale, imponenti sul cielo, a forma di torri, montagne o cupole. I cumulonembi sono formati da masse di cumuli scuri (parte alta bianca e base orizzontale grigia) e si possono estendere per tutta l’altezza della troposfera. Accompagnano manifestazioni temporalesche: portano forti piogge, grandine o neve, oltre a fulmini e in alcune circostanze, tornado.




 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese

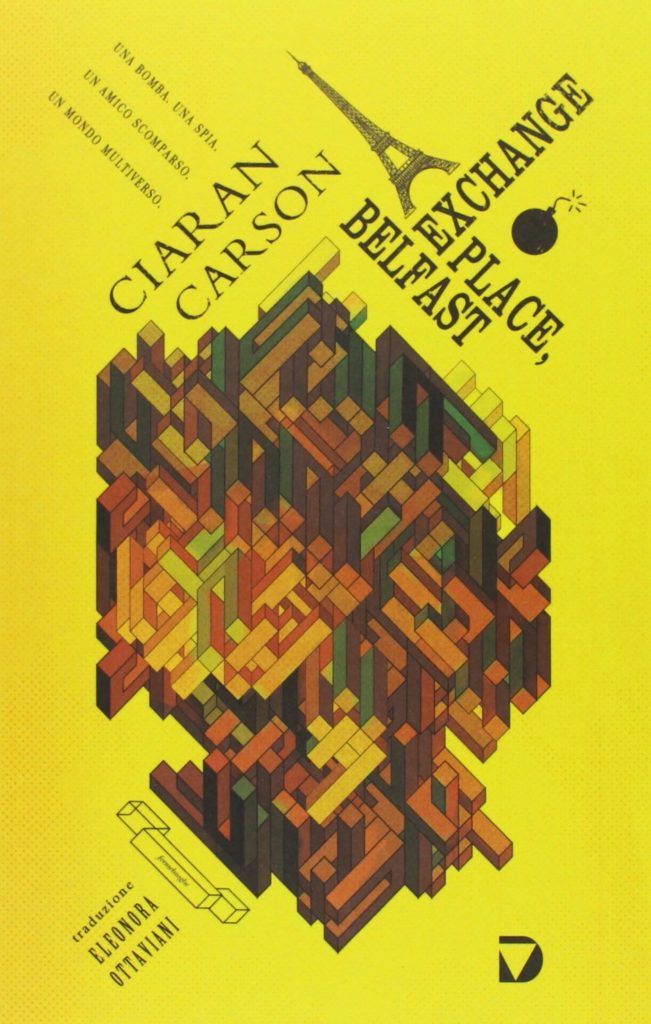

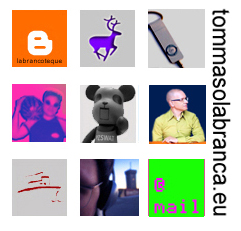 (
(




















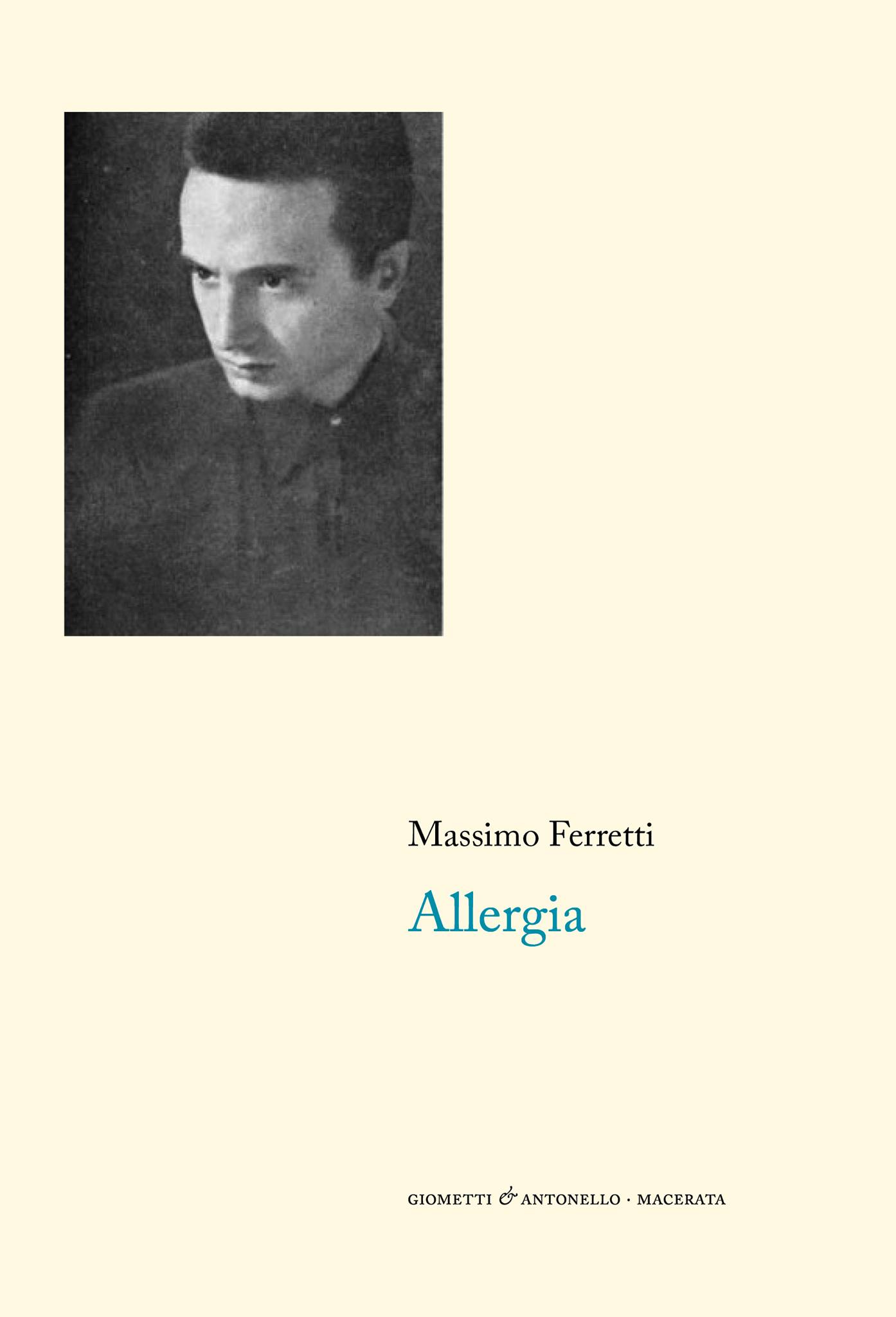

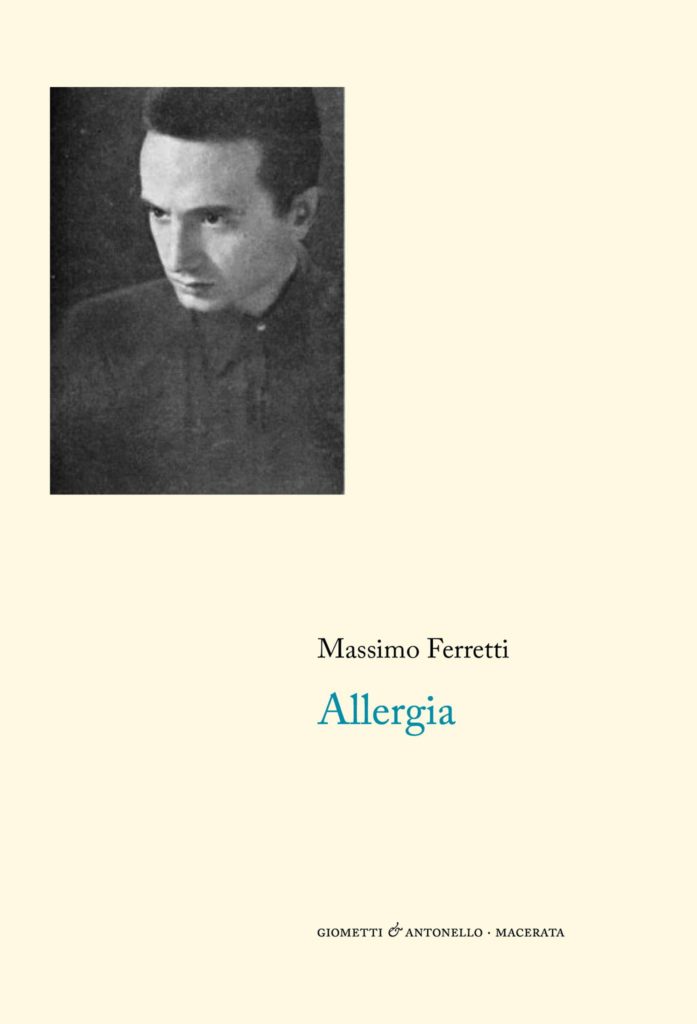

 (recensione di una libreria, con libro finale in omaggio!)
(recensione di una libreria, con libro finale in omaggio!) Parte integrante della Libreria Cardano è il titolare, Fausto Pellegrin. Senza di lui la Libreria Cardano sarebbe qualcos’altro, forse soltanto una rivendita di libri. Fausto Pellegrin è la Libreria Cardano personificata. La pipa in pugno, oppure un toscano all’anisette tra le labbra, è pronto a interrompere qualsiasi cosa per salutare chi entra, sia che stia chiacchierando con un cliente o che stia sfogliando un libro d’arte per qualche ricerca. Uomo di cultura e amabile conversatore, Fausto ha indubbiamente il fascino del libraio vecchio stile, pronto a consigliare, a stimolare la curiosità ma anche ad ascoltare e lasciare che il cliente si aggiri indisturbato frugando tra gli scaffali.
Parte integrante della Libreria Cardano è il titolare, Fausto Pellegrin. Senza di lui la Libreria Cardano sarebbe qualcos’altro, forse soltanto una rivendita di libri. Fausto Pellegrin è la Libreria Cardano personificata. La pipa in pugno, oppure un toscano all’anisette tra le labbra, è pronto a interrompere qualsiasi cosa per salutare chi entra, sia che stia chiacchierando con un cliente o che stia sfogliando un libro d’arte per qualche ricerca. Uomo di cultura e amabile conversatore, Fausto ha indubbiamente il fascino del libraio vecchio stile, pronto a consigliare, a stimolare la curiosità ma anche ad ascoltare e lasciare che il cliente si aggiri indisturbato frugando tra gli scaffali. Insomma, una libreria così carica di atmosfera da ambientarci un racconto. Cosa che ho fatto nel 2005. Da una mia idea iniziale è nato un curioso progetto che Fausto ha concretizzato in un gadget per la sua clientela:
Insomma, una libreria così carica di atmosfera da ambientarci un racconto. Cosa che ho fatto nel 2005. Da una mia idea iniziale è nato un curioso progetto che Fausto ha concretizzato in un gadget per la sua clientela: 
