di Maddalena Fingerle
Strappo con la mano destra una foglia d’acero, tre passi, la infilo nella tasca destra della giacca. Fai che tutto vada bene, tre passi, mi giro. Strappo con la mano sinistra una foglia d’acero, tre passi, nella tasca sinistra. Fai che tutto vada bene, mi giro, tre passi. Tre passi, strappo con entrambe le mani una foglia d’acero: fai che tutto vada bene. Tre passi, mi fermo, la spezzo. Metà nella tasca sinistra, metà in quella destra, tre passi. Tre colpi di tosse, significano: fai che non mi ammali. Fai che non mi ammali, fai che non mi ammali, piroetta. Così, perché è bello farla, piroetta. Piroetta: tre giri, stop.
Passa una macchina, mi fermo, batto i piedi. Forte: un due tre, un due tre. Fai che non ci sia un incidente, fai che non ci sia un incidente, fai che non ci sia un incidente. Fai che non muoia nessuno, non muoia nessuno, non muoia nessuno. Tre pugni veloci con la mano destra sulla gamba sinistra, tre pugni veloci con la mano sinistra sulla gamba destra: un due tre. Un, due, tre. Fai che riesca ad arrivare a casa, fai che riesca ad arrivare a casa, fai che riesca ad arrivare a casa. Fai che non ci sia il coinquilino, fai che non ci sia il coinquilino, fai che non ci sia il coinquilino.
Sei passi, accarezzo con la mano destra un recinto di metallo, sei secondi. Guardo a destra, guardo a sinistra, attraverso la strada. Il piede nel quadratino, il piede nel quadratino, il piede nel quadratino. Il piede nel quadratino, il piede nel quadratino, il piede nel quadratino.
Dentro le linee, strappo con la mano sinistra una manciata di aghi di pino, me li infilo nella tasca destra della giacca. Fai che non la picchi più, non la picchi più, non la picchi più. Tocco un lampione illuminato con entrambe le mani, è freddo: fai che passi la notte.
Altri sei passi, raccolgo con la mano sinistra una pigna da terra, la infilo nella tasca sinistra della giacca. Fai che mi consideri bello, bello, bello. Sei passi, trovo un sasso, lo prendo con la mano destra. Lo metto nella tasca destra della giacca, fai che mi passi l’ansia, sei passi. Altro sasso, lo metto nella tasca sinistra della giacca: fai che riesca a dormire.
Nove passi, strappo con la mano destra una manciata di bacche, apro il pugno. Sul palmo ci sono quattro bacche, no: tre o sei, quattro non va bene. Fai che diventino tre; allontano lievemente l’indice dal medio, una cade giù. Lascio scivolare nella tasca destra le tre bacche: fai che si accorga di me, fai che si accorga di me. Fai che si accorga di me, passa un uomo con un cane, ha un collare illuminato. Deglutisco ogni volta che il padrone parla al cane, uno, due. Manca il tre: così non posso esprimere il desiderio, maledizione. Chiamalo, chiamalo, chiamalo. Niente, niente, niente. Lo faccio io allora, urlo: cane! Il padrone si gira, mi guarda; il cane nemmeno se ne accorge. Un due tre, desiderio: fai che esca dal carcere.
Nove passi, trovo una lattina vuota accartocciata per terra; in realtà gli ultimi due li ho fatti un po’ più lunghi per arrivarci giusto. Ma vale lo stesso: la prendo con entrambe le mani, la rompo in due. Metto una metà con la mano destra nella tasca destra; l’altra metà con la mano sinistra nella tasca sinistra: fai che non mi vengano malattie per aver raccolto una lattina da terra. Nove passi: no, ho imbrogliato. Torno indietro: nove passi a gambero, altri nove. Mano destra, prendo la metà della lattina dalla tasca destra, la rimetto a terra. Mano sinistra, prendo l’altra metà della lattina dalla tasca sinistra e la sistemo accanto a quella di destra.
Raccolgo, raccolgo, tasche. Fai che non mi vengano malattie per aver raccolto una lattina da terra per due volte, due volte: nove passi in avanti. Nove indietro, mano destra, prendo la metà della lattina dalla tasca destra. La rimetto a terra; mano sinistra, prendo l’altra metà della lattina dalla tasca sinistra. La sistemo accanto a quella di destra: fai che non mi vengano malattie per aver raccolto una lattina da terra per tre volte, ti prego.
Dodici passi, giro a destra, mi fermo. Batto le mani, di nuovo e ancora. Fai che la gente si accorga che sono bravo, fai che la gente si accorga che sono bravo, fai che la gente si accorga che sono bravo.
Dodici passi piccoli: un due tre quattro cinque sei, sette otto nove dieci undici dodici. Mi accuccio e tocco con il palmo della mano destra un sanpietrino freddo: fai che riesca a sentire il desiderio del sanpietrino. Mi alzo, mi accuccio e tocco con il palmo della mano sinistra un sanpietrino freddo. Fai che il sanpietrino a sinistra riesca a sentire il desiderio del sanpietrino a destra, sentilo, sentilo. Ora mi dispiace per il sanpietrino a sinistra, ma se ne dovrà fare una ragione: la vita è così. Ciao, sanpietrino, ciao.
Dodici passi decisi, arrivo giusto e raccolgo da terra un pacchetto di sigarette vuoto. Me lo infilo in tasca, mano destra e tasca sinistra. Mi ribello, addio all’aspettativa: fai che ci sia ancora abbastanza spazio nelle tasche.
Quindici passi, c’è una pigna, la raccolgo. Mano sinistra, tasca destra ed è fatta. Non mi ribello: viva la simmetria: fai che si possa dire tutto quello che non si pensa.
Diciotto passi nervosi, arrivo al parco, strappo un filo d’erba. Mano destra, tasca destra: c’è ancora spazio. Fai che paghi per quello che ha fatto, strappo un altro filo d’erba, mano sinistra. Tasca sinistra: fai che si penta di quello che ha fatto, stronzo.
Ventun passi senza pretese; sono davanti al ponticello di legno, mi avvicino all’acqua. Tre passi, altri tre e altri tre. Chiudo le tasche della giacca con i bottoni, prima quella sinistra, poi quella destra. Mi sdraio di pancia, allungo il braccio destro e raccolgo i sassolini in fondo al fiumiciattolo gelido. Li tengo nel pugno chiuso, allungo il braccio sinistro e raccolgo i sassolini in fondo al fiumiciattolo gelido. Mi tiro su, con i pugni chiusi cerco di aprire i bottoni delle tasche della giacca, ma i sassolini mi sfuggono di mano. Mi innervosisco, getto per terra quelli che mi rimangono, apro i bottoni. Mi viene da piangere, cerco nel prato i sassolini, la luce del lampione è fioca. Il prato bagnato, sono inginocchiato: un due tre. Fai uno, che due, tre finisca. Ne trovo altri tre: li prendo, li metto nella tasca sinistra. Uno fai, due che, tre finisca. E altri tre: fai che finisca presto, mi alzo.
Ventiquattro passi veloci; qualcuno mi segue, forse mi sbaglio. Salto, di nuovo, e ancora una volta. Fai che io sia felice, fai che io sia felice, fai che io sia felice.
Ventisette passi da gigante, raccolgo un po’ di terra, la sento sotto le unghie. Mano destra, tasca destra: fai che non diventi pazzo. Altri ventisette passi da gigante, terra, la raccolgo. Mano sinistra, tasca sinistra: fai che non diventi pazzo. Altri ventisette passi da gigante, terra, la raccolgo. Mano destra, metà nella tasca destra; metà nella tasca sinistra. Fai che non diventi pazzo, davvero, sul serio.
Trenta passi, adesso: un due tre. Quattro, cinque, sei. Sette, otto, nove. Dieci, undici, dodici. Tredici, quattordici, quindici. Sedici, diciassette, diciotto. Diciannove e venti, ventuno. Ventidue, ventitré, ventiquattro. Venticinque, ventisei, ventisette. Ventotto, ventinove, trenta. Inspiro, espiro: fai che quello stronzo del coinquilino non abbia finito il latte. Inspiro, espiro: fai che quello stronzo del coinquilino non abbia finito il latte. Inspiro, espiro: fai che quello stronzo del coinquilino non abbia finito il latte. Trenta passi, mi fermo, sono davanti a casa. Suono il campanello, suono il campanello, suono il campanello. Fai che non ci sia, fai che non ci sia, fai che non ci sia. C’è, c’è, c’è. Mi manda a fanculo, mi manda a fanculo, mi manda a fanculo. Lo fa davvero tre volte; entro e salgo le scale. Dodici gradini più uno: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n + o. Anna, Barbara, Dora, Elena, Federica, Gaia, Laura, Marianna, Nora + Olga. Fai che stiano tutte bene, tutte bene, tutte bene. Mi sfilo le scarpe e sbatto le suole l’una contro l’altra, tre volte. Fai che ci siano i biscotti, fai che ci siano i biscotti, fai che ci siano i biscotti. Entro: i nove passi per arrivare in cucina, tocco la maniglia con la mano destra. Fai che Dora sia serena, la tocco con la mano sinistra, è fredda. La tocco con entrambe le mani, fai che Elena faccia carriera; fai che Federica rimanga incinta. Entro, mi tolgo la giacca, l’appoggio sulla sedia. Apro il frigo: maledetto, ha finito il latte. Guardo in dispensa: niente biscotti, faccio una pasta. Prendo la pentola, la riempio d’acqua e la metto sul fuoco. Accendo il fuoco, immergo il dito destro nell’acqua ancora fredda e preparo la tavola. Il piatto al centro, la forchetta a sinistra, il bicchiere centrale. Tovagliolo, acqua, pane. Vino, altro bicchiere, accendo una sigaretta. Non si fuma in casa, cazzo, quante volte te lo devo dire? Fottiti. Fottiti. Fottiti. Sbatte la porta, continuo a fumare, me ne sbatto. Spengo la sigaretta nel posacenere, mi annuso la mano destra, puzza di fumo. L’acqua bolle, butto il sale, butto la pasta. Assaggio la pasta, scolo la pasta, manteco la pasta. Mangio la pasta, mangio la pasta, mangio la pasta. Mastico tre volte, sei volte, nove volte. Tre volte, sei volte, nove volte. Tre volte, sei volte, nove volte. Finisco la pasta, lavo il piatto, bevo il vino. Lavo il bicchiere, finisco l’acqua, volevo i biscotti. Lavo la pentola, lavo la padella, lavo lo scolapasta. Prendo la giacca, chiudo la porta, vado in camera mia. Appoggio la giacca per terra, mi sfilo i jeans, mi sfilo la camicia. Svuoto le tasche della giacca e sistemo tutto sul pavimento: tre foglie d’acero. Fai che tutto vada bene, fai che tutto vada bene, fai che tutto vada bene. Aghi di pino: fai che non la picchi più, pigna. Fai che mi consideri bello, sasso: fai che mi passi l’ansia. Altro sasso: fai che riesca a dormire, tre bacche. Fai che si accorga di me, lattina: fai che non mi vengano malattie per aver raccolto tre volte una lattina da terra. Pacchetto di sigarette vuoto: fai che ci sia ancora abbastanza spazio nelle tasche, esaudito. Getto il pacchetto di sigarette vuoto nel bidone, pigna: fai che si possa dire tutto quello che non si pensa. Un filo d’erba: fai che paghi per quello che ha fatto, altro filo d’erba. Fai che si penta di quello che ha fatto. Manca il terzo, cerco nelle tasche, non c’è. Butto nel bidone i due fili d’erba: irrealizzabili; tre sassolini. Fai che finisca, altri tre sassolini: fai che finisca. Altri tre sassolini, fai che finisca presto; terra. Fai che non diventi pazzo, fai che non diventi pazzo, fai che non diventi pazzo.
Mi sdraio a letto, accendo la luce, spengo la luce. Accendo la luce, spengo la luce, accendo la luce. Spengo la luce: fai che riesca a digerire la pasta, fai che riesca a digerire la pasta. Fai che riesca a digerire la pasta, lenzuolo, coperta. Lenzuolo, fai che le parole non sognino Dora, fai che le parole non sognino Elena. Fai che le parole non sognino Federica; chiudo l’occhio destro, quello sinistro. Apro entrambi gli occhi, li strizzo e li chiudo. Ripeto, tre volte in tutto: fai che il cuore si sblocchi. Fai che il cuore si sblocchi, fai che il cuore si sblocchi. Rilasso il diaframma, lo blocco, prego. Mano sinistra sul petto, mano destra sulla fronte, nel nome del Padre. Sul cuore fermo nel nome del Figlio, sulla spalla sinistra dello Spirito sulla spalla destra Santo. Fai che riesca a smettere, mano sinistra sul petto, mano destra sulla fronte. Nel nome del Padre; sul cuore del Figlio; sulla spalla sinistra dello Spirito sulla spalla destra Santo. Destra fronte Padre; cuore fermo Figlio; sinistra Spirito destra Santo. Destra fronte Padre; cuore fermo Figlio; sinistra Spirito destra Santo. Fai che non finisca all’Inferno, all’Inferno, all’Inferno. Destra fronte Padre; cuore fermo Figlio; sinistra Spirito destra Santo. Destra fronte Padre; cuore fermo Figlio; sinistra Spirito destra Santo.

 di Vincenzo Ostuni
di Vincenzo Ostuni

 di Mario Fresa
di Mario Fresa



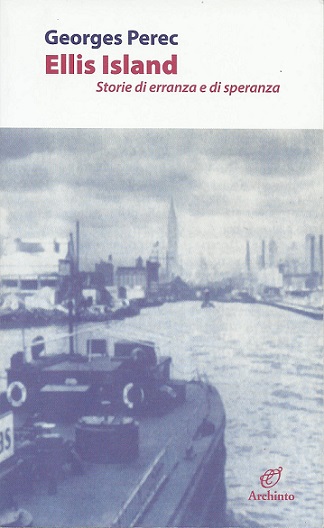 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi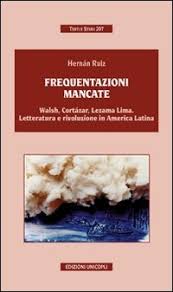
 di Massimo Raffaeli
di Massimo Raffaeli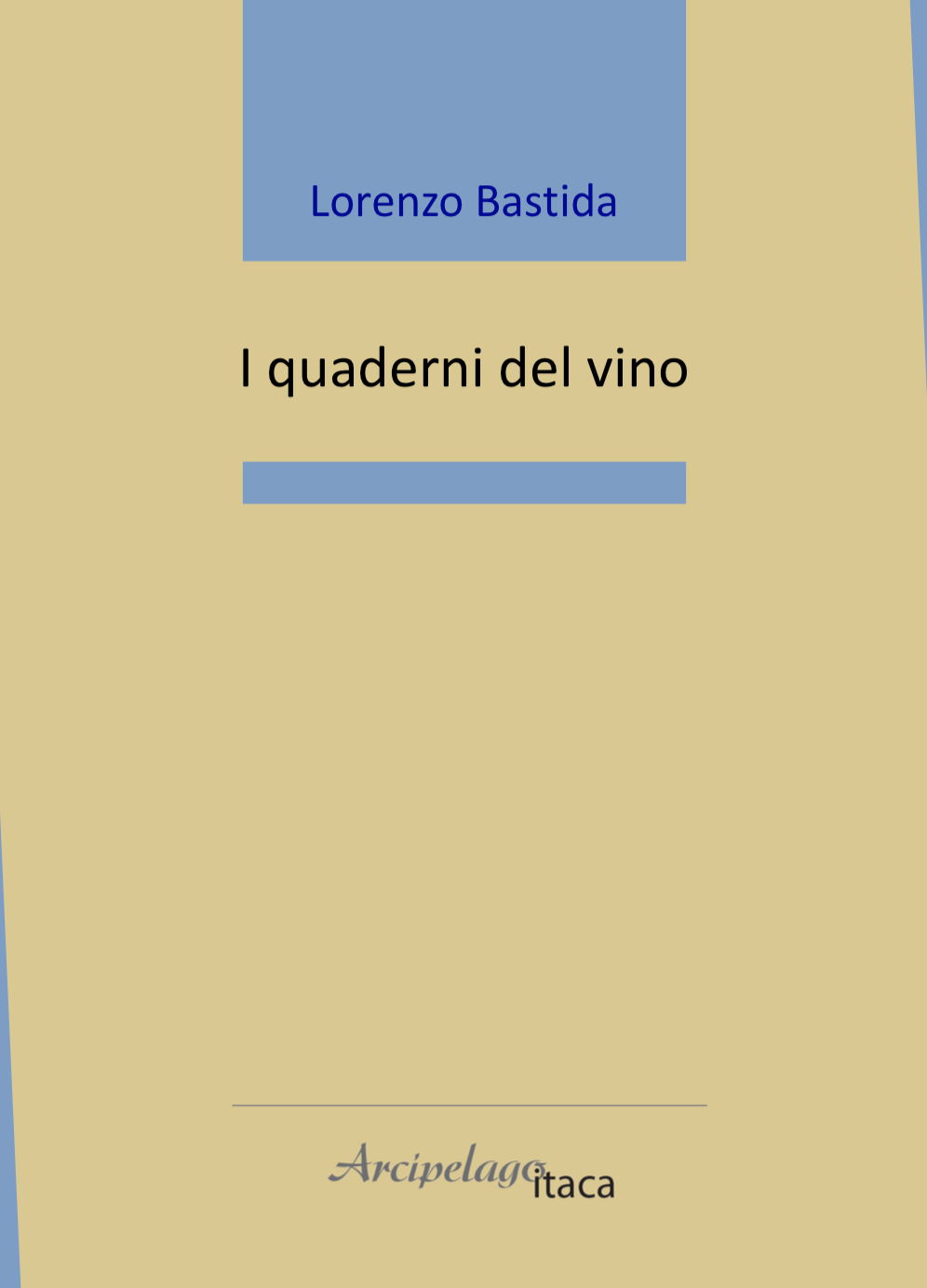




 di Francis Ponge
di Francis Ponge

