Di Giovanni Palmieri

Un bel giorno Perceval, smemorato di sé al punto da non ricordare più neanche Dio né i giorni della settimana, se ne andava in giro armato di tutto punto nel giorno del venerdì santo. Incontrando una compagnia di tre cavalieri che scortavano dieci donne ed erano disarmati in segno di penitenza, viene rimproverato da costoro per aver indossato le armi nel giorno della morte di Cristo. Uno dei cavalieri gli dice tra l’altro:
Molto santa fu quella morte che salvò i vivi e risuscitò da morte a vita i morti. I perfidi Giudei, che si dovrebbe uccidere come cani, fecero il loro male e il nostro gran bene quando lo innalzarono sulla Croce: perdettero se stessi e salvarono noi. […] ogni uomo che crede in Dio, oggi, non dovrebbe portar armi[1]
Così nel Perceval di Chrétien de Troyes, scritto prima del 1190. A prima vista il brano sembra un omaggio di genere all’antisemitismo diffuso nella corte fiamminga del cattolicissimo conte Filippo d’Alsazia, committente e dedicatario del libro di Chrétien nonché suo protettore e fanatico crociato. A ben guardare però il sarcasmo implicito nel fatto che pacifici e disarmati cavalieri cristiani, pur ostentando penitenza e umiltà, si mostrano tuttavia assai ben disposti al massacro degli ebrei, mi fa sospettare che il brano citato sia in realtà una condanna, cautamente dissimulata, dell’antisemitismo e delle sue aporie. Forse Chrétien avrà pensato, prima di Rabelais, che era necessario essere coerenti con le proprie idee sino al rogo. Escluso! Andrebbe in questo senso anche la successiva esposizione della contraddizione logica (misinterpretazione d’un versetto di Giovanni, 4, 22) secondo la quale i giudei, nonostante la loro innata perfidia, persero loro stessi per salvare i cristiani.
Contraddizione ripresa nel 1892 da Leon Bloy nel suo celebre Le Salut par les Juifs, libro peraltro sottilmente antisemita come notò acutamente, primo fra tutti, Franz Kafka.[2]
Questa premessa era per dire che non sempre è facile individuare nel testo letterario il pensiero dell’autore e oltretutto non sempre è utile. Senza sottovalutare l’intentio auctoris, come fece Borges suggerendo di leggere l’Imitatio Christi come se fosse stata scritta da Céline, trovo più efficace un’analisi letteraria basata sull’intentio operis e cioè sull’insieme coerente delle significazioni testuali che possono prescindere dalla volontà o dal sapere dell’autore.
Nel Cimitero di Praga di Eco[3], però, l’esemplarità della storia narrata toglie spazio a qualsiasi dubbio o sospetto di ambiguità circa il pensiero dell’autore. La condanna dell’antisemitismo, massicciamente messo in scena e letterariamente rappresentato, è fortissima e chi ha accusato Eco di ambiguità nella costruzione dell’eroe negativo e di involontaria complicità con il pensiero antisemita ha semplicemente confuso il soggetto dell’enunciazione con il soggetto dell’enunciato. Inoltre il protagonista del Cimitero di Praga, Simone Simonini, non è descritto come un luciferino genio del male, ma come una persona mediocre e come un semplice e squallido artefice della banalità del male.
Senza voler entrare nel dettaglio di una polemica giornalistica che sembra “usare” il testo di Eco senza saperlo “interpretare”, mi limito ad osservare che l’immedesimazione nell’eroe (e non l’identificazione) da parte dell’autore è meccanismo inevitabile; penso a Flaubert con Madame Bovary e a Svevo con Zeno. Tale immedesimazione però non comporta di necessità alcuna adesione ideologica o morale.
Ciò che invece mi sembra abbia seriamente disturbato alcuni lettori del romanzo di Eco, sia ebrei che cattolici[4], sia stato il dover prendere atto di qualcosa che è stato un po’ da tutti frettolosamente rimosso: l’esistenza di un immenso “archivio” antisemita che in tempi moderni ha preparato e “giustificato” la Shoah. Immenso archivio che Eco ha romanzescamente selezionato e ricostruito. Alla scrittura e all’assemblaggio storico d’un tale archivio hanno inoltre collaborato categorie sociali apparentemente insospettabili: mi riferisco alla tristemente lunga teoria di socialisti e di ebrei antisemiti. E anche di questi il Cimitero di Praga si ricorda con dovizia di esempi.
Il socialismo degli imbecilli e l’antiebraismo ebraico
Dopo la Rivoluzione francese e la nascita degli stati liberali, a fianco del tradizionale antisemitismo religioso era sorto un antisemitismo per così dire secolarizzato che giungerà nel Novecento sino al razzismo biologistico. Si trattava di pratiche discorsive che legavano l’anticapitalismo, il mito del complotto giudaico-protestante-massonico e la depressione economica all’odio endemico per le comunità ebraiche. Simon Levis Sullam[5] ha in questo senso ricordato che già nelle vicinanze delle due rivoluzioni europee del 1789 e del 1848, Voltaire, prima, e Marx poi avevano trattato la “questione ebraica” ricorrendo ad alcuni dei più vieti stereotipi della tradizione antigiudaica. In seguito, con l’apporto teorico di Proudhon e di Toussenel (socialista fourierista nato nel 1803 e morto nel 1885)[6], tale antisemitismo laico, a partire dalla Francia, raggiunse presto i ceti popolari europei, diffondendosi negli ambienti socialisti e nei primi partiti operai. Nasceva così il «socialismo degli imbecilli», come lo definì nel 1893 al Congresso socialdemocratico di Colonia August Bebel. Questo nuovo antisemitismo anticapitalista si nutriva anche degli apporti scientifici della recente antropologia razziale (e razzista), della teoria della «degenerazione» e infine della nascente eugenetica. Ma in questo campo tout se tient…
Con il termine «dégénérescence», nel 1857, l’alienista francese Bénédict Augustin Morel (1809-1873) aveva designato una non meglio identificata causa morbosa ed ereditaria che portava l’organismo umano ad un ingravescente decadimento biologico-cellulare.[7] Tale degenerazione riguardava sia aspetti fisici che aspetti psichici e morali. Morel, che partiva da premesse mistico-teologiche legate alla caduta dell’uomo causata dal peccato originale, spiegava così un enorme numero di patologie: dalla semplice alienazione mentale all’acolismo, dal cretinismo al delirio emotivo, dall’isteria alla tubercolosi, senza parlare di tutte le tare ereditarie, delle perversioni sessuali e naturalmente delle devianze sociali. Come si può facilmente intuire, benché nato in un contesto positivista ideologicamente neutrale, il concetto di «degenerazione» fu presto sfruttato dai settori più reazionari della psichiatria e dell’antropologia razzista. In un primo tempo, però, l’intero mondo intellettuale (ricordo solo Svevo e Mann che ne subirono l’influenza) credette a questo vero e proprio mito scientifico, e il brillante sociologo ebreo Max Nordau lo divulgò in tutta l’Europa con il suo trattato del 1892 intitolato semplicemente Dégénérescence.[8] «Era inevitabile che questo termine, già così emotivamente connotato di suo, uscendo dall’ambito strettamente clinico, subisse una deformazione semantica, arrivando a designare un generico, quanto pernicioso, processo di decadenza igienico-morale della società.».[9]
Nelle pratiche discorsive del socialismo degli imbecilli, prima dell’affaire Dreyfus, il mito della degenerazione costituì la principale giustificazione oggettiva e “scientifica” del pregiudizio antisemita. Si diceva: gli ebrei sono di necessità dei degenerati. Prima perché sono tutti ricchi e poi perché si sposano tra di loro e hanno pratiche religiose e sessuali aberranti. In quanto portatori di degenerazione, essi contaminano fisicamente e moralmente il tessuto sociale. Bisogna fermarli.
In questo dibattito si inserisce la singolare figura di Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), uno dei padri dell’eugenetica. Antropologo, magistrato e per qualche tempo docente universitario francese, Lapouge, agli inizi della sua carriera si dichiarava ateo, socialista e libertario. Nel 1882 fu infatti tra i fondatori del Parti ouvrier (poi Parti Ouvrier Français), il primo partito marxista francese. Razzista e antisemita, muovendo da premesse socialdarwiniane, nel libro intitolato L’Aryen. Son rôle social (Paris 1899), Lapouge riteneva che gli ebrei fossero una razza artificiale perché sviluppatasi fuori dalla natura nella sola dimensione culturale. Essi erano pertanto da ritenersi gli unici avversari temibili dell’ariano e andavano soppressi attraverso graduali e opportune politiche eugenetiche.
Nel romanzo di Eco, oltre al socialismo antisemita, troviamo anche gli ebrei antiebraici. Si tratta spesso, anche se non esclusivamente, di assimilati o convertiti che per essere più cristiani dei cristiani sviluppavano un sottile ma ben visibile antisemitismo. Penso ad esempio a Weininger e alla teoria sulla (a suo dire) colpevole passività femminile degli ebrei ma penso anche a ben altri ritratti storici di questo tipo umano presenti, come vedremo in seguito, nel nostro romanzo.
Il discorso produttore della sua verità
Al romanzo di Eco, Anna Foa[10] ha rimproverato di avere fatto della costruzione del falso un’unica verità con il rischio di un’eterogenesi dei fini in base alla quale invece di smontare un falso lo si ricostruiva. A me sembra invece che nel Cimitero di Praga ciò che abbia inteso fare l’autore, o in ogni caso ciò che fa il testo, non sia stato contrapporre la verità al falso, ma mostrare le condizioni di possibilità sociali e culturali in base alle quali quella falsa “verità” è stata storicamente prodotta. Il che è ben diverso. Nelle descrizioni antisemite presenti nel suo romanzo, Eco ci mostra infatti come è stato costruito, o meglio, modernamente reinventato l’antico nemico.
Per quest’ordine di ragioni, invece di analizzare le pratiche discorsive antisemite come si fa di solito ricorrendo ad un criterio esterno di verità, mi sembra più opportuno, foucaultianamente[11], verificare attraverso quali regole sociali di esclusione e inclusione il discorso antisemita abbia prodotto la propria verità. Si tratta di una verità prodotta solo dall’enunciato e non dipendente dalla realtà. In termini linguistici si potrebbe parlare di una singolare performatività dell’atto linguistico antiebraico che si fa vero non per quanto dice ma, indipendentemente da quanto dice, per il solo fatto che si dice. Un buon esempio di ciò può essere l’affermazione di monsignor Jouin, protonotaro apostolico e traduttore francese dei Protocolli di Sion, secondo la quale: «Peu importe que les Protocoles soient authentiques; il suffit qu’ils soient vrais».[12] L’enunciato antisemita viene dunque creduto perché è già stato scritto e ripetuto miliardi di volte con minime sfumature e si è costituito perciò come parte di un patrimonio collettivo, accettato prima ancora di essere letto o ascoltato.
Quando nel Cimitero di Praga, il gesuita padre Bresciani dice a Simonini « – Guarda questo libro […] È La France juive di Edouard Drumont. […] Ecco uno che evidentemente ne sa più di te»[13], Simonini sfoglia il volume e ribatte:
– Ma sono le stesse cose che aveva scritto il vecchio Gougenot, più di quindici anni fa!
– E allora ? – replica il gesuita – Questo libro è andato a ruba, si vede che i suoi lettori non conoscevano Gougenot. E tu vuoi che il tuo cliente russo abbia già letto Drumont? Non sei tu il maestro del riciclo?[14]
Un’altra regola di esclusione che appartiene alla pratica discorsiva antisemita è la mancanza di dati verificabili e in genere una costante impossibilità di verificare alcunché, comprese le paternità dei riferimenti e delle citazioni. Ci si muove sempre in universi discorsivi noti, dati per assodati e confermati dalla loro stessa eterna replicazione. Si varia cioè, con svariate contaminazioni, un patrimonio confuso di idées reçues e di mitologie collettive. Tra le regole d’inclusione, invece, vi sono l’aporia, l’entimema e la contraddizione che invece di ostacolare il discorso si pongono sul piano logico di semplici varianti tranquillamente compresenti.
Ma è tempo di cedere la parola ai personaggi non romanzeschi del nostro romanzo.
L’identità ebraica
Forse la prima regola che codifica la parola antisemita è una certa incertezza e confusione di base sull’identità dell’oggetto in questione.
Chi sono gli ebrei? – si chiede retoricamente Toussenel nella libreria di rue de Beaune – Tutti quelli che succhiano il sangue degli indifesi, del popolo. Sono i protestanti, i massoni. E naturalmente i giudei.
[…] È una razza che passa il tempo a ricordare la sua schiavitù, e sempre pronta a soggiacere al culto del vitello d’oro malgrado i segni della collera divina. La battaglia contro gli ebrei dovrebbe essere il fine principale di ogni socialista degno di questo nome. Non parlo dei comunisti, perché il loro fondatore è ebreo, ma il problema è denunciare il complotto del denaro. […] Vi sono popoli da preda che vivono della carne altrui[15]
L’imbecillità di Toussenel ci deve interessare perché rivela la difficoltà dell’antisemita e del suo discorso nel riconoscere il proprio nemico e cioè nell’assegnargli un’identità univoca. All’inizio del suo diario, Simonini, in piena crisi d’identità e già convivente con il suo doppio, l’abate Dalla Piccola, si chiede «Chi sono?». Non potendosi rispondere in modo positivo, finisce per chiedersi «Chi odio?».[16] Simonini è dunque colui che può dire di sé: «Io son colui che odia». Ma chi odia? La risposta questa volta è pronta ma ancora incerta:
Gli ebrei, mi verrebbe da dire, ma il fatto che stia cedendo così servilmente alle istigazioni di quel dottore austriaco (o tedesco) dice che non ho nulla contro i maledetti ebrei. Degli ebrei so solo quello che mi ha insegnato il nonno: – Sono il popolo ateo per eccellenza, mi istruiva. Partono dal concetto che il bene deve realizzarsi qui, e non oltre la tomba. Quindi operano solo per la conquista di questo mondo.[17]
Come si vede, non solo l’odio antisemita non sa giustificare se stesso se non con se stesso, ma non riesce neanche bene ad identificare il nemico. L’ebreo, per gli antisemiti, è soltanto lo stereotipo che su di lui è stato inventato… e infine coincide con lo stesso epiteto, connotato di razzismo, che a lui viene assegnato con particolari sfumature della voce: «ebreo!».
«Io gli ebrei – scrive Simonini – li ho sempre evitati perché sto attento ai nomi.».[18] Ecco: per l’antisemita che non riesce ad identificare in modo conforme al proprio pregiudizio il nemico, rimangono i nomi. A questo proposito, il narratore della Recherche proustiana, ci informa ad esempio che suo nonno, bonario antisemita, ogni volta che doveva ricevere un amico del nipote, sosteneva sempre che si trattasse di un ebreo.[19]
Prima ancora di averli visti – prosegue il je – semplicemente sentendo il loro nome che.molto spesso non aveva niente di particolarmente israelita, indovinava non soltanto l’origine ebrea dei miei amici che in effetti lo erano, ma anche quel che di dubbio poteva esserci, a volte, nella loro famiglia.
– E il tuo amico che viene stasera, come si chiama?
– Dumont, nonno.
– Dumont… Eh, non c’è da fidarsi![20]
Quando l’ebreo, poniamo Freud, incontrato da Simonini a Parigi, non corrisponde al pregiudizio, il meccanismo retorico che sostiene la pratica antisemita non inquisisce il pregiudizio su cui si regge, ma preferisce negare l’identità ebraica della persona: «Froïde era facondo e spiritoso – scrive infatti Simonini con imprecisa grafia – forse mi sbagliavo e non era ebreo.».[21] In tal modo il pregiudizio viene salvaguardato dal contatto con una realtà che potrebbe smentirlo.
Anche l’identità religiosa non è un criterio così solido come gli antisemiti desidererebbero; non solo esistono ebrei non religiosi ma lo stesso Cristo era ebreo e ciò crea inevitabilmente un po’ di confusione. Questo spiega perché (in una scena del romanzo di Eco ambientata nella redazione della «Libre Parole illustrée», il giornale di Edouard Drumont, fondatore della Ligue Antisémitique) Jacques de Biez, cofondatore della Ligue, rispondesse così all’obiezione di un astante gaffeur che gli ricordava che Cristo era ebreo e del tutto disinteressato al denaro:
– Signori, che Cristo fosse ebreo è una leggenda messa in giro proprio dagli ebrei, come erano san Paolo e i quattro evangelisti. In realtà Gesù era di razza celtica, come noi francesi, che siamo stati conquistati dai latini solo molto tardi. E prima di essere emasculati dai latini, i celti erano un popolo conquistatore, avete mai sentito parlare dei gàlati, che erano arrivati sino in Grecia? La Galilea si chiama così dai Galli che l’avevano colonizzata. D’altra parte il mito di una vergine che avrebbe partorito un figlio è mito celtico e druidico. Gesù, basta guardare tutti i ritratti che ne possediamo, era biondo e con gli occhi azzurri. […] E se gli ebrei erano monoteisti, Cristo lancia l’idea della Trinità, ispirandosi al politeismo celtico. Per questo lo hanno ucciso. Ebreo era Caifa che l’ha condannato, ebreo era Giuda che l’ha tradito, ebreo era Pietro che l’ha rinnegato…[22]
Funziona molto male anche lo stereotipo fisiognomico; il colonnello Dimitri, dei servizi segreti zaristi, volendo raccogliere documenti compromettenti sugli ebrei russi esuli in Francia, si avvale come spia di Jakob Brafmann, un ebreo convertito alla fede ortodossa che si era all’uopo introdotto nell’ Alliance Israélite Universelle di Parigi. Bene: quando Simonini incontra Brafmann, rimane stupito:
Dai racconti del nonno mi attendevo di incontrare un individuo dal profilo di avvoltoio, le labbra carnose, quello inferiore leggermente sporgente, come accade coi negri, occhi infossati e normalmente acquitrinosi, la fessura delle palpebre meno aperta che nelle altre razze, capelli ondulati o ricci, orecchie a sventola… Invece incontravo un signore di aspetto monacale, con una bella barba brizzolata […] Si vede che la conversione trasforma anche i tratti del viso oltre a quelli dell’anima.[23]
Brafmann, ex rabbino e autore del libro Le livre du Kahal (edito in russo a Vilna nel 1869), sostiene la tesi del complotto ebraico contro il mondo cristiano e, al di là dei falsi documenti che esibisce, offre la propria origine ebraica come sola prova della verità delle sue accuse. La costruzione della verità dell’enunciato antisemita è dunque costruita qui non in base alla corrispondenza tra i contenuti del discorso e la realtà, ma solamente in base all’originaria identità religiosa del locutore. Dice infatti Brafmann a Simonini:
Io non mi batto contro gli ebrei, io che sono nato ebreo, ma contro l’idea giudaica che vuole sostituirsi al cristianesimo… Io amo gli ebrei, quel Gesù che loro hanno assassinato mi è testimone…
[…]
– I sentimenti fondamentali che animano lo spirito talmudico sono un’ambizione smisurata di dominare il mondo, un’avidità insaziabile di possedere tutte le ricchezze dei non ebrei, il rancore verso i cristiani e Gesù Cristo. Fino a quando Israele non si convertirà a Gesù i paesi cristiani che ospitano questo popolo saranno sempre considerati da esso come un lago aperto dove ogni ebreo può pescare liberamente, come dice il Talmud.[24]
Vale la pena a questo punto di ricordare anche la figura di Osman Bey, un altro ebreo fanatico antisemita di cui non si fida neanche l’Ochrana, cioè il «Dipartimento per la sicurezza» e i «Servizi di informazione riservata» dell’impero zarista. Chiedendo a Simonini di raccogliere negli ambienti intellettuali russi voci che potessero screditare gli ebrei, Rachkovskij, capo dei servizi segreti, si sente chiedere dal nostro protagonista:
– Quindi volete che gli ebrei siano distrutti, come – forse lo conoscete – Osman Bey.
– Osman Bey è un fanatico, e inoltre è ebreo anche lui. Meglio starne lontano.[25]
Per ragioni di spazio non posso qui passare in rassegna tutte le descrizioni antisemite presenti nel romanzo. Mi limiterò dunque a riportare la divertente tassonomia che, in riferimento a Drumont, ne dà la voce narrativa: «Drumont non era antisemita filosofico e politico come Toussenel, né teologico come Gougenot, era antisemita erotico.». Infatti «Egli odiava gli ebrei, come dire, per amore, per elezione, per dedizione – per un impulso che sostituiva quello sessuale.».[26]
Un’origine paraletteraria
Ricorrere ad una struttura narrativa di tipo affabulatorio tipica della letteratura popolare o paraletteraria, come quella del feuilleton, è una delle più importanti regole inclusive del discorso antisemita.
Il romanzo d’appendice – ha scritto Gramsci – sostituisce (e favorisce nel tempo stesso) il fantasticare dell’uomo del popolo, è un vero sognare ad occhi aperti… In questo caso si può dire che nel popolo fantasticare è dipendente dal “complesso d’inferiorità” (sociale) che determina lunghe fantasticherie sull’idea di vendetta, di punizione dei colpevoli dei mali sopportati ecc.[27]
Ecco perché le moderne pratiche discorsive antisemite sono largamente dipendenti dai romanzi d’appendice. Ma andiamo per ordine: che le fonti dei falsi Protocolli di Sion (usciti in Russia nel 1903 e successivamente) appartenessero in larga parte alla paraletteratura e al feuilleton, era noto ancor prima del 1921. Ancor prima cioè, di quando il corrispondente inglese da Istanbul del «Times», Philippe Graves, pubblicasse tre articoli nei quali dimostrava la falsità dei Protocolli, indicandone le fonti nel dialogo anonimo, ma scritto da Maurice Joly (1829-1879) ed edito a Bruxelles nel 1864, intitolato Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu… Tutta la questione è analizzata e ben documentata storicamente da un saggio del 2006 di Carlo Ginzburg, intitolato Rappresentare il nemico. Sulla preistoria francese dei Protocolli[28] e ideale complemento di lettura del Cimitero di Praga.
Il problema filologico e storico, allora, diventa quello di individuare i collegamenti tra l’ambiente francese e il contesto russo in cui furono confezionati i Protocolli. A ciò il romanzo di Eco dà un contributo interessante e assai valido anche sul piano storico-filologico. Faccio una premessa: Eco segue rigorosamente il “tessuto” lineare della storia e si limita (come già fece nel Nome della rosa)[29] a fare delle piccole “pieghe” immaginarie all’interno di quel tessuto per poi continuare a seguirne il corso. Nel Cimitero di Praga la sola piega presente è rappresentata dal ruolo e dagli interventi di Simonini, unico personaggio di fantasia, se si eccettua il notaio Rebaudengo. Nel dialogo di Joly, dietro ad un tenue velame allegorico, si attaccava Napoleone III e se ne immaginava un futuro complotto antipopolare. Non si parlava di ebrei. La principale fonte di Joly erano Les mystères de Paris (1842-43) di Eugene Sue, nel quale però il complotto era ordito dai gesuiti; in particolare Joly riprendeva dal testo di Sue la lettera che padre Rodin inviava a padre Roothaan. Eco immagina che Simonini, appassionato lettore di feuilleton, per confezionare i suoi falsi documenti antisemiti si sia servito della stessa fonte di Joly, autore ben noto ed elogiato anche da Drumont che Simonini frequentava assiduamente.
In seguito, il nostro ha modo di incontrare Hermann Goedsche (1815-1878), agent provocateur della polizia segreta prussiana e feroce antisemita tedesco. Questi, con abile mossa, riesce a impadronirsi di una copia del “documento” antiebraico pazientemente elaborato da Simonini. In esso, oltre alle ricordate influenze testuali di Joly e di Sue, il complotto degli ebrei per il possesso del mondo era stato ambientato nel cimitero ebraico di Praga. Simonini aveva avuto quest’idea sfogliando un libro di incisioni su quel celebre luogo e leggendo il Giuseppe Balsamo (1849) di Dumas. In una scena di questo romanzo, infatti, Cagliostro riunisce i suoi seguaci massoni sul Mont Tonnerre e con loro ordisce una congiura che avrebbe dovuto cancellare la monarchia francese di Luigi XVI.
Dimentichiamo il monte del Tuono, la riva sinistra del Reno, l’epoca – si era detto Simonini – pensiamo ai congiurati che provengono da ogni parte del mondo a rappresentare i tentacoli della loro setta protesi in ogni paese, raduniamoli in una radura, in una grotta, in un castello, in un cimitero, in una cripta, purché sia ragionevolmente buio, facciamo pronunciare da uno di loro un discorso che ne metta a nudo le trame, e la volontà di conquistare il mondo…[30]
Hermann Goedsche, sotto al nome di John Retcliffe, aveva poi pubblicato nel 1869 a Berlino Biarritz, un «Historisch Politischer Roman» il cui capitolo «Il cimitero di Praga e il Consiglio delle Dodici tribù di Israele», era semplicemente un plagio del documento di Simonini. Così un dialogo di Joly, un’opera di Sue per suo tramite, e il Giuseppe Balsamo di Dumas, per il tramite di Goedsche (o se preferite di Simonini) divennero le principali fonti narrative del nucleo centrale dei Protocolli.
Alla fine del suo romanzo, Eco, concordemente a molti storici, ipotizza l’anello che avrebbe potuto collegare l’ambiente franco-prussiano in cui fu elaborato il nucleo centrale dei futuri Protocolli e quello russo in cui questi furono redatti. Simonini viene pesantemente ricattato da Piotr Rachkovskij (il capo della temibile Ochrana, il servizio russo per la sicurezza) che gli chiede un dossier antiebraico completo da far tradurre successivamente in russo da un uomo di sua fiducia, Golovinskij. Matvei Vasil’evic Golovinskij (1865-1920) era un aristocratico russo fedele allo zar e legato agli ambienti della destra monarchica. Violento antisemita, Golovinskij, di stanza a Parigi, collaborava con zelo con l’Ochrana nella ricerca di documenti che, diffamando gli ebrei, potessero salvare la monarchia stornando il malcontento del popolo russo sul presunto complotto ebraico. Dopo la Rivoluzione sovietica, Golovinskij si trasformò in acceso bolscevico, il che non stupisce. Ciò che Eco non dice e che ricavo dalle recenti ricerche di Vadim Skuratovsky[31] è che, insieme a Charles Joly, figlio di Maurice, Golovinskij collaborava attivamente al «Figaro» pubblicando frequenti e violentissimi articoli antisemiti. Tout se tient… dunque.
Ma torniamo al romanzo: pressato dal ricatto, Simonini si mette all’opera e dopo pochi giorni riceve la visita di Golovinskij. Riassunto il suo lavoro, il cui titolo ipotizzato da Golovinskij doveva essere I protocolli della riunione dei rabbini nel cimitero di Praga, Simonini conclude con alcune orgogliose citazioni dal suo testo. Al che Golovinskij, soddisfatto, esclama: « – Non male per un romanzo d’appendice».[32] Il che conferma quanto ho detto sull’origine paraletteraria del discorso antisemita.
Volendo ora chiudere l’anello della mia analisi mi sembra che con Il cimitero di Praga, Eco, pur non nominandola, ci abbia ammonito indirettamente a non distogliere lo sguardo dalla Shoah, a non distanziarla nell’evento mostruoso e unico e soprattutto a non occultarla dietro a veli olocaustici e sacrificali. Quei veli che – disse una volta Lacan[33] – costituiscono una perversa fascinazione per chi cerca sempre nel sacrificio il bisogno di corrispondere al desiderio di un dio… di un dio, però, oscuro e ingannatore, nascosto dentro di sé.
[1] Chrétien de Troyes, Romanzi, a cura di Carlo Pellegrini, tr. it. di Silvio Pellegrini, Sansoni, Firenze 1962, p. 582.
[2] In Gustav Janouch, Colloqui con Kafka, in Franz Kafka, Confessioni e diari, tr. it. e cura di Ervino Pocar, Mondadori, Milano 1972, p. 1086.
[3] Umberto Eco, Il cimitero di Praga, Bompiani, Milano 2010.
[4] Vd. Anna Foa, La micidiale macchina del falso, in «Pagine ebraiche», in www.moked.it/paginebraiche/3/10/2010; Riccardo Di Segni, Domande senza risposta, in www.moked.it/blog/2010/10/20; Lucietta Scaraffia, Il voyeur del male, in «L’Osservatore romano» del 30 ottobre 2010.
[5] Simon Levis Sullam, L’archivio antiebraico, Laterza, Bari 2008. Vd. anche Michele Battini, Il socialismo degli imbecilli. Propaganda, falsificazione, persecuzione degli ebrei, Bollati Boringhieri, Torino 2010.
[6] Cfr. Alphonse de Toussenel, Les Juifs. Rois de l’époque, Paris 1845.
[7] Vd. Bénédict Augustin Morel, Traité des dégénérescences, Paris 1857. Vd. anche Giovanni Palmieri, I miti europei della «nevrastenia» e della «degenerazione» nell’opera di Svevo, in «Autografo», n. 30, 1995, pp. 75-87.
[8] Max Nordau, Entartung, Berlino 1892; tr. fr. Dégénérescence, Paris 1892; tr. it. Degenerazione, Milano 1893.
[9] Giovanni Palmieri, art. cit., p. 80.
[10] Art. cit. qui alla n. 4.
[11] Cfr. Michel Foucault, L’Ordre du discours, Gallimard, Paris 1971, tr. it. di Alessandro Fontana, Einaudi, Torino 1972.
[12] Traggo la citazione (e rimando per i riferimenti bibliografici) da Carlo Ginzburg, Rappresentare il nemico. Sulla preistoria francese dei Protocolli, in id., Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 197-98 e n. 38.
[13] Op. cit., p. 400.
[14] Op. cit., pp. 400-01. Cfr. Gougenot des Mousseaux, Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens, Paris 1869; Edouard Drumont, La France Juive. Essai d’histoire contemporaine, 2 voll, Paris 1886.
[15] Op. cit., pp. 226-27
[16] Op. cit., p. 11.
[17] Ivi.
[18] Op. cit., p. 49.
[19] Marcel Proust, Dalla parte di Swann, in id., Alla ricerca del tempo perduto, a cura di Alberto Beretta Anguissola e Daria Galateria, tr. it. di Giovanni Raboni, Mondadori, Milano 1983, vol. 1, p. 111.
[20] Ivi, pp. 111-112.
[21] Op. cit., p. 54.
[22] Op. cit., p. 409.
[23] Op. cit., p. 231.
[24] Op. cit., p. 233-35.
[25] Op. cit., p. 399. Cfr. Osman Bey, Gli ebrei alla conquista del mondo (1880), L. Cappelli, Bologna 1939.
[26] Op. cit., p. 401.
[27] Antonio Gramsci, La letteratura popolare, in id., Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino 1950, p. 108.
[28] Cit. qui alla n. 11.
[29] Edito a Milano da Bompiani nel 1980.
[30] Op. cit., p. 95.
[31] Vadim Skuratovsky, La questione della paternità di “Protocolli dei savi di Sion” (titolo e testo in russo), Judaica Institute, Kiev 2001. Non ho visto il libro di Skuratovsky (che non risulta tradotto in alcuna lingua) e ne ho avuto notizia solo da Wikipedia alla voce Protocolli dei Savi di Sion (http:// it.wikipedia.org). Si prenda dunque l’informazione con le dovute cautele.
[32] Op. cit., p. 498. Eco è anche autore di uno studio sul romanzo d’appendice intitolato Il superuomo di massa (Cooperativa scrittori, Roma 1976).
[33] Jacques Lacan, Le séminaire livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Paris 1973, p. 246-47.



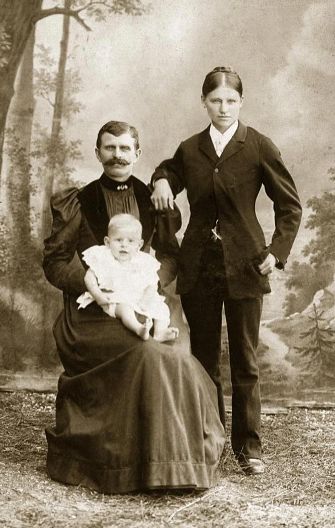


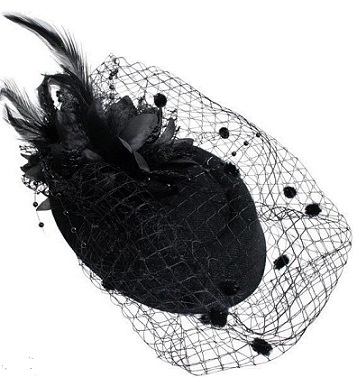







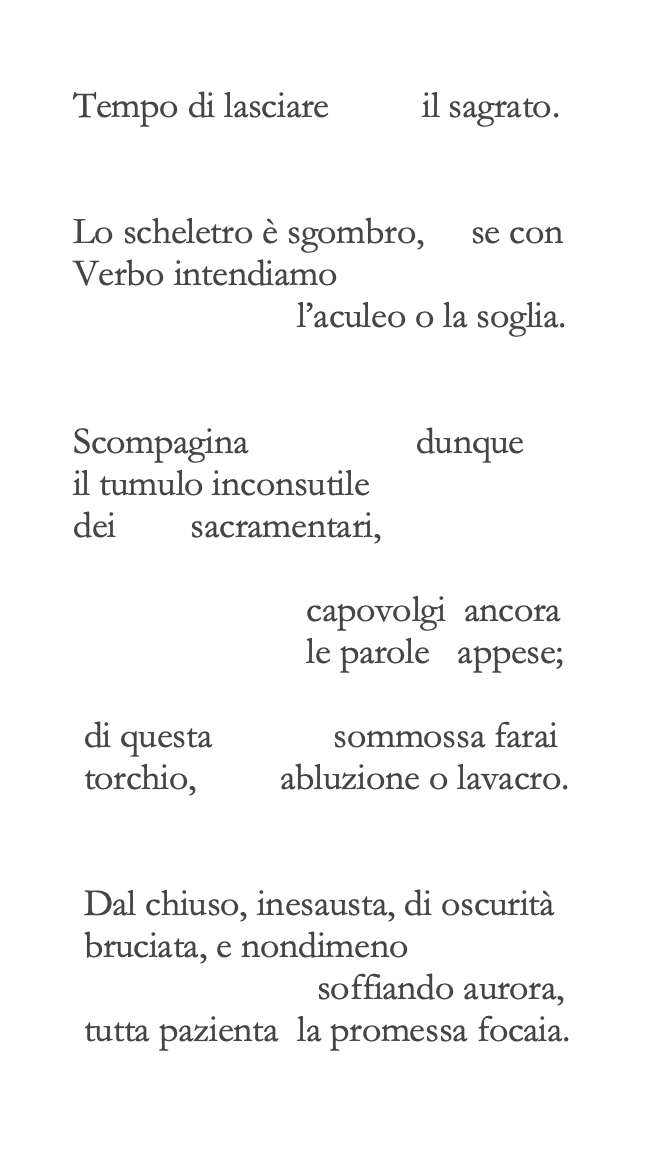
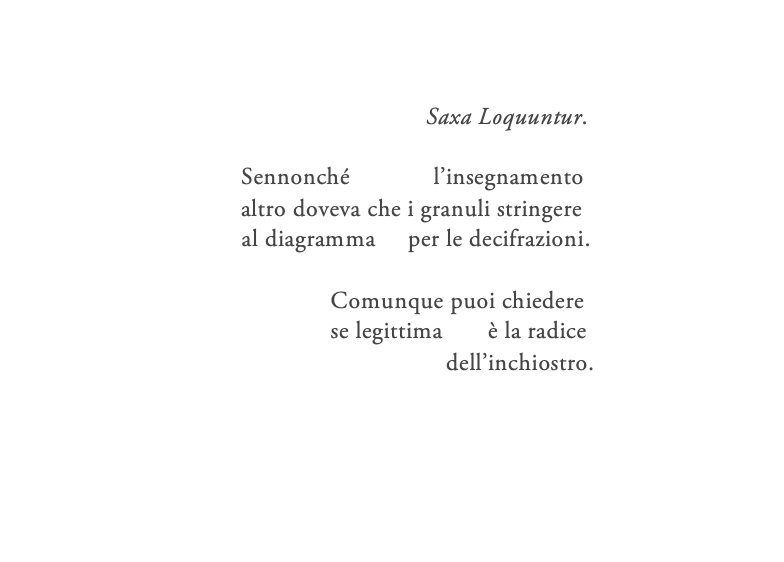
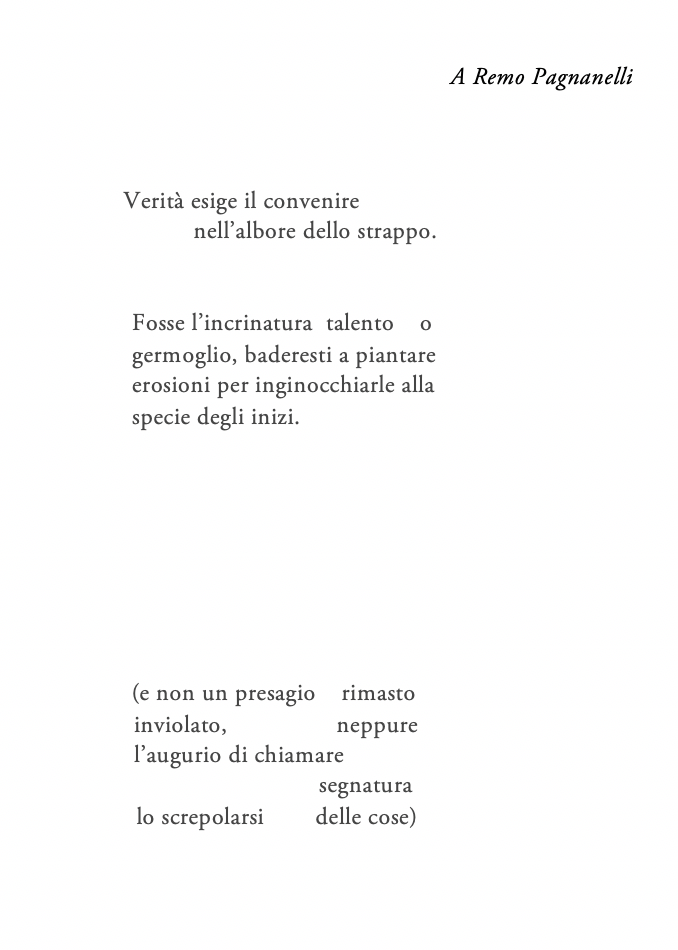


 di Walter Nardon
di Walter Nardon

