
di Simonetta Spinelli*
«In questa geenna dorata adorata nera dà i tuoi addii mia bellissima mia fortissima mia indomabilissima mia sapientissima mia ferocissima mia dolcissima mia amatissima, a ciò che esse chiamano l’affetto e la tenerezza o il grazioso abbandono »
Monique Wittig, Il corpo lesbico, Milano, Edizioni delle donne, 1976, p.13 **
.
Il corpo lesbico (1998)***
Wittig è il rimosso dell’analisi femminista. Rappresenta il punto di rottura sul quale non ci siamo soffermate, che ritorna, non ancora analizzato, e disgrega trame di percorsi e di relazioni politiche, che volevamo fondate sul riconoscimento, ma contenevano un disconoscersi di cui abbiamo, allora, colto istintivamente i nessi, senza riuscire a dargli parola. Non sciolto, quel disconoscimento ritorna e costruisce nuove barriere tra donne.
Piombò, letteralmente, Wittig negli anni Settanta sui nostri gruppi di autocoscienza e sulla fatica di uscire dall’analisi dell’oppressione, tentando di ricostruire un linguaggio altro. Sessuato, diremmo oggi. Allora, in un abbozzo di analisi, tentavamo strade che partissero da noi, dai nostri corpi, e a noi tornassero. Prendevamo distanze da un linguaggio codificato e ci riappropriavamo di corpi che non conoscevamo, di complicità negate. Costruivamo le parole per dirci. Donne lesbiche o eterosessuali. Insieme, in un “Donna è bello” che ci lanciavamo reciprocamente come una sfida e come una rete.
Non c’è stata in Italia, come in altri paesi europei o come negli U.S.A., una frattura nel movimento femminista tra donne lesbiche e eterosessuali. Il lesbismo è uscito allo scoperto e si è nominato come lesbismo femminista. Luogo di costruzione di rapporti, di teorizzazione sul “personale è politico”, il femminismo è stato il naturale approdo delle donne lesbiche politicizzate, che trovavano nei collettivi e nei gruppi un’apertura di discorso che le prevedeva e le rendeva partecipi e protagoniste. La loro presenza ha, parallelamente, spostato l’analisi femminista sulla sessualità. Materializzato nei loro corpi un desiderio non eterodiretto, la loro stessa esistenza metteva in discussione le pretese onnivore del codice e nominava il corpo femminile come corpo desiderante. Perché per una donna dire: il corpo del mio desiderio è una donna, è nominare un indicibile, esplicitare che quel corpo segue strade di desiderio solo sue, di cui solo quel corpo di donna conosce e sa la sua necessità.
Siamo rimaste ai margini di un discorso sulla sessualità. Bloccate in un irrigidimento comune, delle donne lesbiche e delle donne eterosessuali. Come se, invece di ridarci spazio, l’avessimo perimetrato. E abbiamo cominciato a giocare con le parole, limandole mediandole. Le une timorose di una spaccatura che le avrebbe lasciate, ancora una volta, orfane; le altre intimorite da un sospetto di un’egemonia, della messa in mora delle proprie scelte. Tutte a ripetersi parole caute. Su questa cesura è piombata, letteralmente, Wittig. Tracotante Wittig, incurante delle convenzioni letterarie e linguistiche, che stravolge e di cui si riappropria, caricandole dei significati dell’eccesso. Irrecuperabile Wittig, scardinante, incontenibile. Così altro dal codice le sue immagini e il suo linguaggio da rendere impensabile ogni tentativo di addomesticamento. L’iperbole nel suo testo è una lotta a corpo a corpo ingaggiata con le parole, con la struttura sintattica, con i generi. L’iperbole e l’eccesso sono le parole per dire il corpo lesbico, corpo selvaggio, ininquadrabile in termini convenzionali, corpo stravolto, smembrato, ricostruito e poi ancora smembrato.
Il soggetto di quel desiderio e di quel percorso è, a sua volta, un soggetto che si smembra e si ricompone, al di fuori delle categorie date: j/e, né femmina, né maschio, perché il femminile e il maschie sono il portato di una convenzione sociale codificata che il corpo lesbico, nella sua ricostruzione di sé per sé, cancella e rende insensata.
Wittig è stata il nostro primo totale spaesamento culturale. Non si poteva accettare a metà. O si rifiutava il suo testo o ci si cadeva dentro. E spesso il rifiutarla è stata una difesa che ha solo procrastinato il catturamento. Perché da lei siamo state catturate. Noi lesbiche per una parola orgogliosa e potente che riscriveva il mondo della nostra visione, e urlava una storia che eravamo abituate a tenere segreta. Le donne eterosessuali per la fascinazione di un testo che diceva un corpo di donna trionfante, desiderante e impudente. Un corpo non definibile in termini di ruoli.
Eppure de Il corpo lesbico mai abbiamo parlato. Abbiamo discusso, polemizzato su The Straight Mind,[1] sul genere come costruzione sociale – e le giovani lesbiche, ancora oggi, lanciano il suo “le lesbiche non sono donne” per radicalizzare una polemica. Ma sullo spaesamento culturale che tutte aveva colpito, mai ci siamo confrontate. Perché individuava un punto dolente che non volevamo/non eravamo in grado di affrontare. Al punto da rimuovere proprio la diversa valenza che il pensiero di Wittig ha rappresentato per le donne lesbiche e per le donne eterosessuali.
Mi colpisce, oggi, la prefazione di Elisabetta Rasy all’edizione italiana, che non ricordo di aver letto – cosa improbabile – e che mi sembra significativa della divergenza di analisi che andava maturando. Rasy scrive:
«Dietro il romanzesco del lessico anatomico, e seguendo esclusivamente la corporeità degli oggetti e delle sensazioni, Monique Wittig recita il percorso di una ricognizione del corpo che è “lesbico” e non “femminile”, perché il corpo femminile è il corpo della donna visto e usato dall’uomo – un feticcio, cioè, per la donna – e il corpo lesbico è il corpo della donna visto e vissuto dalla donna: come nei sogni l’omosessualità è autoerotismo, cioè ancora una ricognizione, una scoperta» (pp.9-10)
Per Rasy, la decostruzione/ricostruzione che dà origine al corpo lesbico è riappropriazione di un corpo di donna visto e vissuto da una donna, di una dimensione autoerotica, e l’omosessualità è un traslato, “come nei sogni”.
Negli anni Ottanta, in altro contesto, Teresa de Lauretis, teorica lesbica. Studiosa di femminismo e di semiotica, sullo stesso testo scrive:
«E cosa si svolge qui? Lo smembramento e la lenta decomposizione del corpo della “donna”, arto dopo arto, organo dopo organo, secrezione dopo secrezione. Nessuna saprà sopportarne la vista, nessuna accorrerà in aiuto durante questa spaventosa, atroce e esilarante fatica d’amore che smembra il corpo e lo rimembra, lo ricostituisce in una nuova economia erotica, lo ri-conosce in un’altra semiotica… lo riscrive con desiderio in-verso, diverso, lo ritrova diversa-mente: un corpo lesbico»[2]
Non sono due interpretazione tra le tante possibili, sono due ottiche completamente diverse. Rasy, in Wittig, legge “il recupero politico del sociale che la donna vive all’interno del proprio corpo, territorio di colonia sconosciuto e ostile”, o la metafora del viaggio solitario, puntualizzato dalle “stazioni anatomiche del corpo lesbico”, verso la riappropriazione di sé e l’uscita dalla logica dell’oppressione. Per de Lauretis, il corpo lesbico segna il percorso di una “fatica d’amore”, una ricerca del desiderio che, proprio perché è desiderio di una donna per una donna, costruisce una diversa economia erotica. Ma perché questa economia erotica si instauri, non è sufficiente una donna. E’ necessaria una lesbica, cioè una donna amante/amata, desiderante/desiderata da un’altra donna. Consapevoli l’una e l’altra del desiderio e motivate, proprio da quel desiderio, a costruirne il linguaggio e la pratica, a “riconoscerlo in un’altra semiotica”.
“In questa geenna dorata adorata…”: il j/e, soggetto decostruito/ricostruito, è soggetto di una relazione sessuata e sessuale che contempla un tu, soggetto decostruito/ricostruito, smembrato/rimembrato dalla stessa ricerca di senso, dallo stesso desiderio non addomesticato e inaddomesticabile. Un desiderio di donna per donna.
Wittig è il rimosso dell’analisi femminista perché per prima ha nominato il desiderio come unica forza capace di ridislocare simultaneamente tutti i parametri sui quali poggiano le codificazioni sociali, forza fondante che ha in sé la sua necessità, ma il suo testo è stato ridotto a eccentricità letteraria, a provocazione che abbiamo lasciato cadere.
Note
[1] M.Wittig, The Straight Mind, in «Feminist Issues», I,1 (1980), pp. 103-112 [trad. di R. Fiocchetto, in «Bollettino del CLI», IX,2 (1990), pp. 5-14].
[2] T. de Lauretis, Sexual Indifferences and Lesbian Representation, in «Theatre Journal», XL,2, pp. 155-177 ; [trad.it. Differenza e indifferenza sessuale. Per l’elaborazione di un pensiero lesbico, Firenze, Estro, 1989].
*Avevo chiesto a Simonetta Spinelli il permesso di pubblicare alcuni suoi articoli scritti diversi anni fa e già postati sul suo blog. Le avevo anche chiesto di scrivere una breve nota di accompagnamento per ogni intervento, raccontando in sintesi le circostanze della composizione e il contesto di discussione in cui si inseriva, e lei lo ha fatto finora, di questo le sono grata. Purtroppo Simonetta ci ha lasciato più di un mese fa. Altre – più vicine e con maggior cognizione di causa – sapranno dare alle sue riflessioni la risonanza e la continuità che meritano. Qui ci limitiamo a continuare a ritrasmetterla come un segnale radar. La scelta di ripubblicare questi testi in serie spero sia sempre evidente a chi legge: (non solo sono incredibilmente belli, ma) sono inattuali e perciò parlano al presente.
Gli altri articoli di Simonetta Spinelli su Nazione Indiana:
Passioni a confronto. Mario Mieli e le lesbiche femministe
Pratiche lesbiche e vincoli ciechi
** Monique Wittig, Le corps lesbienne, Paris, Les Editions de Minuit, 1973.
*** Questo articolo intitolato “Monique Wittig: Il corpo lesbico”, è stato pubblicato in Cento Titoli, Guida ragionata del Femminismo degli anni Settanta, a cura di A.Ribero e F. Vigliani, Ferrara, Luciana Tufani editrice, 1998, pp. 191-194.


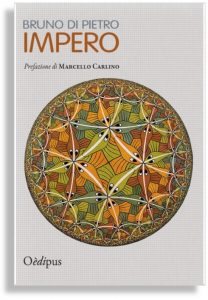
 La post-fazione al libro di Cathie Carmichael Bosnia e Erzegovina
La post-fazione al libro di Cathie Carmichael Bosnia e Erzegovina
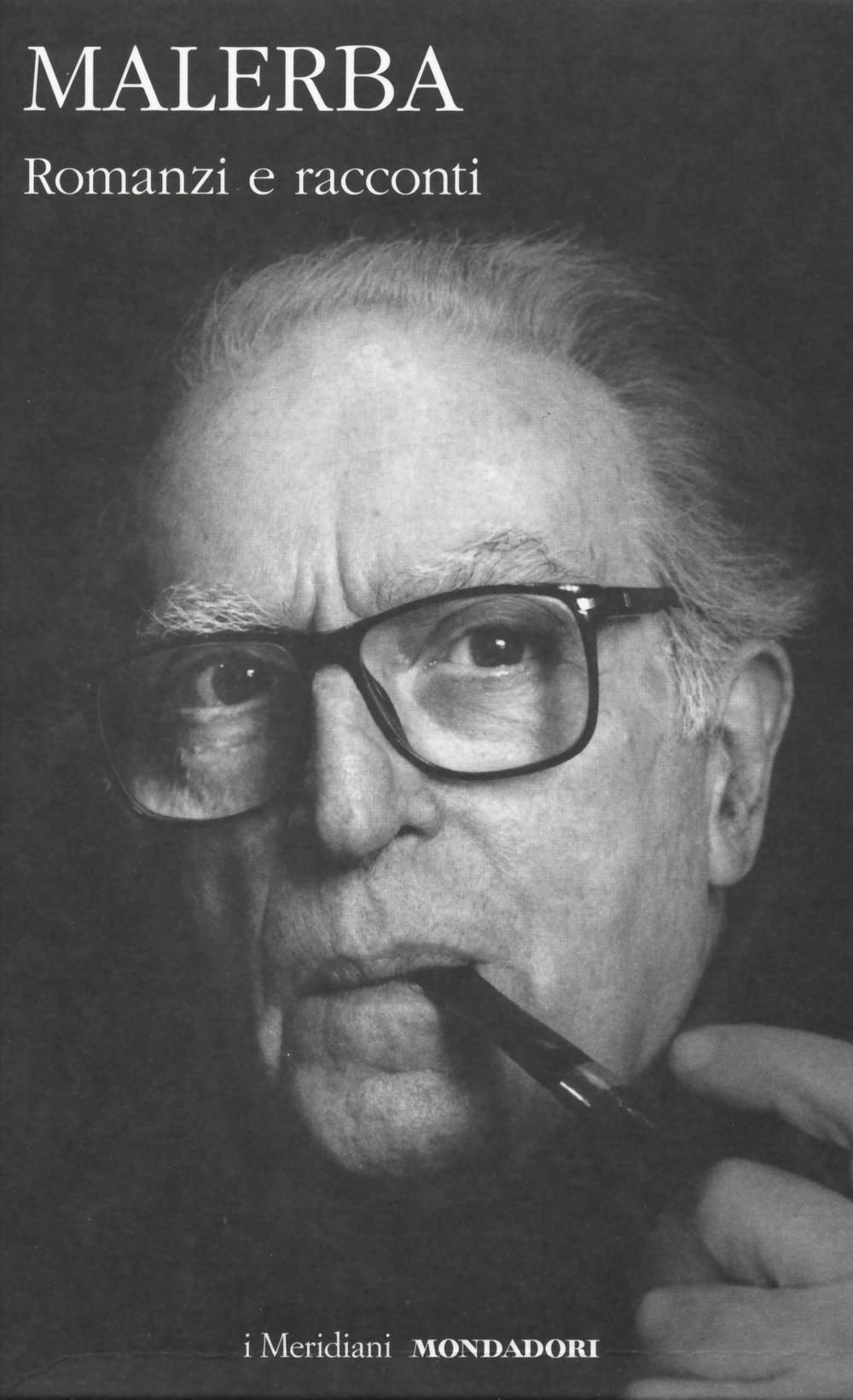
 di Massimiliano Manganelli
di Massimiliano Manganelli 
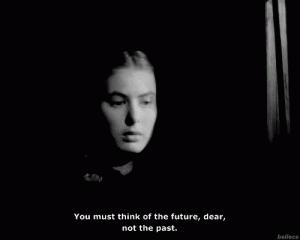
 Questo meccanismo perverso (che di perververtimento si tratta) non solo produce doppiamente senso ed esperienze di colpevolezza e vergogna nella vittima, ma preclude ogni possibilità di essere davvero creduta, di essere presa in considerazione nel suo dire, nel suo appello – là dove ci sia ancora la forza di pronunciarlo.
Questo meccanismo perverso (che di perververtimento si tratta) non solo produce doppiamente senso ed esperienze di colpevolezza e vergogna nella vittima, ma preclude ogni possibilità di essere davvero creduta, di essere presa in considerazione nel suo dire, nel suo appello – là dove ci sia ancora la forza di pronunciarlo.
 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta 

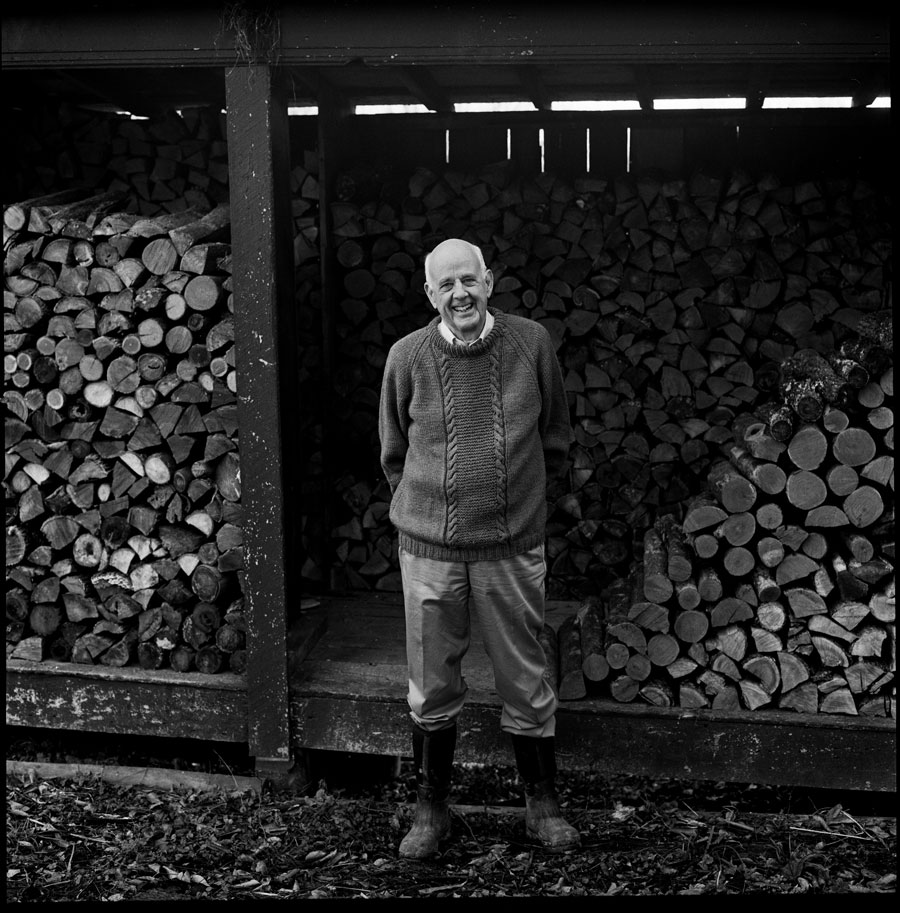


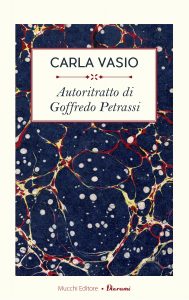 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta







 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta di Edoardo Zambelli
di Edoardo Zambelli
