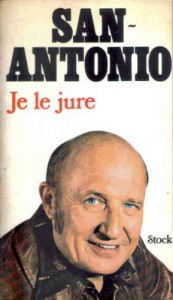Georges Perec, Il Condottiero, traduzione di Ernesto Ferrero, Voland, 2012; W o il ricordo d’infanzia, traduzione Dianella Selvatico Estense, Rizzoli, 1991; La vita istruzioni per l’uso, traduzione Dianella Selvatico Estense, Rizzoli, 1984.
Nel 1960 Gaspard Winckler è un pittore falsario. Nel 1975 Gaspard Winckler è un bimbo sordomuto. Nel 1978 Gaspard Winckler è un artigiano che fabbrica cinquecento puzzle. Carneade sappiamo ormai chi è, ma Gaspard Winckler, chi era costui? E soprattutto, appurato che sia soltanto un personaggio inventato da Georges Perec, come si spiega la sua compresenza in tre romanzi diversi, in vesti diverse eppure caratterialmente affini? Perché quel cognome, tutt’altro che francese, con quella W iniziale particolarmente insistente che dà addirittura il titolo a uno dei tre romanzi (W o il ricordo d’infanzia), che torna come pezzo finale dell’ultimo irrisolto puzzle di Bartlebooth (La vita istruzioni per l’uso)? E se Perec, che conosceva bene Calvino, condividesse con lui quella sarcastica idea che scrivere fosse nascondere qualcosa in modo che poi venisse scoperto? (Ne La scomparsa, 1969, Perec fa addirittura sparire la lettera E che ricompare nella dedica anteposta al libro successivo, appunto W o il ricordo d’infanzia)
Ma procediamo con ordine. Ordine cronologico, si intende, ossia l’unico ordine possibile in questo tipo di indagini. Gaspard Winckler appare per la prima volta nel romanzo breve Il Condottiero. A dire il vero, il titolo originale è La Nuit (La notte), trecentocinquanta pagine dattiloscritte che assumeranno poi il titolo di Gaspard, quindi nel 1959 di Gaspard pas mort (Gaspard non morto), per ridursi a centocinquantasette pagine nel 1960 con Le Condottière e sparire infine nel modo più assurdo per un manoscritto: chiuso in una valigetta di cartone pressato smarrita durante un trasloco. Perec morì credendo perduto per sempre quello che in W o il ricordo d’infanzia definisce come il primo romanzo più o meno compiuto che era riuscito a scrivere. E che per poco non era riuscito a pubblicare. Il manoscritto era stato infatti rifiutato dalle Éditon du Seuil ma accettato da Gallimard con tanto di anticipo sui diritti, quindi inspiegabilmente ribocciato. Perec aveva allora deciso di accantonarlo: “Lo riprenderò tra dieci anni, epoca in cui questo produrrà un capolavoro o magari attenderò nella tomba che un fedele esegeta lo ritrovi in un vecchio baule che ti era appartenuto e lo pubblichi” (lettera a Jacques Lederer, 4 dicembre 1960). Una profezia. Accadrà proprio così o quasi: non il vecchio baule, ma una remota scansia in casa o nella cantina del giornalista Alain Guérin de L’Humanité. Non il manoscritto originale, ormai smarrito per sempre nel trasloco, ma una copia dimenticata da un quarto di secolo che attendeva il biografo David Bellos con la sua monumentale ricerca sul mondo di Perec.
La storia fin qui ricostruita è esposta nella bella postfazione di Cluade Burgelin all’edizione di Voland de Il Condottiero, prima edizione italiana, pubblicata nel novembre 2012. Ne Il Condottiero Gaspard Winckler – per usare le stesse parole di Perec utilizzate in W o il ricordo d’infanzia – “è un falsario geniale che non riesce a rifare un Antonello da Messina e che, in seguito a quel fallimento, è indotto all’assassinio di chi glielo ha commissionato”. Dopo l’omicidio Gaspard Winckler tenta la fuga e sparisce. Dove? Dentro un altro libro, appunto W o il ricordo d’infanzia.
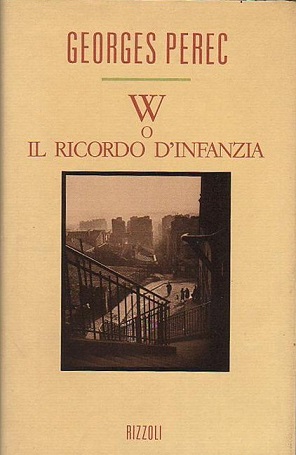 Il problema, almeno per quanto riguarda le edizioni italiane, è che sparisce fisicamente anche il libro in cui Gaspard Winckler è sparito. Nel senso che l’ultima edizione di W o il ricordo d’infanzia, quella di Einaudi del 2005, è da tempo fuori catalogo. Girano voci che sotto la spinta delle celebrazioni per il trentennale della morte di Perec, che ricorreva l’anno scorso, la Dalai Editore stia preparando una nuova traduzione. Ma per un lettore compulsivo quale il sottoscritto, non era possibile attendere tanto tempo. Qualche mese a spiare la rete, da Maremagnum a Ebay, infine con soli dodici euro riesco a procurarmi niente meno che la prima edizione italiana, quella di Rizzoli del 1991. Lo leggo e ritrovo Gaspard Winckler: “Gaspard Winckler era a quei tempi un bambino di otto anni. Sordomuto. Sua madre, Caecilia, era una cantante austriaca, nota in tutto il mondo, che durante la guerra aveva trovato rifugio in Svizzera. Gaspard era un ragazzino rachitico e gracile, condannato dalla sua infermità a un isolamento pressoché totale”. Per aiutarlo a superare le sue problematiche, la madre lo porta fare un giro del mondo. Peccato che il Sylvandre, il panfilo di venticinque metri su cui si imbarcano, faccia naufragio al largo della Terra del Fuoco. Gaspard Winckler scompare dal libro e scompare di nuovo dal mondo letterario. Il libro prosegue con un parallelo – a capitoli alterni – tra il tentativo da parte di Perec di ricostruire la propria infanzia e il mondo straordinario di W, isola della Terra del Fuoco dove vige un sistema sociale basato esclusivamente sullo sport ma che via via, nel corso della narrazione, si rileva una vera e propria parodia dei campi di concentramento nazisti. Che il piccolo Winckler, unico superstite del naufragio, sia finito proprio lì? Che tutto sia una metafora, terribile metafora di una realtà che si ripropone ciclicamente nella storia del genere umano? Ma W è anche il titolo della la storia che Perec inventò, raccontò e disegnò nella prima adolescenza. Scrive nel finale del libro: “Ho dimenticato i motivi che, a dodici anni, mi hanno spinto a scegliere la Terra del Fuoco per collocarvi W: i fascisti di Pinochet si sono fatti carico di dare alla mia terra fantasma un’ultima risonanza: vari isolotti della Terra del Fuoco sono, oggi [1974], campi di deportazione”.
Il problema, almeno per quanto riguarda le edizioni italiane, è che sparisce fisicamente anche il libro in cui Gaspard Winckler è sparito. Nel senso che l’ultima edizione di W o il ricordo d’infanzia, quella di Einaudi del 2005, è da tempo fuori catalogo. Girano voci che sotto la spinta delle celebrazioni per il trentennale della morte di Perec, che ricorreva l’anno scorso, la Dalai Editore stia preparando una nuova traduzione. Ma per un lettore compulsivo quale il sottoscritto, non era possibile attendere tanto tempo. Qualche mese a spiare la rete, da Maremagnum a Ebay, infine con soli dodici euro riesco a procurarmi niente meno che la prima edizione italiana, quella di Rizzoli del 1991. Lo leggo e ritrovo Gaspard Winckler: “Gaspard Winckler era a quei tempi un bambino di otto anni. Sordomuto. Sua madre, Caecilia, era una cantante austriaca, nota in tutto il mondo, che durante la guerra aveva trovato rifugio in Svizzera. Gaspard era un ragazzino rachitico e gracile, condannato dalla sua infermità a un isolamento pressoché totale”. Per aiutarlo a superare le sue problematiche, la madre lo porta fare un giro del mondo. Peccato che il Sylvandre, il panfilo di venticinque metri su cui si imbarcano, faccia naufragio al largo della Terra del Fuoco. Gaspard Winckler scompare dal libro e scompare di nuovo dal mondo letterario. Il libro prosegue con un parallelo – a capitoli alterni – tra il tentativo da parte di Perec di ricostruire la propria infanzia e il mondo straordinario di W, isola della Terra del Fuoco dove vige un sistema sociale basato esclusivamente sullo sport ma che via via, nel corso della narrazione, si rileva una vera e propria parodia dei campi di concentramento nazisti. Che il piccolo Winckler, unico superstite del naufragio, sia finito proprio lì? Che tutto sia una metafora, terribile metafora di una realtà che si ripropone ciclicamente nella storia del genere umano? Ma W è anche il titolo della la storia che Perec inventò, raccontò e disegnò nella prima adolescenza. Scrive nel finale del libro: “Ho dimenticato i motivi che, a dodici anni, mi hanno spinto a scegliere la Terra del Fuoco per collocarvi W: i fascisti di Pinochet si sono fatti carico di dare alla mia terra fantasma un’ultima risonanza: vari isolotti della Terra del Fuoco sono, oggi [1974], campi di deportazione”.
Tre anni dopo l’uscita di W o il ricordo d’infanzia, la Librairie Hachette pubblica il capolavoro di Perec: La vie mode d’emploi (La vita istruzioni per l’uso). Il solo titolo è da sé un colpo di genio. Lo stesso anno vince il premio Médicis. L’intervista a Perec, trasmessa su Antenne 2, è reperibile negli archivi on-line dell’ente nazionale francese INA per le documentazioni audiovisive, qui.
 Ne La vita istruzioni per l’uso Gaspard Winckler è di nuovo uno dei protagonisti. Qui è un artigiano. Moltissime le affinità con il Gaspard Winckler de Il Condottiero. Entrambi vengono reclutati giovanissimi da personaggi di un certo spessore economico: il mercante d’arte (o meglio, di arte falsificata) Anatole Madera ne Il Condottiero, l’eccentrico miliardario inglese Bartlebooth ne La vita. Entrambi sono fatti carico di un progetto impossibile: il primo inventare un Antonello da Messina autentico, il secondo cinquecento puzzle perfetti ma diseguali tra loro. Entrambi si ribellano alla propria condizione di sottomissione: il Winckler de Il Condottiero uccide l’antagonista già nella prima pagina, il Winckler de La vita nell’ultima (a cui seguiranno le due pagine dell’Epilogo). Cambia il modus operandi della ribellione: Madera viene ucciso fisicamente, sgozzato con una lama. Bartlebooth viene ucciso da un enigma insolubile: davanti a lui è il quattrocentonovantesimo puzzle in cui manca un pezzo che disegna la sagoma quasi perfetta di una X, ma il pezzo che il morto regge tra le dita ha la forma di una lettera W. Come W di Winckler, ovviamente.
Ne La vita istruzioni per l’uso Gaspard Winckler è di nuovo uno dei protagonisti. Qui è un artigiano. Moltissime le affinità con il Gaspard Winckler de Il Condottiero. Entrambi vengono reclutati giovanissimi da personaggi di un certo spessore economico: il mercante d’arte (o meglio, di arte falsificata) Anatole Madera ne Il Condottiero, l’eccentrico miliardario inglese Bartlebooth ne La vita. Entrambi sono fatti carico di un progetto impossibile: il primo inventare un Antonello da Messina autentico, il secondo cinquecento puzzle perfetti ma diseguali tra loro. Entrambi si ribellano alla propria condizione di sottomissione: il Winckler de Il Condottiero uccide l’antagonista già nella prima pagina, il Winckler de La vita nell’ultima (a cui seguiranno le due pagine dell’Epilogo). Cambia il modus operandi della ribellione: Madera viene ucciso fisicamente, sgozzato con una lama. Bartlebooth viene ucciso da un enigma insolubile: davanti a lui è il quattrocentonovantesimo puzzle in cui manca un pezzo che disegna la sagoma quasi perfetta di una X, ma il pezzo che il morto regge tra le dita ha la forma di una lettera W. Come W di Winckler, ovviamente.
Da X a W. Del resto in W o ricordo d’infanzia Perec ci aveva già svelato i segreti magici di questa lettera: basta accostare di punta le due V contenute in W per ottenere una X. Ma prolungando le aste della X con segmenti uguali e perpendicolari si ottiene anche una croce uncinata, che a sua volta è composta da due S incrociate, ovvero il simbolo delle famigerate SchutzStaffeln. Non solo, la sovrapposizione di due V capovolte genera la figura XX dove è sufficiente riunire orizzontalmente le aste per ottenere la stella ebraica a sei punte.
W è dunque la lettera simbolo, la lettera che contiene in sé tutti i simboli e tutte le altre lettere, il borghesiano Aleph, l’alfa e l’omega di tutti gli alfabeti. E allora, chi è Winckler se non il personaggio che contiene in sé tutti i personaggi, che ne va del suo essere personaggio trasversale di più libri? Ne La vita è riprodotta tipograficamente la partecipazione listata a lutto della sua scomparsa:
“La S.V. è pregata di assistere all’inumazione di Gaspard WINCKLER, deceduto a Parigi il 29 ottobre 1973 all’età di sessantatré anni. Il trasporto avrà luogo il 3 novembre 1973 alle dieci a.m. partendo dall’obitorio dell’ospedale Bichat, boulevard Ney, 170, Parigi 17°. NIENTE FIORI”.
Winckler non è il joyciano Dignam, il funerale non verrà narrato. Gaspard Winckler muore e scompare così. Scompare ancora una volta. Questa è l’ultima solo perché Perec morirà anche lui appena quattro anni più tardi. Ma non mi stupirei se il buon Winckler riapparisse di colpo in un altro libro di altro autore.
Un ultimo appunto: sul sito americano Bob Armstrong’s Old Jigsaw Puzzles è riportata l’immagine di citato un puzzle realizzato da tale Steve McAllister che porta il nome di Gaspard Winkler (con la sola K, senza la C). Questo significa che in rete già si aggira il suo fantasma.

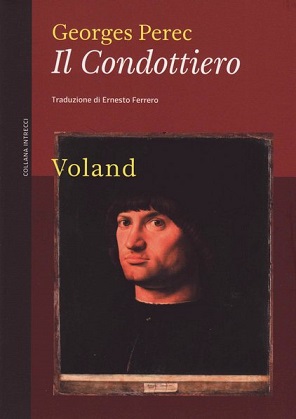

 Il gioco si richiama a Doom (1993) nella storia e nell’ambientazione: gli ambienti sono spesso bui, labirintici ed opprimenti, gli esterni sono inospitali. Deve molto anche ai successivi Quake e QuakeII di ID Software, per la dimensione esplorativa negli ambienti, le architetture monumentali, i problemi fisici (i classici salti, piattaforme mobili e movimenti a tempo). Viene usata abbondantemente l’oscurità come elemento di incertezza per coinvolgere emotivamente il giocatore: molti livelli sono in penombra e alcuni assolutamente bui, la torcia elettrica non è utilizzabile insieme ad un’arma e ciò costringere il giocatore a scegliere se vedere o sparare, o a snervanti cambi di mano tra pila e fucile divenuti ormai proverbiali.
Il gioco si richiama a Doom (1993) nella storia e nell’ambientazione: gli ambienti sono spesso bui, labirintici ed opprimenti, gli esterni sono inospitali. Deve molto anche ai successivi Quake e QuakeII di ID Software, per la dimensione esplorativa negli ambienti, le architetture monumentali, i problemi fisici (i classici salti, piattaforme mobili e movimenti a tempo). Viene usata abbondantemente l’oscurità come elemento di incertezza per coinvolgere emotivamente il giocatore: molti livelli sono in penombra e alcuni assolutamente bui, la torcia elettrica non è utilizzabile insieme ad un’arma e ciò costringere il giocatore a scegliere se vedere o sparare, o a snervanti cambi di mano tra pila e fucile divenuti ormai proverbiali.