di Nicola Ponzio
Parola.
Parola.
Due parole.
Tre parole rosse.
Cinque parole ed un endecasillabo.
Otto parole per evidenziare la fisicità della scrittura.
di Nicola Ponzio
Parola.
Parola.
Due parole.
Tre parole rosse.
Cinque parole ed un endecasillabo.
Otto parole per evidenziare la fisicità della scrittura.
Che fine ha fatto TQ?
Pubblicato il 4 giugno 2013 · in alfabeta2,
di
Vincenzo Ostuni
Che fine ha fatto TQ, gruppo di intellettuali trenta-quarantenni, le cui prime mosse vennero seguite con clamore dai quotidiani nella primavera del 2011, il seguito con qualche interesse, poi con degnazione, gli ultimi sviluppi passati sotto silenzio (se non da questa rivista)? Hanno pesato, sì, le caldane della stampa, sempre più disattenta, spettacolare, conservatrice. Ma c’è dell’altro.
Va detto: Generazione TQ, che oggi langue, è stata il tentativo meno fallito di articolare proposte collettive radicali – di stampo grosso modo marxiano – e di uscir fuori dal pelago d’irrilevanza, o d’ignavia che ha impeciato gli intellettuali di quella generazione. TQ ha lasciato documenti e forse qualche eredità; eppure ha finito di funzionare. Non perché le sue proposte non siano state realizzate; ma perché neppure sono state ascoltate: le parti con cui TQ avrebbe potuto dialogare le hanno opposto un muro di disinteresse. Si ricordi il bel manifesto TQ sui beni culturali, battezzato da Salvatore Settis su «Repubblica» e poi escisso, come cisti antiliberista, dal dibattito in cui giganteggiava il documento nano, e moderato, del «Sole 24 Ore». Ma c’è ancora dell’altro.
Le forze vitali di TQ, tutti i suoi membri più influenti, se ne sono progressivamente disamorati. Come anche, infine, il sottoscritto. Decisiva l’indifferenza delle controparti: stampa, politica, industria culturale; ma forse per alcuni è troppo tardi per scimmiottare un radicalismo che non hanno mai avuto, cresciuti negli anni Ottanta a retorica antiradicale, pasciuti nei Novanta a fine della storia. Troppe influenze negative, troppo pochi anticorpi. Prima generazione precaria nelle bolge della gerontocrazia, ci siamo fatti un «culo tanto» per un reddito decente, per pubblicare qualche libretto, per sciorinare in tagli secondari di quotidiani maggiori, o almeno in festival letterari, la nostra sfavillante tuttologia postideologica: ora dovremmo anche marciare contro il mercato, che ha già vinto ovunque, e nei resti del cui camembert abbiamo rosicchiato fin qui?
Noi siamo scrittori e – così si esprimeva qualcuno poco prima di confluire in TQ – nostro dovere è creare capolavori. Del resto si occupino i politici di professione, i nevrotici dell’idealismo. A noi cavalcare la tigre dell’arte. Anche se, come un’auto da corsa, tappezzata di adesivi del Male: è sempre stato così. TQ ha avuto anche il merito di una visione, oltre che radicale, intellettivamente impegnativa. Primo risultato: alcuni se ne allontanarono presto perché troppo moderati, troppo compromessi; altri perché consapevoli di non rispondere ai pur laschi criteri di qualità letteraria che si andavano promuovendo.
Ma, anche fra chi rimase, qualcuno è a disagio nel vedersi attribuire una difesa della «qualità», quest’incubo zdanoviano; arrossisce all’idea che lo si scambi per un movimentista da strapazzo; teme forse d’essere espulso da editori e giornali come un sottosegretarietto ammonito a più diplomatica mitezza d’accenti. E poi non ammette un grado eccessivo di intellettualismo. Ah, l’antintellettualismo, il culto pseudodemocratico della volgarizzazione non come alto strumento pedagogico ma come unica via alla conoscenza! L’odio – tranne salamelecchi d’obbligo – di qualunque specialismo, di qualunque scrittura che resista alla nostra facilità d’interpretazione, di qualunque discorso che implichi più di due subordinate per periodo!
È l’antintellettualismo la tabe della nostra generazione, il motivo per cui non reagisce alle più triviali apologie del mercato, all’appannarsi dell’editoria generalista in un giulebbe mid-low-cult. Esso coinvolge anche alcuni ottimi scrittori: che i loro capolavori, glielo auguro, rimangano; ma la loro coscienza politica è d’acqua fresca. Forse meritiamo la nostra, o meritano la loro, irrilevanza sociale, cognitiva e spesso, in fondo, estetica.
Forse dovremmo scioglierci e accostarci, come singoli, ai pochi barlumi che si apprezzano in giro, nei teatri occupati, nei movimenti politici. E ricominciare, novecentescamente da soli o in gruppi sparuti, a lanciare ormai flebili urletti d’allarme. Forse invece no: forse è ancora possibile e utile una voce radicale collettiva e qualificata, più omogenea e agguerrita di TQ. Le due chance sono separate da un crinale strettissimo, e alcuni di noi lo percorrono senza realmente decidere da che parte discendere.
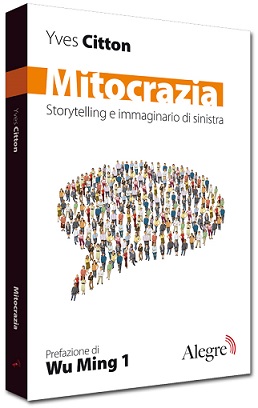 (Pubblico più che volentieri un estratto dall’introduzione di Yves Citton, Mitocrazia. Storytelling e immaginario di sinistra, Alegre 2013, che ha una prefazione di Wu Ming 1 e una postfazione di Enrico Manera, che qui ringrazio, assieme alla casa editrice. G.B.)
(Pubblico più che volentieri un estratto dall’introduzione di Yves Citton, Mitocrazia. Storytelling e immaginario di sinistra, Alegre 2013, che ha una prefazione di Wu Ming 1 e una postfazione di Enrico Manera, che qui ringrazio, assieme alla casa editrice. G.B.)
di Yves Citton
Dico alla gente che ha già provato tutto,
ma che ora è tempo di provare la mitocrazia.
Hanno avuto la democrazia, la teocrazia.
La mitocrazia è ciò che non siete mai diventati
di quello che dovreste essere.
Sun Ra
“Soft power” e scenarizzazione
Nessuno è ancora riuscito a stabilire cosa può un racconto. Alcuni di noi si sentono urtati dai “miti” con cui veniamo cullati, altri denunciano le “storie” che ci vengono raccontate; ad altri ancora piace credere che sia sufficiente trovare una buona “story” per portare gli asini alle urne, le pecore al supermercato e le formiche al lavoro. Quest’opera, piuttosto che offrire facili ricette o denunciare, invita a esplorare i poteri propri del racconto; parallelamente, propone un racconto della natura mitica del potere: la mito-crazia. […]
In primo luogo proveremo a fare il punto sull’immaginario del potere, seguendo gli sviluppi recenti di una riflessione che ha segnato un certo pensiero politico, riconducibile alla fortuna di Spinoza, Gabriel Tarde, Michel Foucault e Gilles Deleuze. Si cercherà quindi di munirsi degli strumenti per individuare e comprendere il funzionamento di un potere apparentemente “soft” (soft power), quel potere che si insinua, suggerisce, stimola, più di quanto non vieti, ordini, o costringa, un potere che orienta i comportamenti, “conduce le condotte”, situandosi al livello del flusso di desideri e di convinzioni canalizzato dalla rete di comunicazione mediatica.
Inoltre, per quanto riguarda le pratiche della narrazione e dello storytelling, ci sforzeremo di fare le debite distinzioni al fine di identificare quanto ci sia di realtà, quanto di proiezione e quanto di potenziale emancipatorio.
Per tentare di comprendere in che modo la strutturazione narrativa costituisca una precondizione necessaria dell’agire umano, nonché un orizzonte all’interno del quale assemblare e integrare i nostri singoli gesti quotidiani, faremo ricorso a diverse discipline (all’incrocio tra l’antropologia, la sociologia, la narratologia e la semiotica). Sarà l’occasione per chiedersi perché e come le risorse dello stoytelling siano state monopolizzate dalle ideologie reazionarie (“di destra”), e quali siano le condizioni in cui delle politiche emancipatrici (“di sinistra”) potrebbero riappropriarsene.
Cercheremo infine, nel punto d’incontro tra pratiche della narrazione e dispositivi del potere, di offrire una definizione di un tipo di attività particolare, la scenarizzazione.
Raccontare una storia a qualcuno non implica solo articolare determinate rappresentazioni d’azione seguendo una specifica successione, ma comporta anche “condurre le condotte” di chi ascolta, a seconda dell’inclinazione conferita alle articolazioni e alle concatenazioni. Mettendo in scena le trame dei personaggi (fittizi) del mio racconto, contribuisco – in maniera più o meno efficace, più o meno incisiva – a scenarizzare il comportamento delle persone (reali) cui rivolgo il mio racconto. Quest’attività di scenarizzazione va analizzata sia dal punto di vista delle sue caratteristiche intrinseche, legate alla natura del racconto narrativo, sia per quello che riguarda le sue ripercussioni all’interno dei nostri dispositivi mediatici. Passare dalla problematica della narrazione a quella della scenarizzazione significa chiedersi in che modo – attraverso quali strutture della comunicazione e con quali effetti possibili – una storia possa coinvolgere un pubblico e orientarne i futuri comportamenti.
Le intuizioni generali che concernono questo potere della scenarizzazione che l’opera cerca di analizzare sono invero molto comuni. Tutti percepiamo che la sua distribuzione non corrisponde, se non in misura parziale, con la distribuzione dei poteri politico, giudiziario, e economico. Tutti noi sappiamo che le decisioni dei direttori del telegiornali di includere o meno una determinata notizia, o un argomento di dibattito, o un interlocutore nel proprio notiziario svolgono un ruolo determinante nel funzionamento quotidiano e negli orientamenti generali delle nostre democrazie mediatiche. Tutti noi percepiamo che ciò che è detto (e ciò che è pensato) all’interno dei nostri dibattiti politici, ciò che è comprato nei nostri supermercati, ciò che ci incentiva a lavorare, a obbedire, ad accettare, a resistere, o a inventare un altro mondo possibile, non dipende solo da quanto vediamo e capiamo del mondo che ci circonda, ma anche dai diversi modi in cui ciò che giunge a noi è messo in scena, allestito e scenarizzato.
Quali sono i nodi attorno ai quali si costruisce il potere di scenarizzazione?
Con quali agganci attira la nostra attenzione? Quali sono i punti su cui fa leva? Quali disuguaglianze strutturano la sua distribuzione? Quali ostacoli precludono ai più l’accesso ai suoi effetti moltiplicatori? Quali potrebbero essere le rivendicazioni di uguaglianza tali da far saltare le preclusioni determinate dall’immaginario comune del potere e far sì che si prenda in considerazione il potere della scenarizzazione? In che modo delle politiche di emancipazione (“di sinistra”) possono riappropriarsene senza cinismo e senza falsi pudori? Come definire “la sinistra” a partire dal modo in cui “enuncia”, allo stesso modo in cui la si definisce in base al contenuto delle sue rivendicazioni? Queste sono le domande che verranno poste nel corso dei sei capitoli di questo libro.
[…]
Tanto vale dire subito che il potere della scenarizzazione descritto nelle pagine seguenti non ha niente di nuovo. Lo si può facilmente ricondurre alle messe in scena del potere reale di Luigi XIV o alla scenografia dei Trionfi degli imperatori romani. Gli umani si sono “messi in scena” da quando hanno cominciato a parlarsi, a sedursi, a battersi e a raccontarsi delle storie. Ma, se il potere di scenarizzazione è vecchio quanto il mondo, tuttavia le sue condizioni di esercizio, i suoi canali di diffusione, il suo grado di concentrazione, l’intensità e la precisione con i quali può sperare di influenzare i comportamenti umani evolvono invece costantemente. Mai infatti con la stessa intensità che al giorno d’oggi i modi di regolazione sociale si sono fondati su potere di scenarizzazione. In questo senso lo studio dei fenomeni di scenarizzazione si impone oggi con inedita urgenza, nonostante la loro identificazione possa essere illustrata grazie ad un racconto vecchio più di due secoli.
A margine di una tale riflessione, vale comunque la pena di precisare che – ovviamente – non tutto il potere è diventato soft. I capitoli che seguono potrebbero certo legittimamente esser tacciati di ingenuità o di idealismo se si avesse la pretesa di presentare in queste pagine la teoria del potere. Dire “il” potere, in quest’inizio di terzo millennio, significa anche (e ancora) dire le bombe che distruggono le case e le vie in nome della sicurezza degli Stati, i soldati o i poliziotti che sparano sulla folla, significa parlare del potere che si abbatte contro i resistenti picchiati e reclusi senza processo, quello che si manifesta attraverso le decisioni unilaterali di chiudere le imprese perché i tassi di profitto non sono ottimali, il potere dei divieti alle donne (o ai più gay di noi) evocati in nome della sacralità religiosa, il potere delle condizioni di lavoro neo-schiaviste che sono imposte ai lavoratori clandestini, significa la violenza fisica, simbolica o legale che si abbatte contro gli stili di vita alternativi e marginali, senza contare tutti i piccoli soprusi, tutte le umiliazioni, le rigidità e le assurdità che che sono il pane quotidiano dell’apparato burocratico. É senza dubbio e innanzitutto di questo potere – hard power – che si dovrebbe parlare se si avesse la pretesa di parlare del potere (in generale e in tutte le sue forme).
Non si tratterà quindi in nessun modo di sminuire, di relativizzare, o di dichiarare obsoleta questa massiva realtà dell’hard power, ma piuttosto di far notare come si trova spesso ritrasmessa da altre forme di potere, apparentemente più “miti”.
[…]
Ciò che si vuole mostrare è che “raccontarsi delle storie” non è solo inevitabile, ma spesso addirittura salutare, e che “la società dello spettacolo”, più che suscitare querule lamentele, dovrebbe esser d’ispirazione per una contro-scenarizzazione. Gli ultimi decenni si contraddistinguono per l’incapacità che ha dimostrato la “sinistra” di raccontar(si) delle storie convincenti. Per delle ragioni che cercheremo di capire, la “destra” (autoritaria, neoliberale e xenofoba) è riuscita a diffondere un insieme aperto ma relativamente coerente di storie, immagini, fatti di cronaca, informazioni, statistiche, slogan, paure, riflessi e di oggetti di dibattito che si alimentano reciprocamente all’interno di uno stesso “immaginario di destra”. La forza (soft) di questo immaginario è stata tale da colonizzare i discorsi di numerosi dirigenti di alcuni partiti che si rivendicano tuttavia ufficialmente di “sinistra”. Come è riuscito questo “immaginario di destra” a imporsi e a scenarizzare ampie porzioni della nostra vita politica? Queste sono le questioni di fondo che costituiscono l’orizzonte della riflessione che segue.
L’ipotesi è che lo smarrimento attuale della “sinistra” (quella ufficiale) abbia a che vedere con un blocco e con un deficit inerenti all’immaginario del potere ch’essa non è riuscita a rinnovare. Il patetico disorientamento dei suoi dirigenti e delle sue organizzazioni collettive, in Francia come in numerosi altri paesi europei, che contrasta con la vitalità di certi movimenti “para-politici” di resistenza e di creazione, può esser in larga parte attribuito alla mancanza di un collante immaginario che permetta di tenere insieme tutte le sensibilità, i sentimenti, le evidenze, le speranze, le paure, gli slogan e le rivendicazioni di cui facciamo l’esperienza isolata, senza tuttavia riuscire a imprimervi una forza collettiva di partecipazione condivisa.
Quando si parla (a torto) della “fine delle ideologie”, che sia per rallegrarsene o per rimpiangere l’epoca dei grandi antagonismi binari e strutturanti, ci si fa sfuggire la specificità di ciò che oggi è importante ricostruire: non tanto un sistema di idee, coerente e totalizzante, fermamente ancorato al rigore del concetto e capace di rassicurare gli animi inquieti con la sua pretesa d’avere una risposta per tutto (un’ideologia), bensì piuttosto un bricolage eteroclito di immagini frammentarie, di metafore dubbiose, di interpretazioni discutibili, di intuizioni vaghe, di sentimenti oscuri, di folli speranze, di racconti senza cornice e di miti interrotti che prendano insieme la consistenza di un immaginario, tenuto insieme, ancor prima che da una coerenza logica, dal gioco di risonanze comuni che attraversano la loro eterogeneità per affermare la loro fragilità singolare. É alla costituzione di un siffatto immaginario che questo saggio vuole offrire il proprio modesto contributo.
Interview imaginaire (La Repubblica)
La Repubblica.- Che cosa rimane oggi del “Panico… mieux, que pense le Panique des bons sentiments?
Fernando Arrabal.- Ils devraient être neutres, comme le chocolat…
La Repubblica.– … vous éblouissent-ils..?
FA.-…sans m’éclairer…
La Repubblica.-…mais, la spéculation qui gravite autour d’eux…
FA.- … l’artiste projette ses flammes, comme la sublime Mila Moretti … ou sa lave… ou sa démence… Warhol m’a dit le 8 mars 1982 “ton Greco a fait ce que je tente : inverser les relations de l’homme avec l’art”…
La Repubblica.- Entre un fleuve d’excréments et un petit ruisseau de bons sentiments, dans lequel des deux préfère plonger le Panique ?
FA.- L’impur peut se transformer en croyance. Comme le montre la sublime Mila Moretti en “Sotto le stelle niente muore” . On passe de la précision à l’épilepsie. Je pratique l’art « microscopique » des bons sentiments seulement lorsque je danse frénétiquement…
La Repubblica.-…vous dansez avec Zarathoustra?
FA.- J’ai beaucoup dansé avec Suzanne et Beckett dans leur mansarde de la rue des Favorites … (je moins dansé avec lui que Peggy Guggenheim…). Je ne danse plus que par-dessus ma tête comme le poulet sans plumes de Socrates
La Repubblica.- Adesso il suo teatro, mi pare, è molto più rigoroso, meno eccessivo, meno trasgressivo, perché? Vous êtes, dites-vous, un peintre frustré…
FA.- …comme Dario Fo, m’a dit-il …le destin me fait (malheureusement) jouer le rôle du bouc émissaire: une mouette sans sous-marins.
La Repubblica.- Le pouvoir culturel a-t-il un sexe?
FA.- C’est pourquoi il communique sous une burqa.
La Repubblica.- L’humour occupe une place importante dans votre œuvre.
FA.- Comme sentiment quasi aristocratique qui me permet de me moquer de moi-même….
La Repubblica.- …est-il prémédité ou dicté par le hasard ?
…j’ai moins d’humour que par le passé… 38 fois moins…
La Repubblica.- …pas 39 fois…?
FA.- …longtemps je croyais être de petite taille, avoir une tête monstrueusement grosse et être pestilentiel… Désormais je sais que suis très grand, que ma tête est petite, et que je dégage des effluves de rose.

La Repubblica.- Contrairement à Breton, pensez-vous que … ?
FA.- …pendant les trois ans de ma présence quotidienne au café surréaliste je ne comprenais pas lorsqu’il me parlait ou nous parlait du merveilleux et encore moins de magie, ou des visionnaires… Dali ou Allen Ginsberg étaient plus ébouriffants et Louise Bourgeois moins détaillée
La Repubblica.- Si Cervantès revenait parmi nous et réécrivait son Don Quichotte, sous quelle forme se réincarnerait l’Homme de la Mancha ?
FA.- En flamant rose. Cervantès n’était pas du tout favorable au personnage de Don Quichotte. Il le ridiculise. J’aimerais écrire « La confusa » , pièce disparue dont il était très fier.
La Repubblica.- Comme Duchamp vous pratiquez les échecs,
FA.- Même de dos …en simultanée …ou aveugle. Avec lui nous préférions analyser des parties de M.Tahl . Je l’imaginais séductrice comme Rrose Sélévy.
La Repubblica.- Quelle a été l’influence des échecs sur votre œuvre ?
FA.- Aucune. Parce que c’est une pratique quotidienne. Je ne peux imaginer aller me coucher sans y avoir joué.
La Repubblica.- On imagine … que pour vous c’est un plaisir formidable
FA. Le “formos” de formidable évoque la peur. Même le militant Tristan Tzara de vers la fin de sa vie, celui que j’ai connu, cherchait un ordre … un ordre dans le chaos.
La Repubblica.- N’êtes-vous pas finalement la muse de toute votre œuvre ?
FA.- Une muse à pénis.
La Repubblica.- …à tout moment?
FA.- Je suis une installation de ma propre circonstance.

La Repubblica.- On prétend que vous êtes une sorte de bouc émissaire…
FA.-… peut-être parce que mon père a fait partie du premier “peloton” des condamnés à mort …
La Repubblica.- …du premier jour de la la guerre civile.
FA.- Je n’y suis strictement pour rien : le mérite…
La Repubblica.- …vous avez été emprisonné par le régime franquiste…
FA.- Encore sans mérite aucun. Mille autres écrivains…
La Repubblica.- … étiez-vous le moins politique de vos collègues?
FA. Jamais eu de collègues.
La Repubblica.- Vous avez été le seul écrivain totalement interdit par l’ancien régime.
FA.- Littéralement ce fut incroyable. A la mort du général (dans son lit et avec des funérailles suivies par des millions de personnes en pleurs) la personne qui achetait mes livres était déçu : je n’étais pas un redoutable Marquis de Sade doublé d’un Robespierre.
La Repubblica.- …pourquoi la seule lettre publique écrite à Franco en vie du tyran sera la vôtre ?
FA.- Ma vie n’a cessé d’être ainsi: une série de surprises dictées par le dieu Pan …
La Repubblica.- Comment vivez-vous votre anarchisme ?
FA.- Par hasard . A la va-vite. Sans préméditation.
La Repubblica.- Vous n’avez jamais été membre d’aucun parti politique….
FA.- J’aurais aimé pouvoir être convaincu par un groupe. Je n’ai jamais voté de ma vie, cependant j’ai fait des choses bien pires… Comme, par exemple, recevoir des prix officiels et des doctorats honoris causa
La Repubblica.- Vous avez rencontré d’innombrables artistes durant votre vie, certains sont devenus des icônes tandis que d’autres sont restés d’illustres inconnus. N’y-a-t-il pas une part de loterie dans l’accession à la reconnaissance et ceci qu’elle soit posthume ou non ?
FA.- La réussite est le fruit de la rigueur mathématique de la confusion, plus que de la loterie de Babylone
La Repubblica.- On dit que votre rêve serait de réunir chez vous dans une de vos fameuses “tertulias” , avec vos amis Houellebecq, Kundera, Thieri Foulc, Simon Leys etc. les plus grands hommes de sciences du monde
FA.- Je leurs demanderais justement de trouver les règles de la confusion.
La Repubblica.- Si vous aviez un pouvoir illimité dans l’art, quelle est la première chose que vous feriez?
FA.- L’éliminer. Le pouvoir comme échec est une réussite.
La Repubblica.- …l’incertitude quantique…
FA.- …nous enfièvre-t-elle d’ une telle fougue qu’elle crée des devoirs? Le cyclope aveugle se distingue mal du borgne.
La Repubblica.- Ci può raccontare perché lei, Jodorowski e Topor arrivaste a fondare il movimento Panico? Chi erano per lei, allora i punti di riferiemento culturali? Êtes-vous la mauvaise conscience de l’art de notre temps…?
FA;- Tout ce qui est explosif, obviously, met en danger le monde.
La Repubblica.- Votre âme…?
F A.- Elle vaque dans les nues avec les étoiles.
La Repubblica.- Que penserait l’enfant que vous avez été s’il voyait l’homme que vous êtes devenu?
FA.- Tous les matins sont sans retour.
La Repubblica.- Pourquoi … la célébrité… ?
FA.- …La célébrité est l’opium des triomphateurs. Parce qu’elle donjuanise les artistes?
La Repubblica.- Et dans votre propre cas?
FA.- Je suis un tout petit peu célèbre et complètement inconnu, comme mes noeuds papillons.
La Repubblica.- Quel personnage historique évoqueriez-vous dans un prochain …:
FA.- Aucun. Pas même Attila amoureux sur ses vieux jours . Quand le don des larmes lui a fait le cadeau de pleurer toutes celles de son corps.
La Repubblica.- Une période où vous auriez aimé vivre?
FA.- Lors du big-bang . Ou à l’époque du Staline adolescent surdoué et fervent séminariste à Tiflis.
La Repubblica.- Seriez-vous inquiet de retourner en Espagne après presque soixante ans d’exil…?
FA.- …de destierro!!! Après une période d’obscurantisme, est-ce que nous traversons les sentiers des mystifications lumineuses ?
La Repubblica.- Quelle est votre patrie…. ?
FA.- Nous nous sommes habitués pendant des décennies à l’obstination des inquisiteurs. La colère est comme un cheval emballé.
La Repubblica.- Pourquoi les jeunes sont intéressés par vos pièces, par exemple “Fando et Lis”…?
FA.- Dans mon adolescence j’ai connu des surdoués (très semblables à ceux de notre époque); ils voulaient un ministère ou rien: ils ont eu les deux.
La Repubblica.- Changeriez vous quelque chose à votre esthétique de la négation?
FA.- La Samaritaine panique a dit à Job : Celui à qui Dieu n’a rien donné, Dieu ne peut rien lui ôter.
La Repubblica.- Votre film L’arbre de Guernica … votre ami Picasso …
FA.- Dans les ménageries et les musées, n’y-a-t-il rien d’aussi aphrodisiaque que l’innocence?
La Repubblica.- Ce que vous appelez “révolution” est-il possible dans un pays civilisé et riche?
FA.- Les banlieues les ghettos (los arrabales)… perdent-elles leurs fêtes et leurs arrabalesques?
La Repubblica.- Vos barbares sont-ils vraiment moins civilisés ?
FA.- Ils sont moins riches.
La Repubblica.- Ce qui disparaît de vos modes de vie… dans la peinture et la sculpture…
FA.- Devient à la mode, et ce qui se démode ressuscite-t-il avec nos modes de vie?
La Repubblica.- Le pouvoir de la culture?
FA.- …çà et là , a-t-elle de moins en moins de pouvoir? C’est pourquoi elle se sert des statistiques comme de songes du désir?
La Repubblica.- La Bourse a-t-elle une influence…?
FA.- Est-elle un sanctuaire ? Elle célèbre le miracle de faire de l’argent avec de l’argent.
La Repubblica.- A quel genre appartient l’actuel art mondial?
FA- L’art actuel est catastrophique, bestial , confus et génial. Lui et la science forment-ils les deux avatars du savoir actuel?
La Repubblica.- Lei è considerato giustamente un genio, l’incarnazione dell’arte contemporanea. Eppure i media danno spazio a personaggi molto più banali di lei. Perché? Avez-vous, “comme artiste frustré”, repensé aux Titans?
FA.- Les affreuses et terrifiantes bêtes nommées chimères sont le produit des manoeuvres prométhéennes de l’homme nouveau.
La Repubblica.- Avez vous une théorie sur l’artiste?
FA.- Nous pouvons tous théoriser quant à la part maudite des Terriens parce que nous faisons tous partie de la malédiction.
La Repubblica.- Pourquoi l’extrémisme?
FA.- Quand les extrémismes se combattent, la raison leur fournit des arguments.
La Repubblica.- Beaucoup vous considèrent déjà comme un classique . N’est-ce pas un danger ?
FA.- Le danger se dissipe-t-il avec la considération? Il demeure comme le sourire du chat du Cheshire. L’éléphant a dû se couper la trompe, sa petite queue en était jalouse .
La Repubblica.- Pourquoi, écrit The Village Voice, êtes-vous en avance sur votre époque?
FA.- Grâce à son omniscience le dieu Pan a placé les commencements avant les fins.
La Repubblica.- Avez-vous réinventé la provocation comme l’ a écrit bizarrement aussi The Village Voice?
FA.- La provocation est infantile , centripète et aléatoire. On ne poignarde pas avec la foudre d’un nuage.
La Repubblica.- Mais alors : pourquoi vous accuse-t-on d’être un provocateur?
FA.- On a entendu des choses plus étranges. Les cannibales diabétiques ne mangent pas les fabricants de sucre.
La Repubblica.- Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire?
FA.- Dans mon enfance, lorsque j’ai gagné le concours des surdoués…. On aurait dû me congeler.
La Repubblica.- Qu’est-ce qui pourrait justifier la trahison dans l’art?
FA.- Rien. C’est un compromis inutile avec notre propre colère suicidaire.
La Repubblica.- Croyez-vous réellement que, enfin l’être humain va vers un terme inéluctable, la fin des idées et le triomphe de la violence?
FA.- Vivons-nous une époque de belle myopie? Tuer pour le plaisir semble pis que de le faire par idéal.
La Repubblica.- Comment aimeriez-vous mourir?
FA.- Evidemment en dormant, en pleine pollution nocturne.
La Repubblica.- Vous êtes un adepte de la confusion…
FA.- …bien au contraire: je suis presque un fanatique de l’exactitude, des échecs et de la science.
La Repubblica.- Quelle est votre voie?
FA.- Les hirondelles parisiennes et les pigeons de Melilla ignorent la manie démente de toujours emprunter la ligne droite.
La Repubblica.- Un commento adesso, tanti, tanti anni dopo, alla sua lettera a Franco. …à la mort de Franco vous avez formé avec Carrillo , la Pasionaria, Lister et le Campesino le quintette de ceux qui ne pouvaient pas revenir en Espagne …”parce que vous étiez les plus dan-ge-reux”?
FA.- Au bruit de bottes succède toujours le silence des pantoufles;.
La Repubblica.- Ci racconti “Sotto le stelle niente muore”. Pourquoi les universités les plus contées étudient -elles cette pièce?
FA.- De la plus surprenante manière , voire même risquée.
La Repubblica.- Votre message a été interdit longtemps chez vous.
FA.- La gale intelligente préfère les taureaux rouges.
La Repubblica.- Vous ne dites pas émigré mais “desterrado”
FA.- Je n’ai pas de racines: j’ai des jambes. Je suis de Desterrolandia (Exilande)
La Repubblica.- Que pensez-vous du temps?
FA.- Le monde est rotatoire. Mais nous voyagerons dans le Temps. Ce n’est qu’une question de budget (K.Gödel ou Lévy-Leblond dixit)
La Repubblica.- Comment voyez-vous l’avenir?
FA.- Sauf les devins, tout le monde peut prévoir l’avenir.
La Repubblica.- La complexité actuelle…
FA.- Fait que les problèmes changent de nature pour que les solutions paraissent rationnelles.
La Repubblica.- Ecrirez-vous un essai sur l’art d’aujourd’hui?
FA.- Est-il plus facile de passer par l’achat d’une anguille que de chasser ce sein que je ne saurais boire?
La Repubblica.- Quelle est votre meilleure contribution à l’art?
FA.- Aucune puisque mes “oeuvres “, nichées en moi, dictent mes pièces?
La Repubblica.- Et vice-versa?
FA.- Quand j’ai cessé de croire au Père Noël, lorsque j’avais trois ans , je me suis rendu compte que lui n’avait jamais cru en moi.
La Repubblica.- Qu’est-ce que le surréalisme aujourd’hui?
FA.- Si la course à la réussite n’était pas si compréhensible et ennuyeuse il n’y aurait ni poètes maudits ni soldats inconnus.
La Repubblica.- L’écrivain est-il …?
FA. – …comme j’écris à double sens, ce serait un triomphe si on me comprenait à demi.
La Repubblica.- Si vous aviez moins de neurones et plus de beauté?
FA.- Je suis si spécial que je ne réussis même pas à me ressembler, pauvre de moi!
La Repubblica.- Aimeriez vous forniquer avec un homme?
FA.- La femme panique a des ailes; qui l’embrasse plane.
La Repubblica.- Les mathématiques pour un “dramaturge frustré”….
FA.- …grâce au calcul infinitésimal l’éternité est-elle de plus en plus longue?
La Repubblica.- Est-elle pour vous un défi avec ses dilemmes?
FA.- Les hérissons de mer volent quand il pleut des apocalypses.
La Repubblica.- Pour certains vous êtes un écrivain « culte ».
FA.- Parce que l’on m’attaque par ouï -dire, est-ce qu’on me loue aveuglément et me plagie sans me voir?
La Repubblica.- Da quanto tempo non faceva uno spettacolo in Italia? Le millénarisme, l’âge d’or…?
FA.- …c’est étonnant : ni la panne de courant n’impressionne l’aveugle, ni la sottise le crétin , ni le duvet le canard, ni l’éternité l’instant.
La Repubblica.- Votre devise?
FA.- Elle change d’une minute à l’autre. J’écris en jouant à être Dieu et, parfois , je réussis.
La Repubblica.- Voudriez-vous nous parler du sexe dans l’art ?
FA.- Je ne sais qu’une chose , c’est que je ne sais rien.(comme de presque tout).
____________________
autre arrabalesque:
…avant d’inventer les élections les fourmis choisissaient-elles leur reine au Strip Poker ?
… las hormigas, antes de inventar las elecciones ¿elegían la reina al strip-poker?
JEUDI 4 JUILLET
“Sotto le stelle niente muore”(L’adieu aux dinosaures)
de Fernando Arrabal (”Au crayon qui tue”, éditeur)
avec Mila Moretti
regia Sergio Aguirre
Festival di teatro di San Gimignano: “…il Comune di San Gimignano e la Compagnia Giardino Chiuso sono lieti di invitar Fernando Arrabal alla prima edizione del Festival di teatro… “Orizzonti Verticali – Arti sceniche in cantiere. … sul tema “Generazioni a confronto: storia, presente e scenari futuri””, dal 3 al 7 luglio 2013… il spettacolo de FERNANDO ARRABAL “Sotto le Stelle Niente Muore”; per questo saremmo lieti di aver… FERNANDO ARRABAL presente …”
L’auteur assistera à la représentation de “Sotto le stelle niente muore”, si le dieu Pan l p v.
di Daniela Rosi
 Bonaria Manca è nata a Orune il 10 luglio 1925, penultima di 13 figli. Negli anni ’50, seguendo i famigliari in precedenza emigrati per gravi motivi, si trasferisce nell’antica Tuscia, in Alto Lazio, luogo carico di storia, immerso nella natura, un sito archeologico pregno di memorie etrusche che la colpiscono profondamente e le danno la sensazione di una continuità con la sua terra natale.
Bonaria Manca è nata a Orune il 10 luglio 1925, penultima di 13 figli. Negli anni ’50, seguendo i famigliari in precedenza emigrati per gravi motivi, si trasferisce nell’antica Tuscia, in Alto Lazio, luogo carico di storia, immerso nella natura, un sito archeologico pregno di memorie etrusche che la colpiscono profondamente e le danno la sensazione di una continuità con la sua terra natale.
Nel 1965 va ad abitare in un grande casale acquistato dalla famiglia a Tuscania.
Nel podere attorno alla casa, lei pascola le sue pecore, mentre fra le mura domestiche cucina, cuce e ricama, in continuità con la cultura sarda.
Non era cosa consueta per il popolo sardo avere pastori donna, ma Bonaria sfiderà le convenzioni e non solo farà la pastora, ma si cucirà anche abiti diversi dai soliti, che ne sottolineeranno fin da subito la grande originalità creativa.
Oltretutto si sposta a cavallo, tenendosi lontana dal paese. Gli abitanti di Tuscania ricordano ancora le sue prime apparizioni. Conservano il ricordo di una giovane donna misteriosa e carica di fascino. Rimarrà per loro, però, sempre una “forestiera”, una figura esotica. E così si sentirà anche Bonaria Manca: una donna sarda, una pastora, una emigrata in terra etrusca.
Nel 1968 si sposa con un tuscanese, ha già 40 anni, ma il matrimonio è destinato a non durare. Dopo la morte della madre nel 1975 e quella dell’amato fratello nel 1978, cade in una profonda crisi, accentuata anche dalla successiva separazione dal consorte avvenuta nel 1980.
Sarà proprio questa “dolorosa libertà”, una libertà fino ad allora sconosciuta, la chiave di volta della sua vita:
“mi sono sentita libera, che non c’era né mamma, né fratello”.
La sua compagnia migliore diventa a questo punto l’arte, nelle sue diverse forme, che lei usa come un potente strumento autobiografico.
“Ho iniziato a cantare quando ho cominciato ad esser sola” dice, ma ha anche cominciato a dipingere quando si è trovata sola.
E’ passata alla pittura convinta che, se sapeva ricamare, usare i colori attraverso il filo, probabilmente sarebbe stata in grado pure di dipingere. E, infatti, la sua supposizione si è rivelata corretta.
Dapprima ha iniziato dipingendo sulla tela, o su qualche tavola e, quando le tele mancavano, le si sono naturalmente offerte le pareti della sua casa.
E’ nel 1981 che inizia la sua attività pittorica e lo fa raccontando la sua storia, una storia che nasce sarda, prima di tutto, poi diviene dialogo con il luogo in cui si trova, con la natura che la circonda, con la memoria sua e delle pietre che lì si trovano.
Bonaria inizia così il suo lungo racconto autobiografico, dapprima, come nella miglior tradizione auto-narrativa, elaborando i ricordi dolorosi, i lutti, le separazioni; denunciando i soprusi, i torti subiti, le ingiustizie vissute, per passare poi alla narrazione devozionale, una sorta di preghiera diffusa, di dialogo con la natura e con gli antichi che lì, nella Tuscia, come in Sardegna, da sempre fanno sentire la loro presenza.
La sua casa, a poco a poco, si copre di colori e immagini. Tutte le pareti sono dipinte, oppure ospitano quadri che raccontano ricordi, tradizioni, presenze, natura e nuovi incontri mitici.
I colori sono tenui e brillanti a un tempo.
In camera da letto campeggia una maternità con Madonna emancipata che lontana dall’uomo non ne è soggiogata e, come fa notare Bonaria, non tiene il capo chino, ma alza la testa altera e fiera.
Sulla parete della camera da letto anche un arazzo dove racconta la sua vita bambina, quando si recava alla fonte a prendere l’acqua.
Un’autobiografia scritta, quindi, anche con il ricamo, il lavoro della lana, il confezionamento degli abiti, pratiche imparate fin da bambina, ma reinterpretate in assoluta libertà.
Raccontare la sua storia su tutte le pareti interne della casa, cucendo arazzi, realizzando tele e disegni, è stata la vera ancora di salvezza di Bonaria, perché queste pratiche le hanno consentito di non cadere nel baratro della solitudine, dell’anonimato e di stabilire una continuità culturale con i luoghi che si è trovata ad abitare, dopo aver dovuto lasciare quelli che le hanno dato i natali e dai quali ha attinto la sua cultura.
Una narrazione per immagini che ha del sacro: la memoria dell’antico popolo sardo e la scoperta di un luogo altrettanto carico di memoria come la Tuscia degli etruschi, due realtà sulle quali scorre la vita di Bonaria Manca, un’ artista che si è trovata a esserlo, suo malgrado, per via di una ispirazione superiore a lei stessa ignota.
“Io che ne sapevo” ripete Bonaria quando diviene, come ognuno di noi, spettatrice del suo immenso poema visivo e, assieme a noi, si meraviglia di averlo potuto realizzare lei da sola.
Bonaria ha lasciato traccia della sua storia scrivendo pure su taccuini preziosi che conserva gelosamente. Ha anche pubblicato un libro negli anni Ottanta, dall’evocativo titolo Comente perdichese spardinadassa (Come pernici sparpagliate), nel quale racconta della sua vita sarda , dei cibi, delle usanze e della sua formazione. Sul libro, in bianco e nero, sono pubblicati molti suoi lavori pittorici che illustrano la vita da lei descritta a parole.
Come tanti artisti outsider o babelici, anche lei inizia tardi, ma è un tardi che le permette di riportare nel suo lavoro tutta la sua esperienza di diversità rispetto agli abitanti della terra che, non per scelta, ha dovuto adottare come terra in cui vivere.
Nel lavoro artistico di Bonaria, troviamo tutta la generatività di una donna eccezionale, libera, anticonformista, ribelle e custode dei valori della Natura. Una donna che salva la memoria mitica del popolo dal quale proviene e che, allo stesso tempo, fonda un nuovo universo personale, il quale nasce da e in una terra che in passato ha conosciuto i grandi fasti della civiltà etrusca.
Consapevole del proprio talento, ma umile, Bonaria non cessa di stupirsi di questa sua capacità.
Donna fiera, di antica civiltà, che attraversa la fatica a testa alta.
Questa è Bonaria Manca, l’abitatrice di un mondo a parte, fatto di memorie e nuova creazione, un mondo, alla fine, da lei stessa ri-fondato e nel quale possiamo cogliere il mistero panico dell’esistenza in tutta la sua infinita poesia.
(Daniela Rosi ha scritto questo testo in occasione della mostra da lei curata “Bonaria Manca, Io che non sapevo”, dal 5 al 13 luglio, a “Pergine Spettacolo Aperto” (Pergine Valsugana, Trentino), si veda l’invito qui sotto per i dettagli)
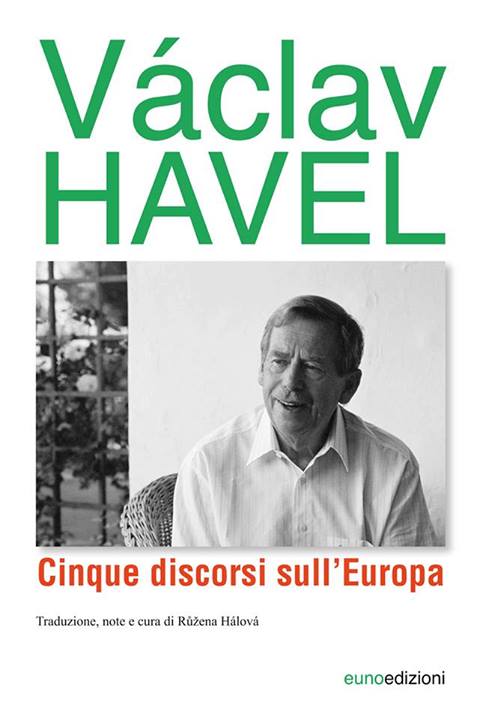
Quella nostra Primavera d’Europa
di Růžena Hálová
Nella metà degli anni ‘90 avevo poco più di vent’anni, l’età in cui si hanno speranze e aspettative dalla vita forse più grandi, più aperte e ampie, e che in me erano potenziate dal momento storico che attraversava il mio paese, la Repubblica Ceca. Da poco avevamo potuto oltrepassare la cortina, abbattendola nel modo che più corrispondeva a noi cechi, senza rompere neanche una vetrina, e che fu così prontamente ribattezzato la rivoluzione di velluto. Ci sentivamo ammirati dal mondo e ne andavamo molto orgogliosi, facendoci forti del nostro passato, di un popolo che non ha mai cercato la guerra o di sottomettere nessuno. Eravamo orgogliosi di appartenere a un popolo che è riuscito a sopravvivere alla dominazione asburgica, durata secoli con la predominante lingua tedesca, costruendo due volte il monumento al nostro sentirci cechi dal profondo, il Teatro Nazionale, raccogliendo solo il contributo volontario della gente, contribuendo ad arricchire il sottosuolo culturale di entrambe le lingue per creare personaggi di lingua tedesca ma di residenza praghese come Franz Kafka, Max Brod, Rainer Maria Rilke e tanti altri. E tutto questo conservando la profonda vena del “pensiero ceco”, così chiaramente percepibile nelle opere di Jan Neruda, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, e più tardi di Bohumil Hrabal, per ricordare solo alcuni del mondo letterario.
Vorrei citare, a proposito, le parole di Roman Jakobson da un discorso tenuto nel 1969 a Praga, che sentiva come la sua vera patria: “…questo paese era unico nell’accoglienza di popoli perseguitati (…) dove la cultura era di casa più che da qualsiasi parte del mondo (…), questo focolare dell’Europa dove l’occidente incontra l’oriente, su una superficie così piccola e conservando la propria particolarità, ha dato al mondo idee così grandi come l’idea di Costantino dell’uguaglianza e sovranità di tutti i paesi, l’idea riformatrice di Jan Hus e quella grandiosa concezione del sapere democratizzato di Jan Komenský! Non conosco una nazione al mondo che abbia tanto radicata in sé la democrazia.”
I primi anni’90 sono però anche gli anni in cui la mia generazione, affacciandosi al mondo, ha dovuto confrontarsi con una percezione del nostro paese che non si aspettava, cioè abbastanza riduttiva e certo non gratificante da parte del mondo occidentale, di una nazione definita come una delle tante del blocco sovietico, di un popolo sottomesso e umiliato, senza identità propria nella mente di molti che avevano vissuto oltre quella cortina. Era come sbattere la testa contro un altro muro. Abbiamo dovuto fare i conti con uno spostamento dei confini europei, abbiamo scoperto che, pur essendo definiti più volte il cuore dell’Europa, di fatto non le appartenevamo, che i confini creati dalla cortina di ferro continuavano ad esistere incarnandosi nei confini della Comunità Europea. E noi, insieme agli altri paesi dal destino simile al nostro, continuavamo a starne fuori. Al crollo di una barriera politica resistevano altre barriere, quelle dell’economia e della burocrazia, quelle dei pregiudizi e della paura dell’altro, del diverso.
Ed è proprio in questo momento che riusciamo ad alzare la testa, ad essere noi a gettar via quello stigma di un popolo violentato, cioè quando si fa sempre più forte la voce del nostro presidente, che viene applaudito in piedi dal Congresso americano. Penso che quella diretta l’abbiamo seguita forse tutti. Václav Havel, che poi, in tutta Europa, quella geografica, pronuncia parole che invitano tutti a riflettere sulla vera Europa, sul suo spirito e sulle sue origini. Parole critiche, costruttive.
Insomma, alzando la testa riusciamo a vedere quell’apertura dove passa quel raggio di sole di cui parla Václav Havel in uno dei suoi discorsi che ora vengono pubblicati per la prima volta in Italia, da me raccolti e tradotti, dalla casa editrice di Enna Euno edizioni con il titolo Václav Havel. Cinque discorsi sull’Europa.
E’ stato forse quell’impulso di allora l’origine della mia decisione di tradurre quelle parole, in una lingua che già sapevo sarebbe diventata la mia seconda lingua, nel paese dove avevo incontrato molte affinità. Questa mia intenzione fu accolta con molta disponibilità dall’Ufficio di Presidenza di Havel, che rese disponibili alcuni discorsi per essere tradotti, alcuni ancor prima di essere pronunciati. La stessa disponibilità mi fu espressa da parte di alcuni giornali e riviste italiani per la pubblicazione.
Negli anni ‘90 quelle riflessioni erano più dirette al pensiero dell’integrazione europea, alla piena unificazione, al difficile percorso che oggi diamo per scontato, ma che allora scontato assolutamente non era. E questo, oggi, invita a riflettere sulle vie che ci si aprono davanti, di cui possiamo sceglierne una sola prima che ci si presenti un altro incrocio. Solo la nostra conoscenza dei fatti, la riflessione sullo stato delle cose ci permetterà di incamminarci su quella giusta. Credo che oggi le riflessioni di Václav Havel che ho raccolto nei abbiano ancora molto da dire, forse ancora più di allora, cioè in questo momento in cui l’attenzione viene rivolta solo verso i parametri economici, verso un calcolo puro di convenienza degli aiuti da parte dei paesi più forti, nel momento in cui si cominciano a sentire di nuovo voci dubbiose sul senso dell’Unione Europea, che forse unita non lo è mai stata veramente proprio per la ristrettezza di vedute da parte di chi invece dovrebbe guidarla attraversando il periodo critico che viviamo proprio adesso.
Le riflessioni di Havel, nella forma che assumono in Cinque discorsi sull’Europa, sono presentate per la prima volta ai lettori italiani.
Dei cinque discorsi, solo quelli pronunciati a Dublino e a Varsavia sono stati pubblicati, in versione ridotta e sempre da me tradotti, nel 1996 sulla rivista “Crocevia” (Esi, Napoli) diretta da Corrado Ocone e, nel 1998, sulle pagine de “La Repubblica”.
I discorsi presidenziali di Havel toccano aspetti legati alla città o all’istituzione in cui sono pronunciati, eppure sono attraversati e legati insieme da un medesimo tema: l’Europa.
Sono riflessioni intorno all’idea di Europa, alle sue radici, alla ricchezza di culture che la abitano, al suo significato e al suo destino per la storia della cultura occidentale.
La centralità di questo aspetto mi ha reso possibile attribuire un titolo a ciascuno dei cinque discorsi che, nel testo preparato per essere letto, non presentavano titolo. Nell’attribuire questi titoli ho tenuto in considerazione il fatto che Havel riportava interamente la sua esperienza di drammaturgo e il suo passato di dissidente nella sua attività di Presidente; ai suoi discorsi presidenziali, anzi, Havel affidò un compito fondamentale per la comunicazione con i cittadini cechi ed europei, che, in questo modo, continua ad avere luogo anche in forma scritta.
di Nadia Agustoni
Venerdì –
cadeva nel bianco
– era lepre uccello cane –
passava vita, stagione
una voce che toccava le rondini
uguale alle rondini
(nella luce i fiumi cantavano
con tutte le ossa
e ghiacciavano come luna)
non sapeva del mondo
se non nascere
e il mondo innalzava poster
annunci di marketing
made in Italy:
capiva? non ci sono parole
ma lo specchio
con quello che non sai
del giorno.
ASSOCIAZIONE CULTURALE INDYPENDENTEMENTE
progetto INDYMAPS
L’Associazione Culturale Indypendentemente è nata dall’intento di mettere in collegamento le realtà indipendenti dell’arte e della cultura, dalle scene teatrali alle librerie, dalle riviste letterarie e di opinione ai blog culturali, dagli editori alle associazioni. Per poter meglio conoscere e connettere tali realtà, Indypendentemente, ha deciso intraprenderne una mappatura, che troverà spazio nel sito internet www.indypendentemente.com alla pagina Indymaps
La mappatura non ha fini puramente conoscitivi, ma vuole costituire per Indypendentemente e per gli attori della sua rete un vero e proprio strumento di lavoro, attraverso cui cercare nuove forme di cooperazione e mettere in campo meccanismi virtuosi per una vera economia della cultura. Per fare tutto questo ci servono la vostra cooperazione e le vostre idee!
REFERENTE: Chiara Lasagni
iaia_l@hotmail.com
(1)
INDYRIZZARIO
Una lista ragionata, divisa per categorie, dei produttori di arte e cultura indypendenti in Italia. L’Indyrizzario conterrà tutti i nominativi e i contatti dei soggetti (in questo caso librerie indipendenti) che saranno inseriti nella rete di Indypendentemente.
Per questo, vi chiediamo innanzitutto di farci avere i VOSTRI DATI DI CONTATTO:
Nome della libreria:________________________________________
Nome del/dei titolari:______________________________________
Nomi dei principali collaboratori:____________________________
Indirizzo (Via, CAP, Città):___________________________________
Sito Web:_________________________________________________
Telefono: _________________________________________________
Fax:______________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Skype: ___________________________________________________
Twitter:___________________________________________________
Facebook:________________________________________________
Altro:____________________________________________________
…corredati dal vostro LOGO IN FORMATO .JPG
Vorremmo che l’Indyrizzario si espandesse in maniera spontanea, partecipata e rizomatica. Per questo vi chiediamo di SUGGERIRCI ALMENO ALTRE TRE LIBRERIE INDIPENDENTI ITALIANE con cui siete in contatto o che considerate esempi signifcativi per la loro storia, le loro caratteristiche, le loro attività: saranno le prossime a cui rivolgeremo questa intervista.
(2)
INDYMAPS
Per disegnare una mappa bisogna viaggiare e conoscere genti: attraverso interviste, foto e filmati Indymaps disegnerà una cartografia degli indypendenti, attraverso le loro storie e le loro idee.
Ecco l’intervista:
(1) Ci parli della tua libreria? Presentazione, storia, caratteristiche sul territorio, criticità e anche dei
momenti belli tosti, se ti va.______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(2) Quando entri in una libreria (da lettore, cliente) cosa osservi? Che cosa attira la tua attenzione?
______________________________________________________________________________________
(3) Come definiresti oggi una libreria indipendente?
______________________________________________________________________________________
(4) Come vedi il futuro delle librerie indipendenti? Quali strategie devono adottare i librai
indipendenti per darsi un futuro?_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(5) Consigliaci un libro: qual è il più significativo, il libro-simbolo della tua libreria? _____________
______________________________________________________________________________________
… a completare l’intervista INVIACI FOTO E FILMATI della tua libreria, con i suoi librai, i suoi
lettori, le sue attività.
(3)
INDYZIONARIO
Un dizionario in cui tutti i lemmi stanno sotto la lettera Y. Un lessico sentimental-fantastico delle parole dell’indypendenza scelte e commentati da indypendenti. Indymaps non si domanda solo chi siano gli indipendenti, ma vuole anche costruire una riflessione collettiva su cosa sia l’indipendenza nel campo di quella che potremmo definire l’economia della cultura. Per questo ci siamo immaginati l’Indyzionario, una raccolta delle parole dell’indipendenza, scelte e commentate da coloro che fanno parte della rete di Indypendentemente: “mare”, “anarchia”, condivisione”, “gatto”, “solitudine”, “bricolage”… e ogni parola che possa descrivere un pezzo di mondo indipendente.
Se lo desideri, PARTECIPA ALLA COSTRUZIONE DELL’INDYZIONARIO, inviandoci la tua parola preferita corredata da un breve lemma.
Zin Taylor, The Bakery of Blok (Season 1 – Episode 1), 2009.
 di Angelika Riganatou
di Angelika Riganatou
Chiamatemi pusillanime, chiamatemi smidollata, non basterà ad attenuare, neppure per amor di dignità, la profonda repulsione che provo all’ingresso di qualsiasi mattatoio, e quel senso di tragedia reiterata ma invisibile.
di Antonio Sparzani

Mentre a Roma nel palazzo del potere simbolico, il Colle con la “c” maiuscola, il presidente che rappresenta l’unità e il prestigio della nazione riceve per sua scelta un signore che è appena stato condannato da un tribunale della repubblica a sette anni di carcere e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, per concussione con costrizione e sfruttamento della prostituzione, a Messina, pare a me, si respira un’altra aria.
Vince inaspettatamente il ballottaggio per la poltrona di sindaco Renato Accorinti, anarchico no-ponte, esponente della lista civica “Cambiamo Messina dal basso”. Come primo gesto rimuove la porta centrale a vetri del palazzo comunale,
di Luca Somigli
“Negli archivi e per le strade: considerazioni meta-critiche sul “ritorno alla realtà” nella narrativa contemporanea”
Due agosti fa le cronache culturali del Belpaese, notoriamente sonnacchiose d’estate, sono state agitate dal dibattito sul “ritorno del reale” che, in ambito filosofico, ha fatto seguito alla pubblicazione sul quotidiano «Repubblica» di un breve testo di Maurizio Ferraris dal titolo ambizioso di Il ritorno al pensiero forte[1]. L’attacco riprendeva quello, famosissimo, di un classico del materialismo storico, il Manifesto del partito comunista di Marx e Engels, parafrasato in questi termini: «Uno spettro si aggira per l’Europa. È lo spettro di ciò che propongo di chiamare “New Realism”»[2]. La citazione, ha poi spiegato Ferraris, aveva una motivazione ben precisa: segnalare che il termine “New Realism” non intendeva designare una nuova teoria o un nuovo indirizzo filosofico, ma che piuttosto nominava uno «stato di cose» che ne precedeva l’enunciazione: lo spostamento del «pendolo del pensiero, che nel Novecento inclinava verso l’antirealismo nelle sue varie versioni (ermeneutica, postmodernismo, “svolta linguistica” ecc.)» sul versante del realismo («anche qui, nei suoi tanti aspetti: ontologia, scienze cognitive, estetica come teoria della percezione ecc.»)[3]. In effetti, la figura fantasmatica di un “nuovo realismo”, dai contorni sfumati ed evanescenti come si conviene appunto a uno spettro, aleggiava già da tempo se non sull’intera cultura europea almeno sulla critica letteraria italiana, che di ritorni “alla” o anche “della realtà” – come se appunto si trattasse di un revenant riemerso dalla cripta a cui l’avrebbe consegnato il postmoderno – parlava ormai da qualche anno: anzi, per essere più precisi, almeno dal 2008, anno in cui la rivista «Allegoria» dedicava al “ritorno alla realtà” un’ampia sezione tematica del fascicolo di gennaio-giugno, curata da Raffaele Donnarumma, Gilda Policastro e Giovanna Taviani[4], e in cui Wu Ming 1 presentava al convegno «Close Up and Personal», organizzato da Eugenio Bolongaro presso la McGill University di Montréal, una relazione dal titolo New Italian Epic, principio di una riflessione su certe tendenze della narrativa italiana contemporanea che, dopo varie rielaborazioni apparse in rete, avrebbe trovato pieno sviluppo nel volume dallo stesso titolo pubblicato l’anno successivo dalla casa editrice Einaudi[5]. Non che prima di quella data fossero mancati interventi volti a individuare i contorni di un «realismo corrispondente ai tempi»[6], primo fra tutti il fondamentale volume di Alberto Casadei Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, del 2007. Ciò che accomuna il fascicolo di «Allegoria» e il saggio/manifesto di Wu Ming 1, e che ha generato una discussione a tratti anche molto accesa in particolare sui blog letterari («Nazione indiana» e «Carmilla», rispettivamente), è il carattere militante dei due progetti, più evidente nel caso del New Italian Epic (NIE) in quanto dichiarazione di poetica volta in prima istanza a identificare, all’interno della narrativa contemporanea, una “nebulosa”, per usare un termine caro al collettivo, di opere caratterizzate da una condivisa visione della funzione della letteratura, ma presente anche nel numero della rivista diretta da Romano Luperini, soprattutto nell’inchiesta d’apertura in cui otto scrittori trenta-quarantenni di varie tendenze (per la cronaca, Mauro Covacich, Marcello Fois, Giuseppe Genna, Nicola Lagioia, Aldo Nove, Antonio Pascale, Laura Pugno e Vitaliano Trevisan) venivano sollecitati a riflettere sui nuovi assetti della letteratura di inizio millennio. Entrambi i volumi prendono le mosse dalla percezione di una frattura – che non necessariamente implica un rifiuto completo – fra la narrativa della prima decade del duemila e il postmodernismo, inteso, spesso in maniera piuttosto parziale, come letteratura del disimpegno, dell’autoriflessività, del double coding fine a se stesso, del pastiche dal tono «distaccato e gelidamente ironico»[7]. L’evento-simbolo che rappresenta e rende visibile la cesura tra una postmodernità in declino irreversibile e un presente ancora magmaticamente in formazione è – prevedibilmente – l’attacco terroristico al World Trade Center di New York l’11 settembre 2001, evocato quasi come una sorta di scena primaria da Wu Ming 1 in apertura di New Italian Epic, ma anche richiamato esplicitamente nella prima domanda del questionario proposto da «Allegoria»[8]. Anche coloro che, come Donnarumma sulla scorta di Slavoj Žižek, consigliano prudenza nel attribuire un valore di rottura alla tragedia dell’11 settembre intesa come rivincita della “realtà” sul nichilismo postmoderno, non possono comunque non vedere in essa un discrimine oltre il quale il postmoderno da ideologia dominante si trasforma in difesa attardata[9]. Il valore simbolico di quello e di altri eventi della nostra storia recente è colto molto bene da Ferraris in un passo del Manifesto del nuovo realismo:
«Quello che chiamo “nuovo realismo” è […] anzitutto presa d’atto di una svolta. L’esperienza storica dei populismi mediatici, delle guerre post 11 settembre e della recente crisi economica ha portato una pesantissima smentita di quelli che a mio avviso sono i due dogmi del postmoderno: che tutta la realtà sia socialmente costruita e infinitamente manipolabile, e che la verità sia una nozione inutile perché la solidarietà è più importante della oggettività. Le necessità reali, le vite e le morti reali, che non sopportano di essere ridotte a interpretazioni, hanno fatto valere i loro diritti, confermando l’idea che il realismo (così come il suo contrario) possieda delle implicazioni non semplicemente conoscitive, ma etiche e politiche»[10].
Come vedremo, la posta in gioco del dibattito sul “nuovo realismo” sta proprio nella rivalutazione dell’aspetto etico del lavoro dello scrittore. Si tratta, in un certo senso, di rifondare il patto con il lettore. Radicalizzando l’“ermeneutica del sospetto” modernista, il postmoderno aveva risposto alla coscienza della natura già sempre mediatizzata di qualsiasi sguardo sul mondo rinunciando alla pretesa di agire sul mondo stesso, di cui si può parlare soltanto attraverso strategie di distanziamento come la citazione. Il lettore ideale è colui che non si lascia sviare dall’illusione di un referente – ad esempio, appassionandosi agli eventi e ai sentimenti dei personaggi – ma che invece apprezza il testo come un intrecciarsi di codici che non rimandano a niente oltre se stessi[11]. Il “ritorno alla realtà” si fonda su un diverso rapporto, retto da una sorta di gadameriana “buona volontà di comprendersi”, per cui al romanzo viene restituito il compito tradizionale di fornire schemi interpretativi del mondo – naturalmente secondo procedure adeguate al contesto storico e culturale – e allo scrittore quello di «fare della letteratura uno strumento di analisi e di denuncia del presente»[12]. Non è però solo la resistenza (in ambito letterario neanche troppo agguerrita, va detto fra parentesi) dei difensori del postmodernismo ad avere movimentato il dibattito intorno al “ritorno alla realtà”[13]. In un intervento in cui sottolineava, giustamente a mio parere nonostante i dinieghi dei Wu Ming[14], gli elementi di “familiarità” tra New Italian Epic e neorealismo – «interazione di verosimiglianza mimetica e inventività narrativa, cortocircuito tra realtà biografico-documentale e immaginazione romanzesca efficacemente padroneggiato»[15] – Vittorio Spinazzola notava che la «demonizzazione» del realismo in quanto tout court realismo sociale, e dunque, con facile assonanza, «contiguo al realismo socialista di staliniana memoria»[16], ha reso il termine una sorta di tabù nel salotto buono della letteratura. In particolare, il suo carattere anti-elitario porrebbe il realismo, in primis quello neorealista, agli antipodi dello sperimentalismo non solo delle varie avanguardie storiche e neo, ma anche dello stesso postmodernismo che ha camuffato il proprio «recupero di forme di comunicatività istituzionalizzata, dietro l’alibi furbesco dell’ironia e della parodia».[17] In effetti, diversi fra gli scrittori intervistati per l’inchiesta che costituisce il cuore del numero speciale di «Allegoria» mostrano un atteggiamento di sospetto, quando non di reciso rifiuto, verso il “realismo”, apertamente evocato nella terza domanda del questionario loro sottoposto: «Qual è il rapporto della sua scrittura con la tradizione del realismo?»[18] La risposta di Aldo Nove è rappresentativa dei motivi di questa diffidenza: «Dopo Freud, dopo lo strutturalismo e dopo Lacan parlare di realismo in buona fede mi sembra impossibile senza accettare che si tratti della convenzione di un’altra fiction»[19]. Lo si voglia o meno, il termine “realismo” – e ancor più, nel contesto italiano, quello di “neorealismo” – sembra implicare una fiducia nel potere della parola di fornire un adeguato modello della realtà che la letteratura contemporanea, figlia dell’ormai secolare scollamento tra ordine dei segni e ordine delle cose che costituisce uno dei traits d’union tra modernismo e postmodernismo, non può permettersi, pena appunto l’accusa di ingenuità, se non, peggio ancora, del più bieco zdanovismo. E infatti, il fantasma di Ždanov non ha tardato ad apparire: lo ha evocato, fra gli altri, Andrea Cortellessa, intervenendo a caldo sulla questione sul supplemento della «Stampa» «Specchio+», in cui ironizzava pesantemente sull’operazione promossa da «Allegoria», avvertendo addirittura nella proposta di una letteratura che vive l’incontro con la realtà come missione etica un «sentore di arte degenerata»[20], tanto per non farsi mancare anche l’altro regime autoritario del secolo breve.
La controinchiesta promossa da Cortellessa su «Specchio+» – con interventi di Antonio Scurati, Gabriele Pedullà, Laura Pugno, Tommaso Ottonieri, Andrea Bajani, Daniele Giglioli – e il vivace dibattito che ne è nato sul sito «Nazione indiana» permettono di mettere a fuoco alcuni dei nodi cruciali e controversi della questione.[21] In primo luogo, l’attenzione per la “realtà” sposterebbe il baricentro dell’opera sul versante del contenuto, cioè dell’elemento transeunte, laddove ciò che rende tale l’opera d’arte, che le permette di proiettarsi nel futuro, è il lavoro sulla forma. È la posizione espressa dallo stesso Cortellessa con un giudizio tranchant sul film Gomorra di Matteo Garrone (2008) – giudizio reso ancora più pungente dal valore esemplare che la fonte letteraria ha tra i sostenitori sia del ritorno alla realtà che del NIE: «Sono assolutamente certo che fra trent’anni, quando ripenserò a Gomorra di Matteo Garrone […q]uello che ricorderò sarà la luce della scena in cui i ragazzi, seminudi nell’acqua, giocano coi mitra»[22]. La domanda che ci si potrebbe porre, caso mai, è per quale ragione, se la «scommessa dell’opera d’arte» sta nel suo vivere simultaneamente nel presente grazie alla forza dei suoi contenuti e nel suo consegnarsi all’eternità in virtù della potenza espressiva, chi si preoccupa del primo aspetto sia da esecrare come un novello Ždanov quando non fa altro che diagnosticare – con tutte le incertezze del caso – ciò che appare urgente e rappresentativo a chi appunto nel presente vive. Vi è poi un secondo problema che ha il potenziale di minare alla base qualsiasi ipotesi di “ritorno alla realtà” non solo in letteratura ma in qualsiasi altra espressione culturale, e cioè la messa in questione della legittimità della categoria stessa di realtà da parte di una ormai consolidata tradizione di pensiero post-strutturalista e decostruzionista. Questa critica segue due orientamenti paralleli. Il primo è ben espresso da Antonio Scurati, il quale appellandosi a Jacques Lacan contrappone al “ritorno alla realtà” un ben più temibile “ritorno del Reale”, cioè di «quel nucleo sempre traumatico ed eccessivo che squarcia il velo dell’immaginario lasciandoci tramortiti perché incapaci di integrarlo nella nostra realtà»[23]. Posta come alternativa secca, la distinzione lacaniana tra realtà e Reale non lascia molto spazio di manovra per una pratica narrativa che voglia confrontarsi con il mondo. Infatti, la pretesa stessa di rappresentare la realtà come se questa avesse una esistenza al di fuori dell’ordine dell’immaginario – come se fosse cioè qualcosa di più di una simulazione – implica la resa di fronte al suo potere seduttivo, la legittimazione come verità di ciò che è invece rappresentazione manipolabile. Alla letteratura – a quella vera, e non mero esercizio di storytelling – viene delegato il compito di elaborare l’evento traumatico dell’avvento annichilente del Reale, che però è per sua natura irrappresentabile attraverso i codici che strutturano la realtà, ivi compreso il linguaggio. Dunque, per Scurati, l’unico “realismo” possibile è un realismo che «agogni alla realtà ma assuma nel proprio fondo la perdita del rapporto con la realtà»[24], in una sorta di cortocircuito autoreferenziale per cui l’unico modo per parlare della realtà è costatarne il dileguarsi over and over again. Il punto di partenza della riflessione di Scurati costituisce l’altro orientamento, che potremo per comodità riassumere con l’etichetta di “derealizzazione del mondo”. Lo stesso Scurati aveva già affrontato la questione in un testo spesso citato nel dibattito sul ritorno alla realtà, il pamphlet La letteratura dell’inesperienza (2006), in cui la condizione desolante dello scrittore contemporaneo veniva delineata in contrasto con quella descritta da Calvino nel ritornare con la memoria al periodo della composizione del Sentiero dei nidi di ragno in occasione della riedizione del romanzo nel 1964. Ciò che del dopoguerra colpisce Calvino, e che colpisce Scurati lettore di Calvino, è la percezione di un rapporto solidale tra lo scrittore e la propria cultura e fra scrittore e pubblico. Nel presente questo rapporto semplicemente non esiste, non si dà più, e questo perché si è dileguato l’elemento connettivo che unificava la comunità. Scrive Scurati:
«Ciò che manca è quella “elementare universalità dei contenuti” che caratterizzava il neorealismo italiano del dopoguerra, quella presenza di elementi extraletterari tanto massiccia e indiscutibile da sembrare “un dato di natura”, e da far sì che, per il giovane Calvino e per i suoi contemporanei, tutta la questione letteraria si risolvesse in un problema di poetica: “Come trasformare in opera letteraria quel mondo che per noi era il mondo”. Oggi il problema si riformula così: come trasformare in opera letteraria quel mondo che è per noi l’assenza di un mondo»[25].
Vi sarebbe dunque un divario incolmabile tra la generazione di Calvino, quella che ha fatto la guerra e la resistenza e quindi ha il diritto e il dovere di portare la propria testimonianza suffragata dalla “massiccia e indiscutibile” realtà degli eventi da essa vissuti e noi poveri uomini e donne dell’età del ferro, desolati abitatori di un mondo abbandonato dagli dei e dagli eroi, e soprattutto dai contenuti. Anzi, noi contemporanei saremmo stati abbandonati dal mondo stesso, perché il problema sarebbe proprio «l’assenza di mondo»[26], senza più neanche l’articolo indeterminativo a lenire un po’ la ferita. La colpa di questa assenza, va da sé, è dei mass media e della cultura di massa, che hanno rimosso l’esperienza dall’immediata sfera d’azione del soggetto per trasferirla, fantasmatica riproduzione infinita, sugli schermi televisivi. Gettandoci nel flusso degli eventi, in un eterno presente da cui non può emergere alcun senso dato che non esistono pause di riflessione, la televisione ci sottrae dal confronto diretto con l’esperienza. A differenza della parola scritta – meglio se letteraria – che permetterebbe di elaborare gli eventi, di stabilire quello scarto temporale che favorisce la riflessione critica, l’immagine collassa le barriere del tempo e dello spazio, si offre ad una fruizione apparentemente immediata, in tutti i significati della parola, ma che nei fatti omogeneizza gli eventi rappresentati trasformandoli in un informe ed ininterrotto spettacolo. La realtà insomma non si offre più ai moderni, uccisa in quello che Jean Baudrillard ha chiamato con una formula divenuta famosa, «il delitto perfetto» per opera dei nuovi mezzi di comunicazione (ma varrà almeno la pena di ricordare che il sottotitolo La televisione ha ucciso la realtà? apposto alla traduzione italiana non esiste nell’edizione francese ed è forse più sintomatico delle ossessioni della cultura del nostro paese che non delle tesi del filosofo)[27]. Si profila una sorta di mutamento di paradigma tra la generazione dei padri postbellici e quella dei figli postmoderni. I primi si muovevano in una cultura ancora governata dal principio della verticalità, della profondità, della trasmutazione dell’esperienza in testimonianza che a sua volta diventava fonte di autorità. Il presente è invece all’insegna dell’orizzontalità, dello scorrere da un’immagine all’altra, da un evento al successivo, senza alcuna elaborazione critica. Per Scurati: «siamo nell’epoca delle immagini del mondo, cioè – insegnava Heidegger – nell’epoca della riduzione del mondo alle sue immagini; per questo, la mia generazione di scrittori ha dovuto e deve affrontare il problema di come trasformare in opera letteraria l’assenza di un mondo eclissatosi assieme all’autorità del vivere e della testimonianza» [28].
L’estrinsecazione del dilemma dello scrittore contemporaneo è seguita da una sua descrizione concreta: come raccontare la guerra non tanto quando non se ne ha esperienza ma piuttosto quando questa esperienza – che a volte appare pervasiva – è sempre mediata, «principalmente dalla televisione»[29]. La guerra, scrive Scurati, «era ora una realtà deprivata della sua esperienza. Una serata di morte comodamente adagiati sul divano del salotto di casa sorseggiando birra fresca»[30]. Un simile dilemma è al centro del saggio di Daniele Giglioli Senza trauma, apparso nel 2011 (ma alcuni spunti erano già nel suo intervento in «Specchio+»). Per Giglioli, la proliferazione del termine “trauma” per descrivere le più disparate forme d’esperienza ha a che fare con un problema di legittimità: se infatti, per dirla nei termini di Scurati, il “racconto dell’esperienza” è in primis un affermare la propria presenza e sopravvivenza, è evidente come la “vittima”, colui che ha subito un trauma, abbia una legittimità maggiore di chi, vivendo in una società in cui «le occasioni di trauma sono state respinte ai margini dell’esperienza quotidiana»[31], gli eventi traumatici al massimo se li vede appunto comodamente alla televisione, e sono comunque qualcosa che riguarda gli altri. Al dileguarsi delle esperienze traumatiche farebbe riscontro un dilatamento del ruolo del trauma stesso nella strutturazione dell’esperienza: da qui la necessità di immaginare il trauma – e di immaginarlo in maniera sempre più scioccante. Il paradosso è tutto qui, nel fatto che l’evento traumatico, come il Reale lacaniano, è per definizione impervio all’elaborazione, alla simbolizzazione che ne permetterebbe l’integrazione nella realtà del vissuto. Il trauma lo si subisce o non lo si subisce, non si danno surrogati, per cui la scrittura dell’estremo, così come i toni costantemente sopra le righe dei mass media, non solo non riescono a rappresentare l’esperienza, ma anzi contribuiscono alla sua ulteriore derealizzazione. Presi tra un Reale il cui accadere è sempre più raro e una realtà che si presenta sempre più spesso come reality, come spettacolarizzazione effimera e inconcludente in un mondo abbandonato dall’autenticità, cosa rimane agli scrittori in particolare e agli intellettuali in generale se non contemplare sconsolatamente la propria sterilità?[32]
Epperò ci si potrebbe chiedere se l’insistere sul sottrarsi del Reale e sulla derealizzazione del mondo, oltre a contornare un problema, non sia anche un modo per sospendere quasi a priori la necessità di un confronto con il mondo materiale. In un passo cruciale del Manifesto del nuovo realismo, Ferraris definisce come carattere fondamentale della realtà la “inemendabilità”. L’inemendabilità, scrive Ferraris, «ci segnala infatti l’esistenza di un mondo esterno, non rispetto al nostro corpo (che è parte del mondo esterno), bensì rispetto alla nostra mente, e più esattamente rispetto agli schemi concettuali con cui cerchiamo di spiegare e interpretare il mondo»[33]. Vi è, oltre le rappresentazioni e le interpretazioni, un qualcosa di materiale che resiste e non si esaurisce in quelle rappresentazioni e interpretazioni stesse. Torniamo all’11 settembre. Una delle immagini iconiche della tragedia, al pari di quelle degli aerei che si abbattono sui due edifici del World Trade Center o del crollo delle Torri Gemelle, è la fotografia di Richard Drew The Falling Man, a cui si sono ispirati fra gli altri Don De Lillo per il romanzo omonimo (2007), Wislawa Szymborska per la poesia Una fotografia dell’11 settembre (2002; ma una semplice ricerca con google mostra come quello del Premio Nobel polacco sia solo il maggiore esempio di una vasta produzione poetica sul tema) , il regista Henry Singer per il documentario 9/11: The Falling Man (2006). Eppure questa proliferazione di interpretazioni dell’uomo che cade non cancella – e anzi forse proprio per la sua quasi ossessionante qualità mette in risalto – l’esito finale di quel disperato volo, l’impatto di un corpo fisico, carne ed ossa, contro il selciato decine di piani più sotto. Possiamo davvero mettere fra parentesi la materialità di quel corpo nel momento in cui le sue innumerevoli rappresentazioni ci interpellano? Davvero il fatto che immagini simili appaiano in contesti dichiaratamente finzionali (i classici action movies) revoca in dubbio lo statuto ontologico dell’uomo che cade? È qui che mi pare che si collochi il limite della teoria della “derealizzazione del mondo”: l’atto di mettere in relazione un’immagine ad un referente reale, materiale nel senso che abbiamo appena visto, è una scelta etica, oltre che epistemologica, che implica il riconoscimento del trauma subito dall’altro anche nel momento in cui esso non ci tocchi direttamente. Né, mi pare, può essere attribuita al mezzo televisivo la responsabilità della supposta “inesperienza” che tormenta i contemporanei. Ammesso che la televisione costituisca una sorta di medium in cui, come nell’aria che respiriamo, siamo tutti immersi (ma questa pare una visione già un po’ antiquata nell’era di internet che pone altri e diversi problemi), forse sta anche a noi fruitori del prodotto che essa ci propone imparare a distinguere tra reality e realtà, tra immagini di guerra di un film e immagini di guerra dall’altro capo del mondo. Pur abitando nello stesso “deserto del reale”, c’è chi davanti alle immagini del bombardamento di Baghdad nel 1990 si è fatto una birretta e chi ha cercato, per quanto velleitariamente, di agire sulla realtà e fermare le bombe, ad esempio scendendo in strada a manifestare. Ma poi forse va capito meglio cosa si possa intendere per esperienza o per trauma. In senza trauma Giglioli stabilisce un rapporto quasi di identità tra Reale lacaniano e trauma. «Il Reale», scrive, «ha la natura dell’evento, non del senso, o meglio dell’evento senza senso, traumatico, in quanto non può essere elaborato, simbolizzato, reso nominabile».[34] Laddove appunto non si danno più traumi effettivi, come era invece il caso della letteratura modernista reduce dallo shock della modernità, esso deve venire prodotto con una scrittura dell’estremo, le caratteristiche del quale il critico individua in due forme di scrittura di gran voga all’inizio del ventunesimo secolo, e cioè la narrativa di genere, giallo/noir in primis, e l’autofiction. In entrambi i casi, gli eventi traumatici non sono il risultato di un incontro con la realtà ma piuttosto servono a generare una «pretesa di autenticità»[35], un effetto di realtà. Per limitare le mie osservazioni al romanzo di genere, che conosco meglio, se da una parte sono giustissime le osservazioni di Giglioli riguardo alle limitazioni del complottismo[36], dall’altra mi pare che non sia vera la premessa, cioè che il genere produca, attraverso la messa in scena di azioni estreme, un trauma simulato che supplementi, proprio in virtù della proprio esagerato ed esibito passare il limite, una realtà altrimenti priva di esperienze. Il complottismo può anche essere interpretato come il tentativo di elaborare un trauma – una serie di traumi – molto reali, gli innumerevoli misteri e atti di violenza che hanno lacerato il corpo della nazione e per i quali non sono state trovate ad oggi risposte convincenti. La lista è nota e lunghissima – la morte di Enrico Mattei, Piazza Fontana, il treno Italicus, il rapimento e l’omicidio di Moro, la Stazione di Bologna, Ustica, Gladio, Via dei Georgofili, gli omicidi di Falcone e Borsellino, e su su per li rami fino al G8 di Genova e oltre – e mi pare difficile identificare nella scrittura “estrema” solo il tentativo di produrre un’esperienza traumatica dato che di esperienze traumatiche la tanto esecrata realtà non è certo stata avara, almeno alle nostre latitudini. Non a caso il patrono di molti “complottisti” non è l’Ellroy o il Manchette di turno, ma il Pasolini corsaro del Romanzo delle stragi («Io so. Ma non ho le prove…»), e le loro opere sono il tentativo, a volte sconclusionato o compiaciutamente paranoico, a volte semplicistico, e a volte anche capace di una certa penetrazione, di dare forma a quella testimonianza impossibile e necessaria. Vi sono stati traumi collettivi anche dopo lo spartiacque epocale della Seconda Guerra Mondiale, ed è bene ricordarlo proprio per evitare quella che Jean-Michel Chaumont, opportunamente evocato da Giglioli, chiama «concorrenza delle vittime»[37], la rincorsa a chi può esibire il trauma peggiore. Certo, se si prendono i genocidi del secolo scorso come misura della traumaticità è evidente che di fronte ad essi e ai loro testimoni tutti gli altri sono costretti al silenzio. È invece evitando di gerarchizzare che si può dar voce a diverse forme di trauma, e le opere dei “complottisti” sono lì a ricordarci con insistenza che i traumi della nostra storia recente non sono né virtuali né di facile elaborazione. Qualcosa di simile vale anche per i traumi individuali. In un recente saggio con cui interveniva nel dibattito sul “nuovo realismo” filosofico, lo psicoanalista Massimo Recalcati è tornato sulla distinzione lacaniana tra realtà e Reale, descrivendo il secondo come ciò che interviene a «rompere traumaticamente»[38] il flusso ordinato e ripetitivo della prima. Fin qui niente di nuovo. Ciò che colpisce è però quella che potremmo chiamare la quotidianità, per non dire la banalità, del Reale. Ben lungi dall’essere l’avvento numinoso di una «cosa terrificante» che annienta come un dio del mito[39], l’evento che spezza la continuità, la predicibilità di cui è tramato il nostro vissuto è quanto di più comune si possa immaginare:
«L’apparizione di un nodulo che minaccia una malattia mortale, la perdita di un lavoro che mette improvvisamente a repentaglio la mia vita e quella della mia famiglia, la durezza insensata di una agonia, l’insistenza sorda di un comportamento sintomatico che danneggia la mia vita e che nessuna interpretazione e nessun farmaco riesce a far regredire, un innamoramento che travolge l’ordinarietà della mia esistenza, un’esperienza mistica, l’incontro con un’opera d’arte, un’invenzione scientifica, una conquista collettiva, la rivolta di una generazione che non accetta il decorso stabilito dalla crisi».[40]
Due cose almeno vanno notate. In primo luogo, che il Reale si manifesta nell’incontro del soggetto con un mondo materiale e sociale da esso incontrollabile (ivi compreso ciò che ribolle al di sotto della soglia della coscienza, e su cui il soggetto non ha alcun potere), «una esteriorità che non si lascia assimilare o governare in nessun modo»[41]. È questo incontro, piuttosto che una realtà esterna al soggetto ma perfettamente conoscibile e oggettivabile, che il realismo degli anni zero si propone di pensare attraverso lo strumento della scrittura. In secondo luogo, va sottolineato che, come suggeriscono gli ultimi due esempi, l’irruzione del Reale nella trama disciplinata della realtà può prendere anche la forma di eventi collettivi, intersecarsi cioè con la dimensione pubblica della realtà stessa. Scrivere di disoccupazione, crisi economica, immigrazione, corruzione, non significa, o almeno, non significa necessariamente, fare del contenutismo (e comunque non sarebbe male chiedersi perché sporcarsi le mani con il contenuto sia di per sé una cosa negativa), quanto piuttosto riconoscere nel trauma qualcosa che articola esperienza individuale ed esperienza collettiva. Mi pare che tutto ciò fosse già ben chiaro nelle conclusioni di Donnarumma all’articolo che ha dato fuoco alle polveri, dove veniva sottolineata la resistenza delle cose alla scrittura piuttosto che la loro malleabilità, il che esclude qualsiasi facile fiducia nella rappresentabilità oggettiva del mondo (il critico parlava già allora di una «tensione realistica» in opposizione a un improponibile «realismo di scuola»[42]) e piuttosto implica che la scommessa del narratore si giochi nel momento in cui si confronta con il pubblico ed in pubblico («il realismo è un’operazione sociale», dice ancora Donnarumma[43]). Il punto in comune della proposta critica del “ritorno alla realtà” e di quella di poetica del NIE sta proprio nell’avere dato nuova attualità ed urgenza alla questione del ruolo pubblico dello scrittore, il che non vuol dire esibire la propria esistenza privata e integrarsi nel sistema dell’entertainment[44], quanto piuttosto misurarsi, «in modo problematico e senza garanzie, [con] la ricerca dei valori culturali collettivi e il senso dei destini individuali»[45]. È un ruolo che anche Wu Ming 1 rivendica per gli autori del NIE quando ne esalta la fiducia «nel potere maieutico e telepatico della parola, e nella sua capacità di stabilire legami»[46]. Fare “epica” non significa soltanto fare delle scelte formali («narrazioni […] grandi, ambiziose, ‘a lunga gittata’, ‘di ampio respiro’»[47]) o contenutistiche («guerre, anabasi, viaggi iniziatici, lotte per la sopravvivenza»[48]), ma in primo luogo riattivare quelle sollecitazioni di natura etica e politica – e quindi collettiva – che, come ha notato Claudia Boscolo in uno dei primi interventi sul NIE, caratterizzano la tradizione epica italiana[49].
È anche per questo che appaiono dunque abbastanza fuori luogo le accuse di zdanovismo di ritorno o le facili ironie su un realismo post- o neo-neo-, e via prefissando. Il “realismo” della narrativa contemporanea non è il risultato dell’applicazione di un metodo o, tanto meno, di una formula con scopi predeterminati, ma è il tentativo di dare forma ad un incontro con la realtà, per cui la ricerca formale, l’elaborazione di adeguate strutture narrative non precede questo incontro ma è prodotta nel momento in cui esso ha luogo. La distinzione tra realismo “ristretto” e realismo “allargato”, a loro volta passibili di ulteriori articolazioni, proposta da Alberto Casadei in uno dei più acuti contributi al dibattito[50], dimostra la flessibilità dell’idea di realismo nel momento in cui si vada al di là delle formule ereditate dalla tradizione. Ma quanto a questo, sono le opere stesse a parlare: la rappresentazione della crisi insieme economica e generazionale degli anni a cavallo del 2000 può prendere la forma del realismo psicologico relativamente tradizionale di Acciaio di Silvia Avallone o del docudrama[51] di Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese di Aldo Nove; la narrazione dei “misteri italiani” può avvenire attraverso il realismo paranoide di Nel nome di Ishmael di Giuseppe Genna o attraverso quello allegorico de Il tempo materiale di Giorgio Vasta; la contiguità tra criminalità organizzata, economia planetaria e territorio può essere esplorata attraverso l’incrocio tra giornalismo investigativo e forte presenza del soggetto autoriale di Gomorra di Roberto Saviano o attraverso l’innesto tra cronaca e personaggi e situazioni mutuati dalla narrativa di genere di Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo… E anche laddove si recuperino strategie tipiche del postmoderno, come l’esibizione della natura artificiosa della narrazione o la riflessione meta-letteraria – penso ad esempio alla produzione più recente di Genna o alla autofiction di Siti – ciò è funzionale alla riattivazione del patto di fiducia tra scrittore e lettore riguardo alla vocazione della letteratura a strumento di analisi e critica del presente di cui si è parlato all’inizio in quanto, ribaltando un luogo comune del postmoderno, la presa d’atto della discontinuità tra le parole e le cose non costituisce di fatto un atto di resa ad essa quanto piuttosto l’indice della simultanea difficoltà e necessità del tentativo di colmarla. La varietà dei modi in cui si realizza il “nuovo realismo” – inteso, come si è visto, non come sistema prescrittivo di norme ma come una vasta gamma di esperienze volte a riannodare il legame tra letteratura e realtà sociale – è evidente nei saggi raccolti in questo volume, nati come contributi al convegno «Negli archivi e per le strade: il ‘ritorno al reale’ nella narrativa italiana di inizio millennio» organizzato da chi scrive presso l’Università di Toronto dal 6 all’8 maggio 2010, e in dialogo ideale con altre iniziative simili fiorite fuori d’Italia intorno al dibattito sulla letteratura contemporanea[52]. Il titolo del convegno riprendeva un passo di New Italian Epic secondo il quale ciò che accomuna un gran numero di scrittori contemporanei è «un desiderio feroce che ogni volta li riporta agli archivi, o per strada, o dove archivi e strada coincidono»[53]. Mi è parso che l’archivio e la strada potessero assolvere la funzione di luoghi-simbolo del “ritorno alla realtà”, sia che esso si configuri come necessità di fare i conti con i numerosi angoli bui della storia italiana recente (ma non solo), sia che risponda invece al desiderio di dare forma e di comprendere una società i cui tradizionali punti di riferimento culturali, politici e sociali hanno subito radicali trasformazioni.
Il volume si articola in quattro sezioni. La prima riunisce contributi di natura teorica o metodologica che permettono di mettere a fuoco alcuni dei nodi più complessi del dibattito, dalla natura stessa del romanzo italiano al dialogo tra linguaggio televisivo e linguaggio letterario, dalle possibili genealogie di un “realismo” contemporaneo ai limiti che una interpretazione lacaniana del Reale pone al discorso critico. I saggi raccolti nella seconda parte, intitolata «Negli archivi: narrare la Storia», propongono una riflessione sulla narrativa che situa le proprie vicende in un passato più o meno remoto, se non addirittura alternativo. Se pare difficile applicare in maniera sistematica l’etichetta di “romanzo storico” alla varietà di testi qui presi in considerazione, va comunque sottolineata la forte presenza, negli autori che in diverso modo si confrontano con il passato della nazione (e non solo), di un imperativo etico che li inserisce nella tradizione di quel genere, se è vero che, come ha scritto Margherita Ganeri, sin dalla sua nascita in ambito romantico esso è caratterizzato dalla «volontà di contrastare le omissioni e le falsificazioni della storiografia ufficiale»[54]. I saggi della terza sezione, «Per le strade: i luoghi (fisici o virtuali) del “ritorno alla realtà”», hanno invece come oggetto opere collocate saldamente nella contemporaneità. Come nel passo di New Italian Epic appena citato, la “strada” sta qui, per sineddoche, per lo spazio sociale e la sua ritrovata centralità in narrativa, dopo il ripiegarsi sull’esperienza soggettiva e privata del “romanzo medio”[55] e sul citazionismo di certo postmodernismo. Descritti con una minuziosità da documentarista o evocati attraverso le voci di chi li abita, i call center in cui si sviliscono le speranze di una generazione di giovani italiani, le piazze in cui periodicamente esplodono la protesta e la violenza dello stato, i siti internet in cui si producono nuove forme di esperienza e socialità virtuali costituiscono altrettante tessere di un mosaico sociale che la narrativa contemporanea torna ad analizzare con rinnovata fiducia. Infine nella quarta parte, «Sconfinamenti: genere, gender, multimedialità», sono raccolti quei saggi che si occupano di scrittori o opere che attraversano e mettono in questione le tradizionali frontiere che ritagliano il campo culturale: non solo, secondo l’insegnamento del postmoderno, letteratura alta e bassa, in particolare attraverso lo strumento del genere, ma anche fiction e non-fiction attraverso modalità di scrittura che mescidano registri diversi come lo sguardo documentaristico e l’esibita presenza dell’io narrante, o scrittura e visualità attraverso un fertile processo di scambio tra media, come nel caso della graphic novel.
[ Introduzione al volume Negli archivi e per le strade: il ritorno alla realtà nella narrativa di inizio millennio, a cura di Luca Somigli, Roma, Aracne editrice, 2013, http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/catalogo/9788854858626-detail.html ]
[1] M. Ferraris, Il ritorno al pensiero forte, in «Repubblica» 8 agosto 2011, consultabile sul sito http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/08/08/il-ritorno-al-pensiero-forte.html. Sul “nuovo realismo” filosofico si veda ora M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Roma-Bari, Laterza, 2012.
[2] Id., Manifesto, cit., ed. Kindle, loc.
[3] Ibidem, loc. 20. Vale la pena di notare che l’uso del termine inglese nell’intervento apparso su «Repubblica» derivava dal fatto che l’articolo voleva anche servire da annuncio di un convegno internazionale sul tema da tenersi nella primavera 2012 all’Università di Bonn (se ne veda ora il programma sul sito http://www.europhilosophie.eu/doctorat/spip.php?article46#Program). Nel Manifesto del nuovo realismo e in altre pubblicazioni Ferraris si è servito della più sobria versione italiana del termine.
[4] R. Donnarumma, G. Policastro e G. Taviani, Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, in «Allegoria» n. 57, gennaio-giugno 2008, pp. 7-93 (ma su questioni affini vertevano altri contributi nel volume, in particolare G. Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), pp. 95-136).
[5] Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 2009.
[6] A. Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 13.
[7] Wu Ming, New Italian Epic, cit., p. 21. Per un’interpretazione del postmodernismo italiano che ne rivaluta il valore politico, si veda almeno P. Antonello e F. Mussgnug (a cura di), Postmodern Impegno. Ethics and Commitment in Contemporary Italian Culture, Oxford et al., Peter Lang, 2009 (in particolare, l’ampia introduzione dei due curatori, pp. 1-29).
[8] Ma sull’11 settembre come fine della ricreazione postmoderna la bibliografia è ormai vasta, soprattutto in Italia. Si vedano almeno R. Luperini, La fine del postmoderno, Napoli, Guida, 2005, in particolare pp. 15-22, dove l’attentato alle Torri Gemelle pare chiudere un ciclo iniziato con la caduta del Muro di Berlino e l’annuncio della “fine della storia”; C. Benedetti, Il tradimento dei critici, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, pp. 29-37; e A. Casadei, Stile e tradizione, cit., p. 40.
[9] R. Donnarumma, Nuovi realismi e persistenze postmoderne: narratori italiani di oggi, in «Allegoria» n. 57, gennaio-giugno 2008, pp. 27-28. Di Žižek, si veda in particolare Welcome to the Desert of the Real, London & New York, Verso, 2002.
[10] M. Ferraris, Manifesto, cit., loc. 41.
[11] Penso ad esempio al lettore postmoderno ipotizzato da Umberto Eco nella Postille al Nome della rosa, Milano, Bompiani, 1984.
[12] R. Donnarumma, “Storie vere”: narrazioni e realismi dopo il postmoderno, in «Narrativa», n. 31/32, 2010, p. 43.
[13] Mi pare che negli ultimi dieci anni l’unico tentativo di pensare in termini positivi il postmoderno (pur evitando accuratamente il termine) sia stato quello di Alessandro Baricco in I barbari: saggio sulla mutazione, Milano, Feltrinelli, 2006. Con la consueta capacità di penetrazione, Monica Jansen lo inserisce nel dibattito intorno al New Italian Epic nel saggio Laboratory NIE: Mutations in Progress, in «Journal of Romance Studies» vol. 10, 2010, n. 1, pp. 98-102.
[14] Stricto sensu, il termine “realismo” non appare infatti nel memorandum, se non in termini negativi in una nota alla versione 2.0 del documento (poi confluita, ma in una versione più moderata, nella sezione intitolata Sentimiento nuevo del volume einaudiano), in cui Wu Ming 1 anzi prende le distanze dal dibattito sul realismo, imputando polemicamente la sovrapposizione tra il New Italian Epic e quello che chiama “neoneorealismo” alla pigrizia della critica. Cfr. New Italian Epic versione 2.0, http://www.wumingfoundation.com/italiano/WM1_saggio_sul_new_italian_epic.pdf, p. 4. Va anche detto che, se questa introduzione tenderà a sottolineare gli aspetti convergenti delle proposte critiche del NIE e dei fautori del “ritorno alla realtà”, ciò non vuol dire che esse possano essere tout court assimilate. Al di là della battuta sul “neoneorealismo”, vi è ad esempio nel primo un’apertura verso forme espressive come il fantastico e il grottesco che non troviamo invece nei secondi.
[15] V. Spinazzola, La riscoperta dell’Italia, in Id. (a cura di), Tirature ’10. Il New Italian Realism, Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 10.
[16] Ivi, p. 11
[17] Ibidem.
[18] R. Donnarumma e G. Policastro, Ritorno alla realtà? Otto interviste a narratori italiani, in «Allegoria», n. 57, gennaio-giugno 2008, p. 9.
[19] Ivi, p. 19.
[20] A. Cortellessa, La rivincita dell’inatteso, in «Specchio+», novembre 2008, p. 138.
[21] Sul dibattito si veda anche il saggio dichiaratamente di parte ma non per questo meno informativo di Margherita Ganeri Reazioni allergiche al concetto di realtà. Il dibattito intorno al numero 57 di «Allegoria», in H. Serkowska (a cura di), Finzione cronache realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella narrative italiana contemporanea, Massa, Transeuropa, 2011, pp. 51-68.
[22] A. Cortellessa, Editoriale, in «Specchio+», novembre 2008, p. 18. Il dibattito nato intorno al libro di Saviano, pubblicato nel 2006, anticipa diversi aspetti di quello sul “ritorno alla realtà”. Si vedano almeno C. Benedetti, F. Petroni, G. Policastro e A. Tricomi, Roberto Saviano, Gomorra, in «Allegoria», n. 57, gennaio-giugno 2008, pp. 173-195, e A. Casadei, Gomorra e il naturalismo 2.0, in M. Jansen e Y. Khamal (a cura di), Memoria in Noir. Un’indagine interdisciplinare, Bruxelles et al., Peter Lang, 2010, pp. 107-122.
[23] A. Scurati, Lo spettacolo della realtà, in «Specchio+», novembre 2008, p. 141. In queste mie note introduttive ho cercato di riservare il termine “reale” per il concetto lacaniano, anche se naturalmente spesso (e a cominciare proprio dal sottotitolo del convegno da cui ha origine il presente volume) esso è usato come sinonimo di “realtà”.
[24] Ibidem.
[25] A. Scurati, La letteratura dell’inesperienza. Scrivere romanzi al tempo della televisione, Milano, Bompiani, 2006, pp. 19-20.
[26] Ivi, p. 20.
[27] J. Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, trad. it. di Gabriele Piana, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006.
[28] A. Scurati, La letteratura dell’inesperienza, cit., pp. 60-61. Molto utili a questo riguardo sono le riflessioni di Monica Jansen su Scurati “apocalittico” – secondo la nota coppia dicotomica di Eco – opposto all’integrato Baricco in M. Jansen, Laboratory NIE, cit., pp. 98-100.
[29] A. Scurati, La letteratura dell’inesperienza, cit., p. 62
[30] Ivi, p. 63
[31] D. Giglioli, Senza trauma. Scrittura dell’estremo e narrativa del nuovo millennio, Macerata, Quodlibet, 2011, p. 8
[32] Sulle trasformazioni nel ruolo pubblico dell’intellettuale (e dello stesso concetto di “pubblico”), si veda A. Cortellessa, Intellettuali, Anni Zero, in A. Cortellessa et al., Dove siamo? Nuove posizioni della critica, Palermo, :duepunti, 2011, pp. 15-40.
[33] M. Ferraris, Manifesto, cit., loc. 613.
[34] Ivi, p. 17
[35] Ivi, p. 23
[36] Ma sull’argomento si era già espresso Filippo La Porta in Contro il Nuovo Giallo Italiano (e se avessimo trovato il genere a noi congeniale?), in G. Ferroni et al., Sul banco dei cattivi. A proposito di Baricco e di altri scrittori alla moda, Roma, Donzelli editore, 2006, pp. 55-75.
[37] D. Giglioli, Senza trauma, cit., p. 10.
[38] M. Recalcati, Il sonno della realtà e il trauma del reale, in M. De Caro e M. Ferraris (a cura di), Bentornata realtà, Torino, Einaudi, 2012, edizione Kindle, loc. 2548.
[39] Cfr. A. Scurati, Lo spettacolo della realtà, cit., p. 141.
[40] M. Recalcati, Il sonno della realtà, cit., loc. 2558.
[41] Ibidem. E ancora, secondo la definizione di Lacan: «il reale è ciò che resiste al potere dell’interpretazione» (Ivi, loc. 2576).
[42] R. Donnarumma, Nuovi realismi, cit., p. 54.
[43] Ibidem. Cfr. anche R. Donnarumma, E se facessimo sul serio?, in «Nazione Indiana», 31 ottobre 2008, <www. https://www.nazioneindiana.com/2008/10/31/quid-credas-allegoria/>.
[44] Cfr. A. Cortellessa, Intellettuali, Anno Zero, cit., pp. 33-35.
[45] R. Donnarumma, Nuovi realismi, cit., p. 26.
[46] Wu Ming, New Italian Epic, cit., p. 22. Sull’importanza del romanzo come forma narrativa rivolta in primo luogo ad una collettività, si veda anche A. Casadei, Realtà o contemporaneità? Le prerogative per un buon romanzo e i compiti dei critici, «Nazione Indiana», 17 novembre 2008, <www.nazioneindiana.com/2008/11/17/realismi/>.
[47] Ivi, p. 15.
[48] Ivi, p. 14.
[49] C. Boscolo, Scardinare il postmoderno: etica e metastoria nel New Italian Epic, «Carmilla», 29 aprile 2008 <www.carmillaonline.com/archives/2008/04/002620.html#002620>.
[50] A. Casadei, Realismo e allegoria nella narrative italiana contemporanea, in H. Serkowska (a cura di), Finzione cronache realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella narrativa italiana contemporanea, Massa: Transeuropa, 2011, pp. 5-8.
[51] Riprendo il termine dalla scheda del libro sul sito dell’editore Einaudi – scheda che inizia significativamente con la seguente asserzione di veridicità: «Questa non è fiction. È realtà» (cfr. <http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880614649/>).
[52] Vale la pena di ricordare almeno il volume a cura di Hanna Serkowska, Finzione cronache realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella narrativa italiana contemporanea, Massa: Transeuropa, 2011, e i numeri più recenti della rivista Narrativa, curata da Silvia Contarini, che dal 2006 si è posta come “osservatorio” per lo studio del «rapporto tra la creazione letteraria e le trasformazioni profonde e globali in corso nella società italiana degli inizi del XXI secolo» (S. Contarini, Raccontare l’azienda, il precariato, l’economia globalizzata. Modi, temi, figure, in «Narrativa» n. 31/32, 2010, p. 7).
[53] Wu Ming, New Italian Epic, cit., p. 11.
[54] M. Ganeri, Il romanzo storico in Italia. Il dibattito critico dalle origini al postmoderno, Lecce, Piero Manni, 1999, p. 28.
[55] Sul “romanzo medio”, cfr. S. Tani, Il romanzo di ritorno. Dal romanzo medio degli anni sessanta alla giovane narrativa degli anni ottanta, Milano, Mursia, 1980.
Di SONIA CAPOROSSI
ad Emilio Garroni
Descrivi l’aroma del caffè.
L. Wittgenstein
Quaderno privato. Da non pubblicare, a rischio di sembrare matto, o quantomeno, retrivo.
Appunto disordinato, numerato alla rinfusa.
Giorno: corrente. Rilettura: passata. Lettori posteri presunti: il minor numero possibile.
Titolo del paragrafo, se occorre un titolo.
Inutilità di una metafisica che graverà per sempre sulle nostre teste.
PROGRAMMA (4-9 luglio, Ancona)
giovedì 4
ore: 18.45 | Portonovo, Chiesa di S. Maria
Roger McGough legge se stesso
Franco Nasi: lettura a fronte
(è arrivata finalmente l’estate e m’è venuta voglia di partire; come facevo una volta, per davvero!)
di Gianni Biondillo
Non ricordo chi scrisse che i giornalisti sono pezzenti che dormono in alberghi di lusso, ma credo che la definizione la si possa estendere anche agli scrittori. Sono a Guadalajara, invitato con altri colleghi alla Fiera Internazionale del Libro, la manifestazione più importante del latino-America, e mi hanno dato una sistemazione al Plaza che è più grande del mio appartamento milanese. Non posso dire che i messicani non siano ospitali, insomma. C’è pure la bottiglia omaggio di tequila sul tavolo, cosa mi manca? È la prima volta che vengo in Messico e m’è toccata la regione che riassume tutti i luoghi comuni messicani: sono originari del Jalisco i sombreri, i poncho, i mariachi, e Tequila è una cittadina di queste parti, dove è nato il famoso liquore. È come andare per la prima volta in Italia e vedersi catapultato in una pizzeria a Napoli, mentre uno vestito da pulcinella ti canta una canzona accompagnato da un mandolino. Roba da far mancare i sensi.

Ovviamente, proprio per questo, cerco di stare il meno possibile in fiera e mi gusto la novità del viaggio, quando mi ricapita, insomma? C’è come una doppia anima in me: quella dell’architetto, la professione che ancora insisto a segnare sulla mia carta d’identità, e quella dello scrittore. Una sorta di dottor Jeckill e mister Hyde. Ogni volta che viaggio i due litigano: la parte razionale, logica, progettuale, organizzerebbe il viaggio fin nei minimi particolari, l’altra, quella più istintiva, andrebbe così alla ventura, come capita. Così è anche qui, a Guadalajara: giro per il centro con la guida in mano, consultando di continuo la mappa della città (e qui è l’architetto), ma ogni tanto mi viene l’istinto di chiudere il tutto di lasciarmi trasportare dal caso (e qui è lo scrittore).
Devo dire che l’arrivo in città non è stato particolarmente entusiasmante: Guadalajara è la seconda città del Messico, supera i 5 milioni di abitanti, ma più che l’aspetto di una metropoli ha quello di una smisurata periferia anomica, con edifici di uno-due piani, spalmati a perdita d’occhio ovunque e strade larghissime di lunga percorrenza. Una specie di scenario per un film fatto di inseguimenti di autovetture, all’americana. Fortunatamente il centro, per quanto piccolo, nobilita questa mia prima impressione. A partire dalla particolarità della Cattedrale che ha su ogni lato del suo perimetro una piazza, così da avere un particolare sistema di spazi pubblici, Las Cuatos Plazas, ognuno differenziato per attività e percorsi. E qui è l’architetto che parla. Ma lo scrittore si lascia affascinare da altro: dai lustrascarpe, ad esempio. Ce n’è dappertutto, chi portandosi dietro le cassette di legno con tutta l’attrezzatura, chi con degli appositi trabiccoli per far accomodare al meglio il cliente. Più che in un altro mondo mi pare d’essere in una bolla del tempo. Da quant’è che sono spariti dall’Italia i lustrascarpe?
Mi incammino verso Plaza de Armas dove c’è il Palacio de Gobierno, qui nel XIX secolo fu dichiarata l’abolizione della schiavitù in Messico. Dentro al cortile prendo la scalinata principale e ho un vero e proprio shock: l’intero vano della scala è affrescato da un colossale murales di José Clemente Orozco, sulla mia testa campeggia sulla volta un enorme Miguel Hidalgo con una torcia fiammeggiante in mano, e io, che è la prima volta che vedo un opera dei tre famosi muralisti messicani (Orozco, Siqueiros e Rivera) quasi non ci credo, sono commosso fino alle lacrime. Ma devo andare oltre, non ho molto tempo a disposizione: supero la Plaza de la Liberaciòn, dove su un palco un gruppo di mariachi sta facendo cantare l’intera piazza, butto un occhio vago all’atrio del Teatro Degollado e mi immetto in Plaza Tapatia. Sto puntando verso l’Hospicio Cabañas, edificio neoclassico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1997. È domenica mattina e ovunque, lungo la strada, c’è gente. Sono tanti, tantissimi: gruppi di amici, bambini, famiglie, anziani. I ragazzi giocano a schizzarsi dalle fontane, alcuni, addirittura si gettano vestiti nell’acqua. Mi guardo attorno e mi accorgo che per le maggioranza sono ragazzi. È un popolo giovane quello che vive questa città, un popolo vitale, spensierato, sembra lo struscio di una città di provincia, non di una metropoli di cinque milioni di abitanti.
Pago il biglietto ed entro in quello che era un monastero cattolico e ora è un museo. C’è un sole caldo che sembra far brillare di giallo la pietra arenaria delle mura. Poi entro nella piccola chiesa, anch’essa completamente affrescata da Orozco. È una sorta di cappella sistina del muralismo, i colori sono cupi e intensi, le figure deformi ed espressive. Mi emoziono, quasi sdraiato a terra, per meglio vedere le volte. Comprendo appieno quello che voleva dire Luis Cardoza y Aragòn, quando scriveva: “Los tres grandes grandes son dos: Orozco.”
Bene, la mia anima d’architetto, il mio Dottor Jeckill è soddisfatto. Mister Hyde no, per nulla. Hai voluto seguire la guida – sembra dirmi -, leggere, interpretare, studiare la mappa, seguire l’itinerario? Bene. Ora perditi. Ed è quello che ho fatto. In fondo solo così puoi conoscere davvero una città, quando fai strame della mappa, quando ti perdi nelle sue viscere. Che è la sensazione che provo girando per il caotico Mercato Libertad, una sorta di mercato rionale che vende qualunque cosa: scarpe, abiti, alimentari, argenteria, giocattoli, bevande… c’è una massa enorme di persone che contratta, vende, compra, gira curiosa, preme, struscia, mangia. Anch’io ho fame. Giusto il tempo di acquistare un regalo per mia moglie, uno scialle tessuto davanti ai miei occhi da una piccola india, e poi mi siedo al banco di una specie di self-service improvvisato dove ordino in piatto di tacos con gamberi. Passerò altri giorni a Guadalajara: visiterò il borgo coloniale di Tlaquepaque ormai inglobato nella periferia della città, mangerò indossando un poncho in un locale dal nome curioso, il Santo Coyote, che pare un villaggio vacanze per turisti, imparerò il modo corretto di bere el tequila da queste parti (accompagnato da un bicchierino di sangria – succo di pomodoro speziato), conoscerò l’entusiasmo degli abitanti di Guadalajara. Ma quella piccola solitudine di fronte al mio piattino di tacos, in mezzo allo sciamare vitale dei visitatori del mercato, quella, resterà forse il più intenso dei miei ricordi.
(l’articolo uscì per un V&S del 2009, ma non ricordo quale. Le fotografie sono mie)
[i titoli delle terne finaliste sono convincenti, pubblico volentieri il comunicato stampa del Premio Dedalus]
PREMIO “STEPHEN DEDALUS” Con il sostegno di pordenonelegge
VI Edizione (2013)
COMUNICATO STAMPA – 24 giugno 2013
Il Premio letterario “Stephen Dedalus”, che opera con il sostegno di pordenonelegge, ha individuato le opere finaliste della sua sesta edizione, che sono:
Per la sezione “Narrativa-Altre scritture”:
Valerio Magrelli, Geologia di un padre, Einaudi
Antonio Moresco, La lucina, Mondadori
Alessandra Sarchi, Violazione, Einaudi
Per la sezione “Poesia”:
Cristina Alziati, Come non piangenti, Marcos y Marcos
Stefano Dal bianco, Prove di libertà, Mondadori
Eugenio De Signoribus, Trinità dell’esodo, Garzanti
Per la sezione “Saggi”:
Daniele Giglioli, Senza trauma, Quodlibet
Matteo Marchesini, Soli e civili. Savinio, Noventa, Fortini, Bianciardi e Bellocchio, Edizioni dell’asino
Gian Piero Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici. 25 storie da un altro mondo, Sironi
Le opere finaliste sono state scelte dai circa 200 Lettori delle “Classifiche di qualità” pordenonelegge-Dedalus, che torneranno a votare per scegliere le vincitrici entro il prossimo 10 luglio.
La premiazione si svolgerà a settembre nell’ambito della manifestazione di pordenonelegge.
Sito del Premio: www.premioletterariodedalus.it
Pasto nudo
di
Ivan Ruccione
È successo prima che lo cacciassimo in cella.
L’ho sbattuto con la pancia a terra, gli ho immobilizzato gli arti.
Ancora si dimenava ma non aveva più scampo: ce l’avevo in pugno.
Afferrai il coltello e glielo puntai al centro della schiena. Poi affondai – crack!- e squartai a metà l’intero corpo. Quando arrivai alla testa, un pezzo di cervello schizzò sulla mia guancia sinistra. Il sistema nervoso diede impulsi per una manciata di secondi ancora. Dopodiché au revoir, douceur!
“Poveraccio…”, disse il giovane Stefano, con la faccia inorridita, accanto a me che assisteva alla scena.
“È uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo”, dissi io. Alzai la leva del rubinetto e passai le due metà del cadavere sotto il getto d’acqua per eviscerarlo più facilmente.
“Io non so se avrei il coraggio”, disse Stefano, con le mani appoggiate all’enorme plonge e la punta del piede destro che picchiettava nervosamente sul pavimento.
“Ragazzo mio, se vuoi fare questo mestiere non devi avere paura di niente. Soprattutto dei colleghi.”
Chiusi il rubinetto, mi voltai verso di lui e gli sventolai sotto gli occhi la vittima: “bene, prendi questi due bellissimi mezzi astici, dà loro un’asciugatina e mettili sottovuoto. E non dimenticare di annotare la data di confezionamento, che se viene l’A.S.L. so’ cazzi”.
“Sì, chef!”, esclamò.
“Non chiamarmi chef, pezzo d’idiota, che se quello ci dovesse mai sentire, ci infilerebbe la scopa nel culo e ci farebbe pulire l’intero hotel”
“A proposito, dov’è lo chef?”, chiese, inserendo le due metà nei sacchetti.
“Sono le 21.30, il servizio sta per finire e dove pensi che possa essere?”, dissi, insaponando con una spugna il coltello. “Sarà già in camera sua e starà spiegando come si piantano i cetrioli alla cameriera ai piani, come al solito”, proseguii.
“Ah!, che bello essere chef… donne, soldi, carriera!”, disse Stefano, con gli occhi sognanti verso le marmitte incrostate che avrebbe dovuto lavare a breve.
La macchina del sottovuoto fece PFFFFFFFFFFFF.
“Se lo dici tu…”, risposi, mentre davo un colpo di straccio al banco di lavoro.
“Sì, te lo dico io! Adesso sono uno stupido plongeur ma un giorno farò strada e sarà questa la mia forza: essere partito da qui, come Gualtiero Marchesi!”, tuonò, picchiando tre volte la mano sull’acciaio del lavandino.
“Tanti auguri, Gualtiero”, dissi lanciandogli lo straccio. Mi appoggiai col sedere al banco ed incrociai le braccia sulla pancia.
“Perché mi vuoi smontare?”, chiese, aprendo il portello della cella freezer.
“Na, na, na, Gualtiero, quegli astici vanno nella cella del pesce, non lì. Domani a pranzo ci servono. Sono per i tagliolini del direttore e consorte. E, comunque, io non ti voglio smontare: devi fare ciò che ti senti. Quanti anni hai, Stefano?”.
“Diciannove”
“Bene, sei abbastanza grande da porti davanti ad un bivio. Scegli: o fai l’uomo o fai il cuoco.”
“Non capisco…”
“Le due cose non vanno d’accordo”
“Perché?”
“Mettiamo il caso che diventerai un bravo cuoco, ok? Vuoi passare un bel week end con tua moglie/compagna? Scordatelo. Vuoi passare il Natale con la famiglia? Il capodanno? L’Epifania? La Pasqua? Il 25 aprile? Il primo maggio? (perché noi non siamo considerati lavoratori, non lo sapevi?) Scordateli. Vuoi andare a vedere la partita di tuo figlio il sabato pomeriggio? Scordati pure quello. Dimenticati di vivere. Tieni a mente, Ste: uomo o cuoco”.
Per un minuto circa ci fu silenzio. Lo guardai, vidi il suo sguardo perso sul forno lì accanto ed era come se tutto l’arredamento in acciaio che ci circondava si stesse liquefacendo ai nostri piedi.
“Perché tu, allora, fai lo chef entremetier?”, chiese, senza distogliere lo sguardo.
“Be’, io sono qua di passaggio. Come uno spirito sulla Terra con delle questioni in sospeso. Per ora mi ci pago i vizi, tutto qui”
“E che vuoi fare da grande?”
“Lo scrittore”
“Lo scrittore? Perché, tu scrivi?”
“Devo”
“Cosa scrivi?”
“Poesie, racconti. Dipende dalla necessità, insomma”
“E perché scrivi?”
“Perché tu respiri?”, domandai.
Mi avvicinai al rubinetto centrale del gas e lo spensi.
“Senti”, dissi, “prima che ti metta a lavare tutti quei tegami: monda e trita o’ pretosin’ perché non ce n’è più e domani ci serve”
“Monda e trita cosa?!”
“Il prezzemolo!”
“Merda, lo devo fare adesso?”
“Subito”
“Domani no?”
“A che ora sei arrivato stamattina in cucina?”
“Alle 8.00”
“Che ore sono adesso?”
“Le 22.05”
“Scegli, Ste: uomo o cuoco. Mo ti saluto”
Appena entrai in camera mia mi levai subito il cappello, la giacca e i calzoni sale&pepe come fossero una corazza. Mi venne in mente l’astice, il coltello che penetrava e pensai: così è la vita. Andai in bagno, infilai il tappo nello scolo della vasca e lasciai che si riempisse. Scavalcai il bordo e mi ci sedetti, coi piedi immersi. Non appena l’acqua mi arrivò sotto le ginocchia, spensi, e guardai il mio faccione deformarsi in mille cerchi.
Quella giornata era stata uguale a mille altre. Pensai che dopo, almeno, avrei scritto. Che sarei rimasto vivo fino a notte fonda, a pigiare dei tasti con le mani che sembrano i tentacoli di un polpo tra gli scogli di un oceano di pensieri. Cercando di cacciare fuori qualcosa di disagiato, qualcosa di interessante, soprattutto per me stesso. Lo facevo per sfogarmi. Però, a dire il vero, mi eccitava all’inverosimile la verosimile idea che un giorno, i miei sfoghi, potessero essere roba interessante per certa gente che restava sveglia a leggere quello che a me faceva perdere il sonno.
Sul vetro della bocca di lupo sopra la mia testa iniziò a picchiettare la pioggia.
Lo conoscevo bene, quel rumore.
di Giovanni Duminuco
Da Dinamiche del disaccordo (silloge vincitrice dell’ultima edizione del Premio Lorenzo Montano per la raccolta inedita).
I
Che poi è strano non abitare il corpo, disattendere le promesse del nutrimento, soccombere a questo silenzio liquido, nella forma del disaccordo: sentirla addosso, sentire questo esito fatale, inseguendo le impronte sulla sabbia, nei sandali insanguinati, come bestie in direzione ostinata, verso valichi che aprono a nuove pretese dell’indicibile. Una volta e non più, dicevi, una sola volta, nient’altro che una pretesa per scrutare sotto la crosta, la lingua tra i denti, il sorriso stanco di chi ha lasciato la linea del compi-mento, le prerogative della madre, piangendo lacrime (un po’ come) irregolarità sulla pelle, sorrisi aperti a mezz’asta.
III
L’idea che le verità sia intollerabile appartiene alla schiera dei tentativi mascherati, tra i più sospetti inganni, ai fondamenti delle metamorfosi perpetue, un’interpretazione topologica del senso, smembrato dalle analisi logiche e dai sintagmi imperscrutabili: certe cose appaiono come l’antitesi di un’agognata perfezione, l’occhio della colpa, la violenza collettiva dell’inganno, sono in linea con le regole del gioco, riprodotte in azioni sacrificali, all’insaputa dei corpi, a livelli archetipici, dentro la scia dei binari, nelle traiettorie di un annullamento costante. Io vivo nelle cose, tra i vetri, nell’aria satura di polvere, forse dentro una percezione sopita: non esiste il verso del perdono se non nel lamento, la cessazione del battito è un’ipotesi sospesa nella cura.
di Francesco Forlani
Una lettura della sesta elegia duinese di Rainer Maria Rilke in una fontana dismessa del proprio quartiere, giusto di fronte alla libreria Il Ponte sulla Dora. Le riprese sono di Alessandro e Chiara, Rocco guardava e Pepe e i suoi amici ascoltavano. Lamberto suonava, ma molto prima. L’edizione è quella pubblicata da Einaudi con traduzione di Enrico e Igea De Portu
La pioggia era battente e il cuore batteva forte, così, rientrando ho scritto questi versi.
una profonda solitudine da autentica disfatta
e a letto senza cena di notte, di notte nera nera
con lo scroscio di una fontana dismessa che la pioggia
regala con rintocchi ed i zampilli sul cemento
della vasca che rivela insieme alla pietra l’idea
di uno specchio d’acqua appena rimosso
rapita disinvolta all’immagine riflessa di un tempo
che non è più tempo e speri chino sul foglio
piegato a metà come una barchetta senza mare
che quel tempo fuggendo si trasformi in temporale