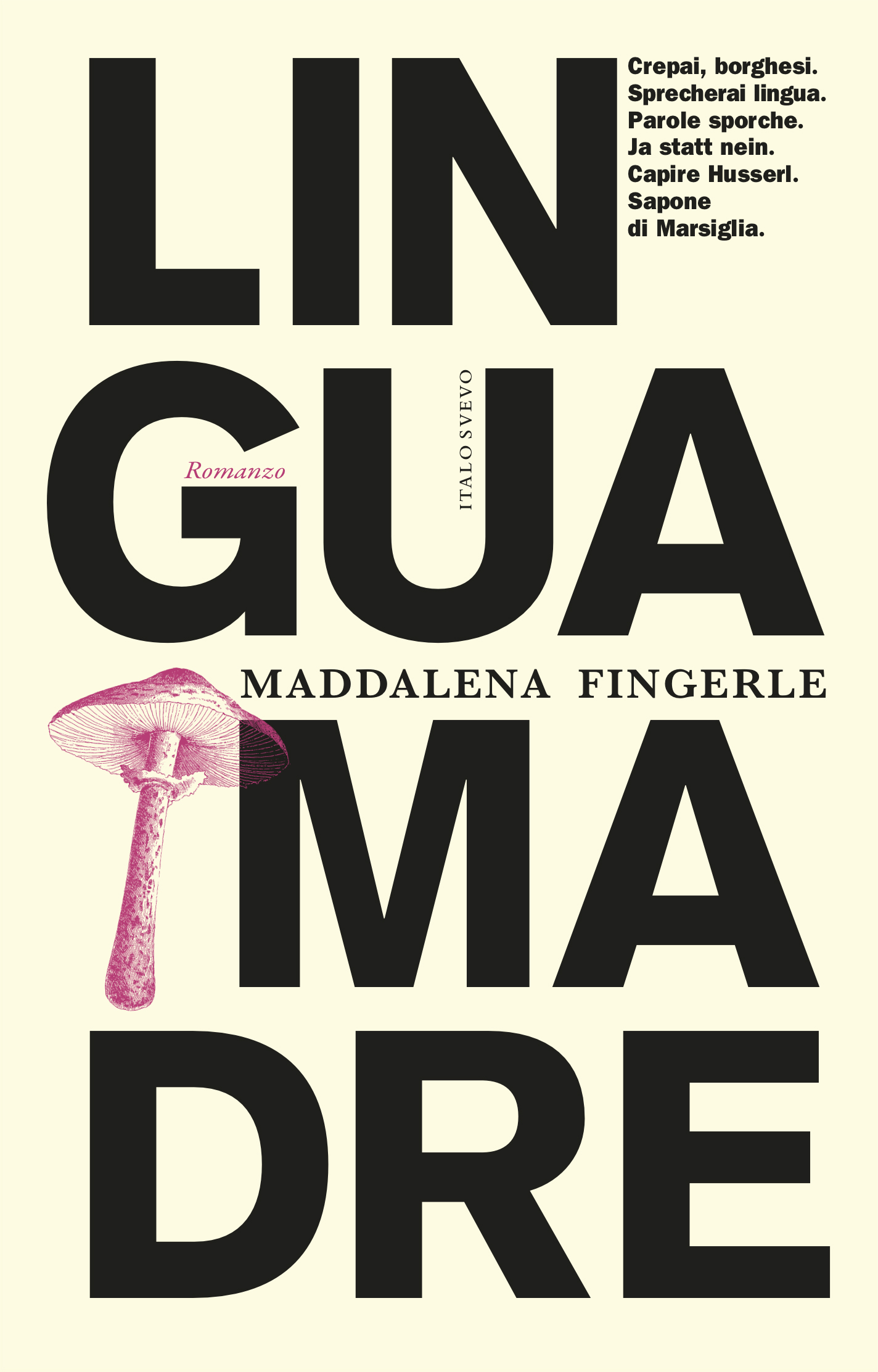sento dalla radio stamani che la seconda fregata che vendiamo all’Egitto sta ormai navigando verso quel paese. Forse per compensare il fatto che l’Egitto, nella persona del suo dittatore Abdel Fattah Al-Sisi e della sua cricca, ci sta continuamente fregando. Dopo quello che hanno fatto a Giulio Regeni e quello che stanno facendo a Patrick Zaki, noi manteniamo un solido commercio, anche di armi, con questa gentaglia, addestriamo i loro poliziotti in Sardegna, insegniamo forse loro a torturare meglio? Il nostro ambasciatore al Cairo, ritirato per poco tempo, è ancora lì che mantiene cortesi e diplomatici rapporti? Cosa ne è della causa intentata dai genitori di Regeni allo stato italiano per la vendita di armi a un paese che non rispetta i diritti umani, violando così un’apposita legge dello stato di qualche anno fa? Il Draghi che è così tanto cattolico confonde forse, dato il suo passato, il Dio trino col dio quattrino?
la seconda fregata
L’Anno del Fuoco Segreto – La serpe
La descrizione del progetto L’Anno del Fuoco Segreto, si può leggere QUI.

di Elena Giorgiana Mirabelli
… e per un mese intero suonarono e ballarono
È mia madre ed è nel bosco.
Ci sono le primule viola, l’odore di fiori e di sterco, il suono dell’acqua sulle pietre, una lunga gonna bianca. C’è la luna e una brezza di terra, lei è scalza. I capelli sulle spalle, sciolti, ciocche mosse e lucide; lascia dietro di sé l’odore dei balsami alle erbe che usa. Gli occhi sono piccoli e chiari, le labbra sottili, il viso senza grazia.
Ilda, la donna dai capelli rossi, racconta una storia fatta di desideri e preghiere, di danze notturne e di rettili, di caviglie e gole blu. Quella storia arriva a me, al mio corpo di squame e al veleno che ho fra i denti. È la storia di mia madre che ha pregato ogni notte gli dèi del cielo e della terra, le nuvole e la luna: vedeva donne diventare madri, animali deporre uova, fiori riempire il giardino di profumi.
Indossava la sua veste bianca, e mentre mio padre dormiva, scendeva giù verso il giardino, prendeva il sentiero e andava verso la radura. Lì, a piedi scalzi, sedeva sul masso, il masso dei segreti, degli umori e dei sussurri. Si sdraiava a terra, respirava, copriva i seni di sassi. Ingoiava erbe, seguiva le luci, pregava. Nessuno sa, neanche mia madre, per quante notti andò lì, nel bosco, scalza.
Nacqui che ero senza ossa. Una serpe lucida e piena di squame.
Nella mia stanza c’erano velluti e cuscini, felci e alloro. In un angolo, la gabbia con i topi bianchi che squittivano alla luna e battevano sul metallo. Quando all’alba Ilda entrava per svegliarmi, si sedeva accanto a me, le leccavo le mani e le succhiavo i seni, scivolavo fra le sue spalle, mi attorcigliavo alle sue caviglie. E lei intrecciava i tessuti e le storie.
Ingoiavo le bacche rosse del biancospino e pensavo che altrove, a sud, un re serpe era ridiventato uomo.* Ilda diceva che anche per me l’incantesimo si sarebbe spezzato.
«Come?», le chiedevo.
«Devi solo sposarti. Lui si toglierà sette vesti e tu sette strati di pelle. E avrai le ossa e i capelli, avrai i seni e così dovrà accadere per tre notti».
Doveva, però, essere bello e ricco. Figlio di un imperatore o di un re. Se così non fosse stato avrei potuto affondare il mio veleno in quella gola di uomo. Come accadeva nella storia.
Passavano gli anni e le mute. Lasciavo gli involucri in giro, sui tappeti, sui miei cuscini, sulle pietre.
Una volta, al fiume, l’ho lasciata accanto ai talloni delle donne. Mia madre intrecciava i rami di salice. Ilda era seduta accanto a lei. Mio padre era via, chissà dove, lo vedevo sempre meno. Ricordo le sue spalle, la sua nuca, il suo viso no. Ilda diceva che lui non sopportava me e che viaggiava per tutte le terre conosciute e ignote alla ricerca di una soluzione al problema che ero. Quel giorno, Ilda bisbigliava perché non voleva che mia madre sentisse e soffrisse. Ma mia madre non soffriva. Intrecciava selci e masticava le bacche e poi si illuminava sempre quando Lui era presente. Lui, unico uomo che le donne ammettevano al fiume, era senza ciglia e capelli. Di solito, quando Lui arrivava, Ilda mi portava lontano da mia madre, diceva che era meglio così e che prima o poi avrei capito, quel giorno invece prese a bisbigliarmi la storia del serpente, dei sette strati di pelle e del grande ballo.
«Anche per te ci sarà un grande ballo. Tuo marito non danzerà, rifiuterà gli inviti di contesse e marchesi, di principesse vestite di organza e principi vestiti di lino. Poi arriverà una dama dal lungo abito d’oro: quella dama sei tu, ma nessuno lo saprà. Al secondo ballo sarai vestita di blu. Al terzo sarai coperta di velluto».
«E poi?» chiedevo.
«Ci sarà festa».
L’indomani, eravamo nella radura. C’erano le primule viola, l’odore di fiori e di sterco, il suono dell’acqua sulle pietre. C’era la luna e una brezza di terra, presi a guardare con più attenzione le donne. Le vesti erano trasparenti e chiare, le gambe erano scoperte, i talloni screpolati e duri. Non avevo mai notato quanto i polpacci possano essere pieni di vene e cicatrici, quanto siano i piedi a definire la fatica. Mia madre ha i piedi piccoli e senza graffi. I polpacci non sono gonfi, ha le caviglie sottili. Quando abbraccio le sue gambe sento l’odore delle creme e degli oli. Queste donne sono robuste, muscoli in tensione, nervi abituati allo sforzo. Le vesti che indossano sono macchiate di terra, umori e sudore. Hanno croste e calli. La pelle dei talloni è una ragnatela di crepe e tagli. Sono belle perché diverse. Alcune sono piccolissime e nerborute, altre immense e piene di carne, altre ancora hanno capelli radi, ciocche scomposte e stoppose. Mi accorgo di non averle mai guardate davvero.
Raccolgono malva e ortiche, striscio fra le loro caviglie, Ilda mangia more, mia madre è rimasta a casa con Lui.
Ilda beve e poi mi mostra la sua lingua, mostra la sua gola. È blu e ride. Anche le altre bevono e ridono. Cominciano a cantare una canzone fatta di sole consonanti, poi di vocali apertissime, ma non c’è nessun significato in quello che dicono. Intonano catene di suoni, variando il volume a seconda delle indicazioni di Ilda perché è lei che ha chiamato il rito. Si muove fra le donne, le sfiora, a volte bacia la fronte o la guancia. A volte scende giù fra le gambe. Quando lo fa, quando decide di scendere con la testa fra le gambe di qualcuna, il ritmo accelera e le altre battono i piedi così forte che sento la terra vibrare. E allora comincio a strisciare sempre più veloce per evitare che mi schiaccino. Sono sul masso dei segreti, degli umori e dei sussurri. E le vedo che si avvicinano e si allontanano, girano attorno a Ilda e girano girano girano ognuna attorno al proprio asse. I vestiti si gonfiano e poi aderiscono alle gambe e ai busti. I seni cominciano a mostrarsi.
Sono fiori che sbocciano, pianeti che orbitano, fiammelle che brillano.
E attorno tutto muta.
L’odore del bosco si mischia al selvatico delle loro ascelle. Le vesti sono a terra e vedo i corpi graffiati, pieni di croste, splendidi come solo alcune storture sanno esserlo. Vedo schiene dritte, ricurve, seni gonfi di latte e grasso, vedo una donna con una lunga cicatrice al posto di un seno, delle pance slabbrate, capelli che cominciano ad appiccicarsi su fronti sporche e sudate.
Una donna si accovaccia e sento salire l’odore acre dell’urina. E quell’odore è l’odore di vita, di sporco, è un odore che mi chiama.
Comincio a strisciare e a risalire su per le loro gambe e sento un odore ferino che cambia e cambia e cambia ancora. Ilda è l’odore del bosco dopo la pioggia.
Le salgo su per il corpo, Lei mi chiede di passarle fra le gambe, io le disegno una traiettoria lungo il fianco, fin su, fra le scapole e il collo. Le avvolgo la gola per tre volte. Lei comincia a danzare. A muovere i fianchi in modo morbido. Chiude gli occhi. Le sue mani sulle mie squame. Il ritmo di tutte è rallentato. Vedo lingue e braccia e seni e danze. Ilda vibra fra le mie spire.
E poi arriva Lui. Si avvicina a Ilda mentre le altre donne hanno iniziato a intrecciare i capelli con i fiori. Sono stanche, alcune sono sedute e poggiano la schiena sul masso, altre preferiscono rimanere sdraiate a terra. Hanno gli occhi chiusi, le braccia abbandonate. La donna senza il seno ride. Io avvolgo il collo di Ilda che mi tiene ferma perché non vuole che io mi allontani. Lui si accovaccia accanto, nel silenzio del bosco l’unico suono, ora, è il respiro di Ilda. Le accarezza la fronte. Accarezza me. Dice che non esistono formule giuste, ma esistono formule. Non esistono storie esatte, ma esistono storie piene di errori. Dice che mia madre ha solo bisogno di luce, e che non c’è alcun incantesimo da spezzare. In quel momento il respiro di Ilda è un grido che mi frantuma.
E accade.
Tutti i sette strati di pelle scivolano via, l’uno dopo l’altro senza che io l’abbia deciso. E sono carne e sangue. Ossa e pelle. E gli involucri sono abbandonati e Lui li mangia, uno dopo l’altro.
Quando va via, le altre si rivestono lasciando me e Ilda sdraiate lì, da sole. Non ci sono più le fiamme a illuminare la radura. Sono completamente nuda. Guardiamo verso l’alto, ho le mani sulla pancia. Ilda ha un braccio dietro la nuca e le gambe sopra le mie. Sente la consistenza delle mie ossa. Le sento anch’io. Le chiedo cosa accade al re dopo il terzo ballo. Mi dice che lui è vestito da monaco, che i sovrani suoi genitori hanno bastonato sua moglie perché non doveva danzare con degli sconosciuti. Mi dice che allora la donna svela che quel monaco è il re serpente, che con quelle bastonate hanno impedito che si trasformasse in uomo, per sempre. Ilda quando racconta fa le voci. Stridule per i sovrani, la voce della moglie è roca, quella del re serpente è piena di toni bassi.
Dice che dopo quelle bastonate, il re serpe si trasforma in un altro animale.
«Ora è un uccello che vola via. La moglie lo cerca e lo riconosce. Ma lui le mozza le mani e le cava gli occhi».
«Perché?»
«Per spezzare l’incantesimo».
E Ilda racconta che lei avrà di nuovo mani e occhi grazie all’intervento del divino. Le basta immergere i moncherini in una pozzanghera e passare le nuove mani sul viso. E con le nuove mani e i nuovi occhi costruirà un palazzo di fronte a quello del re. E alla fine i due si riconosceranno e danzeranno. E saranno felici.
Poi, il suo entusiasmo si smorza.
«Lui ha dovuto farlo. Ha dovuto mozzarle le mani, ha dovuto levarle gli occhi, perché solo così avrebbe rotto l’incantesimo e sarebbe rimasto uomo», mi dice.
«Io non voglio mozzare mani né cavare occhi». Sono finalmente calma.
Ilda si mette su un fianco e mi ascolta.
«Non voglio nessuno a cui mozzare mani, non voglio gole in cui affondare veleno. Non voglio togliere strati, non voglio nascondermi. Non voglio attendere che arrivi chi spezzi l’incantesimo».
«E allora, cosa vuoi?»
«Voglio solo danzare ogni notte».
*Il Re serpente, in Italo Calvino, Fiabe italiane, vol. II, Einaudi, Torino 1956.
Immagine di Francesco D’Isa.
**
Elena Giorgiana Mirabelli, nata a Cosenza nel 1979, laureata in Filosofia, ha curato volumi per Carocci, Laterza e altri editori. Collabora con la rivista dedicata all’arte e alla letteratura erotica Queef Magazine. È redattrice della rivista Narrandom e dell’agenzia Arcadia b&s di Cosenza. Ha esordito a febbraio 2020 con il romanzo Configurazione Tundra (Tunué).
Grande Karma o il luogo dove il destino del Testo ha da compiersi
di Sonia Caporossi
L’ultimo romanzo di Alessandro Raveggi Grande Karma – vite di Carlo Coccioli (Bompiani 2020) fin dalle prime pagine sembra rispondere ad alcune linee ermeneutiche precise, al di là dei facili inquadramenti di genere e specie. Non è qui il caso di domandarsi, infatti, se il testo strutturalmente appartenga al modus ponendo ponens un po’ stucchevole della biofiction o alla definizione, meno in voga, della biografia romanzata. A nostro giudizio, esso riflette piuttosto, come sembra, la natura di un caleidoscopico e surreale gioco del doppio, in cui il tema portante è una battuta di caccia identitaria dove lo scambio continuo di forma e sostanza tra il protagonista/autore-che-dice-io e l’oggetto dell’indagine, il Grande Scrittore Outsider archetipico, diviene motivo di sviluppo narrativo e di riflessione sul senso stesso della scrittura.
L’oggetto di questa neomassimalista Ur-Ermittlung è Carlo Coccioli, scrittore dai mille volti come una divinità Indù, che esiste concretamente nelle peregrinazioni in cui si aggirò per mezzo mondo inseguendo i suoi demoni reali e finzionali, dall’Africa in cui nacque a Parma e poi a Fiume, a Napoli e a Firenze, fino a Parigi e al Messico più sperduto e conglobante, laddove disperdere opportunamente le tracce di un’esistenza in continuo fieri. Carlo Coccioli esiste davvero nei viaggi, nell’epistolario, nelle relazioni omosessuali e nelle frequentazioni letterarie (conflittuale quella con Curzio Malaparte, per dirne una; un inseguirsi e perseguirsi continuo). Ma quel Coccioli insiste nel suo esistere anche e soprattutto letterariamente nei propri scritti, continuamente perduti e ritrovati, alcuni nemmeno realmente essenti, altri solo ipotizzati, paventati, altri ancora di momentaneo successo ma che, attraverso un inusuale e straniante processo di distaccamento dalla fama, sono stati ben presto dimenticati colpevolmente in patria, fino a lasciare scarsa traccia mnemonica di un romanziere paragonato un tempo “ad Albert Camus e Marcel Proust” (p. 53). Una sorta di Gide già postmoderno e postumo a sé stesso, autore di opere difficilmente classificabili come Fabrizio Lupo (1952, in italiano nel 1978), Omeyotl, diario messicano (1962), Piccolo Karma (1987), Budda (1994) tanto per citarne alcune in mezzo alla sterminata produzione di questo grafomane tanto prolifico quanto interlocutoriamente evanescente.
Epperò, alla fine, anche se esiste o, per meglio dire, proprio visto che esiste, non importa poi tanto, nella sede del metaromanzo raveggiano di cui stiamo parlando, che Carlo Coccioli sia vissuto davvero: l’atmosfera che si respira tra le pagine di Grande Karma ha un che di misteriosofico, il testo è ricoperto a ogni pagina da una patina grassoccia di obnubilante nebbia cognitiva che avvolge non solo il personaggio Coccioli nel trascorso “analitico” del tema, ovvero sé stesso (laddove l’analisi è un tentativo continuo dell’io narrante di entrare in possesso o, quantomeno, in contatto con l’oggetto sfuggente dell’indagine stessa), quando l’auctor oggetto di ricerca e i personaggi in quanto tali, compresi quelli compresenti, di sfondo e di contorno. Coccioli è sintetizzato nel doppio, reduplica n-volte prismaticamente la narrazione e, per il tramite di essa, il senso stesso della parola detta oltre il quid della materia narrativa trattata.
In questo senso, Carlo Coccioli, ricercatore di una religione iper-rivelata proprio perché in ab-sentia, abituato a spostare indefessamente l’oggetto della propria ricerca cambiandole nome e volto in tutte le divinità pensabili che attraversano l’unico vero Dio per lui esistente, ovvero l’Io senza dentale sonora, è un esploratore dell’abisso del senso a cui Dio stesso si cela senza rimedio: “perché Dio ti nascondi sempre, se io ti bramo, innamorato pazzo?” esclama Raveggi/Coccioli con il corsivo dell’Erlebte Rede a p. 46, utilizzando il meccanismo steineriano del Doppelgänger che ritroveremo per tutto il romanzo, progressivamente usato e abusato come espediente attraverso cui rendere “quel suo andirivieni sempre compromesso tra vita e invenzione” (p. 50), nel tentativo di darsi forma e definizione: “Sono stravagante, un anormale, un mostro, un marziano, una creatura apocalittica? O forse, più semplicemente, un fuori di testa?, si chiedeva in uno dei suoi articoli” (p. 53).
L’autore che propugnò la prima cellula della Alcolisti Anonimi a Firenze, che si spostò come un girovago neobarocco in cerca della verità col lanternino sbeccato dell’Eremita dei Tarocchi, il mistico sensuale che della propria omosessualità non disdegnava l’anelito all’innamoramento assoluto (per un Dio, per un uomo, per un cane), potrebbe somigliare, chessò, a un Achab che avrebbe potuto benissimo accarezzare con amore la balena facendola rientrare nel suo Ashram come divinità degna di venerazione, a un Argo dai mille occhi, a un Erma bifronte a cui due soli volti starebbero stretti. La parola magica che amava ripetere era Passione, con una maiuscola non scelta a caso: “ho perso la bussola […] sono preso dalla Passione, venero degli Idoli, hai capito, Miguel? […] Ho definitivamente abbandonato le Divinità del monoteismo, perché, non trovi?, un Dio terribile non ha senso! Un dio che sacrifica il proprio figlio, come è possibile!…quando io nutro persino i topi che ho in casa?” (p. 93). Del resto, il misticismo panico di Coccioli, contraddittorio ma olistico, onnipervadente e metafisico nel senso religioso del termine, gli permetteva persino di vedere in Bhaktivedanta Swami Brabhupada, nella disciplina atarassica e asessuale degli Hare Krsna “una sorta di insegnamento pansessuale. Che coinvolgeva le piante, gli animali, in un erotismo per tutte le cose…” (p. 94).
Inseguire il Manoscritto archetipico nascosto in chissà quale anfratto della sua Casa Museo o custodito nel cassetto di chissà quale enigmatico amante/comparsa, cercare ogni dove i diari segreti occultati da chissà quale fantasmatico attore secondario della vita di questo Scrittore junghianamente Primigenio è la vera missione del protagonista che dice io, il quale si perde e si confonde nei meandri della ricerca stessa, sentendosi rubato dalla/alla letteratura come fosse disciolto in un gioco linguistico, in un dedalo wittgensteiniano dalle infinite regole riscritte infinite volte, immerso giocoforza e suo malgrado nell’imprinting borgesiano e bolañano di un atto letterario concepito come supremo fine proprio perché inevitabile fine. In questo contesto, anche il Messico diventa un non-luogo invischiante in cui disperdere i propri punti di riferimento identitari. C’è qualcosa a metà tra Lynch e Tarantino nelle descrizioni, nei luoghi, nei particolari, sempre spostati altrove, sempre descritti in altro, che rimangono lì, sospesi, senza dato definitorio e senza direzione.
In tutta questa dissipante dispersione, il segreto di Carlo Coccioli è uno e uno solo, identico a quello di qualsiasi narcisista patologico che si rispetti: voleva solo essere amato. Esattamente la medesima aspirazione di Enrico Capponi (è ora di svelare il nome fittizio del protagonista/doppio, anzi triplo, visto che dietro alla sua imago romanzata si nasconde, date le frequentazioni fiorentine, parigine, messicane e il physique du rôle, Raveggi stesso). La dispersione di energia, l’entropia cosmica della parola letteraria dissimulano dietro uno spesso strato di facili promesse di fama e di riscontri due/tre uomini che si inseguono in un gioco di specchi. E allora Enrico, già promesso sposo, si lascia sedurre prevedibilmente e facilmente da una ragazza messicana e coinvolgere da un cameriere parigino che lo conduce di fronte a sé stesso. Tanto è sfuggente e misterioso Carlo, nel suo caos preordinato di cui per tutto il romanzo si intuisce l’immanità, quanto Enrico è epimeteico e goffo: egli, Cappone di nome e di fatto, si lascia catturare e cucinare a puntino dall’animale stesso di cui va disperatamente a caccia.
È un immergersi carne e sangue in un percorso a ritroso con “al centro, un vuoto tremendo. Forse il vuoto dell’ubiquità di Coccioli, la ricerca della sua vita come nirvana pneumatico, un particolare mihrab di moschea, lo spazio architettonico dove tutti si rivolgono in preghiera. Vuoto” (p. 185). Nel romanzo ci troviamo più volte di fronte a un vorticoso essere-assente da riempire di senso, a un avvolgente effetto Morgana in cui dal miraggio emergono i fili e le p-brane di un’esistenza da ricomporre, quella dello Scrittore Archetipico; solo attraverso quella Enrico potrà costruire o rimettere insieme i pezzi della propria percorrendo “la doppiezza del viaggio” visto che “si va avanti tornando indietro, incatenati dove siamo stati sempre, senza mai esserci stati davvero” (p. 186).
È così che Enrico Capponi, andando avanti nella sua ricerca, si scopre essere “un filologo fallito nudo allo specchio, un scimmia testuale piena di desideri che si azzuffano tra loro” (p. 206), non ultimi quelli che lo dividono tra la figura di Lola, la ragazza messicana suicida a causa sua, che evoca il proprio atavico senso di colpa nei confronti dell’eterno femminino e Dina, la promessa sposa di una vita, per la quale non prova che un affetto di tipo sessual-fraterno come nel più tipico degli obblighi familiari, figura protettiva e confortante in cui rifugiarsi per trovare un ordine, un senso, una stabilità ormai troppo logorata e stretta nelle sue maglie autogiustificatorie per non sottintendere la presenza di una nevrosi desiderante. Pansessuale anch’essa, come quella di Coccioli, che lo conduce verso il proprio Grande Karma, passando attraverso “l’ombra intera di un’assenza” (p. 252), la sparizione, la dissipatio Humani Philologi, esattamente nel giorno paventato per le nozze, coup de théâtre in cui il Destino, quello di una vita che coincide col Testo, ha da compiersi. Del resto, il protagonista lo aveva detto fin dall’inizio: “Sarà che tutto ruota intorno a me, e io lo manovro, come fissi il perno di una ruota. O che, al contrario: sono io la trottola che gira a vuoto, e il mondo attorno è sempre lo stesso. Cambio le facce, o le facce cambiano me, con la velocità. Oppure ancora peggio: è tutta una specie d’altalena, un columpio, come direbbe lui” (p.). La vita non è una, ma tante: come le vite di Carlo Coccioli poste in sottotitolo, in esergo e in calce all’esistenza di Enrico, del lettore e, con loro, di chiunque sappia che la vita, pirandellianamente, “o si vive o si scrive”; ma anche entrambe.
Poesia e perdita. Un’intervista di Gilda Policastro a Franco Buffoni
 L’intervista-dialogo che segue nasce da un incontro di poesia, tenuto presso la scuola Molly Bloom nel 2017.
L’intervista-dialogo che segue nasce da un incontro di poesia, tenuto presso la scuola Molly Bloom nel 2017.
Poesia e perdita: quando abbiamo concordato il titolo di questo incontro ho pensato ai versi di Eliot, a Fleba il fenicio che dimentica il grido dei gabbiani, il gorgo profondo del mare e il guadagno e la perdita (the profit and the loss). Qual è stato il tuo impulso?
Dovendo tornare alla Molly Bloom, dove avevo già parlato di traduzione, ho ripensato al precedente incontro che avevo chiuso con le parole di Robert Frost: «What is poetry? What gets lost in translation». Un binomio micidiale, poesia e perdita. E non posso non pensare ad Amelia Rosselli, a quei terribili versi di Documento (1976) in cui l’albero sulla strada diventa rosso perché la base della lampada da tavolo si riflette nel vetro. Lampada per la quale l’io poetico non vuole ricordare il luogo e le circostanze dove fu acquistata, «perché anch’essi pesano». Già nella prima parte del componimento si parla di peso e perdita:
C’è come un dolore nella stanza, ed
è superato in parte: ma vince il peso
degli oggetti, il loro significare
peso e perdita.
La stanza invasa dal dolore e la finestra sono le stesse da cui vent’anni dopo Rosselli si sarebbe lasciata cadere, rendendo ancora più micidiale il binomio peso e perdita.
All’estremo opposto di Rosselli, Elizabeth Bishop, nella sua celebre L’arte di perdere tempera la disperazione per il suicidio di Lota de Macedo Soares, sua compagna per quindici anni, con l’ironia, prendendo il discorso alla lontana:
L’arte di perdere non è difficile da imparare;
così tante cose sembrano pervase dall’intenzione
di essere perdute, che la loro perdita non è un disastro.
E via con un elenco comprendente le case, l’orologio della madre, le chiavi, il tempo, un continente, due fiumi. Per concludere:
Ho perso persino te: la voce scherzosa, un gesto che ho amato.
Questa è la prova, evidente, che l’arte di perdere non è difficile da imparare,
benché possa sembrare un vero – scrivilo! – disastro.
Quindi la perdita primaria è quella della fiducia nella vita, nella possibilità di goderne come se fosse un perenne incanto, che è poi l’idea dominante che si ha della poesia. La poesia è invece il referto di una perdita?
Cerco di rispondere inquadrando il tema della perdita in un’ottica filosofica e filologica, partendo dalla distinzione di Wittgenstein tra «parole sane» e «parole malate»: parole che significano quello che c’è e parole che muoiono in quello che non c’è e che non è mai esistito. La distinzione dipende da ciò che le parole richiamano. Se richiamano troppo o non richiamano più nulla, esse si ammalano. Esemplifico con un passaggio dal mio dramma Personae appena pubblicato, in cui il personaggio Narzis ricorda come le parole nascano «traviate»:
concrete al tempo di gioghi e genitali,
muoiono in quello di coniugazioni e genitivi.
Ricordo anche agli allievi quanto sia concreto – contadino, terragno – il giogo, lo strumento di legno che “aggioga” due buoi, da cui i “coniugi”, destinati e restare per il resto dei loro giorni sotto lo stesso giogo. E come si proceda verso l’astrazione coniugando i verbi e definendo genitivo un caso.
Dunque le parole stesse, anziché consistere in un guadagno, marcano una perdita?
In un intervento che risale al 1967 Auden disse: «Siccome gli uomini sono sia individui sociali sia persone, necessitano di un codice e al tempo stesso di un linguaggio, l’uno e l’altro fatti di parole. Ma tra l’uso delle parole come segnali e l’uso delle parole come linguaggio personale c’è un abisso insormontabile». Poiché sono convinto che se non si prende coscienza di questo fatto, non si può capire il perché dell’esistenza di un’arte letteraria come la poesia – e soprattutto non se ne può comprendere la funzione – non mi resta che riflettere sull’opera del poeta che più di tutti ha coniugato il binomio poesia e perdita. Premesso che non c’è bisogno di essere linguisti per sapere che la congiunzione è un elemento fondamentale, forse addirittura l’elemento fondamentale della costruzione linguistica, come definire la scrittura di Emily Dickinson, dove le parti connettive nel migliore dei casi sono abbreviate e più frequentemente espunte? La “e”, congiunzione principe – ancora più pesante e significativa nell’and inglese – in Dickinson non compare. Al suo posto appaiono barre, separazioni, intervalli. È la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, non può essere la stessa cosa. Perché così barrato, intervallato, separato, il dettato dickinsoniano giunge al lettore in modo nervoso, isterico. Immediatamente si coglie un dato: quella poesia comunicherà sempre asprezza, ansietà, disagio.
C’è dunque un circolo che porta dal concreto della scrittura alla reazione emotiva, solitamente empatica del lettore. La perdita della congiunzione e dei nessi cos’altro implica sul piano dei significati relazionali? La nostra perdita riguarda solo chi scrive o anche chi legge, in qualche modo?
La lingua di Emily Dickinson è compressa, contratta, lacunare, perché procede from blank to blank. Proprio il procedimento da spazio bianco a spazio bianco la rende evanescente e infinitamente interpretabile, la rende unica. In pratica, con Dickinson, ci si trova quasi sempre ad avere a che fare con una mancanza “centrale”: una perdita. Da qui la necessità di ridurre le parole al minimo, di lasciare parlare gli spazi bianchi: appunto, i famosi blank, e le barre. Un procedimento sintetizzabile in due aggettivi tipicamente dickinsoniani: scant e slant. Il primo significa “secco”, “aspro”, il secondo “obliquo”: «Tell all the truth, but tell it slant», scriveva Emily, cerca di raccontare la verità, di dirla fino in fondo, ma dilla in modo obliquo, dilla “obliqua”. Se la dici chiaramente puoi offendere o uccidere. Come il sole a mezzogiorno, troppa luce può accecare, piuttosto che illuminare. In una notte di luna si vede meglio che non con il sole allo zenit. Ecco allora la necessità vitale dello slant, che potrebbe essere tradotto con la necessità di modulare il grido. Un’impresa ingaggiata da Emily con la forza della disperazione nei confronti della “parola”. Da qui la sua costante necessità di stordimento, di “estasi”. E di ricorso a un linguaggio ellittico. Dire la verità intera non si può, se non attraverso la narrazione di una serie di “estasi”. Emily Dickinson definisce questa serie di estasi “bollettini dell’immortalità”.
Perdita e distanza hanno a che fare solo con le persone, o con il compito stesso del poeta, ammesso che ce ne sia uno?
«My business is circumference»: ciò che mi concerne è la circonferenza, scrive Dickinson. Che cosa significa? Significa che io – poeta – miro al centro, bramo il centro, lo voglio raggiungere, colpire, trafiggere; il mio business è colmare questa distanza. Ma non posso farlo in altro modo se non continuando a spostarmi, scivolando sulla circonferenza, e da lì scagliando i miei dardi, i miei “strali”, verso il centro. Questi dardi, questi strali sono le millesettecento poesie che ci ha lasciato. Così, in questa poesia dickinsoniana della perdita, avviene che la particella più infinitesima («l’atomo opaco del male», scriveva Pascoli, che – se ci riflettiamo – è la vera Dickinson italiana), il punto infinitamente più piccolo, diventi un mito, un universo senza confini, tanto prossimo da poterlo toccare. E, per contro, può accadere che ciò che ci stava accanto, l’oggetto consueto, persino la persona cara, vengano proiettati a enorme distanza, tanto da non poterli più vedere né sfiorare. Dickinson è perfettamente consapevole dei limiti, delle insufficienze, della parola in genere e della parola poetica in particolare. E ne soffre perché la parola resta l’unico mezzo che ha a disposizione per mirare al centro. Certo, esiste la musica; magari – come scriveva John Keats – una «tuneless music», una musica senza suono, oppure la musica della natura, il ronzio dell’ape che – se estaticamente ascoltato – diviene più alto e armonioso della più complessa sinfonia. Ma Emily non è un musicista; Emily solo con le parole può “trattare”, quello è il suo business. E sempre nel timore per il Tempo che ci sfugge e ci impedisce di raggiungere il Centro da quella circonferenza su cui continuiamo a scivolare. Il Tempo irrimediabilmente passa, sulla Circonferenza si continua a scivolare. Ma forse non è il tempo che passa: siamo solo noi che passiamo; e forse siamo già al centro mentre crediamo di stare sulla circonferenza.
Veniamo infine all’altro tema su cui ti abbiamo sollecitato: la traduzione, di cui sei uno dei massimi esperti in Italia, non solo come traduttore (ad esempio dei Poeti romantici inglesi) e direttore della rivista “Testo a fronte”, ma anche come teorico. Cosa si perde nella traduzione?
Se siamo partiti dalla definizione di poesia di Robert Frost, possiamo citare ora quella di Josif Brodskij: «Poesia è traduzione. Traduzione di verità metafisiche in linguaggio terrestre». Esemplifico con una mia traduzione da un altro testo fondamentale di Dickinson, “To tell the Beauty would decrease”:
Raccontare la bellezza significa svilirla,
Definire l’incantesimo intaccarlo;
C’è un mare senza sillabe
Di cui bellezza e incanto sono segno.Con la volontà mi sforzo invano
Di ricreare la parola giusta,
Ma sempre poi me la rapiscono
Miniere di pensieri introspettivi…
Il mare senza sillabe è come la musica senza suono di Keats che citavi prima? I poeti romantici che hai tradotto nell’antologia uscita per Bompiani nel ’97 e poi ripubblicata negli Oscar nel 2005, come si confrontano col tema della perdita?
Riprendo proprio dalla citazione tratta dall’ Ode on a Grecian Urn di John Keats: «Heard melodies are sweet, but those unheard /Are sweeter»: se dolce è la melodia che s’ode, ancora più dolce è quella senza suono. I flauti sono incisi nel marmo: suoneranno per sempre la musica più dolce, così come i due amanti staranno per sempre sul punto di baciarsi e i rami degli alberi saranno per sempre fioriti. Aggiungo un riferimento all’altro grande romantico della seconda generazione, P.B. Shelley, che sintetizzò il concetto di perdita nell’imperativo Lift not the Painted Veil:
Non sollevare il velo dipinto:
Quelli che vivono lo chiamano vita,
Anche se mostra immagini irreali
E simula ciò che vorremmo credere
Con i colori sparsi a capriccio.
Dietro stanno in agguato i destini gemelli
Della Paura e della Speranza, a tessere
Le loro ombre sull’orrido mostruoso (…).
Gli allievi a questo punto vorranno sicuramente sapere come la perdita si sia fatta tema nella tua opera. Puoi leggerci qualche testo?
Posso citare un passaggio da Guerra – il libro è uscito nel 2005 – ricordando «le voci dei bambini / Separati dai padri / all’ingresso dei campi»:
[…] si può dire ciò che è bello
E ciò che è brutto
Si può dire anche ciò che è molto bello.
È il troppo brutto
Che non si riesce a dire
Perché esistono tutte le parole
Ma sono lunghe e finisce
Che assorbono
Dei pezzi di dolore.
Nei miei libri più recenti la perdita è l’indicibilità che rimane «lì sotto» (così in Jucci, del 2014); oppure ancora una volta storica, come «lo strappo sintattico» che restituisce «l’intraducibile» nella poesia tratta da La linea del cielo (Garzanti 2018), dedicata a Christine Koschel, poetessa e traduttrice nata a Breslavia nel 1936, attualmente a Roma.
L’autobus dei bambini morti
È quello che Christine Koschel
Vide a Berlino nel quarantacinque,
Alcuni ancora vivi, molti infanti
Tutti assolutamente soli
Abbandonati in una fuga dal nulla al nulla
Durante l’avanzata dei sovietici.
Da qui gli occhi per sempre
Che l’orrore hanno visto
Di Christine
Intraducibile se non
Nello strappo sintattico.
Le parole non esistono, dicevi prima, ma se mi consenti un gioco facile, da poeta sei addirittura diventato “paroliere”, di recente. Com’è successo?
Tutto parte da un testo che s’intitola “Perché so delle cose che so” (dalla raccolta I tre desideri, del 1984) e dice:
Perché so delle cose che so
E non ti posso spiegare
Perché non esistono tutte le parole
Ci sono solo le distanze e il tempo
Tra quello che io so
E tu dovrai
Si tratta di un testo (e un libro) che si chiudono così, senza punto o puntini di sospensione. Proprio a significare dickinsonianamente la perdita: recentemente la poesia è stata musicata e incisa dal cantautore romano Riccardo Sinigallia. Curiosa la storia: quando scrissi quella poesia, all’inizio degli anni Ottanta, la lessero due amici, Milo De Angelis e un giovanissimo Aldo Nove. Milo mi suggerì di togliere il «non», trasformando il terzo verso in «Perché esistono tutte le parole». Non lo feci, ma vent’anni dopo, nel testo di Guerra che ho citato poco fa, evidentemente recuperai il consiglio, se al quart’ultimo verso scrivo: «Perché esistono tutte le parole». Antonello (come si chiamava allora Aldo Nove) imparò a memoria quei versi, inventandosi una variante e con quella variante li citò trent’anni dopo a Riccardo Sinigallia, che se ne innamorò e volle musicarli. Così va il mondo, con la poesia e i suoi abitanti.
Testo tratto da: Franco Buffoni, Il triangolo immaginario (Secop Edizioni, 2021)
Diario della pandemia dall’Himachal Pradesh # 2
 di R. Umamaheshwari
di R. Umamaheshwari
R. Umamaheshwari è una storica e giornalista che vive in India. Ha pubblicato When Godavari Comes: People’s History of a River (Journeys in the Zone of the Dispossessed), Aakar Books, New Delhi, 2014; Reading History with the Tamil Jainas: A Study on Identity, Memory and Marginalisation, Springer, 2017 e From Possession to Freedom: The Journey of Nili-Nilakeci, Zubaan, New Delhi 2018. Un anno fa ha cominciato a scrivere un diario della pandemia dall’Himachal Pradesh che pubblichiamo a puntate. Qui la prima. Quella che segue è la seconda.
18 marzo, un morso di cane, il vaccino antirabbico e qualche consapevolezza.
Quella sera, in un villaggio particolarmente bello, dentro una casa nei pressi di un ruscello gorgogliante, il cane addomesticato della famiglia mi morse il dito del pollice all’improvviso. Il tranquillo villaggio dell’Himachal Pradesh ha bellezze in abbondanza, ma in situazioni di emergenza, non c’è nessun medico, ad eccezione di un RMP, ovverosia un Registered medical practitioner, iscritto all’albo dei medici, che gestisce anche una farmacia, a sei chilometri di distanza. Anche lui non aveva il vaccino antirabbico. Mi informò che il vaccino scarseggiava da mesi. Beninteso, tutti i centri sanitari pubblici dovrebbero tenere scorte di questo vaccino, specialmente in uno Stato famoso per i molti casi di morsi di scimmia (e anche di cane, una volta ogni tanto…). Persino il più vicino ospedale governativo (Theog), qualche chilometro più lontano, non aveva scorte.
Frattanto si cominciava a riferire di uno o due casi sospetti di Coronavirus a Himachal, negli ultimi giorni. Il coronavirus era ancora un evento lontano. Eppure lo Stato aveva allestito due reparti di isolamento per i malati affetti da Coronavirus, a Shimla (presso l’ospedale IGMC) e a Tanda. Ho fatto un’antitetanica dal farmacista, e dopo cena la famiglia mi ha accompagnato fino a Shimla, all’IGMC, a oltre due ore di macchina.
Anche quando arrivammo, alle dieci e mezza di sera, l’ospedale era affollato, e ci è voluto un bel po’ prima che il molto loquace dottore, un medico dell’esercito in pensione, che ora, ci disse, lavorava part-time qui, prescrivesse le iniezioni; la registrazione e l’iniezione sono state gratuite. E finalmente alle 23.30 la vaccinazione era giunta a termine.
Mi sono resa conto di cosa significhi per le persone che provengono da villaggi lontani venire a Shimla (con i mezzi pubblici, o, in situazioni di emergenza, in mancanza di ambulanze, noleggiando mezzi privati) e cosa significava per il personale sanitario qui presente gestire (molto bene) quel numero esorbitante di malati e feriti che arrivano in continuazione, cosicché alcuni devono aspettare nei lunghi corridoi fino a quando non è possibile predisporre alla bell’e meglio, con risorse e spazio limitati, un letto per il paziente. Una sezione separata di isolamento era stata rapidamente preparata in questo ospedale (lontano dai reparti destinati agli infortuni, dagli ambulatori e dal Pronto Soccorso), ma la gente sembrava ansiosa, e alcuni indossavano delle mascherine. Anche a me questo ha fatto paura.
Ma anche in mezzo a tutto quel caos, a notte fonda, trovai l’infermiera più gentile che avessi incontrato da molto tempo; una donna che si premurò di scusarsi con me per il dolore straziante che mi aveva provocato, facendomi piangere, quando aveva iniettato il siero nella ferita. Avrei completato le restanti iniezioni in un altro ospedale governativo, nei successivi cinque giorni. Gratis. Questo è l’ospedale pubblico, dove la maggioranza della gente riceve un trattamento gratuito o comunque sovvenzionato, ma che è trattato come un cugino povero degli ospedali privati super specialistici dell’India.
Prima di poter trovare una casa in cui vivere, l’isolamento è sceso sulla nazione. A volte sono grata a quel cane, Tukki, perché adesso ho l’occasione di vedere e osservare il mondo da questo mio punto di vista, relativamente vulnerabile, che altrimenti non sarebbe esistito per me, benché ancora mi rammarichi della punizione piuttosto dura che gli fu inferta per la sua bravata. Invano quella notte avevo chiesto che lo perdonassero. Ma in futuro, in tempi “normali”, spero di incontrare di nuovo il suo sé un po’ più calmo…
22 marzo 2020. Prime riflessioni su un virus.
Un profondo silenzio mi avvolge qui a Shimla. Le orde invasate dei soliti chiassosi turisti – alla ricerca del consumo a tutti i costi di ciò che deve essere consumato, secondo le indicazioni delle guide turistiche o dei blog di viaggio – non sono più la “normalità”, in quest’inizio della bella stagione. Alcune delle nazioni che vantavano una storia di successo fondata sull’economia di mercato, la privatizzazione dell’assistenza medica e il “turismo sanitario”, sembrano ora fare un passo indietro, e dichiarano, pur con scarsi risultati, di voler mettere in atto un piano di intervento medico statale. Un presidente come Donald Trump parla del sussidio di disoccupazione, e ad alcuni questo fa venire in mente le imminenti elezioni negli Stati Uniti alla fine di quest’anno.
Il mondo oggi sembra comprendere che un’equa assistenza sanitaria statale è una necessità inevitabile. Il mondo, o la maggior parte di esso, sta combattendo una guerra senza armi di distruzione, ma al contrario con strumenti che salvano vite umane. In un contesto di rigida religiosità e di religioni strutturate, che in tutto il mondo ha avuto una tradizione storica secolare, oggi troviamo quasi tutti i luoghi di culto chiusi e i rituali comunitari abbandonati, in un consenso mondiale senza precedenti. Chiusi anche i supermercati e i centri commerciali, per la maggior parte del tempo. Invece delle folli corse per raggiungere qualche posto o ritornarne, ventiquattr’ore su ventiquattro, con la polvere e la sporcizia che hanno avviluppato le nostre città metropolitane, ora sperimentiamo i silenzi e il minimalismo e la qualità di un’aria più pulita. Per molti oggi lo spazio più sicuro sembra essere ‘casa’: non importa quanti non possano ancora assaporare ciò che la ‘casa’ veramente è o dovrebbe significare, o che ‘casa’ dovrebbe significare qualcosa di diverso dalle immagini stereotipate di ‘famiglia’ (quasi sempre sorridente, felice) dentro mura di mattoni, isolata dal resto delle cose che ci circondano. In alcuni casi, come è stato più volte rilevato, le case non sono davvero quegli spazi sicuri e felici per donne, anziani e bambini.
Il “distanziamento sociale” – non uno dei momenti più gravi della storia indiana, a paragone del concetto di casta (ma si potrebbe dire lo stesso per il concetto di razza, e per altri tipi di discriminazione) – è diventato un comportamento “normale” e virtuoso: la cosa da fare, anzi.
Le proteste e il dissenso si sono quasi fermati: un vantaggio per tutti i governi del mondo, che in passato hanno dovuto affrontarli, affrontare le proteste divampate contro l’ingiustizia e l’oppressione, nei rispettivi Paesi, fino a questo momento storico. Per la prima volta dopo tanto tempo, le zone di crisi non sono la Siria o il Libano o la Palestina, o qualsiasi altra area di frizione geopolitica, ma territori usurpati da un virus. Di ritorno a casa, non sentiamo più parlare del CAA (Citizenship Amendment Act), di questioni di casta o di genere, di discorsi sulle migrazioni; persino i problemi economici non sembrano al momento così gravi o visibili. Gli Stati liberi stanno cercando di mantenere il controllo in molti modi. Si può dire che questo ha posto fine ai nazionalismi insulari a favore di un’alleanza globale, che combatte unita una malattia che colpisce la “specie” umana? Oppure l’epidemia ha aumentato gli ultranazionalismi, come se ad ognuno andasse bene anche che solo la propria nazione fosse risparmiata dalla malattia? E questo anche se i viaggi internazionali sono stati parte integrante del nostro mondo, e l’economia è multinazionale e globale, e non soltanto locale?
Un virus, la cui origine opinabile e discutibile si presta a disquisizioni di geopolitica e multinazionalismo, e a illazioni sulla guerra biologica; un virus che ha fatto di tutto: ha mosso nazioni grandi e piccole, simultaneamente. Eppure…
Il nazionalismo culturale e il razzismo non sono scomparsi, anzi, sono apparsi più frequentemente sui social media, come mai prima d’ora. Questo virus ha avuto il potere di costruire cameratismo e abbattere muri di rigidi nazionalismi, ma lo ha fatto davvero? Questo virus ha avuto il potere di ribadire i principi basilari del concetto di “specie” (in senso puramente scientifico), invitandoci a ripensare l’uomo come Homo sapiens, al di fuori del paradigma Stato-nazione. E ha ribadito come questa specie, in conseguenza della sua stessa intelligenza o del suo agire, continua a rendersi di tempo in tempo vulnerabile agli agenti patogeni. In un senso sociologico, il virus ci fa considerare la possibilità di guardare alle società umane nel loro insieme (naturalmente, in contesti culturali diversi, eppure, all’interno di quei contesti culturali molto diversi, con un’uguale insicurezza di fronte al virus, forse?), e di metterle a confronto nel loro complesso con altre società non umane. Eppure, sarà importante guardare al contesto sociale, culturale e politico in rapporto a questo virus: chiedersi chi è più vulnerabile, perché, e chi soccombe. O forse chi muore soccombe da solo, o a causa di altre variabili di cui non ci stiamo ancora occupando. Benché “co-morbilità” sia un termine che si sta diffondendo, negli ultimi giorni.
Oltre che per indicare cause mediche di morte tra loro concorrenti, infatti, mi chiedo se il termine “comorbilità” non possa essere visto anche in relazione a un contesto sociale o economico, in riferimento a persone che sono morte apparentemente a causa di questo virus. Per esempio, una concausa di morte, per alcuni, potrebbe essere la difficoltà di un accesso tempestivo ai servizi medici.
C’è anche una certa connotazione morale nel riferirsi al virus: il “demone”, il “cattivo”. Alla radio (All India Radio), nei giorni precedenti al primo lockdown, si parlava di un coprifuoco Janata (un coprifuoco della popolazione, anche se imposto dallo Stato), e abbiamo sentito messaggi che invitavano la gente a suonare le conchiglie, e le campane, ecc. alle 17.00 (il 22 marzo), in modo che le vibrazioni delle conchiglie e l’energia positiva cacciassero il virus demoniaco dal nostro paese. Messaggi che, naturalmente, non si sono più sentiti in seguito.
Un’altra caratteristica fondamentale di questo virus è associata ai viaggi, o al movimento: interregionale, internazionale, ecc. Le società umane e le idee hanno sempre viaggiato ‘attraverso’, ‘a’, ‘da’, ‘per’, ‘avanti’ e ‘indietro’. Attraverso il viaggio, culture, idee, e persino cucine, hanno viaggiato. E quel viaggio è stata una parte accettata della storia umana. Anche gli uccelli viaggiano, e senza polizia, e finora, per fortuna, sono stati accettati come visitatori graditi in luoghi dove costruiscono temporaneamente i loro nidi. Anche le creature nei mari e negli oceani viaggiano, ignari dell’idea di acque territoriali e controlli di polizia. Ma in questo momento, tornando all’ “umano” (culturale, o politico, o scientifico), come si presentano le conseguenze di questo virus? Ci costringeranno a porre confini e frontiere dove prima non esistevano (se e dove non esistevano già…)? Metteranno fine alla possibilità di una visita casuale di un amico a un altro amico, che non susciti domande o sospetti?
Per inciso, alla ricerca di una casa, l’anno scorso, in alcune “colonie recintate” di Hyderabad, ho trovato dei residenti costretti dai gestori dei complessi abitativi a scaricare un’applicazione sui loro telefoni e ad invitare a farlo anche i loro visitatori (che ovviamente dovrebbero essere quelli abituali, e non un amico che non si sente da tempo, o un parente che arriva improvvisamente a casa tua), per non parlare del giornalaio, del postino, ecc., al fine di un tracciamento all’ingresso di queste sacre colonie. Queste applicazioni diventeranno la nuova normalità? La vita sembrerà piuttosto pericolosa se ciò succederà davvero. La Cina, come riferito da un canale televisivo internazionale, è stata la prima a sviluppare un’applicazione che decideva, sulla base di alcuni algoritmi, se una persona era positiva al Coronavirus o no, e solo se il segnale era verde (indizio di negatività) si aveva il permesso di entrare in casa sua. A quanto pare, ci sono stati dei malfunzionamenti e presto l’applicazione è stata sospesa. Quanto è pericolosa la possibilità di esclusione basata su meri algoritmi progettati da uomini in laboratori tecnologici? Ci sarà un nuovo quadro legislativo per dirimere le questioni e sanare le ingiustizie derivanti da questi dispositivi e dal loro possibile malfunzionamento? Un’azienda potrebbe ad esempio essere citata in giudizio per aver causato un trauma fisico e mentale a causa del cattivo funzionamento della sua applicazione? E queste applicazioni non potrebbero essere state progettate anche per secondi fini? Perché accettarle tout court senza distinguo o domande?
Il potere di gran lunga più pericoloso di questo virus è questo: accettare come “assoluto” o “vero” ciò che vediamo e sentiamo sui vari media o i numeri delle statistiche governative, senza alcuna possibilità di accedere ad indicatori alternativi o strumenti di verifica di queste verità, o per lo meno strumenti di ricerca e di analisi della loro veridicità, sia che si tratti di ‘verità’ su un particolare tipo di test, su un dispositivo, o semplicemente sul numero di casi in ogni stato o distretto.
Da un lato, il virus può confinare, e creare confinamenti; ma allo stesso tempo può far sì che il confinamento stesso sembri di per sé “sano” e “sicuro”, mentre la natura di tale “sicurezza” finisce in realtà per distanziare le comunità umane tra loro (al loro interno, fra regione e regione, tra Stato e Stato e nei rapporti internazionali) e, quindi, rendere più semplice e in un modo più insidioso di prima, la nascita di nuovi totalitarismi.
Nel frattempo, questo virus ha il potere di imbrigliare il profitto sfrenato tanto nel campo delle multinazionali farmaceutiche quanto in quello delle prestazioni mediche, così da rendere le une e le altre più umane, e regolate da una sorta di patto internazionale fondato su un uguale accesso, per tutti e in tutto il mondo, a strutture mediche sofisticate per salvare vite umane?
Solo il tempo lo dirà. In India, alcuni laboratori e ospedali privati sono già stati autorizzati a procedere con i test e le terapie anti Covid. Ma ancora una volta, sapremo nei prossimi giorni quanto siano stati accessibili questi enti privati per i poveri e le persone svantaggiate, e quanto “corretti” (e quindi trasparenti e regolamentati) siano i loro parametri di prova e i loro indicatori di trattamento.
Per ora, molte cose sono state messe insieme in grande fretta per contenere il contagio, ed ecco perché ci occorrerà, nel prossimo futuro, un saldo quadro giuridico utile a prevenire eventuali pratiche illecite cui, anche in tempi normali, è risaputo che il settore medico privato ha già ampiamente fatto ricorso, almeno a giudicare dal gran numero di cause legali intentate dai pazienti e dalle loro famiglie agli ospedali privati in India. Inoltre, ci sono voluti anni di indagini per svelare la politica delle case farmaceutiche in tutto il mondo e la natura dei loro affari legati ai prezzi di farmaci salvavita essenziali nelle cosiddette economie in via di sviluppo. Nel caso si trovasse, com’è possibile, un nuovo vaccino per il Coronavirus, o, a seconda dei casi, un farmaco, stiamo pensando a nuovi e rigorosi quadri giuridici multilaterali che garantiscano un accesso equo e sovvenzionato al nuovo vaccino o al nuovo farmaco, quando sarà svelato? Questo virus cambierà la natura del commercio farmaceutico internazionale (rendendolo più equo) o lo renderà più competitivo e segreto?
Cos’altro ha fatto questo virus? Ci ha mostrato, o ci ha fatto vedere, più chiaramente, alcune verità fondamentali: le cose che possiamo o non possiamo controllare; il tempo in cui realizzare ciò che ancora non possediamo. Questa conoscenza non può essere ciò che già conosciamo: verità che apparentemente non cambieranno per secoli. Non esistono sistemi e verità antiche che funzioneranno per sempre. Dobbiamo accettare il nuovo (anche se ciò significa accettare nuovi modi di affrontare una pandemia); e il nuovo richiede, se necessario, modifiche e aggiustamenti del vecchio che possano includere nuove idee politiche, religiose o economiche. Può il modello economico, finora considerato come il modello da emulare (un modello iniquo, basato sul consumo, e pericoloso per l’ambiente), avere contribuito alle modalità di diffusione di questo virus? Dobbiamo almeno provare a capirlo. Non è un caso che il maggior numero di positivi al Coronavirus, in India, provenga dalle grandi aree urbane che si sono sviluppate in modo disordinato e dalle zone industriali, e da quei luoghi che hanno un indice globale di viaggi e spostamenti piuttosto importante, almeno in base a quanto indicato dalle statistiche attuali.
Resta da vedere se il nuovo virus aprirà nuove idee di umanità ed umanesimo, o creerà muri e spazi di autosegregazione intorno a ciascuno di noi. Un aspetto che il virus ha reso più evidente è l’iconografia dei nostri tempi: medici, infermieri e addetti alle pulizie completamente avviluppati in protezioni e mascherine, in particolare quelli che lavorano per il governo, o in aziende statali e strutture sanitarie. Nel contesto indiano, sappiamo già quanto questa gente si sia ammazzata di lavoro, e in condizioni di certo non invidiabili. Il numero di persone povere che affollano gli ospedali pubblici in India è davvero ingestibile.
Molti di questi operatori affrontano anche la brutalità e la violenza della gente, in caso di diagnosi errata o di morte del paziente. Eppure, in un tempo come questo, sono questi ospedali che diventano gli spazi più affidabili per le cure e l’assistenza, anche rispetto agli ospedali privati. Ci si rende conto, adesso, della necessità e dell’importanza della gestione pubblica dei sistemi sanitari (e di quanto sia importante non privatizzarli, anche parzialmente, anche se in alcuni Stati dell’India sono stati compiuti passi significativi in tal senso), e persino dell’utilità di espandere queste strutture, di fornire loro infrastrutture che funzionino bene durante le crisi, in modo da essere preparati con largo anticipo, piuttosto che apportare modifiche ad hoc incalzati dall’emergenza. Solo il tempo ci dirà se, quando un antidoto al nuovo virus arriverà, saranno gli ospedali privati che se ne impadroniranno, o la sua somministrazione sarà strettamente regolamentata e gestita solo tramite gli ospedali pubblici, in ambienti consoni e nel rispetto della dignità di tutti i pazienti. Il caso dell’Italia deve essere uno dei più difficili da affrontare per gli operatori sanitari, nel momento in cui, nonostante tutto, la morte sembra vincere ogni volta, e i cadaveri devono essere accatastati. Ciò che all’inizio deve essere iniziato come un normale esercizio di somministrazione quotidiana di farmaci e di calcolo di dosaggi, deve essere presto diventato un incubo in cui la monotona routine degli ospedali ha lasciato il posto ad una situazione drammatica, in cui i medici sembravano guardare impotenti ciò che accadeva sotto i loro occhi, e sono diventati, quasi, gentili amministratori della morte stessa. In effetti è stato solo quando l’Italia ha attraversato questo disastro che il mondo ha cominciato a prendere una maggiore consapevolezza di ciò che stava per accadere. Ci si chiedeva del trauma emotivo, affrontato dagli operatori sanitari in momenti come questi. Cosa dire dei Paesi con un numero limitato di operatori sanitari, ed in cui viene loro fornito un sostegno economico o politico inadeguato?
Cos’altro ha fatto questo virus? Per la prima volta nella storia indiana post-indipendenza, ha portato ad un brusco arresto dei treni passeggeri. Questa era la rete ferroviaria che, a fine marzo 2017, aveva trasportato più di 8 milioni di passeggeri, percorrendo un totale di 141,7 milioni di chilometri. Le ferrovie indiane, per inciso, hanno 7.349 stazioni ferroviarie, sparse per tutto il paese.
Stranamente, i servizi che il governo indiano in carica ha cercato di privatizzare (parzialmente o totalmente) – le ferrovie e la compagnia aerea nazionale, Air India – si sono rivelati i più utili in una crisi come quella attuale. I servizi ferroviari hanno continuato a trasportare merci essenziali, e la compagnia aerea nazionale ha lavorato anch’essa senza sosta per il trasporto di beni di prima necessità, comprese le forniture mediche, e ha persino riportato indietro diversi Indiani bloccati negli aeroporti di altri paesi del mondo.
Dal punto di vista economico, questa pandemia sta colpendo e colpirà per un lungo periodo la maggior parte della forza lavoro non organizzata e indipendente o freelance in India. Mentre quelli che svolgono lavori governativi – e questo include anche gli accademici che lavorano nelle università pubbliche federali o statali, oltre che nei college e nelle scuole pubbliche in tutto il paese – non sono altrettanto duramente colpiti, perché i loro stipendi sono protetti, e attualmente la maggior parte di loro è a casa. Sicuramente il virus ha colpito molto duramente coloro che non entrano nelle statistiche del governo. Un numero che comprende, fra gli altri, oltre ai lavoratori freelance (tra cui forse molti che fanno lavori ad hoc basati su contratti e consulenze, così come giornalisti non accreditati o stranieri, nei villaggi), artisti non ‘all’avanguardia’, i proprietari di quei minuscoli locali di cibo da strada, i venditori ambulanti di ogni tipo di merce, che di solito si vedono per le vie, in vari quartieri delle città.
Mentre in questo momento molti hanno perso il lavoro o non si aspettano di trovarlo, e altri hanno dovuto chiudere i negozi, nessuno può dire se e quando il periodo di isolamento finirà. E fino ad oggi non esiste un pacchetto di aiuti pubblici a lungo termine, ben pensato, né alcun meccanismo di facilitazione per una così grande forza lavoro informale.
Forse dovrei aggiungere qui come mi vedo in questa situazione. Perché la mia situazione, allo stesso modo, è intrinsecamente legata alla natura dell’economia che mi riguarda sia come donna single, e che vive da sola, sia come donna che non ha un lavoro regolare, regolarmente retribuito. E rivado ai tempi in cui si correva costantemente come un topo su un tapis roulant, per pagare la rata mensile di un mutuo per la casa. Non c’è mai stato un periodo di tregua. Durante la crisi economica le persone perdono la loro casa o finiscono per avere un rating di credito negativo. In tutto il mondo, questo ricorda la recessione economica globale del 2008.
Adesso la Reserve Bank of India sembra aver annunciato alcune misure, abbassando i tassi di interesse e riducendo così l’onere per la classe media nel rimborso dei mutui per la casa. Ma si sa che l’industria del debito non cancella mai i prestiti della gente comune, e questo significa anche un aumento della durata del mutuo per la casa. Inoltre significa che, ad un certo punto, quando le cose torneranno ad un nuovo tipo di “normalità”, i mutui per la casa diventeranno più cari e saranno di fatto aumentati di quel tanto necessario a salvare le banche, e non certo la classe media, la gente comune.
Il virus ha viaggiato in lungo e in largo sulle spalle di viaggiatori compulsivi: celebri oratori, uomini d’affari, artisti giramondo, vacanzieri di routine e altri (non invece sulle spalle degli strati economici inferiori della società, dato che il virus viaggiava essenzialmente sugli aerei), e ognuno aggiungeva le sue impronte di carbonio. Almeno qualcuna di queste persone oggi può fregiarsi di nuovi ‘distintivi’: essere positivo al Coronavirus o, almeno fino al blocco dei viaggi in aereo e di quelli in treno, di essere stato un potenziale portatore del virus.
Alcuni di loro, purtroppo, hanno dovuto affrontare il peso del pregiudizio, come anche l’intoccabilità. In quel momento i loro progetti di business, le loro idee, o semplicemente i viaggi di piacere (a meno che, naturalmente, alcuni di loro non abbiano viaggiato per partecipare a emergenze), non contavano tanto quanto l’essere portatori di un contagio di cui sono stati a volte accusati. Il pregiudizio sarebbe stata l’ultima cosa che si sarebbero aspettati di meritare all’arrivo in questo paese, mentre, al contrario, la gente ha cominciato a guardarli con sospetto e a dare la colpa di tutti i mali (come si fa regolarmente qui) alla persona che è tornata da fuori, o allo straniero: insomma, l’altro che “entrava” (altrimenti detto, ‘il turista’), e che fino ad oggi era di solito blandito e accolto a braccia aperte, a causa del denaro che lei o lui o il gruppo portava con sé; il virus, che viaggiava in lungo e in largo, senza alcuna distinzione di razza o cultura e senza alcun pregiudizio proprio, invece di riunire l’umanità contro le malattie, ha ribadito in alcuni paesi l’opposizione del “locale” versus lo “straniero”, l’ “altro”. Un virus ha fatto tutto! Ci vorrà un po’ di tempo, tuttavia, prima di ottenere un quadro completo, da fonti varie e affidabili, dell’esatta distribuzione sociale, demografica e geografica della popolazione colpita in tutto il mondo, e delle sue ragioni. L’ultima parola sul virus non è ancora stata detta.
Il vantaggio (che può anche essere uno svantaggio) di questo servizio della radio nazionale è ottenere l’accesso ai dati ufficiali sulla situazione quotidiana, e alle comunicazioni del governo sugli interventi medici e le strategie di contenimento. In assenza di canali televisivi di informazione, si tratta di un pacchetto di dati fondamentale per dare un senso alle cose, nel modo in cui si desidera; e tenendo presente che, dopo tutto, in fin dei conti, si tratta dello Stato, che ti fornisce le informazioni che ritiene necessario condividere. Per la maggior parte dell’India rurale, le notizie della radio sono l’unico modo per avere il polso della situazione del Paese, oltre che il mezzo cui affidarsi per le previsioni del tempo e, di solito per le comunità di pescatori, per gli allarmi di tempeste, cicloni e così via.
(traduzione di Rosario G. Scalia, foto di R. Umamaheshwari)
Dante in love
Se mi chiedessero di far tornare Dante da qualche parte su questa terra, mi piacerebbe fosse in Liguria, il luogo preciso non importa, ma basterebbe uno degli scorci nominati da lui.
“Tra Lerici e Turbia, la più diserta
la più romita via è una scala
verso di quella agevole ed aperta”.
È quando si ferma davanti alla montagna del Purgatorio, lo accompagna Virgilio. Farlo giungere in terra ligure a vedere le opere che ha ispirato, gli affreschi che rappresentano la bolgia infernale, con Ugolino che rode il cranio, nella chiesa di San Giorgio a Campochiesa di Albenga, o a Noli, dove Dante passò da esule. Insomma, un po’ immaginai questo, quando seppi che Giuseppe Conte, ligure come me, di Dante ne raccontava il ritorno. Ma non sarebbe andato bene per nulla, e non perché Conte non condivide la mia ossessione di ficcare la Liguria in ogni narrazione (ha decisamente un respiro ben più universale di quello dei miei microcosmi), ma perché far tornare Dante in un luogo che non sia Firenze sarebbe un nostos amputato.
Dante in love (Giunti, 2020) ha dunque la sua geografia perfetta e la sua avventura: chiedere al Sommo Poeta un percorso inverso, nessuna risalita dello scalone dalle fiamme alle azzurrità, ma la calata in una Firenze quando “Il sole è appena sceso dietro i tetti, le cupole, le torri della città. Come ogni volta. Il buio non è ancora fitto. Guarda, dilaga nell’aria tra le vie e le case come un’acqua cupa.”
Abituati così alla piena notte, o all’alba, al pieno giorno e al tramonto, non ci stupiamo mai abbastanza di un tempo poco frequentato dalle nostre narrazioni: oltre il tramonto, quando il buio non è ancora fitto, e c’è la pienezza della sera. Chissà perché piena sera non si dice mai. Forse è davvero il miglior tempo di Firenze quello che sceglie Conte, le immagini di una città trasformata nel tempo stesso, e l’esercizio, le capacità che ha l’ombra di assumere l’insolita luce lambita da nuovi ritagli, da nuovi segmenti, nella processione di improbabili andirivieni creati dal caso, e poi la mineralità del Battistero, i palazzi nobili, i semplici cornicioni, i tetti. Il passaggio davanti all’ombra di Dante di un’umanità, e tra essa quella della presenza che più lo emoziona, lo attrae, la donna.
Il romanzo racconta il motivo per cui ogni anno, da seicentonovantanove anni, a Dante è concessa la discesa, con le sue regole d’ingaggio, a Firenze. Dante è lui, l’esule e l’esiliato, ossia quel sentirsi qualcosa o il sentirselo addosso come una pelle. Libertà e costrizione. Anche se la più felice, quella che l’autore giustamente non scopre, come se toccasse al lettore la necessità di intuirla nelle ombre della notte, e prima ancora, in quella sera non ancora notte, è la figura del clandestino. Dante sa di esserlo e riesce a sopportarlo, è l’altro e nessuno lo saprà mai, anzi nessuno dovrà mai saperlo. Ma poi le regole d’ingaggio saltano, un amore, anche quello, sognato e immenso perché invisibile, lo mette in viaggio, attraverso il percorso orizzontale della città, e assieme a tutto questo torna prepotente il pensiero della sua donna amata, dell’amico caro, e la visione di questa città oscura, sicuramente non felice, in questi giorni…
Insomma, potrebbe essere una delle seicentonovantanove notti “guardate” quaggiù finora, destinata a finire all’alba. Ma stavolta Dante non ci sta, è come se stavolta glielo chiedesse il suo cuore clandestino, esule e trasparente, di trasgredire alla concessione del cielo. E allora, davanti alla possibilità, per concessione celeste, di esercitare la sua solita ginnastica dell’occhio, egli stavolta sceglie altro, il miracolo, si lascia trasportare dal desiderio, attraverso la città impaurita e mascherata. La meravigliosa trasgressione ha persino un nome, si chiama Grace. Non ci saranno colpe. Solo poesia. È il libro che condensa ed esalta le anime narrative di Giuseppe Conte, il romanzo storico, quello in qualche modo fantascientifico, e persino l’esistenziale, nutrendosi di mito.
Appunti al tempo del Covid 19
di Camilla Albini Bravo
Consigli per la lettura
Le pagine che seguono sono solo in apparenza una sequenza di 18 articoli, in realtà sono 18 voci soliste di un unico coro, essendo il risultato di un lavoro di aiuto reciproco che ha coinvolto una sessantina di colleghi, divisi in sei gruppi clinici, che si sono incontrati via Skype durante il difficile periodo del lockdown. Alle voci soliste va aggiunto il coro muto di quelli che non hanno scritto, ma che ci hanno aiutato a pensare. Ringrazio tutti, indistintamente, per l’aiuto reciproco, per la fiducia nella possibilità di sostenerci a vicenda, per la testimonianza che è il rapporto, sempre, che ci salva. Nessuno scritto ha la pretesa di teorizzare, il nostro intento era ed è quello di fissare i punti di un discorso che parte ora e cerca interlocutori. Buona lettura.

Giugno 2020
Da quasi due mesi il nostro lavoro di psicoterapeuti ha dovuto confrontarsi con delle limitazioni e dei cambiamenti che, all’inizio, sembravano solo formali. Ci siamo trovati, tutti, soli nello studio con un computer davanti, o un cellulare, nel tentativo di continuare, a distanza, un lavoro che prima avveniva in vicinanza.
Abbiamo sentito tutti l’urgenza di un confronto fra colleghi per capire quali potevano essere le implicazioni di un tale cambiamento. Le riflessioni che ci proponiamo qui di condividere sono emerse dal dialogo tra colleghi e sono in fieri, ma ci sembra opportuno o addirittura necessario fermarle in uno scritto.
La prima attenzione, ovviamente, si è soffermata sul mezzo di comunicazione, che ci è apparso subito paradossale: la chiamata in video-conferenza testimonia la nostra vicinanza e la nostra distanza. I volti in primo piano sono fin troppo vicini, gli spazi privati delle case dei nostri pazienti quasi violati, la distanza è nell’assenza dei nostri corpi che condividevano prima la stessa stanza. Sono i confini ad essere diventati fluttuanti, troppo vicini e troppo lontani e abitati dalla inquietante sensazione di poterci perdere nella lontananza e di poterci infettare nella vicinanza. Il mondo stesso, il nostro oggetto, sembra essere diventato molto ambiguo e collocato in uno spazio-tempo quasi indifferenziato. Le giornate non sono più scandite dall’uscire e l’entrare per il lavoro o la scuola, sembrano scivolare fuori dal tempo lineare in un tempo circolare in cui è difficile distinguere ieri, oggi e domani.
Un giovane ragazzo che in questa emergenza ha dovuto sospendere la frequenza della scuola e il confronto con i suoi compagni, descrive perfettamente la dimensione esistenziale in cui scivoliamo quando perdiamo il mondo e la misura che lo stesso ci sa dare. Dice infatti: “Il tempo in questo periodo mi sembra non scorrere, mi sembra di stare sempre nella stessa giornata (…) prima lo scorrere del tempo mi faceva pensare al futuro, ora è come essere in una bolla, è strano, vedere sempre le stesse persone mi dà la sensazione di essere fermo. Nel contatto con gli altri potevo vedere i miei miglioramenti. Ora non li posso verificare”.
Ma il mondo rimane là fuori e noi, uscendo dotati di mascherina e guanti, non riusciamo più a capire chi sia pericoloso per chi. Siamo noi che possiamo infettare gli altri o gli altri noi? Il mondo quindi si è trasformato in un oggetto ambiguo, abitato da un fantasma tremendo di morte e di malattia portata da un virus sconosciuto e non visibile che può essere in noi o negli altri e che induce in un’angoscia abbandonica ma anche persecutoria. Se ci isoliamo la seconda si attenua, ma la prima si alza a dei livelli insopportabili. Siamo soli e desideriamo un contatto che ci atterrisce e ci ricaccia nella solitudine.
L’oggetto ambiguo, il fantasma di pericolosità reciproca, l’angoscia di morte, sia per vicinanza che per lontananza, sembrano riportarci a una relazione con l’altro quando il nostro Io, ancora incapace di definirsi in uno spazio e in un tempo, non era ancora in grado di decodificare l’altro nel suo essere a tratti buono e a tratti cattivo e quindi siamo costretti, noi adulti, a immergerci in quelli stati originari del nostro essere dove le angosce erano senza nome, senza fine e senza tempo.
Da lì, da questi spazi in cui l’Io è costretto a immaginarsi, escono angosce e paure per ognuno diverse e pensate ormai lontane e un Io adulto che si credeva sufficientemente collocato nello spazio e nel tempo, si trova a confrontarsi con antiche paure spesso indicibili che prendono forma in lunghi sogni spaventosi.
Per quanto individuale sia la storia di ognuno di noi, comune nei nostri sogni è l’immagine ricorrente di allagamenti, di contatti perduti, di confusione. Un sogno di una collega sembra perfettamente rappresentare la pericolosità della situazione che stiamo vivendo e può essere utile accoglierlo come un tempo si accoglieva il sogno di un singolo come visione utile al gruppo. Per questo ringrazio la collega che lo ha sognato e raccontato perché diventasse prezioso per tutti.
Nel sogno si trovava con altre persone a nuotare in una pozza di acqua terrosa, anzi era proprio fango, acqua e terra così mescolate da non distinguerle. Allora, alzando gli occhi al cielo, lei lo vide della stessa sostanza e sentì, con terrore, che stava per collassare giù.
Ci ha fatto pensare, questo sogno, a come viene descritta l’origine del creato: prima il caos, lo spalancarsi, poi le acque si separano dalla terra, il cielo si differenzia e si alza. Il nostro esistere ha assoluto bisogno di questo doppio movimento che installa tre livelli del nostro essere nel mondo.
Dalla nostra liquidità, abitata dalla mescolanza, dalle ondate emotive, dall’assenza di spazi definiti emerge la terraferma, luogo dove poggiare saldamente i piedi, solida madre terra, corpo asciutto delimitato e distinto che ci permetta di avere un davanti, un dietro, un prima, un dopo, un orizzonte finito. Ma un terzo elemento necessario sarà una cesura fondamentale: il cielo e la terra si devono staccare. Se la madre terra, la nostra possibilità di sentirci un corpo, orientato nello spazio e nel tempo sono necessari, ancor più necessario sarà per noi umani l’elevarsi del cielo. Solo la visione dall’alto infatti ci permette di cogliere l’intero orizzonte, di dare un senso e un significato al nostro esistere, di vivere come individui e di pensare la nostra vita.
Nessuno di noi è in grado di accettare una vita senza darle un senso. Ce lo ricorda l’Ulisse dantesco quando incita i compagni verso la ricerca dell’altrove, ce lo ricordano le tremende depressioni di chi non riesce ad accedere a un senso che dia ragione della fatica dell’esistere. Per noi umani questo è il tremendo che ci divide dal regno animale, cui peraltro apparteniamo. Non ci basta la vita dobbiamo saperne le ragioni. Homo faber e homo philosophicus non si possono escludere l’un l’altro.
Nel sogno il pericolo sembra rappresentato dal ritorno ad un indifferenziato dei tre elementi: le nostre liquidità emotive e immaginali, la nostra base ferma su cui ergersi e dire: “Io”, e il nostro poterci pensare. È il ritorno nel mondo senza spazio e senza tempo, senza pensiero e senza senso, dell’ambiguità totale. Abbiamo pensato che lo sforzo da fare tra noi, colleghi, e tra noi terapeuti con i pazienti sia proprio quello di tenere alto, limpido e differenziato il cielo. Pensiamo che sia necessario pensare e che questo sia proprio il terrore, l’oggetto impensabile che ci può far scivolare in un orrore della perdita dell’aggancio al cielo, di quel vertice alto che, cogliendo il tutto, ne veda il senso.
Abbiamo detto tra di noi che il paziente non può pensare quello che noi non riusciamo a pensare e che mentre lo aiutiamo a ritrovare frammenti di terra emersa su cui poggiare i piedi mentre teme di scivolare nel fango, noi dobbiamo fortemente tenere alto il cielo sopra di noi anche quando i nostri piedi stessi sono già bagnati delle stesse acque che bagnano loro. Pensare insieme, pensare al senso di queste ore lente di quarantena, pensare al tempo, mantenere la luce che ci aiuta a distinguere le forme, saper riflettere tutti insieme.
Per fortuna l’inconscio in tutti noi sta cercando di capire e di vedere quello che accade e lo esprime in sogni incredibilmente intensi, riconosciuti dal sognatore come eventi/visioni speciali. Una giovane antropologa, che sta tenendo un diario dei sogni di questo periodo, ce ne offre due particolarmente intensi.
Nel primo si trova a camminare per una strada liminare tra il bosco e la città, con lei è la madre, arrivate a un bivio la strada a destra va verso il centro abitato, a sinistra nel bosco. Proseguono verso il bosco e arrivano a una radura al centro della quale vedono, con spavento, un irsuto cinghiale. Vincendo la paura la giovane gli si avvicina e lo vede ingigantirsi. Sulla schiena dell’animale ci sono tracce di ruote di macchina come cicatrici. Lei si rende conto che da questa tremenda dissacrazione può nascere una nuova possibilità. Nei commenti ci rendiamo conto che l’animale sacro della grande madre terra, il suo furore selvaggio porta i segni di una civiltà violenta che lo ha calpestato ma che non lo ha ancora distrutto a patto che se ne regga il furore e il terrore che ne deriva.
Nel secondo sogno si trova in una foresta amazzonica aggrappata ad un tronco d’albero che sta andando alla deriva in uno spazio d’acqua senza fine. L’albero sradicato non ha più l’aggancio con la terra e non è più in grado, come nelle tradizioni amazzoniche, di reggere il cielo. Ci rendiamo conto insieme che il tremendo è rappresentato proprio da questo, come se l’albero, nella sua funzione di axis mundi, capace di collegare acqua, terra e cielo, si fosse sradicato e scivolasse in una liquida deriva senza orizzonti.
Non crediamo sia necessario commentare queste tremende immagini che perfettamente descrivono il pericolo che su tutti noi incombe di diventare esseri alla deriva delle nostre emozioni, disorientati come naufraghi in un gigantesco infinito mare. Ma continuare a pensare, il tenerci forte all’albero ci permetterà di arrivare a un nuovo approdo in cui noi, diversi, consapevoli della follia di cui siamo capaci, quando titanicamente non rispettiamo più i limiti e i confini che la madre terra ci impone, ci chiederemo chi vogliamo essere ora.
Testo tratto da: Rivista di Psicologia Analitica Nuova Serie, Volume 101/2020, n. 49
Camilla Albini Bravo è Psicologa Analista, membro ordinario A.I.P.A. e I.A.A.P. con funzioni didattiche – Roma e Pistoia
Mots-clés__Attesa
Attesa
di Ornella Tajani
Lucienne Delyle, J’attendrai -> play
___

___
Da Louis-René des Forêts, Les Mendiants, Gallimard, 1986, traduzione inedita di Camilla Diez
«Quando non ti amerò più, sarà il ritorno del caos», dice Otello, ma io dico che quando non lo amerò più sarà il ritorno alla serenità. Ha detto che sarebbe venuto alle due ed erano le due e dieci. Mi sono alzata, sono andata verso l’armadio e ho aperto le due ante, ho infilato la mano sotto la pila di biancheria morbida, ho toccato la pendola piatta e fredda e l’ho posata sullo scrittoio. Ho teso l’orecchio ma il rumore violento della fiera copriva i rumori familiari: i rintocchi, il cigolio della porta e i passi. Le donne salgono sui vagoncini e in cima a un ripido pendio si stringono l’una all’altra, avvertono un delizioso bruciore nel petto. Il vagoncino è lento, lentissimo, poi precipita; le viscere scendono nelle gambe, esplodono grida; la gente, a testa in su, da sotto le guarda ridendo. Mi sono rimessa a letto, le mani incrociate sotto la nuca. Quando credevo di sentire il cigolio della porta mi alzavo di scatto e tutta stordita mi guardavo allo specchio premendomi le tempie con il palmo delle mani e giravo per la stanza, non sapendo più che farne, delle mani: non è lui, non è lui, lo so che non è lui, ma rimanevo immobile, i muscoli dolorosamente contratti (mi dicevo che non era lui perché se mi fossi detta che era lui ogni speranza sarebbe sfumata: bisogna dire no ed è sì, o sì ed è no), e attraverso la parete ascoltavo i passi che si allontanavano nel corridoio e che venivano coperti dalla musichetta delle giostre, poi non sentii più nulla. Mi ha mentito di nuovo, e continuavo a dirmi che non sarebbe venuto. Non verrà e stavolta è finita davvero, ma al tempo stesso pensavo che forse il pranzo si era protratto, avevano bevuto e fumato sigari, non poteva andarsene o magari avevano iniziato tardi, aveva perso la nozione del tempo e non sapeva che erano già le due e un quarto (non verrà, non verrà, non verrà) e lo vedevo in mezzo a volti congestionati, rideva e parlava a vanvera come sempre gli uomini dopo un buon pasto (non verrà, non verrà). Quando ieri sera mi aveva detto che sarebbe venuto alle due avevo avuto la certezza che sarebbe venuto, la certezza che sarebbe venuto proprio alle due, ma erano le due e un quarto passate, forse il mio orologio va avanti di cinque minuti. E difatti l’orologio di Sainte-Anne batté il quarto, e fui sollevata: era una vittoria sul tempo. Così tornavamo tutti indietro di cinque minuti, e durante quei cinque minuti sono rimasta seduta senza muovermi, mi bruciavano le mani, gli occhi sorvegliavano la lancetta, la vedevo scendere, ero furiosa che fosse tanto rapida e tra poco avrebbe nascosto il IV. Già sapevo che non sarebbe venuto. Ma perché, quando mi stava davanti e mi ha detto, inclinando la testa e sollevando un cappello immaginario, che sarebbe venuto alle due, non ho insistito perché mi confermasse che sarebbe venuto proprio alle due in punto? Mi guardava con quegli occhi così vivaci che ero assolutamente sicura che avrebbe mantenuto la parola. Ora ero assolutamente sicura che non sarebbe venuto. La lancetta era scivolata sul IV e continuava il suo cammino silenzioso. La lunga cenere della sigaretta mi era caduta sulle ginocchia. Mi sono alzata e ho scrollato la cenere leggera dalla gonna. Mi ricordavo le sue parole: «Faccio quello che mi pare, ascolto il sangue nelle vene, io, mentre tu non saprai mai cos’è la vita perché stai sempre ferma ad aspettarla, invece di inseguirla», non ho osato dirgli che lo inseguivo notte e giorno, e quando sono sola nel mio letto penso: «Sta con l’altra», e vedo come si china su di lei, come le sorride e vedo come fossero sopra la mia testa i suoi occhi grigi attraversati da tutti i riflessi della passione. Eppure della passione non sapeva nulla, conosceva solo il piacere. Avrei voluto che fosse nel mio cuore un minuto soltanto per vederne le ferite. O forse l’amava? Se sapesse che lo inseguivo notte e giorno sarebbe così contento che mi ignorerebbe ancora di più, perché allora saprebbe che i miei sentimenti non si fermano di fronte a nulla.
Ero rimasta sdraiata, tranquilla, con gli occhi aperti, mentre il brusio della folla che saliva dal porto a ondate d’intensità variabile rendeva più dolorosa la mia solitudine. Poi non ho pensato più a nulla, non aspettavo più, non soffrivo più, e per molto tempo rimasi con la mente vuota. Di colpo, le vibrazioni dell’orologio: mi ronzarono le orecchie. Lentamente mi sono seduta; avevo i capelli appiccicati alle tempie, e lentamente ho ripreso i sensi; poi mi sono alzata: la stanza girava piano piano. Quando ho sentito Valencia biascicata senza slancio dall’organetto della giostra i miei occhi si sono riempiti di lacrime. Guardavo i miei piedi rosa, solcati da vene azzurre, con le dita strette nelle scarpe di camoscio e mi sono ricordata che era domenica. «Devi cercare e troverai», diceva, «ma tu resti immobile ad aspettare che la vita ti piova dal cielo. Non devi aver paura dei tuoi impulsi, rincorri ciò che può darti gioia, non è la gioia a venire da te, sei tu che devi andarle incontro, e più tardi dovrai correre, e più tardi ancora, quando non avrai più la forza di correre, almeno potrai dirti sorridendo: l’ho avuta quando ho potuto averla e cerco di averla ancora quando ormai non posso più; quindi sono ancora viva», ma lui parla così perché cerca una gioia qualunque; oppure è più fortunato degli altri. Perché forse l’ama e sta con lei, ecco perché non è venuto. E, di nuovo, lo vedevo chino su di lei, le accarezzava la mano, gli occhi la penetravano con un tiepido chiarore, eppure era sempre sdegnoso come se tutto gli fosse dovuto, e di nuovo ho sentito il desiderio di addormentarmi: non volevo più vedere quelle immagini, non volevo più sentire le sue parole che al mio orecchio, risalendo dal passato, si agitavano come mosche d’estate. Avrei voluto che fosse notte e sprofondare nel buio, nel buio, il buio, ma quando chiudevo gli occhi vedevo una distesa rossa che mi bruciava le palpebre e preferivo vedere la luce brutta e cruda. Lo cercavo notte e giorno: come era stato in mia presenza, gentile o ostinato, come aveva recitato, e tutti i suoi gesti, tutte le sue espressioni riprendevano vita a mezzanotte, quando nell’albergo regnava finalmente il silenzio e sentivo solo le fronde, il mare, i muggiti delle navi. Pesavo le sue parole più dolci e quelle più cattive, le più dolci mi sembravano spesso venirgli dal cuore e le più cattive elaborate dal cervello per nascondere quelle più dolci, per turbare la mia fiducia, perché è convinto che l’amore sia un gioco e per alimentare la fiamma si debba stuzzicare la gelosia. Era colpa mia: avrei dovuto amare un uomo che cerca il riposo. L’amore, una pianura tenera e malleabile (e al tempo stesso mi dicevo: «No, no, io amo solo la violenza, non so che farmene di quegli uomini mansueti che si fanno comandare a bacchetta; lui è un uomo, un uomo, un uomo»). Attraverso la camicia sentivo una frescura leggera e salina, un po’ umida; la fronte poggiava sulle braccia incrociate, la bocca sul copriletto madido di lacrime; sotto la pelle delle tempie si stringevano due tenaglie. Non verrà e sta con lei. «Il giorno in cui non ci sopporteremo più troncherò all’instante», diceva, «bisogna essere schietti, perché la libertà esige schiettezza.» – «Ma Grégoire, noi non ci lasceremo, non ci lasceremo mai.» Lui fischiettava e mi guardava con un’aria assorta, impietosita, intollerabile. Mi ero stretta a lui ed eravamo rimasti per un po’ senza parlare. Ciascuno va per la sua strada, ciascuno va per la sua strada, aveva canticchiato, e le strade non si incontrano; suppongo fosse una citazione (alle domande imbarazzanti lui risponde con delle citazioni); poi mi aveva abbracciata e aveva posato le labbra ardenti sulle mie e io avevo pensato, stupida che sono, che quella fosse la risposta migliore, ma ora so che era un insulto.
Mi sono girata, sbadigliando, e sono rimasta stesa sulla schiena, con gli occhi spalancati e le mani sotto la nuca lacerata da un dolore cocente, a guardare il soffitto chiazzato di macchie di ruggine tanto da somigliare a una mappa. Mi sembrava che il lungo gemito di una nave, le risate dei bambini, le spirali rapide e cristalline degli organetti e il baccano metallico del Scenic Railway mi martellassero forte la fronte, le tempie e la nuca, e mi gridassero che era finita, finita, finita, che la vita mi metteva alla porta: vattene, vattene, vattene; prendevano a calci un cadavere, vattene, vattene, vattene, non ce ne importa nulla di te, vattene, vattene, vattene, nulla di te, nulla di te. Mi sono tirata su di scatto: il sole che splendeva sotto le tapparelle abbassate faceva brillare il nichel della pendola, che segnava le tre meno un quarto; mi sentivo perduta, impotente, presa in trappola come una mosca nel ritmo monotono e vorticoso della giostra, e le sue grida acute squarciavano l’aria assonnata come grida di rivolta in un mondo pesante, dolciastro e opprimente. Mi sono alzata. Davanti allo specchio mi sono stropicciata gli occhi con il fazzoletto attorcigliato; ho acceso una sigaretta e mi sono affacciata alla finestra: la folla era ammassata contro le giostre che, viste dall’alto, parevano ombrellini; palloncini gialli, rossi, verdi e azzurri svolazzavano altissimi, uniti in un grappolo multicolore, trattenuti a terra da fili invisibili; un odore di scuderia, di torrone, di noccioline, di bambini e di folla saliva a ondate fino a me, e sulla piattaforma brulicavano le macchinine, minuscole macchie rosse che si scontravano in una specie di danza vana e scomposta tra le urla di gioia e gli spari del tiro al bersaglio. A fare da sfondo, rimorchi scuri, golette bianche e pesanti barconi carichi di carbone e sabbia rossa.
___
[Mots-clés è una rubrica mensile a cura di Ornella Tajani. Ogni prima domenica del mese, Nazione Indiana pubblicherà un collage di un brano musicale + una fotografia o video (estratto di film, ecc.) + un breve testo in versi o in prosa, accomunati da una parola o da un’espressione chiave.
La rubrica è aperta ai contributi dei lettori di NI; coloro che volessero inviare proposte possono farlo scrivendo a: tajani@nazioneindiana.com. Tutti i materiali devono essere editi; non si accettano materiali inediti né opera dell’autore o dell’autrice proponenti.]
Le “Nughette” di Canella: Wunderkammer di una civiltà idiota
[Presento qui alcuni testi tratti dal volume di prose Nughette ’17-’20 di Leonardo Canella, appena uscito per Affinità Elettive, seguito dal saggio che ho scritto come postfazione. A. I.]
di Leonardo Canella
1)
pensavo che potevi spararmi prima di leggere le tue poesie. Mentre la Polly chiama il centodiciotto che facciamo un bel pubblico letterario, e la Dimmy dirimpettaia che grida e Bruno Vespa che ride, in TV. E mentre leggi, ti ascolto. Tranquillo. Che felice penso che tanto ci sei tu chi mi hai già sparato. E leggi le tue poesie. Ed io rivedo la mia piantagrassa Selly divenuta cieca e le nuvole in alto. Bianche.
2)
tutti a dirmi che eri morto. Con una siringa nel braccio e un batuffolo di cotone rosso sull’erba. Tipo fiore sfiorito. E invece no. Adesso sei nero e fai il nigeriano ai giardinetti, mitico Ellis. E sorridi. Tutti a dirmi che eri morto. E Invece no. Sorridi tipo 1978. E tu sei lì, mitico Ellis, con la Dalmy sdentata e il Dirby stecchetto. Che adesso fanno i nigeriani neri pure loro, ai giardinetti. E sorridono tipo 1978 che il fiore sfiorito c’è pure per loro, sull’erba. La siringa e il batuffolo di cotone lo porto invece io.
3)
donna tenuta in freezer per 19 anni. Mitico Ciclope, leggo questo sul corrierepuntoit e penso alla tua isola che mi piacevano un sacco le capre. E le bacche, nere. E davanti alla TV c’eravamo noi, io tu e le capre. E il rumore del freezer. E stavamo la sera così, davanti alla TV, davanti al mare. Col rumore del freezer. A pensare, a fare poesia. Poi il freezer si è rotto e c’hanno trovato dentro una donna. Dopo 19 anni. E non so se sono stato io o sei stato tu che la Polly dice che sono un mostro quando in casa non ci do retta. E oggi quando l’ho rivista tornare coi sacchetti della spesa, ho pensato che anche lei era uscita di casa 19 anni fa. Sì, ora ricordo, era uscita di casa diciannove anni fa.
4)
Bubu migrante, tu sei lì. Io lo so. Tocco lo schermo, e tu sei lì. Infilo le dita, e sento la tua lingua. Non so, tipo spugnetta umida. E ci sono dieci centesimi, ma dipende. Se metto un euro, ce ne sono sessanta, di centesimi. Sulla lingua. A scuola dicono che parlo da solo ma non è vero: IO PARLO COL DISTRIBUTORE DEL CAFFÈ! E dentro al distributore del caffè ci sei tu, Bubu migrante. Io lo so. E sento la tua lingua, umida tipo spugnetta. E la tua voce. Che se parliamo di letteratura, tu mi dici ‘prendere il resto’. Ed io sono d’accordo.
5)
in fondo al mare c’è più plastica che vita. E ci sono i migranti. Con la plastica nello sterno e dentro il teschio, seduti in poltrona col telecomando. Che ti vedono con pantaloni a zampa di elefante calibro 38 e basette lunghe, mitico Ellys. Com’eri nel 1978, alla tv. Così ti ho invitato a cena trent’anni dopo in fondo al mare, mitico Ellys. Con pantaloni a zampa di elefante, calibro 38 e basette lunghe. E i migranti seduti in poltrona col telecomando. A parlare della plastica e del dolore. In cerchio, in fondo al mare. E sentire la vita e le previsioni del tempo.
6)
a Milano c’è il bosco della droga e ci sono gli zombi. E c’è anche un agglomerato di cemento armato e rifiuti, vicino. Vicino agli zombi. E Canella va lì, a leggere le nughette e a sentire l’eco fra i rami del bosco della droga. E l’arietta di primavera. Che la Polly dice che in casa sono uno zombi che non pulisci mai. E io vado fra i rami del bosco della droga per sentire l’eco delle mie nughette. Felice. E l’arietta di primavera. E gli zombi ridono sorrisi sdentati nel bosco della droga. A Milano. Con l’agglomerato di cementoarmatoerifiuti vicino. Felice pure lui.
*
LE WUNDERKAMMER DI UNA CIVILTÀ IDIOTA
di Andrea Inglese
devo combattere la morte e i peli, dici mentre ti strappi i peli sul braccio.
Nughetta n° 47.
Nonostante la crisi che l’ha accompagnata nel corso di tutto il Novecento, la lirica, genere dominante delle scritture poetiche, è sopravvissuta al cambio di secolo, e coabita, con più o meno imbarazzo, con altre forme, più sperimentali, anti-liriche o post-liriche, che si dispongono comunque nei medesimi dintorni editoriali e di attenzione critica. Per altri versi, la poesia continua vivacemente a morire, come tutta la letteratura, nell’era della cultura di massa e digitale. Al di là delle innumerevoli diagnosi apocalittiche, è interessante vedere come questo genere si caratterizzi più di altri per un destino ambivalente: la poesia, da un lato, è vergognosa editorialmente, perché non ha compratori, e spettacolarmente, perché – in genere – ha pochi spettatori; dall’altro, però, gli si affibbia spesso e volentieri una nobilissima missione. Per molto tempo, soprattutto a partire dagli anni Zero, si è parlato della poesia come una zona di resistenza, ossia un’attività letteraria che sembra, pur nella sua marginalità riconosciuta, salvaguardare qualcosa di “umano”, “non mercificato”, “autentico”. La poesia, insomma, costituirebbe, nella narrazione apologetica che essa tende a fare di se stessa, l’ultimo bastione contro la disumanizzazione e la mercificazione universali promosse dalla barbarie capitalistica. In quest’ottica, persino i media generalisti sono propensi di tanto in tanto a tirar fuori qualche figura di poeta, colmo di umanità e saggezza, di pazienza artigianale e ritrosia ascetica. Oggi, poi, la poesia sembra addirittura profittare di una nuova ondata culturale, ossia la sensibilità ecologica. Fino a ieri, il poeta difendeva i valori dell’umanesimo, ma oggi, con la faccenda dell’antropocene e del riscaldamento climatico, la centralità dell’uomo è diventata un po’ sospetta. Quindi si è passati al filone poesia ed ecologia. E, ancora una volta, la periferica scrittura in versi può riacquistare, almeno fino alla prossima crisi, una nuova autorevolezza.
L’interesse che desta un autore come Leonardo Canella viene, innanzitutto, dalla postura generale che egli assume nei confronti del genere che pratica. Canella sembra aver fatto i conti fino in fondo con le narrazioni catastrofiche e apologetiche che circondano la poesia. E le conclusioni che tira, lo vedremo, vanno nella direzione di una grande vitalità accompagnata da un perfetto disincanto. I testi che egli raccoglie sotto il titolo di “nughette”, pur non assomigliando in prima battuta a delle poesie, vogliono inscriversi, seppure in forma ironica e autoparodica, nella tradizione della poesia occidentale. Lo notava già Renato Barilli, introducendo il primo libro dell’autore (Nughette, Guaraldi, 2014), e ricordando le nugae del Petrarca, ossia un genere adatto a componimenti di secondaria importanza, scritti in volgare. Prima ancora, il termine è utilizzato nella lirica latina da Catullo, con il significato di “bagatelle” o “inezie”, per definire testi poetici brevi e di soggetto leggero, ossia legato alla quotidianità e alla vita privata dell’autore, che si distinguono dai carmina docta, testi più lunghi e su temi gravi, legati all’epica e all’impegno civile.
Riesumando un genere antico della tradizione poetica occidentale e assolutizzandolo, ossia limitando a esso la poesia possibile del XXI secolo, Canella non solo gli riconosce di fatto un carattere minoritario – per altro incontestabile –, ma anche gli attribuisce di diritto un carattere di scrittura minore, ossia programmaticamente non edificante. Questa preliminare operazione, che si pone a livello d’istituzione letteraria, ossia di “genere”, ed è quindi rivolta innanzitutto verso il pubblico per orientarne la lettura, annuncia una consapevolezza forte, storica, dell’azione di produrre letteratura. Oggi, la poesia, per Canella, può esistere principalmente nella forma diminuita delle “nughette”: componimenti brevi, seriali, privi di verso, d’argomento quotidiano. Si tratta, insomma, di scegliersi il proprio pubblico, di disambiguarsi rispetto al contesto che, pur essendo assai fragile e periferico, non rinuncia ai propri sogni di centralità e grandezza. In Canella non si troveranno elogi degli alberi e delle erbe di campo, come non si troveranno meditazioni sul destino nuvoloso dell’umanità. Non saremo confrontati a un uso estremo, sofisticato, della parola. Non vi è nessun tentativo di riscattare il linguaggio dalla sua usura, né attraverso operazioni di “pulizia” del dettato né attraverso operazioni d’“ispessimento” espressionistico. La strategia di Canella guarda in tutt’altra direzione: bisogna indebolire e rilasciare enormemente i filtri, per fare entrare quanta più materia possibile, quante più “occasioni”, anche se esse si caratterizzano per un alto grado d’insignificanza. Le nughette sono pensate non come un baluardo formale, stilistico e retorico, contro il già-detto, la parola ordinaria, il flusso eterogeneo e destrutturato della comunicazione mediale, la piattezza delle situazioni connesse alla vita domestica e lavorativa. Esse funzionano, al contrario, come un formidabile e sensibilissimo strumento di captazione; tutto vi può entrare: le frasi fatte, i titoli di cronaca, i gesti più comuni e impoetici, come tagliarsi le unghie o farsi la ceretta. E vi è un insolente proposito di rovesciamento dei valori: la poesia, se ancora esiste, si fa con le inezie o, più precisamente, si fa con gli scarti dell’esperienza, ciò di cui vorremmo senza sosta liberarci: le idiosincrasie, il funzionamento testardo e animale del corpo, le narrazioni mediali, che costituiscono per noi, cittadini informati e intrattenuti, una sorta d’inquinamento “delle menti”, altrettanto evidente di quello realizzato sugli ecosistemi del pianeta. (Della violenza di questo inquinamento se ne è avuta una prova ulteriore e recente nei mesi di confinamento obbligato a causa della pandemia di Covid-19. Durante questo periodo anomalo, tra le cose estremamente gravi da cui bisognava difendersi – il virus, ovviamente, la perdita del proprio lavoro, il dolore e il caos psichico – quasi tutte le persone che conosco hanno citato l’informazione televisiva e giornalistica.)
Alle spalle di questo atteggiamento di Canella potremmo individuare eredità o analogie: la linea crepuscolare che va da Gozzano a Sanguinetti (soprattutto quello di Postkarten), ma anche l’objet trouvé e il collage dei dadaisti, e più recentemente l’Aldo Nove di Woobinda. Quello che più conta, però, è l’effetto globale che questo abbassamento dei valori produce sui suoi testi. Da un lato, assistiamo al gesto cinico-nichilista che dissacra ogni tema o figura dai possibili risvolti consolatori, dall’altro abbiamo la rilevazione, all’interno degli scenari più triti e triviali, di zone d’intensità impreviste. E queste zone sono spesso legate all’impoetica, anti-lirica, dimensione che Bachtin aveva definito il basso materiale e corporeo. Si legga la nughetta 31, che funziona anche da manifesto di poetica:
“mentre parli ¬ sei uno scrittore ¬ penso al verme che ho visto. L’ho visto sul cemento, pieno di vita. Al sole. Dici che tuo padre aveva i baffi. Negli anni Settanta. E io penso al verme che ho visto sul cemento. Pieno di vita, al sole. Non riesco a non pensarci, non so. Anche lui coi baffi, negli anni Settanta. E intanto parli di letteratura e io penso al verme che ho visto. L’ho visto sul cemento pieno di vita e al sole. Coi baffi, mentre parlava di letteratura anche lui, negli anni Settanta. Non riesco a non pensarci, non so. E questa è la mia idea di letteratura.”
Nulla è più basso, rasoterra, lontano dall’antropomorfismo e dall’antropocentrismo del “verme”, che però appare qui “sul cemento pieno di vita e al sole”. È quello che definisco una zona d’intensità, e che funziona grazie alla strategia globale della composizione, che si costruisce per contrasto con la zona debole “scrittore, anni Settanta, letteratura”. Questi termini generici che rinviano a un sistema d’identità e valori radicati nella storia umana si oppongono qui alla concretezza di una specifica situazione non umana: l’asse verme-vita-sole. In fondo, Canella fa qui quello che scrittori e artisti sono, a volte, in grado di fare, ossia si libera da quella “asfissiante cultura” – per riprendere il titolo di un celebre pamphlet di Jean Dubuffet – , che funziona, in realtà, come un sistema per ritardare e ostruire la visione, la presa d’atto della vita presente, delle cose come stanno. (Dubuffet, per altro, compare in un testo delle Nuove nughette, edite da Prufrock spa nel 2017. E, sia detto di passaggio, Canella è anche pittore e critico d’arte).
Bisogna, quindi, leggere il lavoro di Canella consapevoli della duplicità che manifesta: tanto più esso dismette ogni residuo sogno d’integrità lirica, ma anche d’emancipazione avanguardistica, tanto più organizza una macchina macrotestuale efficiente e articolata sul piano letterario. Egli, infatti, ha creato una chimera, un ibrido mostruoso, ossia un genere individuale, le nughette, appunto, come già fecero alcuni illustri predecessori novecenteschi, quali Francis Ponge (è l’oggetto della scrittura che crea il genere, non il contrario), ma anche suoi coetanei altrettanto ambiziosi, quali Vincenzo Ostuni con il suo Faldone.
La virtù delle nughette, lo abbiamo detto, consiste nella straordinaria capacità inclusiva che offre loro. Esse costituiscono un dispositivo onnivoro, che si nutre della straripante insignificanza e idiozia delle nostre vite. È opportuno, però, chiarire subito una cosa. Questa insignificanza e idiozia non è semplicemente l’effetto di un sistema storico per molti aspetti detestabile, come quello rappresentato dalle tarde società capitalistiche all’epoca dell’offensiva neoliberista e dello scontro tra tecnocrazia e populismo. La consapevolezza storica di Canella non offusca in lui una consapevolezza, diciamo, antropologica. Le nughette sono attraversate da cima a fonda da un’inesauribile sete di felicità, e di felicità esclusivamente terrena. E più questa sete è intensa, più colui che la patisce è confrontato al rischio dell’insensatezza. Canella fa affiorare, all’interno del nostro orizzonte storico, la fisionomia di un’umanità che ha preceduto il capitalismo e la modernità, e che è caratterizzata da una serie d’invarianti antropologiche: il cibo, l’eros, le narrazioni condivise, la morte. L’abbassamento di temi e registri linguistici è parte di una strategia più generale, che è quella di un denudamento o, se vogliamo, di una riduzione, alle attività più elementari dell’animale parlante. Ecco, allora, che i personaggi che compaiono nelle nughette sono costantemente alla prese con il cibo – dal barattolo di nutella al sugo al ragù – e se non stano mangiando, cucinano o pensano al cibo. È il corpo che lo vuole, non l’eterea coscienza. Allo stesso modo, il corpo è costantemente proteso al godimento sensoriale. Ma per soddisfarsi non ha bisogno di sofisticate esperienze no limits, turistiche, sportive o sessuali. Gli basta farsi scompigliare i capelli “dall’arietta di primavera”, “sentire il sole su in vena e la serotonina sparata a mille”, avere intorno “Polly tettinedorate” o sbirciare la Selly Dirimpettaia che se ne esce nuda dalla doccia. Vi è poi, ricorrente, il motivo del “cerchio” dei parlanti: “E ci siamo detti storie antiche”, “In cerchio tra i fiorellini colorati, sul prato”, “Intorno al fuoco. E raccontarci della vita, sul prato. Tutti in cerchio sulle bave, sotto la luna”… Uno dei momenti di felicità dell’animale parlante riguarda l’atto di parola non immediatamente strumentale, ossia il racconto condiviso e reciproco, che potrà avere tratti epici, di narrazione collettiva (“storie antiche”) o autobiografici, di narrazione individuale (“raccontarci della vita”). Poco importa che il “cerchio” si presenti come sogno, immagine irreale, esso ricorre puntualmente a mostrare l’insufficienza sia dell’apostrofe lirica, privata e confinata al tu, sia delle forme di narrazione elaborate dai media di massa (stampa, TV, internet). La morte, infine, interviene come leitmotiv “spettrale” ad affiancare, quasi a rafforzare, le certificazioni di presenza fornite dal corpo, che percepisce, si nutre, racconta. La morte circola innanzitutto nella forma del fatto di cronaca, ossia come morte violenta e/o insolita, che viene celebrata nei media per il suo carattere al contempo spaventoso e attraente. Varrà la pena di citare per intero la nughetta 22:
“tutti a dirmi che eri morto. Con una siringa nel braccio e un batuffolo di cotone rosso sull’erba. Tipo fiore sfiorito. E invece no. Adesso sei nero e fai il nigeriano ai giardinetti, mitico Ellis. E sorridi. Tutti a dirmi che eri morto. E Invece no. Sorridi tipo 1978. E tu sei lì, mitico Ellis, con la Dalmy sdentata e il Dirby stecchetto. Che adesso fanno i nigeriani neri pure loro, ai giardinetti. E sorridono tipo 1978 che il fiore sfiorito c’è pure per loro, sull’erba. La siringa e il batuffolo di cotone lo porto invece io.”
I morti popolano le nughette e sono spia non solo del destino comune, che nessuna orgia consumista e spettacolare potrà davvero esorcizzare, ma anche di una condizione “spettrale” che incombe su ogni tentativo di aderire vitalisticamente alla propria esperienza. La vitalità del verme, allora, o delle pulsioni elementari di cui il corpo è portatore, vengono costantemente controbilanciate da una fissità allucinatoria. Le nughette non registrano spaccati di vita, ma dei tableaux vivants, ossia delle ricostruzioni artificiali di situazioni. E in queste ricostruzioni intervengono, sulla stessa scena dei vivi, anche i morti. L’opzione figurativa di Canella è quindi decisamente antimimetica. Ad accentuare questo aspetto vi è poi quella che chiamerei la porosità delle identità individuali e delle coordinate spazio temporali. Il tossico di fine anni settanta, morto per overdose di eroina, si confonde con il nigeriano, forse spacciatore, e frequentatore in ogni caso dei giardinetti, e assieme ad essi altre figure marginali di consumatori di droga, Dalmy sdentata e Dirby stecchetto. Qui l’apostrofe lirica non è più indirizzata a un “tu” amoroso o intellettualmente e affettivamente affine (il lettore-ascoltatore), ma a un campione di marginali, che non si riesce però a espellere fuori dallo spettro dell’identità personale. Chi dice io nella nughetta 22, come in molte altre, è in realtà abitato da spettri, e poco importa se all’origine di questi spettri ci sia una scandalistica inchiesta sullo spaccio di droga vista in TV o un ricordo personale nato da un’esperienza diretta o trasmessa oralmente.
Questa spettralità anti-mimetica è all’opera in modo particolarmente evidente nella sezione intitolata Migranti. In questi anni, con tutte le buone intenzioni del mondo, ma non sempre con sufficiente consapevolezza letteraria e critica, i poeti e le poetesse hanno spesso preso la parola, nei loro testi, per esprimere e denunciare alcuni fenomeni legati alla cosiddetta crisi migratoria. L’idea diffusa dietro queste scelte poetiche è quella di “restituire voce a chi voce non ha”. Soprattutto si è sollecitati, attraverso strumenti letterari, a combattere contro gli stereotipi della stampa e della propaganda politica spesso intrecciate tra loro. Il problema, in tutta questa faccenda, è che si rischia di produrre inconsapevolmente un ulteriore stereotipo o di lavorare per variazioni su stereotipi esistenti. Affinché la poesia possa esprimere la voce dei senza voce (gli immigrati clandestini e fuggitivi), bisognerebbe innanzitutto che fosse fatto un lavoro di “raccolta voci”, e che, di conseguenza, e non in modo episodico, i migranti in questione abbiano già preso la parola. Ma questo implica un processo politico e conflittuale lungo e difficile da realizzarsi. In questo contesto, la poesia sembra proporre una scorciatoia che ha una finalità consolatoria. Canella opera qui ancora una volta un rovesciamento: allo stereotipo della narrazione massmediale non viene opposta una rappresentazione più complessa, umana e autentica (con il rischio di prolungare ulteriormente la portata della semplificazione e dell’occultamento). Lo stereotipo è preso e trattato come una figura “spettrale”, ossia accentuandone i tratti di meccanicità e di fissità disumanizzanti. Canella usa in modo parodico, in questo e altri casi, le formule di matrice omerica che accompagnano i nominativi. Abbiamo, allora, “Buby africano pesciolinoinbocca”, così come in altri testi “bavettalabiale Polly” o “la Daldy tettinesgonfievicinadicasa”.
Il prezzo che l’autore paga giocando in questo modo antimimetismo e spettralità si riscontra nel carattere programmatico, e per certi versi meccanico, della sua operazione. Nello stesso tempo la ripetizione delle formule, dei personaggi, di certe situazioni o scenari crea quella coerenza e forte identità macrotestuale, che collega non solo i vari componimenti tra di loro, ma anche le diverse raccolte di nughette. Si apre questo libro non per andare alla ricerca di qualche pensiero sublime o esperienza sfuggita alla spettacolarizzazione, ma per girovagare in una successione di “camere delle meraviglie”, dove sono allestite scorie ideologiche dell’epoca e pulsioni umane fondamentali. Non so dire se la passeggiata sia catartica, ma essa contribuisce in forma allegramente impietosa a riconoscere alcune componenti tossiche e dementi del nostro orizzonte individuale e collettivo. D’altra parte, ogni forma di felicità dovrà costruirsi attraverso di esse, traendone anche energia, non solo disgusto e scoramento.
Diario della pandemia dall’Himachal Pradesh # 1
 di R. Umamaheshwari
di R. Umamaheshwari
R. Umamaheshwari è una storica e giornalista che vive in India. Ha pubblicato When Godavari Comes: People’s History of a River (Journeys in the Zone of the Dispossessed), Aakar Books, New Delhi, 2014; Reading History with the Tamil Jainas: A Study on Identity, Memory and Marginalisation, Springer, 2017 e From Possession to Freedom: The Journey of Nili-Nilakeci, Zubaan, New Delhi 2018. Un anno fa ha cominciato a scrivere un diario della pandemia dall’Himachal Pradesh che pubblichiamo a puntate. Questa la prima.
Elucubrazioni intorno a un virus. Prologo
(traduzione di Rosario G. Scalia)
Tutto andava secondo la stagione. A fine ottobre, nell’antico monastero buddista di Tabo, a Spiti nell’Himachal Pradesh, i bambini aspettavano con ansia le vacanze invernali del mese venturo, e anche se con qualche ritardo, le mele erano state raccolte nel vicino villaggio di Lari, da alcuni dei campi più piccoli. Gli ultimi sparuti turisti sciamavano per i monasteri di Spiti; i Bengalesi erano i più rumorosi, tutti ansiosi di capire cosa c’era da vedere dopo. Alcuni muratori stavano approntando una nuova casa vacanza per la prossima stagione turistica. La gente era impegnata nella propria vita e si preparava per il nuovo anno, ormai imminente, mentre io qui riempivo il mio cuore di rimorso, e di nostalgia del mio ultimo viaggio con il mio cane e compagno di viaggio, Malli. Qualche settimana più tardi, nel villaggio Mudh, nella Vallata di Pin, poche donne, tra cui la suora buddista Chomo Tchering, stavano sistemando la strada, e condividevano con me il loro pranzo, a base di pane, tè e risate.
Lentamente, a fine dicembre, la neve aveva coperto quasi tutto. Era giunto il tempo di stare a casa intorno ai caminetti e guardare l’anno che se ne andava, e il nuovo che arrivava. In un Capodanno particolarmente freddo e nevoso, a Kibber, il giovane Sonam, sua madre ed io, condividevamo lacrime di gioia e dolore, e il nostro chang di orzo fermentato, rannicchiati intorno al camino, nella loro casa di fango e mattoni. Il primo giorno del 2020 cominciò qui, con trionfanti raggi del Sole che scintillavano sui tetti di questo minuscolo villaggio. Quell’inverno era come tutti gli altri inverni, almeno fino a quel momento. Di là a pochi giorni, tutto sarebbe stato più duro. Circolava la notizia di un leopardo delle nevi che aveva ucciso uno stambecco, e allora gli ultimi Suv provenienti dalle città trasbordavano la gente per una foto veloce con il leopardo. Poi ripartivano, appena in tempo.
Tre cuccioli giocavano lungo il fiume Pin, e ci si chiedeva se sarebbero sopravvissuti ai prossimi tre mesi di quel rigido inverno (e purtroppo, non ci sarebbero riusciti), ed io ero alle prese con il dilemma di decidere se adottarne uno o no. Recentemente un cane era già morto di fame e di freddo, e il suo corpo giaceva sul fiume gelato, sotto il ponte. La volpe rossa si aggirava nei dintorni, pressoché indisturbata, e alcuni stambecchi pascolavano fuori. Era per loro il momento di sentirsi liberi. Tutto, d’altronde, andava nella maniera in cui era sempre andato. I rifugi sarebbero stati presto chiusi e gli ultimi yak, mentre i campi venivano messi a maggese per il periodo della neve, si sarebbero spinti a cercare pascoli lontano nella foresta.
Da sempre la gente fa le stesse cose in questa stagione, e gli yak sarebbero ritornati a casa presto, appena i rigori dell’inverno si fossero attenuati. Per loro questo è il momento di pascolare liberi a temperature pressoché normali. Foraggio e legna a sufficienza sono stati immagazzinati a casa per i mesi invernali, quando le temperature varieranno da meno trenta a meno trentacinque gradi; le mucche, così come le pecore, rimarranno con le famiglie nel recinto sotto casa. Le lanterne solari vengono caricate approfittando di qualunque raggio di sole comparisse di giorno. I lunghi mesi invernali sono una sfida anche per chi vive in queste regioni da diverse generazioni. Ma l’atteggiamento è sempre quello di guardare all’estate che verrà.
Più tardi, fin circa la metà di marzo di questo 2020, Shimla è stata piena di traffico e di turisti, e le solite attrazioni, Mall Road e l’edificio coloniale della Viceregal Lodge, conosciuta anche come Rashtrapati Niwas, che oggi ospita l’Istituto di Studi Superiori, dedicato dal secondo presidente dell’India, Dr. S. Radhakrishnan, al Paese, come primo istituto autonomo di studi avanzati, brulicavano di persone che si godevano l’estate nella stazione collinare. La gente si ammassava intorno ai piccoli ristoranti sulle strade, come sempre. La vita andava avanti al suo ritmo normale, anche se le notizie del nuovo virus in Cina, lontano da qualche parte, era ovunque l’argomento principale di conversazione.
Il Buddha una volta aveva osservato che la permanenza è nulla (o, per dirla in modo più affermativo, che tutto è transeunte). Eppure io ero venuta qui per porre su queste montagne una base permanente, piuttosto che essere nomade. In fondo lo sono stata per anni. La prima volta che arrivai a Himachal Pradesh, oltre vent’anni fa, fu una specie di serendipità: condividere con tre donne qualche canzone e la cena preparata con verdure fresche colte dai campi di fiori di sesamo gialli, in un meraviglioso, piccolo villaggio, chiamato Deot. Anni dopo ci sarei ritornata in un contesto diverso, eppure vi avrei condiviso lo stesso calore, con altra gente, nel quartiere di questo Istituto, nei villaggi tra le valli e le alte montagne, con il mio cane e compagno di viaggio Malli. Talora sono i legami tra le persone, più che i paesaggi semplicemente divini, che diventano l’idea di casa. Il sentirsi a casa, anche se non sei nata lì. Talora invece è l’altro che arriva da terre lontane, che trova una strada “dentro” a significati che chi è dentro da sempre non vede. Tu arrivi sempre da fuori. Il Buddha trovò la sua verità interiore da fuori, e trovò case in regioni lontane da dove era nato, attraverso i paesaggi. E allora ti chiedi se potrebbero esserci luoghi simultanei per arrivare a casa. O se invece finisci per appartenere a questo solo posto. Fra un fiume e una montagna, come fai a decidere dell’uno o dell’altro? Cosa sai della gente che vive qui e là, e di quelli che vivono a metà strada?
Così tu aspetti di arrivare in un certo posto, dopo tutti i tuoi viaggi. Come fanno gli yak, dopo tutto il loro vagabondare per la foresta, lontano da casa, in tempo per l’estate, per andare al lavoro. Come ho fatto io, dopo alcuni anni di vagabondaggio, per trovare infine il mio spazio tra questi luoghi, anche se stavolta senza Malli. Ma l’anti-climax è accaduta. E la vita è cambiata, non solo per me, ma per altri nel mondo. Per alcuni, nel bel mezzo dei loro viaggi, e prima dell’arrivo.
Scrivo da un luogo e da una situazione particolare, quindi quello che scrivo qui è condizionato da entrambe le cose: il luogo e la situazione attuale. La situazione, naturalmente, è comune a molte persone in tutto il mondo, confinate in qualche spazio, sotto un blocco totale o parziale. Scrivo da dentro i limiti e i confini del mio presente spazio, una donna solitaria, in una minuscola stanza di una pensione dell’istituto cui una volta appartenevo, a Shimla, Himachal Pradesh. E si dà il caso che le uniche persone con cui sono in contatto provengano da diverse vocazioni, classi e caste (tra gli altri un postino, un contadino, un pastore, un fioraio, un venditore di frutta, un guidatore di risciò e un tassista, un addetto alle pulizie), con i quali talora ho avuto rapporti più lunghi o, semplicemente, legami di vicinato, o robuste catene forgiate nel corso degli anni di viaggio e di soggiorno in diverse regioni. Guardo il mondo che mi circonda, mentre li ascolto parlare a loro volta del loro mondo, e mi rendo conto di quanto siano diversi i mondi di molte persone, nonostante il globale isolamento e la comune reclusione. Una linea telefonica regolare, quando e dove funziona, diventa un grande strumento per rafforzare alcune di queste connessioni, concedendo in qualche modo un’incursione “nel mondo”, e permettendo di condividere ansie, paure ed esperienze. In passato mi è capitato di essere una giornalista free-lance e una storica, ed era così che mi piaceva pensarmi. E mi rendo conto adesso che il mio sostentamento è stato alimentato in larga misura dalla cosiddetta “economia informale”. Da dove mi trovo oggi, sarebbe quasi impossibile essere quella giornalista o quella storica (di qualsiasi tipo); è senz’altro più difficile adesso accedere alle voci delle persone, o alle loro storie nei modi in cui lo facevo allora, sul campo. Molte cose sono cambiate nell’ultimo anno e mezzo, e in particolare negli ultimi due mesi. Una volta avevo una casa che chiamavo casa, e un “indirizzo permanente” nelle città gemelle di Hyderabad-Secunderabad e ora non ce l’ho più. Ora mi appare importante parlare di questa parte “personale” di me, così legata all’economia; una situazione che lo stato attuale di lockdown rende ancor più indicativa della relazione di ciascuno con il mondo e del senso di esclusione che talora si prova nel non riuscire pienamente a farne parte. Incapace di gestire rate mensili, la mia eterna lotta contro il tempo che mi collega a molti in tutto il mondo, non avendo un reddito regolare permanente, ho venduto l’appartamento e ho perso, insieme ad esso, il mio indirizzo permanente.
Finché non ero una donna sola, e avevo un compagno in questi viaggi (il mio cane, Malli), è stato più facile affrontare l’idea di non avere un recapito. Ma dopo averlo perso, mi interrogo su cosa veramente sia “casa”, e dove. Cosa significa “possedere” una casa? Ed è così essenziale per la sopravvivenza? Oggi, mentre rifletto sul mondo che mi circonda, e sul futuro dell’economia con cui presto dovremo confrontarci, mi chiedo se questa prigionia globale nell’industria del debito sia stata migliore della “libertà” dell’attuale incertezza e della speranza di una casa in cui vivere che non produca debiti. Forse molti si pongono una domanda simile sull’isolamento: se essere fuori al lavoro sia meglio che essere confinati, benché questo confinamento dovrebbe permetterci di liberarci dal virus; e che cosa accadrà se l’economia continua a rimanere chiusa in alcuni settori, e il denaro diminuisce di giorno in giorno senza un afflusso costante di reddito (stranamente, per una volta la questione della generazione di reddito oggi tocca anche i paesi più ricchi, a causa del virus). Ho riflettuto sullo stato attuale dal punto di vista dei differenti contesti economici dei molti che ho sentito al telefono. La situazione attuale, l’economia, sfida me e molti altri. O diciamo che gli Stati, in tutto il mondo, sembrano sfidare le persone a sopportare il peso delle perdite attuali, nella speranza di un futuro migliore. Ho camminato a lungo nel miraggio del settore delle case cosiddette “a prezzi accessibili” (l’unico settore per il quale ero “eleggibile”), e ho visto il modo in cui cambia il modo di fare dei promotori o degli agenti immobiliari nel momento in cui dici loro il tuo “budget”, e come cercano di farti capire quali sono le tipologie di spazi alla tua portata), riflettendo per mesi sull’idea di “casa”. Nel contesto odierno, anche se ora capisco perfettamente l’ansia di molti di “andare a casa” o “tornare a casa”, continuo a chiedermi a cosa serva una casa.
Può esserci un’idea universalmente condivisa di “casa” attraverso tutte le culture, le regioni e le storie? E che dire dell’idea di casa per le comunità tradizionalmente itineranti? C’è anche un’idea “concettuale” e “reale” di casa, distinte l’una dall’altra? Se dovessi considerare me stessa come un soggetto della mia indagine, direi che mi sento ‘a casa’ qui tra le montagne. Eppure non sono nata qui (come alcuni di quelli che sono nati nell’Himachal si sentono ‘a casa’ altrove, in campagna o fuori); la città dove avevo il mio cosiddetto ‘indirizzo permanente’ non mi ha fatto sentire a casa e nella cosiddetta “città massima” in cui sono nata, non sono mai stata a casa mia, se escludo il tempo dell’infanzia, quanto una bambina percepisce i suoi genitori come l’unica idea di sicurezza / casa. Ma se si dovesse parlare in termini più specifici, a volte la sensazione “a casa” non viene da una struttura a quattro mura (e dipende dalle persone, dalla natura, da ciò che ti ispira un senso di appartenenza e di intimità); eppure ancora, molte volte, quando si parla di casa si pensa a una struttura, un riparo e un tetto sopra la testa (soprattutto un tetto e un riparo che dia dignità alle persone che ci vivono dentro), dove ci si sente sicuri e protetti. Quindi, i milioni di lavoratori migranti che ogni giorno tornavano a piedi ai loro villaggi da una città lo facevano perché la città e la sua popolazione non estendevano a loro quello spazio di dignità.
Gli spazi in cui vivevano sembravano quasi irridere l’idea stessa di umanità e dignità. Molte di queste persone devono aver deciso di spostarsi dai villaggi alle grandi città per sfuggire ai contesti restrittivi delle loro vite: l’oppressione delle caste, la mancanza di terra, la disoccupazione, la scarsa opportunità di istruzione, la perdita di dignità e di autostima. Nella loro idea di futuro, forse, speravano che gli spazi della città potessero fornire loro non solo un sostegno monetario ma anche un sostentamento non basato sul pregiudizio di casta, o comunque per quanto possibile non connotato dalla casta, nella misura in cui era possibile? Un tetto e un rifugio dignitoso, non una semplice carta d’identità con un indirizzo e un numero designato, oltre alla sicurezza economica, a volte conta come “casa”. Molti prendono la decisione di lasciare quella che chiamiamo ‘casa’ verso una prospettiva migliore. E fanno ‘case’ altrove. Questa scelta dell’altrove deve essere senza dubbio considerato come uno degli aspetti cruciali delle storie umane.
Questo tetto e questo rifugio che ho in questo momento temporaneo mi fanno sentire sicura, mentre, ma allo stesso tempo, essendo uno spazio condizionato (condizionato alla misericordia dell’istituto che li “possiede”, e al tempo e al contesto) procura un’ansia di “essere a casa” da qualche parte.
Per tanti, in tutto il mondo, il virus può essere causa di trauma: la perdita di una persona amata, la perdita del lavoro, l’incertezza del futuro. Gli Stati che distribuiscono indennità di disoccupazione per la gente affrontano almeno una parte del problema. Ma che dire degli Stati dove non c’è un welfare generalizzato?
Ho viaggiato a lungo per trovare una casa tra le montagne, ma poi, quando forse stavo per concedermi un nuovo indirizzo ‘permanente’, il virus ha colpito. Mi chiedo quanto ancora sia lungo il cammino verso una vita che si potrebbe definire “normale”, guidato dalla speranza della “libertà” (libertà dai limiti, ma anche libertà di scegliere dove andare e come sostenermi, e infine libertà di dissenso: la scelta di dire “no” e “sì”). Quella libertà che dovrebbe essere normale per le persone di tutto il mondo.
Una nota più positiva è che questa stanza della guest house si trova in un Istituto immerso tra alberi di cedro e querce argentate, che concedono lunghi momenti di silenzio, in cui è possibile percepire ogni minuscola forma di vita. La mia esistenza è molto meglio della desolazione di molti altri fuori. Il presente è precario; in questo momento incontrare persone, vivere con loro, scrivere le loro storie non è possibile. Quindi, come tutti gli altri qui, obbedisco alle regole del lockdown: uscire durante gli orari consentiti per andare a prendere il latte e le cose da mangiare (a volte seguita da un cane). La maggior parte delle altre ore del giorno, al chiuso, è facile cadere preda della depressione, anche se oggi faccio parte di una comunità più grande di persone che combattono la stessa battaglia.
Ricordo la mia penna, il mio taccuino e questo presente: un momento storico troppo importante per perderlo. Così mi viene in mente, a volte, che ogni casa è impermanente come il resto del tutto. In questa prigionia, non posso scrivere nel modo in cui scrivevo una volta (indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia letto o meno quello che ho scritto finora; ma anche questa preoccupazione del ‘chi leggerà’, così come la questione della morte, non mi preoccupa più). So solo che posso condividere l’unica cosa che conosco: la mia attuale verità. I miei sentimenti, come anche ciò che ascolto da tutte quelle persone con cui in qualche modo, da qualche parte, ho condiviso la vita quotidiana. E posso solo scrivere di come cerco di dare un senso al virus. Sono anche collegata al mondo esterno attraverso la radio tascabile a transistor di mio padre, un pezzo d’antiquariato che Satyanarayana (l’anziano elettricista di una vecchia via di Secunderabad) ha rimesso in funzione per me l’anno scorso. Penso a Satyanarayana e solo ora vengo a sapere da lui che era solito viaggiare ogni mattina (da quarantacinque minuti a un’ora) con un treno passeggeri da Yadadri, a diversi chilometri da Hyderabad, per poi raggiungere il suo negozio in autobus poco dopo mezzogiorno. Riparava i modelli più vecchi di registratori a nastro, televisori e radio, fino alle 17 circa, quando usciva per tornare a casa. Oggi il suo negozio è chiuso: anche lui è confinato in casa, nel suo villaggio.
Chissà se e quando tornerà alla sua specializzazione, che ha da decenni. Per fortuna il mondo esterno e le persone continuano ad entrare in questa stanza attraverso il telefono. Ricordo il tempo in cui riattaccavo, “spegnendo” le persone dal mio mondo, immersa com’ero nelle bozze dei miei manoscritti. Oggi, benché mi limiti ad aspettare che il telefono squilli, non vedo l’ora di sapere come sta qualcuno: tutte quelle persone il cui quotidiano si era per caso legato al mio durante un viaggio o per qualche altra circostanza occasionale. E mi rendo conto che c’è qualcosa di nuovo; che questo è l’effetto del presente su di loro. Non mi faccio illusioni su di me o su ciò che percepisco. Sono profondamente confinata e limitata. E penso a quelli che vanno a raccogliere storie, mentre io mi limito a scrivere di un mondo limitato all’interno della mia cerchia di contatti.
Per fortuna, la riflessione su se stessi e sul mondo è ancora libera, accessibile e immensamente possibile. Così rifletto, pur con molti dubbi. Queste sono le mie osservazioni, riflessioni basate su informazioni sentite e viste che per ora posso solo attingere dallo spazio in cui vivo e da una distanza imposta dalle circostanze. Ma lontana, non lo sono; e disimpegnata, non ancora. Ogni giorno è un nuovo osservare; il risultato di ciò che vado sentendo alla radio o guardando alla televisione; ogni giorno porta con sé qualcosa che prima non c’era. Nel complesso, questo momento storico sta arrivando in contemporanea con un sostanziale intento politico globale, che i comuni mortali come me non riescono a comprendere. E in questo momento di certo io non sto giocando il ruolo del corona-eroe o del corona-guerriero, ma mi sento una donna come tante, seppur immensamente consapevole e grata di essere relativamente più vicino di tante alla natura, al calore di quartieri familiari, alla gentilezza di molte persone comuni; una pura e semplice benedizione, nonostante io sia condizionata dallo spazio di una stanza, in una guest house.
Ascoltare la radio ogni giorno, per un tempo prestabilito, tre volte al giorno (con la semplice estensione di banda delle onde medie), e in particolare la programmazione dell’Akashvani Shimla Kendra, significa ascoltare un’ampia gamma di programmi folk, canzoni di ogni regione linguistica dello stato dell’Himachal Pradesh. Rispetto ai programmi radiofonici di altri stati dove ho vissuto, non mi sono mai imbattuta in una stazione che dedica così tanto spazio alla musica e ai musicisti folk (alcuni programmi hanno addirittura uno speaker che parla nella lingua/dialetto di quella particolare regione). E questo non è un fenomeno nuovo. Continua da anni. L’Akashvani Shimla Kendra possiede alcune rare registrazioni di musicisti folk, uomini e donne, di molti anni fa. È una stazione radio molto antica, che ha cominciato a trasmettere il 16 giugno 1955/56, ancor prima della formazione dello stato dell’Himachal Pradesh – almeno così mi dice un loro dipendente. In un certo senso, custodisce la tradizione delle diverse lingue parlate in questo stato, e delle espressioni dialettali che ricorrono nelle canzoni, specialmente ora che l’hindi è diventata la lingua universalmente utilizzata per gli usi ufficiali e per i principali scopi comunicativi.
Nel frattempo, la radio pubblica nazionale (All India Radio), con le sue numerose stazioni in tutto il paese, ha accompagnato le giornate di persone di ogni casta, classe, sesso e religione.
Agricoltori sul campo, camionisti sulla strada, sarti nel più piccolo angolo di ogni villaggio, le donne a casa, quegli uomini che stirano al bordo delle strade (un’usanza ancora praticata nei bylanes di ogni città dell’India, per chi si annoia a stirare i propri vestiti), ortolani e fruttivendoli. Anche in tempi come questi la radio nazionale si preoccupa di stabilire delle fasce orarie “tematiche” per l’allevamento, la zootecnia, il pollame, l’orticoltura, donne e bambini. Già all’indomani dell’indipendenza, vari governi hanno cominciato ad utilizzare la radio a loro vantaggio, e ancora oggi la radio è l’unico mezzo di diffusione delle notizie nei villaggi più remoti. Nonostante il numero dei telespettatori sia in costante aumento, la popolarità della radio non è diminuita.
Ferlinghetti io vorrei
di Gian Piero Fiorillo
Ferlinghetti, io vorrei
Che tu e Corso e Ginsberg
E Jack e tutti gli altri
Possiate non avere pace
Se pace è la coscienza stanca dei morti
Possiate rivoltarvi nella tomba
Irrequieta sentendo il vostro nome
E i versi
Sulla bocca degli adolescenti
Aspettando – sempre aspettiamo qualcosa
Che il prato partorisca altri fiori
Altre margherite
Altre canzoni e speranze
Vorrei sentire ancora la vostra voce
Sirene familiari e pericolose
Perché ci avete insegnato l’inquietudine
E che soltanto l’inquietudine è vita
E avete affondato i vostri denti
Nella nostra carne
Ferite dolci di miele e veleno
Strappandoci alle illusioni
Di esistenze annebbiate
E mute maschere sottomesse
Ferlinghetti ti maledico e ti abbraccio
Per avere strappato le calde
Pesanti tende di velluto e di corda
Che nascondono il retrobottega
Per avere scoperchiato i vasi
E bombardato gli idoli
Dal ghigno rassicurante
Sempre in cerca sempre in attesa
Come vagabondi cacciatori nel dharma
Come prede paranoiche
Chine a dissetarsi ai ruscelli sovversivi
Di versi sincopati e monchi
Di promesse rinnovellate
Di scadenze e rinvii
Sentendo sempre il terrore
Venire dall’ombra
E le nostre ombre
Nutrirsi di terrore
E di gioia
Anche la maschera è nuda
Adesso, Ferlinghetti
Il tempo la sa molto lunga
E noi siamo diventati conchiglie
Disperse su spiagge roventi
Innamorate del teschio di un cane
Dello scheletro di una barca
Della carcassa bianca
Della balena
Di una foglia ballerina nel vento
E sulle onde
Mentre poco più in là sulle dune
Le erbacce e il rosmarino
Contendono pochi centimetri
D’anima alla sabbia ospitale
Come l’eterno movimento
Del caso.
***
La Heimat è una cosa da matti? Intervista a Maddalena Fingerle
di Giovanni Accardo
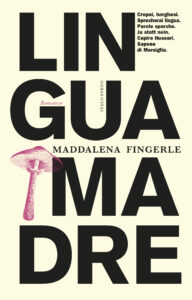
“Lingua madre” è il romanzo d’esordio di Maddalena Fingerle, bolzanina trapiantata a Monaco di Baviera, dove ha studiato germanistica e sta svolgendo un dottorato di ricerca in italianistica, pubblicato da Italo Svevo e con cui ha vinto l’ultima edizione del Premio Calvino, il più importante premio letterario italiano per esordienti. La vicenda è quasi interamente ambientata a Bolzano, con una parte a Berlino, e in qualche modo è una dissacrante riflessione su talune ossessioni che caratterizzano l’Alto Adige/Südtirol, soprattutto ossessioni linguistiche e identitarie. Un romanzo fortemente comico, specie nella prima metà, di grande maturità stilistica e di notevole freschezza.
Nell’intervista che segue proviamo a farci raccontare qualcosa in più dall’autrice, che i lettori di Nazione Indiana conoscono bene, visto che proprio qui ha pubblicato alcuni suoi racconti.
Paolo Prescher, anagramma di parole sporche, non sopporta le parole sporche, appunto, cioè quelle segnate dalla falsità, dall’ipocrisia. Ci fai qualche esempio?
Giuliana, la madre, utilizza espressioni politicamente corrette ma in maniera totalmente ipocrita, dice per esempio “sudtirolese di madrelingua tedesca” e “persona di colore”. Paolo odia la falsità con la quale lo dice e preferirebbe un atteggiamento sincero che per lui si rispecchia in espressioni come “tedesco” o “negro”.
Pur vivendo a Bolzano, anzi, forse proprio per questo, non crede nel bilinguismo. Perché?
Cresce in una famiglia italiana senza parlare il tedesco. Non crede nel bilinguismo altoatesino perché è qualcosa che sente nominare a livello politico ma di cui non trova riscontro nel quotidiano, tanto che il tedesco lo impara da solo con i libri e lo migliora poi a Berlino.
Il protagonista si accorge che non basta conoscere il tedesco per sentirsi davvero figlio della sua terra, l’Alto Adige/Südtirol, anche perché, ragiona, la vera lingua è il dialetto sudtirolese, inaccessibile agli italiani, che proprio di un dialetto sono orfani.
Per Paolo, ossessionato dalle parole, la mancanza di un dialetto è qualcosa di molto sofferto e che invidia, per esempio, all’amico napoletano che conosce a Berlino, ma in realtà anche a Jan, amico d’infanzia, che parla dialetto sudtirolese. Vorrebbe anche lui una lingua della famiglia, una parlata marcata, forte, decisa. Nei confronti del dialetto prova (in)sofferenza, legata all’essere cresciuto in un luogo di cui conosce una sola lingua. Personalmente non credo che il dialetto sia inaccessibile, penso però sia difficile da imparare in età adulta senza che faccia effetto scimmiottamento.
E ritiene la Heimat una cosa da matti.
La Heimat è una cosa da matti. Lo pensa da ragazzino, poi però rivaluta il concetto di Heimat una volta arrivato a Berlino, quando, solo, si accorge che una specie di Heimat, legata alla figura del padre, ce l’ha avuta e l’ha persa insieme a lui: “L’unica cosa brutta di Berlino è che mi sento un po’ solo perché non ho amici e non parlo praticamente con nessuno. Anche a Bolzano non avevo amici e non parlavo praticamente con nessuno, ma finché c’era papà io non mi sentivo così. Forse era quella la mia Heimat, non sentirmi solo.”
Per Maddalena Fingerle il rapporto con la sua terra d’origine può essere solo conflittuale? Dipende dall’essere italiani? Credi che per un tedesco, anzi un sudtirolese di madrelingua tedesca (sic!), sia diverso?
Sul piano della realtà non lo credo, no, penso però che ci sia ancora una forte divisione tra i mondi di madrelingua italiana e tedesca. E che ci siano molti pregiudizi. E diffidenza. A volte mi stupisco pensando che si possa vivere anni in un luogo senza conoscere una delle due lingue che lì vengono parlate. Mi sembra assurdo, possibile che non ci sia un minimo di curiosità, almeno? In linea generale è vero che le persone di madrelingua tedesca tendenzialmente sanno l’italiano, mentre le persone di madrelingua italiana raramente sanno il tedesco e, ancora più raramente, il dialetto; ma ci sono eccezioni, ovviamente. Il mondo sudtirolese di lingua tedesca l’ho conosciuto solo l’anno scorso, dopo il Calvino, quando sono stata accolta alla biblioteca Teßmann. Avevo paura di non capire e invece ho avuto una sensazione simile a quella che ho provato in Puglia al Festival Armonia: mi sono sentita a casa, che è molto raro, per me.
È solo trasferendosi a Berlino che Paolo finalmente scopre le parole pulite e trova un luogo dove si sente a casa. Pensi che per amare la propria terra sia necessario andar via, cioè prenderne le distanze?
Paolo si sente a casa soprattutto quando conosce Mira, di cui si innamora. Lei gli pulisce le parole ed è grazie a lei che Paolo riesce ad amare Bolzano, riscoprendola: ciò che prima gli faceva orrore, insieme a Mira diventa improvvisamente meraviglioso perché lo è per lei e lui lo guarda attraverso il suo sguardo. Paolo da piccolo odia così tanto la città che ha bisogno di allontanarsi per poterla poi amare. In generale, nella realtà, non lo so. Io, che vivo a Monaco e sto costruendo casa in Allgäu, sicuramente inizio a sentirne nostalgia. Ma è più per le persone e per la radio italiana in sottofondo, che per il luogo; forse dipende anche dal fatto che non ci si può spostare a causa della pandemia.
Vero protagonista del tuo romanzo è la lingua, anzi, le parole. Le cose non esistono, ci vuole dire Paolo Prescher, finché non le nominiamo, solo dopo acquistano la loro identità, evocano emozioni, hanno odori?
Assolutamente sì! La parola per Paolo è la cosa, ha un rapporto sinestetico e ossessivo con la lingua e con le letture e la ripetizione. Ci sono parole sporche e pulite, ma anche parole in grado di sfamarlo, parole (e voci) che lo spaventano e parole che lo tranquillizzano.
A partire dalla terza parte assistiamo a una progressiva normalizzazione dello stile e anche del protagonista, come mai?
Il linguaggio segue le fasi della vita di Paolo in una sorta di climax in tre atti. Nella prima parte, a Bolzano, la voce è quella di un ragazzino, è la sua naturale di quando è a casa ed è insofferente e addolorato; nella seconda parte, ambientata a Berlino, il linguaggio, attraverso l’innamoramento, diventa positivo e si calma, Paolo stesso è come anestetizzato, ciò che prima lo infastidiva ora lo riscopre grazie a Mira. Nella terza e ultima parte, in cui Paolo perde il contatto con il reale, le parole si svuotano invece di senso, il mondo si ovatta e si allontana, lasciando così spazio al delirio finale.
Le prime due parti, molto pirotecniche linguisticamente, sono fortemente dissacranti e derisorie, è la lingua più che la storia a decidere il registro di un romanzo?
Non credo che ci sia una divisione dicotomica tra lingua e storia che vanno invece di pari passo. L’esperimento linguistico è nella terza parte, dove italiano e tedesco si mescolano, le parti dissacranti sono legate al fastidio che prova Paolo nei confronti dell’ipocrisia bolzanina, nella parte e nell’ultima parte. È vero però che una storia priva di una voce adatta tendenzialmente non mi affascina e, quando leggo, cerco un registro che sia deciso, come Paolo con i dialetti.
Paolo ha un giudizio molto duro sui suoi insegnanti di Bolzano, dice che s’interessano solo di radici e territorio, di beghe sui monumenti e sui nomi delle vie, mentre sono disinteressati agli scrittori che arrivano da fuori. Condividi?
Non ha importanza se condivido o meno perché sono due piani differenti, questo è il filtro di Paolo, all’interno della finzione letteraria e non la realtà. Lui si innervosisce per il provincialismo e la megalomania dei suoi insegnanti che, se non organizzano loro gli incontri con gli scrittori, se ne disinteressano.
Come pensi che sarà accolto il tuo libro dai lettori di Bolzano e dell’Alto Adige? Come vorresti che fosse letto?
Vorrei che venisse letto come una storia di finizione che racconta di un giovane uomo ossessionato dalle parole e non solo come una storia su Bolzano. Certamente Paolo non avrebbe le ossessioni che ha se fosse cresciuto, per esempio, a Roma: ne avrebbe avute altre e la storia sarebbe stata diversa. Ma sono proprio le ossessioni che mi interessano. È il filtro di Paolo, il suo modo di vedere e sentire le parole è ciò che ho voluto raccontare, partendo dall’idea che fosse l’esasperazione di idiosincrasie che possiamo avere tutti, evitando di etichettare le sue stranezze come malattia mentale.
Possiamo rivelare un segreto ai lettori? Il tuo incontro con il premio Calvino risale al 2009, quando eri ancora una studentessa di liceo, ed è merito di Giorgio Vasta, la cui lingua, tra l’altro, è da te estremamente apprezzata.
Certo, e solo a pensarci mi emoziono perché quel ciclo di incontri, organizzato da te (sveliamone un altro di segreto!) me lo ricordo ancora. Mi ricordo soprattutto Giorgio Vasta che parlava del Calvino e delle schede di lettura e pensai per la prima volta: parla pulito. Per me quell’espressione designava una precisione di linguaggio, un rispetto e una correttezza che non avevo mai percepito così. Ritrovai tutto ciò nel romanzo Il tempo materiale.
Un’ultima domanda sugli scrittori italiani che ti hanno formata e in un certo senso dato una lingua.
A nove anni mi coprivo di ridicolo vantandomi di aver letto Il Gattopardo, recitavo le battute di Angelica a memoria, probabilmente senza nemmeno capirle. Allo stesso modo leggevo la poesia italiana del Novecento, mi trascinavo quei volumi Einaudi ovunque e giocavo a cercare le ricorrenze. Quando leggevo Bernhard non avevo bisogno di mangiare perché mi sfamava e mi faceva ridere e mi faceva piangere. Ho pensato mi scoppiasse il cuore quando ho letto Bassotuba non c’è perché Nori è così bravo – mi dicevo, terrorizzata dalla velocità del battito – ma così bravo che sembra morto. L’Adone è il mio nuovo tormentone (da quattro anni, ormai), il modo in cui Marino riesce a giocare con i riferimenti intertestuali mi diverte e mi affascina così tanto che mi viene voglia di urlare. Bisognerebbe leggerlo a scuola! E non le parti noiose…
Pasolineggiando
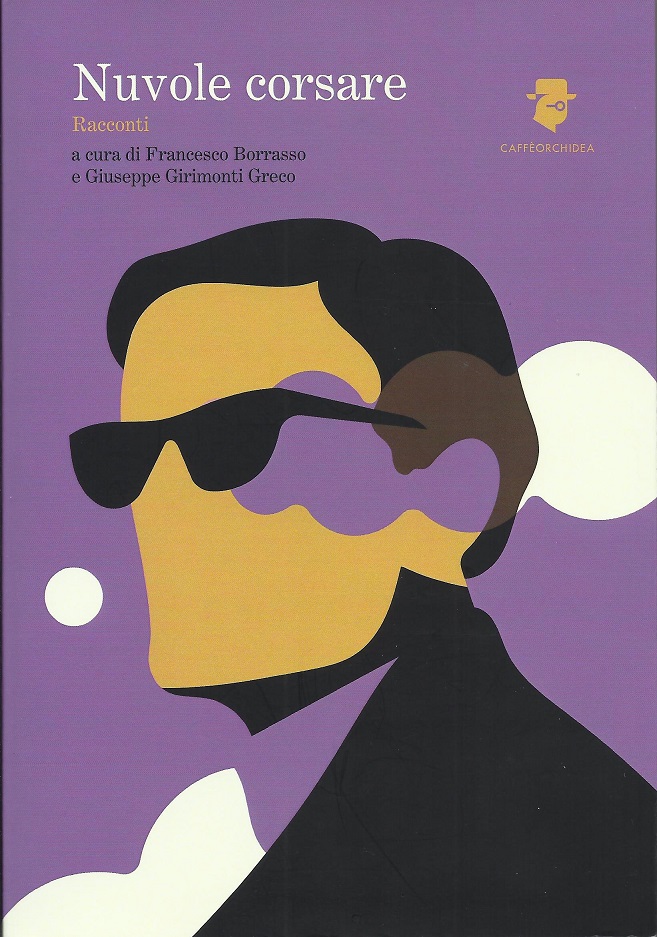 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi
Autori vari, Nuvole corsare, 2020, Caffèorchidea Editore.
Anno di antologie, il 2020. Solo per citarne un paio: la Piccola antologia della peste curata da Francesco Permunian (Nazione Indiana ne parla qui) e appunto questa, Nuvole corsare. Ma ne sono uscite molte altre, su carta e in e-book, soprattutto legate al tema dell’epidemia. Come se questo periodo di destabilizzazione sociale avesse spinto gli scrittori (e i poeti) a coalizzarsi contro un nemico comune. Che non è la pagina bianca generata dalla depressione e dal conseguente blocco della creatività, bensì l’isolamento in sé, l’interruzione del rapporto con i propri simili. Lo scrittore inventa storie (così come il poeta inventa immagini) per condividerle nel mondo in cui vive. È impossibile scrivere su un’isola deserta sapendo che ciò che si scrive non raggiungerà mai nessun altro lettore al di fuori di sé stessi. Lo scrittore è un animale sociale. E Pier Paolo Pasolini lo era molto più di altri. Non per nulla, a quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa, sopravvive attraverso testi che continuano ad essere stampati e letti, che si insinuano nella scrittura delle nuove generazioni di autori come se il controverso narratore-poeta-saggista-regista-drammaturgo continuasse a scrivere per loro tramite.
Nuvole corsare è dunque un esperimento di questo tipo. I curatori, Francesco Borrasso e Giuseppe Girimonti Greco, devono aver pensato di misurare la presenza spirituale di Pasolini invitando quindici narratori, molto diversi tra loro per visione letteraria ed età anagrafica (all’incirca dai trenta ai cinquant’anni), a scrivere un “racconto pasoliniano”. Non si è chiesto di copiarne lo stile, o i temi, o le ambientazioni, ma semplicemente di ispirarsi a lui. Quindici autori più uno, perché un’iniziativa di questo tipo, progettata da un editore attento all’originalità della veste grafica come Caffèorchidea, non poteva se non coinvolgere anche l’illustratore. Quello che Stefano Marra realizza in copertina è a mio avviso il primo “racconto pasoliniano” dell’antologia: un ritratto posterizzato dello scrittore riconoscibile nei suoi tratti essenziali, con le nuvole corsare che gli attraversano il volto. Ed è con questa immagine quasi subliminale che Pasolini permea ogni racconto, dando vita a voci narranti – parte in prima persona, parte in terza – che alimentano una vera e propria polifonia pasoliniana.
Potere e violenza, provocazione e scandalo, personaggi di periferia simili ai sottoproletari delle borgate romane, amori omosessuali, situazioni sadiane, questa la materia alla base dei racconti. Impossibile dire chi più abbia centrato lo spirito dell’antologia, ogni lettore troverà la chiave per la propria valutazione. Ci sono citazione velate di testi e di film, da Petrolio a Salò (ad esempio in Bertelli e Policastro), visioni distopiche (Mirabelli e Sorrentino) o visioni ucroniche (bellissima quella di Zaccuri, autore tra l’altro presente anche nella Piccola antologia della peste), gioiellini di impeccabile fattura com’è nello stile di Sinigaglia (che in questi ultimi anni sta pubblicando libri di alto livello letterario), racconti che scavano nella psicologia dei femminicidi come in Serena Penni (che scrive quasi un seguito del suo Il vuoto, uscito due anni fa), oppure ancora storie delicate di relazioni omosessuali, come quella “foscoliana” tra un professore e un giovane allievo narrata da Di Liberto (scrittore tra l’altro attivissimo nella promozione della lettura con il gruppo su Facebook Billy, il vizio di leggere), o semplici storie di malavita come in Simone Innocenti.
Merita due parole l’origine del titolo scelto per l’antologia, per quanto intuibile da parte degli appassionati pasoliniani: Nuvole corsare è il risultato del connubio tra il Pasolini poetico e struggente del cortometraggio Che cosa sono le nuvole (uno dei sei episodi del film Capriccio all’italiana, 1968) e il Pasolini agguerrito e provocatorio di Scritti corsari, la raccolta di articoli uscita postuma l’anno stesso della morte, nel 1975. Estrema sintesi, in fondo, dello spirito di uno dei più originali e discussi artisti italiani della seconda metà del Novecento.
Di seguito, gli autori dei quindici racconti presenti nell’antologia: Diego Bertelli, Giorgio Biferali, Angelo Di Liberto, Ilaria Gaspari, Simone Innocenti, Elena Giorgiana Mirabelli, Jacopo Narros, Serena Penni, Gilda Policastro. Ivano Porpora, Fabio Rocchi, Ezio Sinigaglia, Piero Sorrentino, Giorgia Tribuiani, Alessandro Zaccuri.
L’Anno del Fuoco Segreto: Barbablù_1
La descrizione del progetto L’Anno del Fuoco Segreto, si può leggere QUI.

di Francesco D’Isa
– Questa storia non ha senso.
– Lo so.
– Ma quando è iniziata?
– Appena ho aperto il suo computer.
– Cioè?
– Ora ti spiego, non guardarmi così.
– Scusa, è che sono preoccupata. Ti guardo così perché sono preoccupata. È una roba strana, secondo me devi andare da qualcuno.
– Ci sono stata, che credi, poi ti dico. Voglio raccontarti tutto, dammi tempo. Lo so che mi serve aiuto.
– Ok ti ascolto, scusa.
– Insomma, tempo fa sono entrata nel suo studio all’improvviso. Non lo faccio mai, però boh, è capitato. Appena mi ha visto ha chiuso il computer di scatto e si è rigirato come non ha mai fatto, mi ha chiesto che cosa volevo, che stava lavorando… io sono uscita subito.
– Magari guardava un porno.
– L’ho pensato anch’io, infatti non ho dato importanza alla cosa. Tanto più che poco dopo è uscito e si è scusato.
– Porno sicuro.
– Il fatto è che dopo mi ha detto una cosa strana.
– Cosa?
– Mi ha detto che potevo fare tutto, che non aveva segreti per me, che teneva il telefono senza password eccetera eccetera, ma che non dovevo mai e poi mai aprire il suo computer senza di lui. Ho chiesto perché è mi ha detto che era una questione di fiducia.
– Una specie di prova?
– È quel che ho chiesto, ma è stato evasivo.
– Boh. Comunque anche a me darebbe noia, il computer è una roba privata.
– Sì, certo. È che mi ha fatto strano che me l’abbia detto. Perché sottolineare l’ovvio? Così sembra che nascondi qualcosa.
– Vero. E quindi?
– E quindi niente, il giorno dopo quando è uscito ho aperto il computer.
– Ovvio. E..?
– E nulla, c’era la password. Ne ho provate due o tre, poi ho rinunciato.
– Ma cosa c’entra questo con…?
– Ora ci arrivo. Un giorno, tipo un mese dopo, mi è tornata in mente una vecchia favola, non so nemmeno perché, hai presente la storia di Barbablù?
– Il tipo che ammazza le mogli?
– Esatto. Barbablù ha una stanza segreta e dice di non aprirla, anche se dà la chiave alla moglie. Lei ovviamente la apre e trova tutte le ex mogli assassinate, eccetera.
– Sì sì ricordo, ma…?
– Insomma, ho aperto il computer e ho provato come password “barbablù”
– Tu sei scema.
– Non ha funzionato.
– Ma dai.
– Poi però ho messo Barbablù_1, con maiuscola, carattere speciale e numero, ed ha funzionato.
– Merda.
– Esatto, merda. E sai cosa c’era dentro il computer?
– Cosa?
– Nulla. Nulla di nulla. Le sue robe di lavoro, punto.
– Vabbé…
– Che scherzo di merda, ho pensato.
– Già.
– Però non ho detto nulla. Alla fine ero io nel torto, il computer è suo e anche a me darebbe fastidio se frugasse nel mio. Non che nasconda nulla, per carità, è più, boh…
– …una questione di privacy.
– Esatto. Fatto sta che da allora è cominciata. La prima volta non ci ho fatto molto caso, è durato solo un istante, ho pensato di essere stanca o cose così. Poi però è risuccesso e ho cominciato a preoccuparmi.
– Ma uguale?
– Non proprio, ma simile. La durata sì.
– E poi?
– Poi è accaduto ancora, e ancora, e ancora. Tipo una volta ogni dieci giorni, ma senza regolarità, poteva accadere anche due giorni di fila e poi nulla per due settimane.
– Per quanto tempo?
– Sempre per poco ma sempre di più, direi da uno a cinque secondi.
– Cinque secondi sono tanti.
– È quel che ho pensato.
– Ma glielo hai detto?
– Mai.
– E non sei andata da un medico?
– Subito, mi sono fatta consigliare uno psichiatra da Laura e ci sono andata.
– E che ha ti detto?
– Ha detto che le cause potevano essere molte e mi ha fatto fare molti controlli, dai quali non è riuscito a capire nulla. Alla fine mi ha detto che poteva essere lo stress – la risposta che dai quando non si capisce nulla. Mi ha dato un po’ di Trilafon.
– E..?
– Ho seguito la cura ma niente, i glitch continuavano. Non solo, stavo persino peggio. Così niente, ho chiuso con lo psichiatra.
– Non so che dire, hai provato anche altri medici?
– Ho fatto anche una visita neurologica approfondita, una tac, mille analisi del sangue, ma al momento è tutto regolare. Niente anomalie, niente tumori, niente di niente.
– Meno male.
– Sì, ma anche no. Fa quasi più paura. Il problema è che peggiora.
– Cosa ti succede di preciso?
– All’inizio vedevo il suo viso tremolare, come se ci fosse un disturbo di ricezione televisiva, hai presente? Una specie di fruscio, poi si metteva di nuovo in fase.
– Cristo.
– Ed è peggiorata. Non solo nella durata, ma anche nella qualità. Il suo viso, che prima si limitava a vibrare e tornare al suo posto, ha cominciato a cambiare anche nelle forme e nei colori. Una roba un po’ fosforescente, verdina e blu. Nulla di chiaramente riconoscibile ma nemmeno di completamente alieno. Non saprei descriverlo. Hai presente quelle immagini create dalle reti neurali dei computer in cui sembra ci siano degli oggetti e invece non c’è nulla?
– Ovviamente no, non faccio il tuo lavoro.
– Vabbè, è tipo una deformazione, ma nel farlo lascia i confini vaghi, indefiniti. Non è un viso che diventa mostruoso, ma come se apparisse attraverso un filtro… non so, hai presente i papi di Francis Bacon? Una roba così, una specie di filtro orrorifico sulla realtà.
– Non ci sto capendo nulla.
– Tu sei miope no?
– Lo sai.
– Ecco, immagina una cosa tipo l’ammasso sfocato che percepisci quando sei senza occhiali e non riesci a capire che cosa stai vedendo, se fosse perfettamente a fuoco.
– Davvero: boh. Ma sempre il viso?
– No, ora accade con quasi tutto il corpo.
– Merda.
– Già. Inoltre non è più solo una cosa visiva: mi capita di sentire anche la sua voce come se provenisse da una vecchia radio…
– Questa storia è allucinante.
– Letteralmente. Dura sempre poco, anche se è un poco relativo. Tre secondi sono abbastanza per morire di paura ed essere certi di vedere quel che si vede, ma non per capirci qualcosa. Le prime volte mi spaventavo, gridavo, lui non capiva e inventavo delle scuse. Si è insospettito e preoccupato, anche per questo era d’accordo con lo psichiatra. Ormai ci ho fatto l’abitudine e non mi spavento nemmeno più di tanto, tranne…
– Ma non gli hai detto nulla? Forse dovresti.
– Ci ho pensato. Se non ci fosse stata quella storia di Barbablù ci avrei parlato subito. Ma così, non so, qualcosa mi ferma. Ho paura.
– Ci credo che hai paura.
– Il fatto è che ora…
– Dai non fare così…
– È che non so più che fare.
– Lo so, ti capisco. Ma vedrai che ne veniamo a capo.
– È una roba tremenda, capisci? T r e m e n d a. Ieri io…
– Aspetta ti prendo un fazzoletto.
– Non importa faccio con questo.
– Vuoi un po’ d’acqua?
– Lascia fare, mi riprendo, scusa.
– Scusa di che? Sei stata anche fin troppo forte – e stupida – dovevi parlarmene prima.
– Insomma ieri mi ha baciato e mentre lo faceva è successo. Anche col tatto. Anche col tatto, capisci?
– Ma cosa?
– Ma che ne so, era tipo come toccare un fantasma.
– Mai toccato uno.
– Appunto.
– Non so che dirti, davvero.
– Sono disperata, anche per questo ti ho chiesto aiuto.
– Come nella favola.
– Cosa?
– La moglie di Barbablù viene aiutata dalla sorella.
– Ah già. Ma che faccio adesso, asptto i cavalieri?
– Purtroppo non abbiamo fratelli, dobbiamo cavarcela senza uomini.
– Meglio. Ma non so come.
– Ti succede solo con lui?_
– Sì.
– Lascialo allora. Lo ami?
– Io? Sì certo… insomma, questa storia mi ha messo alla prova ma…
– Così non puoi andare avanti. Se non trovi una soluzione forse dovresti lasciarlo.
– Non credi che il problema sia mio? Che potrebbe ripresentarsi?
– Se non lo sanno i medici figurati io. PeRò no, non è un problema tuo, è vostro. Se ti succede solo con lui è vostro, anche se lo percepisci solo tu.
– In un certo senso è vero.
– Parlaci, diglielo. Vedi come reagisce. Raccontagli tutto e in base alla reazione scopri il da farsi. Che ne sai, forse scompare tutto appena ci parli, così com’è successo all’inizio.
– Forse hai ragione.
– Non vedo alternative, dovete parlarne.
– È che non so come potrebbe reagire.
– Dio santo, si preoccuperà, è ovvio, ma se ti ama cercherà di aiutarti, che deve fare?
– Capirà, per quel che si può capire.
– Non so come potrebbe prenderla.
– State insieme da quanto, dodici anni? Un po’ lo conosci, no?
– In realtà non si conosce una persona neanche dopo cent’anni. Non sai quanto di quel che vedi è una tua proiezione. Le persone non sono un regalo da indovinare prima di scartarlo, non c’è un’essenza definita da scoprire una volta per tutte. Sono più un processo… a dirla tutta questo vale per qualunque cosa_.
– Ora passi da Barbablù al Sofista.
– Dico davvero: non c’è un Alessandro che conosco o non conosco, c’è solo Alessandro più Rosa, o alessandro attraverso Rosa.
– Ok, e ora che questo Alessandro+Rosa è diventato un mostro, come la mettiamo?
– Non è diventato un mostro. C’è come un’interrferenza, qualcosa che si frappone nel passaggio tra Alessandro e Rosa e rende la lettura impossibile.
– Non è che ti sei presa qualcosa di strano ultimamente’
– Niente più in là di una birra. Dai per scontato che quel che vedo sia un’allucinazione: perché è una roba strana, perché lo vedo solo io, perché in qualche modo dura poco… ma non sai con certezza quale delle mie percezioni è corretta, nesusno lo sa.. Se ci pensi tutto è cominciato proprio quando ho messo in dubbio la mia conoscenza, con quella storia della stanza segreta.
– Stanza segreta?
– Sì, il computer, penSavo ancora a Barbablù.
– Basta con questa storia, Alessandro non ha ucciso nessuna ex moglie. Nemmeno ce l’ha una ex. Sei la sua pppdf e unica moglie.
– Sì ma cjf aslkd
– njfedf kklòll
DDgjkfv r credi llòpl,
– kerufhj4r–
.dlknvnelnvk ?
,jsfndjkvn c
ddsdsa con lui sck k
È arr ejklvr
n ewjkcjekwnv lefncvew ew c 1\e9320fj30+cnweioc opmc39022 i
**
Immagine di Francesco D’Isa
Francesco D’Isa (Firenze, 1980), di formazione filosofo e artista visivo, ha esposto internazionalmente in gallerie e centri d’arte contemporanea. Dopo l’esordio con la graphic novel I. (Nottetempo, 2011), ha pubblicato saggi e romanzi per Hoepli, effequ, Tunué e Newton Compton. Il suo ultimo saggio è in Trilogia della Catastrofe (effequ, 2020) mentre il suo ultimo romanzo è La Stanza di Therese (Tunué, 2017). Direttore editoriale dell’Indiscreto, scrive e disegna per varie riviste.
Lo sperimentalismo e il ‘cielo contemporaneo’ di Elio Pagliarani
di Giovanni Palmieri
Elio Pagliarani e Guido Guglielmi, nell’antologia intitolata Manuale di poesia sperimentale da loro curata ed edita nel 1966 presso Mondadori, così scrivevano:
Sperimentalismo […] in questo senso: di verifica e di ricostruzione critica delle effettive funzioni della lingua, oggi che, nelle moderne civiltà industriali, i modelli linguistici vengono realizzati, con varie e complesse conseguenze, dagli strumenti di comunicazione di massa.[1]
Lo sperimentalismo poetico viene dunque inteso qui come necessaria reinvenzione critica di una nuova funzione poetica. Negli anni Sessanta, infatti, la funzione della poesia era bloccata da uno stato di lingua che tendeva ad imporre, attraverso la comunicazione di massa, modelli linguistici poveri e del tutto funzionali ad una visione del mondo basata sull’utilitarismo mercantile e sul consumismo.
Non si volevano recuperare i modelli letterari del passato, né orientarsi verso un neo-crepuscolarismo nostalgico. Si cercava invece una proiezione, appunto sperimentale, verso un futuro che rinnovasse la fiducia nell’atto poetico. La poesia sperimentale doveva perciò confrontarsi con i nuovi modelli linguistici in voga per difendersene e per attaccarli. In una parola, per sopravvivere, mantenendo un senso che non fosse quello, perdente, di un isolamento eburneo dalla realtà e dalla comunità sociale. Parallelamente si doveva anche evitare un appiattimento sui modelli linguistici esistenti e massificati. Quello che poi è invece accaduto con la deriva del postmoderno poetico negli anni Ottanta-Novanta.
Il problema non era, dunque, più soltanto quello di contestare gli istituti tradizionali della poesia e del sistema letterario, avanzando con la bandiera delle avanguardie storiche o del modernismo. Era invece quello di contestare dall’interno i nuovi modelli linguistici che legittimavano ed esprimevano quell’ideologia mercantile che l’organizzazione sociale dei discorsi e dei segni veicolava. Così ad alcuni dei poeti che formarono il gruppo dei Novissimi (1961)[2] sembrò necessario distruggere il codice linguistico ordinario per distruggere l’ideologia che vi era sottesa. L’abbaglio di tale posizione fu acutamente segnalato da Maria Corti già nel 1965:
L’equivoco di base sta nel considerare che la permanenza nel sistema e la conseguente comunicabilità siano un limite alla libertà linguistica e non invece lo strumento, il mezzo, della libertà stessa. L’innovazione o creazione linguistica è prodotta da un mutarsi dei rapporti della parola o del sintagma entro il sistema; sottratta ad esso, la parola cade nel vuoto extra atmosferico del cosmo, ruota inerte senza possibilità di evocazione e di innovazione.[3]
Inoltre, chi (come certe avanguardie) ha inteso distruggere il linguaggio a mezzo linguaggio è pervenuto ad un linguaggio molto più artificiale, meno libero e più convenzionale di quello contro cui aveva combattuto.
Un percorso individuale
Elio Pagliarani (1927-2012) partecipò al gruppo organizzato dei Novissimi e del Gruppo 63 ma da una posizione del tutto personale e appartata, anche perché scelse la strada di una poesia a vocazione narrativa, assai diversa, se non opposta, a quella della frantumazione cellulare del discorso propria di Sanguineti e di Balestrini.
Scheda dell’opera
Poemetto scritto tra il 1954 e il 1957 e ambientato a Milano nel 1948 (ma prima delle elezioni), La ragazza Carla è stato edito integralmente solo sul n. 2 del “Menabò di letteratura” del febbraio 1960 (pp. 143-169). Più volte ristampato, ha avuto nell’edizione Mondadori del 1997 una sola variante importante di cui parleremo.
La ragazza Carla – ha affermato Pagliarani – è una “moderna educazione sentimentale, cioè come si impara o non si impara a crescere”.[4]
Metricamente, il poemetto – composto da versi polimetri e prosa ritmata – si articola in tre parti a loro volte suddivise rispettivamente in nove, sette e sette sezioni, a cui corrispondono i vari nuclei narrativi. Si tratta di un verso “ a fisarmonica che si restringe e si allunga”[5] in base a esigenze espressive sino a raggiungere le ventidue sillabe. Anche la disposizione grafica dei versi tende a realizzare visivamente questa “fisarmonica” metrica.
Nelle parti liriche, messe in corsivo e affidate ad una sorta di voce recitante che commenta il testo in senso lirico-corale, prevale invece l’endecasillabo. Un endecasillabo cantabile, con pochi rime, poco ritmato perché spesso privo degli accenti tradizionali. Giuliani ha parlato di un “verso epico” appartenente al filone Eliot, Pound, Majakovskij, Brecht.[6] Un Brecht, direi, senza propulsione pedagogica ma con un’intensa tensione etica. In sostanza, Pagliarani usa quello che si chiama “verso sintattico” (arbitrario nell’a capo non ritmico) ma lo contamina con ampi spazi di versificazione tradizionale come l’alternarsi di endecasillabi e settenari.
Lingua e stile. La struttura narrativa del poemetto è basata su una narrazione diegetica in terza persona con frequenti dialoghi, intercalati a commenti epico-lirici di una sorta di voce corale. In genere la voce narrativa è estranea all’azione narrata ma vi sono alcune significative eccezioni e in ogni caso la narrazione è quasi sempre condotta nell’ottica del personaggio protagonista, cioè di Carla.
La prima parte del testo ha un movimento circolare: l’episodio iniziale dal punto di vista della fabula è in realtà l’ultimo e ad esso si ricollega la sezione finale. Analessi, retrospezioni e flashback sono ovunque presenti. La sintassi volge verso l’abbassamento prosastico e colloquiale con frequenti espressioni del parlato. Anacoluti, pleonasmi, dialettalismi e concordanze ad sensum sono molto diffusi. Si trovano anche diversi registri compresenti come quello cronachistico, quello epico-lirico, quello grottesco, quello onirico ecc. Non vi è alcuna imitazione neorealistica della parlata dei personaggi perché i vari materiali linguistici sono continuamente sottoposti a montaggio, a contaminazioni interne, a interruzioni, a giustapposizioni o sono bruscamente intercalati tra loro. Tra questi materiali troviamo ad esempio elementi della lingua letteraria in contrasto con elementi della lingua parlata oltre a contaminazioni di diversi linguaggi tecnici con ampie porzioni di testi altrui direttamente citati. Si va da un manuale di dattilografia, all’epistolografia commerciale (anche in inglese o in francese), da un manuale di diritto internazionale sino a citazioni di canzonette o filastrocche debitamente deformate. Insomma la lingua di Pagliarani è una lingua polimaterica in cui (anche con effetti di lieve surrealtà) domina un sapiente montaggio che ricorda quello cinematografico di Ejzenštejn. È del resto noto che il poeta ebbe in animo di tradurre cinematograficamente il proprio poemetto.
Per esemplificare lo sperimentalismo di Pagliarani, ho scelto un’analisi a campione di tre loci selecti della Ragazza Carla che è e resta il suo capolavoro.
Primo locus
Un amico psichiatra mi riferisce di una
giovane impiegata tanto poco allenata
alle domeniche cittadine che, spesso, il
sabato, si prende un sonnifero, opportu-
nemente dosato, che la faccia dormire
fino al lunedì. Ha un senso dedicare a
quella ragazza questa “Ragazza Carla”?
1
Di là dal ponte della ferrovia
una trasversa di viale Ripamonti
c’è la casa di Carla, di sua madre, e di Angelo e Nerina.
Il ponte sta lì buono e sotto passano
treni carri vagoni frenatori e mandrie dei macelli 5
e sopra passa il tram, la filovia di fianco, la gente che cammina
i camion della frutta di Romagna.
Chi c’è nato vicino a questi posti
non gli passa neppure per la mente
come è utile averci un’abitudine 10
Le abitudini si fanno con la pelle
così tutti ce l’hanno se hanno pelle
Ma c’è il momento che l’abito non tiene
chissà che cosa insiste nel circuito
o fa contatto 15
o prende la tangente
allora la burrasca
periferica, di terra,
il ponte se lo copre e spazza e qualcheduno
può cascar sotto 20
e i film che Carla non li può soffrire
un film di Jean Gabin può dire il vero
è forse il fischio e nebbia o il disperato
stridere di ferrame o il tuo cuore sorpreso, spaventato
il cuore impreparato, per esempio, a due mani 25
che piombano sul petto
Solo pudore non è che la fa andare
fuggitiva nei boschi di cemento
o il contagio spinoso della mano.[7]
Sono questi i versi iniziali che costituiscono la prima sezione della prima parte del poemetto. Dopo la descrizione topografica e ambientale, viene evocata ai vv. 13-20 l’immagine di un suicidio per precipitazione dal ponte ferroviario di via Ripamonti (Milano). Si tratta di una riflessione ipotetica e smarrita sui meccanismi che possono portare al suicidio.
Sino all’ed. Mondadori del 1979, la lezione del v. 13 era “l’abitudine non tiene”. Nell’ed. 1997 troviamo invece “l’abito non tiene”.[8] La variante rimanda al latino “habitus” ed innalza “l’abitudine” alla dignità psicologica di “modo di comportarsi”, o meglio di “forma mentis abituale”. Ciò che nel suicida non tiene più – la sua “burrasca […] di terra” – è proprio l’abitudine alla vita. E si veda in questo senso l’esergo iniziale. La nuova lezione, inoltre, consente anche di variare la serie del lessema “abitudine” già presente ai versi 10 e 11.
Il film di Jean Gabin (v. 22) non fa riferimento ad un film visto al cinematografo da Carla che peraltro sta tornando a casa dopo la scuola serale (come chiarirà poi il testo), ma ha una funzione particolare. Tra l’altro, credo che i film qui sottintesi siano due: Il porto delle nebbie (Le quai des brumes, 1938) di Marcel Carné con Jean Gabin è qui evocato proprio dall’espressione “fischio e nebbie”, mentre L’angelo del male (La bête humaine, 1938) di Jean Renoir con Jean Gabin – che è un film ferroviario terminante col suicidio del protagonista che si lancia dal treno in corsa – è ricordato forse da quel “disperato / strider di ferrame” dei vv. 23-24.
Mi sembra che la funzione del richiamo a Jean Gabin e al suo tipo di film abbia la funzione di amplificare l’atmosfera. C’è qui come una filtrazione della realtà del testo con l’immagine filmica, un raddoppio di segni. Vi è, infatti, una totale congruenza tonale tra il contesto poetico e il clima dei film citati. Vi è cioè un’identità di atmosfere: squallide periferie, nebbia, treni, suicidi, equivoci, personaggi marginali, vinti, spesso l’incontro traumatico tra un uomo e una donna ecc.
Dunque la verità che può dire uno dei tanti film di Jean Gabin (e si ricordi che a Carla non piacciono quei film) è quella sulla crudezza o crudeltà della vita. Una vita in cui spesso i falliti, i reietti della società, vengono spinti verso l’abiezione da una forza incoercibile. A queste crudeltà Carla non è ancora pronta, come non è pronta all’inopportuna avance di Piero, il compagno di scuola che, accompagnandola a casa, le mette le mani sul petto.
Nei versi che sto commentando, si può vedere bene la messa in atto di quella “eccedenza del significante” rispetto alle serie in difetto dei significati che è uno dei meccanismi essenziali del testo poetico. “abito” (v. 13) e “Jean Gabin” (v. 22), ad esempio, funzionano qui come dei significanti polivalenti ed eccessivi ed infatti rimandano ad una sfera di significati ampia e non ben determinata che evade le loro immediate referenze. In particolare “Jean Gabin” racchiude in sé tutto un clima poetico in bianco e nero che rimanda alla dimesione cupa e tragica dell’esistenza; una dimensione che Carla non riesce ancora ad accettare e a vivere ma da cui viene inconsciamente vissuta.
Secondo locus
E questo cielo contemporaneo
in alto, tira su la schiena, in alto ma non tanto
questo cielo colore di lamiera
sulla piazza a Sesto a Cinisello alla Bovisa 30
sopra tutti i tranvieri ai capolinea
non prolunga all’infinito
i fianchi le guglie i grattacieli i capannoni Pirelli
coperti di lamiera?
È nostro questo cielo d’acciaio che non finge 35
Eden e non concede smarrimenti,
è nostro ed è morale il cielo
che non promette scampo dalla terra,
proprio perché sulla terra non c’è
scampo da noi nella vita.[9]
Sono questi i versi finali (27-40) della 2 sezione della II parte del nostro poemetto. All’interno di una evocazione dei sobborghi milanesi e dei cicli lavorativi della città, qui “il cielo” non è più quello eterno dei poeti. È invece un “cielo contemporaneo”, inserito nel tempo presente e nella storia, nella realtà della gente… Al cielo eterno del sogno, viene contrapposto qui quello della realtà e si tratta di un cielo che non copre più solo Milano ma si estende all’infinito sino a coprire tutto il mondo. Inoltre è un cielo di una durezza impenetrabile (“d’acciaio”) e dunque non si pone più come simbolo di trascendenza.
L’autore rivendica come suo, come nostro, questo cielo-realtà che non mente come quello del sogno e non finge paradisi terrestri inesistenti o lirici deliquii. È un cielo morale che dice la verità e non ci promette palingenesi, resurrezioni, scampo; scampo dalla terra, scampo da noi nella vita.
Tra le molte suggestioni intertestuali, cito solo, per il sintagma “cielo d’acciaio”, il Majakovskij del poemetto Il ponte di Brooklin (1925) dove si accenna a un “piede di acciaio / su Manhattan”.[10]
Terzo locus
Quanto di morte noi circonda e quanto
tocca mutarne in vita per esistere
è diamante sul vetro, svolgimento
concreto d’uomo in storia che resiste
solo vivo scarnendosi al suo tempo
quando ristagna il ritmo e quando investe 20
lo stesso corpo umano a mutamento.
Ma non basta comprendere per dare
empito al volto e farsene diritto:
non c’è risoluzione nel conflitto
storia esistenza fuori dell’amare 25
altri, anche se amore importi amare
lacrime, se precipiti in errore
o bruci in folle o guasti nel coinvitto
la vivanda, o sradichi dal fitto
pietà di noi e orgoglio con dolore.[11]
Sono questi gli ultimi versi (15-30) del poemetto appartenenti alla settima sezione della III parte. Si tratta di un denso e lirico commento in corsivo affidato a quella voce corale che è ben distinta (a livello enunciazionale) dalla voce narrativa. Quest’ultima parte del testo di Pagliarani sintetizza e riassume tutti i nodi problematici esposti negli interventi commentativi precedenti.
Cominciamo con una importante variante in clausola finale che il poeta ci ha segnalato nella poesia che chiude la raccolta Inventario privato. Questa raccolta è stata edita nel 1959 (un anno prima dell’edizione competa della Ragazza Carla) ma il poemetto oggetto della mia analisi è stato scritto a partire dal 1954. Ecco il testo:
Il verso “quanto di morte noi circonda”
apriva, e nella chiusa, isolato, bene in vista
“tu sola della morte antagonista”.
Ma già prima del termine di giugno
la mia palinodia divenne sorte:
nessun antagonista alla mia morte.
E sono ancora vivo, senza rimedio
sono ancora vivo.[12]
Il verso citato da Pagliarani all’inizio della poesia è ovviamente il primo verso del commento finale presente nella Ragazza Carla ed è un verso che ha resistito mentre il verso inizialmente deciso per il finale (“tu sola della morte antagonista”) è stato cassato forse perché ritenuto troppo sentimentale. Solo che questa “palinodia”, questa ritrattazione, è diventata poco dopo un destino reale, una sorte. Come si evince leggendo tutto Inventario privato (che è un canzoniere amoroso), la “milanese signorina” che il poeta ama (guarda caso una dattilografa come Carla), lo ha infatti definitivamente lasciato poco dopo la scrittura della variante espuntiva. Ecco perché quella ritrattazione era diventata sorte: per il poeta, infatti, non vi era più alcuna antagonista alla morte.
Da una variante a una fonte. Luigi Ballerini, a proposito dei primi due versi del nostro finale (vv. 15-16), ha osservato in nota a un suo articolo: “non è forse illecito ammettere il riaffiorare di un noto andante cavalcantiano: ‘Quando di morte mi conven trar vita / e di pesanza gioia, /come di tanta noia / lo spirito d’amor d’amar m’invita?’ (ballata XXXII, vv. 1-4)”.[13]
Credo che l’accertamento di Ballerini non solo sia esattissimo ma consenta di approfondire molto l’analisi dei versi finali di Pagliarani.
Linearizzo prosasticamente i versi di Cavalcanti: “Dato che [Quando] mi tocca di mutare la morte in vita e l’afflizione in gioia, come [è possibile che] da tanta dolorosa contingenza lo spirito d’amore m’inviti [ancora] ad amare?”.
Dentro al paradosso di una morte (quale esito inevitabile del processo amoroso) che si deve (è opportuno) trasformare in vita e dentro all’universo apparentemente omnipervasivo dell’amor cortese, qui Cavalcanti tocca temi universali di grande portata. Allargando un po’ il contesto, ad esempio, ci si pone la seguente domanda: come può l’uomo, che deve accettare tutte le mortificazione che la vita gli impone, convertendo il dolore in gioia, trovare ancora la forza di amare e cioè mantenere intatta la pulsione vitale di Eros? La risposta che Cavalcanti darà del tutto indirettamente, sarà che Amore contiene già questo paradosso di sua natura: esso è infatti vita che contiene la morte e il rovesciamento di gioia in “pesanza” (affanno, pena). Dunque non vi è alcuna differenza tra le mortificazioni della vita e quelle dell’amore.
Pagliarani riprende Cavalcanti non solo attraverso l’eco formale dei due versi incipitari ma anche e soprattutto perché prima presenta in forma dichiarativa il problema e poi offre una risposta diretta alla stessa domanda che il maggior Guido si era posto. Il fatto è che la risposta di Pagliarani è molto diversa da quella data da Cavalcanti che ho riassunto prima.
Dunque il poeta della Ragazza Carla si chiede quante porzioni di morte sia necessario mutare in vita per esistere, cioè per sopportare le mortificazioni dell’esistenza. Noto per inciso che al provenzalismo della “pesanza” cavalcantiana (v. 2) corrisponde in Pagliarani lo straziante “diamante sul vetro” e alla morte nella ballata di Cavalcanti corrisponde nel nostro poemetto quel ritmo che investe “lo stesso corpo umano a mutamento”.
Ecco la risposta di Pagliarani che, semplificando, definirei come appartenente ad una forma di “ottimismo” dantesco: l’uomo deve accettare la mortificazione – anche quella dell’amore – perché non c’è risoluzione del conflitto tra storia ed esistenza se non nell’amare altri, anche se questo amare comporti, appunto, mortificazioni, dolore, follia, pietà orgogliosa di noi stessi ecc. Il motivo dell’autocommiserazione appartiene fra l’altro ai motivi più tipici di Cavalcanti.
In sintesi, anche tenendo conto dell’excursus intertestuale qui compiuto, mi sembra che proprio nella contaminazione e nel montaggio (cioè in due operazioni eminentemente formali) Pagliarani, nel suo sperimentalismo, abbia operato quella critica radicale e decostruttiva all’ideologia veicolata dai linguaggi alienati della modernità e, oggi, della post-modernità. In questo senso, scrivere di Pagliarani oggi significa semplicemente reagire.
[1] Dal risvolto di copertina del Manuale di poesia sperimentale, a cura di Elio Pagliarani e Guido Guglielmi, Milano, Mondadori, 1966.
[2] Vd. I novissimi. Poesie per gli anni ’60 (1961), Torino, Einaudi, 1965. Pagliarani, Giuliani, Sanguineti, Balestrini e Porta furono i poeti “novissimi” ivi antologizzati.
[3] Maria Corti, La lingua e gli scrittori, oggi (1965), in Ead., Metodi e fantasmi, Milano, Feltrinelli, 1977, p. 106.
[4] Elio Pagliarani, Cronistoria minima (1977), in Id., I romanzi in versi. La ragazza Carla, La ballata di Rudi, Milano, Mondadori, 1997, p. 123. La vicenda del poemetto è assai nota e ciò mi consente di non doverla riassumere qui.
[5] Commento in nota alla Ragazza Carla di Alfredo Giuliani, in I novissimi… cit., p. 46.
[6] Ivi.
[7] Cito La ragazza Carla da Elio Pagliarani, I romanzi in versi… cit., pp. 9-35. Qui pp. 9-10. Per l’importante saggio introduttivo di Andrea Cortellessa (pp. 11-67) e la bibliografia delle opere, vd. anche Elio Pagliarani, Tutte le poesie 1946-2011, a cura di Andrea Cortellessa, Milano, il Saggiatore, 2019.
[8] Da Elio Pagliarani, I romanzi in versi…, cit., p. 10.
[9] Ibidem, p. 20.
[10] In Poeti russi del Novecento, a cura di Angelo Maria Ripellino, Milano, Guanda, 1954, p. 313.
[11] Elio Pagliarani, I romanzi in versi…, cit., p. 35.
[12] Elio Pagliarani, Inventario privato, Milano, Veronelli ed., 1959, p. 46.
[13] Luigi Ballerini, “Perché l’opposizione agisca da opposizione e abbia i suoi testimoni”, in “L’immaginazione”, n. 190, agosto/settembre 2002, p. 9, n. 2.
Confini. Intervista a Francesco Tomada
di Claudia Zironi

Francesco Tomada, poeta, insegnante di materie scientifiche nella scuola superiore, abita una terra di confine, in senso letterale, visto che la sua città Gorizia è divisa in due tra Italia e Slovenia. Tomada vive una vita di scrittura appartata dal rumore dei social media concedendo la sua presenza attiva solo al lit-blog Perigeion. Nonostante non faccia nulla per mettersi in mostra, è noto e stimato nell’ambiente poetico italiano e, come ho avuto occasione di dire in altro contesto, viene letto non solo dai lettori che frequentano la poesia ma anche dai colleghi poeti, con interesse e passione – non con l’occhio tecnico di chi sorveglia le produzioni altrui (sic) – probabilmente perché, come pochi, sa coniugare nella sua scrittura capacità espressive originali e contemporanee con l’apertura e l’accoglienza al mondo, andando oltre i confini individualistici e retorici.
In questa intervista cercherò di toccare vari ambiti ma la parola o solo l’idea di “confine” tornerà ancora.
CZ: – Benvenuto Francesco. Inizierei contestualizzando la tua presenza artistica in un territorio molto fecondo di arte e di parola che è il variegato ambito culturale del Friuli Venezia Giulia…
FT: – Prima di tutto grazie per la tua attenzione.
Difficile dare lettura di un panorama culturale vivendoci dentro, si rischia di mancare di una visione di assieme. In generale però mi sembra di poter dire che nel Nordest (estenderei la visione geografica almeno al vicino Veneto) si è assistito negli anni a una fioritura di validissime voci poetiche, di autori nati più o meno a cavallo fra gli anni ’60 e ’70, che hanno seguito percorsi individuali e solitari ma comuni per tematiche e approccio: penso a Franzin, Casagrande, Di Palmo, Crico, Fierro, Obit, Mattiuzza, Benedetti, Micelli e molti altri a cui chiedo scusa per non averli nominati. Si tratta in generale di una generazione con i piedi ancora nella cultura rurale e la testa immersa nelle conseguenze di quello che avrebbe dovuto essere il “miracolo economico”, una generazione che ha vissuto il disfacimento del tessuto cattolico e contadino a favore di una polverizzazione sociale senza più radici. La mia impressione è che il livello raggiunto da questi autori sia molto elevato, però quella stessa marginalità che ne ha rappresentato la forza propulsiva dal punto di vista artistico ha finito per limitarli per quanto riguarda il riconoscimento pubblico (Cappello e Villalta, ad esempio, rappresentano in questo senso delle eccezioni): da tanti percorsi isolati non si è riusciti a trarre un movimento. Ecco, a prescindere da quello che può essere il valore dei miei lavori, se appartengo a un ambito culturale è probabilmente questo, dove non a caso trovo alcuni fra gli amici più cari.
CZ: – Gorizia è per certo una città attraversata da un palese confine geografico. Ma con quanti confini “fantasma” si devono misurare la tua vita e la tua scrittura?
FT: – Per cominciare voglio dire che mi piace il modo in cui hai posto questa domanda, e ti spiego perché. Io mi sono trasferito a Gorizia da adulto, e sono rimasto letteralmente affascinato e rapito da questa terra attraversata dal confine come se fosse una cicatrice, un libro di storia a cielo aperto. Allora ne ho parlato a lungo, così a lungo da ritrovarmi io stesso ingabbiato in questo profilo di “scrittore di confine” che adesso sopporto a stento. Quindi grazie perché mi chiedi di altri confini, quelli che esistono qui come altrove, esattamente allo stesso modo.
So che può sembrare banale e scontato, ma il confine più grande è quello dell’egoismo e dell’incomunicabilità. Non è qualcosa con cui si deve misurare la mia vita, ma la vita di tutti: qualcuno magari si accontenta o si rassegna più di altri, io per indole tendo a scomporre i comportamenti, ad analizzarli quasi per istinto, cercando di identificare difese e sovracostruzioni. C’è una dose di finzione importante nel nostro agire, e la mia reazione è stata per molti anni quella di una rabbia presuntuosa e quasi adolescenziale verso il prossimo.
Devo dire però che sono più bravo a giudicare il prossimo che a cambiare me stesso. Negli ultimi anni (sarà l’età?) l’aspetto con cui mi scontro di più è la mia incapacità di comunicare: riconosco in me stesso gli stessi limiti che così a lungo mi hanno infastidito negli altri. Forse è ora che anche io cominci a crescere, a essere un po’ meno indulgente verso i miei confini invece di infastidirmi per quelli altrui.
CZ: – E quante sono le lingue della tua poesia?
FT: – Rispondere purtroppo mi è facile: una sola, l’italiano. Ho perso il friulano perché faccio parte di quella generazione a cui i genitori parlavano solamente in italiano, così da evitare che le costruzioni linguistiche e sintattiche del friulano diventassero una penalizzazione in ambito scolastico. Io stesso, fino a pochi anni fa, ho avuto un rapporto più di odio che di amore con la cultura friulana. Quando poi ho cercato di recuperare ciò che avevo lasciato per strada era già tardi, quindi la mia unica lingua è l’italiano. Pur vivendo sul confine, inoltre, sono entrato in contatto con lo sloveno da pochi anni, anche in questo caso troppo tardi per impadronirmene. Penso, sogno, scrivo e impreco solo in italiano, è il mio recinto.
CZ: – Ogni tanto ti cimenti anche con la traduzione di poesia pur non essendo un traduttore professionista: secondo te per tradurre poesia è più utile avere competenze tecniche nell’ambito della traduzione o avere sensibilità per la metrica e per la figura retorica?
FT: – Ho iniziato a tradurre dall’inglese per caso. Non mi sentivo minimamente all’altezza e quindi lo facevo solamente “per uso personale”, ma poi è accaduto che alcuni autori abbiano apprezzato le versioni delle loro poesie e mi abbiano chiesto di continuare, per cui ne sono derivati anche lavori più complessi. Ti direi che per la traduzione serve tutto: la conoscenza della lingua e degli strumenti della poesia trasposti in quella lingua, così come la capacità di immergersi nella scrittura di un autore, di entrare a farne parte. Per me – e sottolineo “per me”, che non sono un professionista – quest’ultima è la condizione necessaria per iniziare: se non riesco a ritrovarmi nella poetica di chi devo tradurre, le mie competenze sono troppo limitate per permettermi di portare a termine un lavoro accettabile soltanto grazie alla professionalità, all’utilizzo della tecnica.
CZ: – Cosa ti spinge all’attività di traduzione? E cosa ti lascia?
FT: – Oltre alla possibilità di studiare un autore che amo, quello che mi spinge è anche una sfida: la traduzione è un equilibrio molto precario fra devozione per la poesia di un altro e orgoglio personale. Bisogna dimenticare se stessi per mettersi a disposizione della poesia che si traduce, ma è necessario anche trasformarla, renderla in parte propria, perché nella trasposizione da una lingua all’altra molto andrà sicuramente perso e quindi questo è l’unico modo per poter dare un valore aggiunto, direi una prospettiva nuova, al testo tradotto. Come dicevo, il limite da raggiungere ma da non superare è difficile da individuare, per cui paradossalmente traducendo autori che amo ricevo un duplice regalo: attraversare la loro poesia e comprendere di più me stesso, le mie possibilità e le mie lacune. In alcuni momenti questa esperienza mi è stata davvero utile, soprattutto in passaggi in cui la mia scrittura sembrava essersi fermata.
CZ: – Non solo poesia: mi hai detto di avere pronto all’uscita un romanzo fiabesco-politico ambientato nel 1931 sul confine italosloveno, che hai scritto a quattro mani con Anton Špacapan Vončina. Ci regali un’anticipazione su titolo e trama?
FT: – Per quanto riguarda il titolo non posso rispondere perché ne esiste solo la versione slovena, il nostro “working title” mentale, ma la traduzione in italiano sarebbe davvero indecente. Quindi non è stato ancora deciso.
Il lavoro è nato in modo imprevisto e sorprendente a partire dal soggetto per un film elaborato da Anton e da un altro caro amico, Luca Chinaglia. Il film per ora è rimasto in standby, anche perché i finanziamenti necessari sono decisamente ingenti; io mi sono letteralmente innamorato della storia, quindi con Anton abbiamo deciso di provare a svilupparla in ambito letterario. Non si tratta di un romanzo tratto da un film, da un certo punto in poi le strade si sono divise completamente e oggi non hanno più nulla a che fare l’una con l’altra.
La vicenda è ambientata a Čepovan, un paese di mezza montagna che oggi si trova in Slovenia a una quindicina di chilometri dal confine, ma che ovviamente nel 1931 era sotto il controllo italiano e, come tutta la zona, era sottoposto a un processo spesso brutale di “italianizzazione”. Durante l’inverno l’arrivo di un nuovo contingente militare porta a una brusca accelerazione dell’operazione, e nella comunità isolata di Čepovan si sviluppa una serie di reazioni che vanno dalla connivenza all’indifferenza, fino alla reazione violenta. Tutto è racchiuso nel volgere di circa un mese, periodo in cui si sviluppa il contrasto fra il tenente italiano Angelo Ottavi e l’anziana maestra slovena Majda Žled: preso in qualche modo in mezzo a loro è Srečko, un ragazzino costretto passare fin troppo velocemente dall’infanzia all’adolescenza, a operare una scelta assumendosene le conseguenze e fronteggiando il fatto che da nessuna parte esistono i buoni senza colpa o i cattivi senza pietà.
CZ: – Sempre restando sul romanzo: mi incuriosisce la definizione che ne dai “fiabesco-politico”. Come si coniugano questi due termini nella realtà?
FT: – Si tratta indubbiamente di un libro politico: per quanto lo scopo di un romanzo non sia quello di risultare didattico, anzi è un rischio che speriamo di essere riusciti a evitare, il concetto centrale attorno a cui ruota il lavoro è quello di “Resistenza”. Resistenza non è soltanto quella degli sloveni al processo di italianizzazione: è piuttosto un’idea di comportamento etico e in questo senso mi sembra più attuale che mai, per quanto la storia si sviluppi in un momento storico ben preciso. Esistono infatti numerosi riferimenti a situazioni reali, alcune delle quali sono state riportate a galla di recente, ad esempio nel libro di Adriano Sofri “Il martire fascista” edito da Sellerio. Però l’idea non era costruire un romanzo storico, quanto cercare di incastonare in un quadro temporale delimitato e definito anche una presenza assolutamente irrazionale e fiabesca, in qualche modo mitologica, cercando di farla risultare credibile anche se ovviamente non può essere stata reale. Abbiamo cercato di costruire un affresco che mi piacerebbe poter definire “verosimile”, questa è stata la sfida: sappiamo benissimo che il confine fra l’inventiva e la banalità è labile, ma senza rischiare non si arriva da nessuna parte, né del resto avevamo alcuna comfort zone da difendere.
CZ: – Ancora sulla prosa: vorrei sapere come vi siete organizzati per scrivere un intero romanzo a quattro mani: un capitolo a testa? O ogni frase l’avete concordata? O, ancora, uno dei due metteva le idee e la ricerca e l’altro la capacità di resa scrittoria?
FT: – Quando Anton mi ha chiesto di collaborare nella stesura del romanzo, inizialmente gli ho risposto di no perché non mi sentivo minimamente all’altezza per formazione e capacità. Poi, a causa delle sue insistenze e del rapporto di amicizia che ci lega, ho accettato, con la condizione che fossimo impietosi per davvero: nel rispetto reciproco avremmo dovuto criticarci, tagliarci, correggerci senza alcuna remora e alcun risentimento. A conti fatti penso che questa sia stata una fortuna. Nella scrittura in sé siamo stati indipendenti, nel senso che non abbiamo mai lavorato insieme sulla prima stesura nemmeno di una singola pagina; nella pianificazione, nella revisione e nella correzione invece ci siamo confrontati continuamente, modificando, tagliando, cambiando, al punto tale che – in tutta sincerità – ci sono molti passaggi di cui davvero non ricordo nemmeno chi sia stato il primo autore, e altri completamente stravolti rispetto alla versione originale. Aggiungo anche che un ruolo fondamentale lo hanno avuto le illustrazioni, perché Anton è anche un grafico; probabilmente nel libro non saranno incluse se non in minima parte, ma sono state un elemento insostituibile di ispirazione e suggestione.
Insomma, la mole di scritti e di materiali che abbiamo prodotto è davvero enorme, e da questa abbiamo cercato di distillare – e qui il plurale è un plurale vero, sarebbe bello se anche in italiano ci fosse il duale, come in sloveno – la storia nella sua versione finale con un rapporto assolutamente paritario. Devo dire che per me, che nella scrittura sono un testardo e lavoro sempre da solo, è stata un’esperienza meravigliosa e commovente, soprattutto dal punto di vista umano. Sarò riconoscente per sempre a chi mi ha permesso di viverla, e ti confesso senza falsa modestia che il risultato finale mi ha sorpreso e mi convince.
CZ: – Secondo te un buon poeta è sempre anche in grado di gestire la prosa e un buon romanziere ha in sé il germe della poesia o le due attività hanno in comune solo il supporto cartaceo e la penna? Tu ti senti, ora che hai fatto anche questa esperienza, più vicino alla prosa o alla poesia?
FT: – Al di là della padronanza dello strumento linguistico, mi sembra che l’approccio mentale alla prosa e alla poesia siano piuttosto differenti: la prima richiede una disciplina che può invece risultare un freno per la seconda, la prima esige una costruzione rigorosa a priori mentre spesso la seconda identifica solo alla fine il percorso compiuto. Senza voler essere categorico, quindi, credo che non sia affatto scontato che un valido prosatore sia anche un valido poeta e viceversa. Non voglio però sembrare integralista, e so bene che, per fortuna, esistono confini impalpabili fra i generi letterari e splendide eccezioni al concetto che ho appena espresso.
Per quanto mi riguarda, rimango sicuramente più vicino alla poesia: il mio modo di pensare è più puntiforme, naif, occasionale, e sono mediamente incapace di progettare un lavoro a priori o scrivere in modo disciplinato e rigoroso; piuttosto mi lascio portare per poi cercare di capire dove sono andato a finire. Il mio impegno e la mia dedizione stanno nell’ascolto, nella prospettiva, ma ho proprio dei “tempi di attenzione” piuttosto brevi: è un dato di fatto, anche se in questo senso l’età mi ha cambiato rispetto a un approccio che in passato era ancora più frammentato ed episodico. Non è detto che ciò sia un bene, perché mi rendo conto di avere perso qualcosa in visionarietà e naturalezza. Spero, in cambio, di averne guadagnato da altri punti di vista, ma non sta a me giudicarlo.
CZ: – Per quanto riguarda la scrittura in generale, sappiamo che ti sono cari concetti come verità e onestà. Ma sappiamo anche che di norma la scrittura è finzione. Come concili queste due contrapposte posizioni?
FT: – Non le concilio per il semplice fatto che non credo che la scrittura sia finzione, o almeno non per come la vivo io: anche in quelle (poche) volte in cui riesco a uscire dalla dimensione autobiografica – e vorrei essere capace di farlo molto più spesso, ma mi sembra di diventare didattico e didascalico – deve essere presente una componente di interiorizzazione che mi permette di essere parte di quello che racconto, un coinvolgimento che mi dà il diritto di scriverne. Se non fosse così mi sembrerebbe di mentire, di lavorare su un artificio. Per tornare al romanzo, per anni mi sono trovato a pensare come un tenente fascista o un ragazzino sloveno, a livelli che in certi momenti sono diventati quasi destabilizzanti. A maggior ragione, poi, questo vale per la poesia, dove a mio avviso l’autore deve essere presente e nella sua presenza c’è la certezza di quello che Stefano Guglielmin, con una espressione illuminante, definisce come “valore di verità” della scrittura.
CZ: – Come stai vivendo tu e come sta reagendo la tua scrittura a questo prolungato periodo emergenziale di semi clausura, di lutti e di sgretolamento delle certezze relazionali e economiche?
FT: – Stiamo parlando di una tragedia assurda, quindi non si può viverla bene. All’inizio, come si fa nelle emergenze, ho cercato di tenere la barra diritta e un profilo ottimistico, soprattutto per rispetto delle persone che ho vicino, anche se per carattere non sono fra coloro che partecipano ai flash mob sui terrazzi e ho assunto dei comportamenti piuttosto schivi. Adesso che è passato un anno faccio sicuramente più fatica, le relazioni mi mancano perché vivo di relazioni. In certi giorni vado avanti per inerzia, anche se so di essere fra i fortunati almeno dal punto di vista economico, perché lo stipendio non mi è mai mancato.
La mia scrittura ha reagito molto peggio di me. Non ho scritto praticamente nulla su questa situazione, un po’ per pudore, un po’ perché da dentro non mi esce niente. In compenso ho rallentato la scrittura anche su tutto il resto, probabilmente a causa della mancanza di stimoli dovuta all’isolamento. La sola vera conseguenza è stata probabilmente la necessità interiore di andare verso testi in qualche modo non dico più ottimisti, ma almeno più sereni anche a costo di sembrare infantili. Ho scritto talmente tanto del dolore in passato – perché sono un uomo ombroso, questa è la verità – che non lo reggo più; in un momento in cui il dolore stesso diventa paesaggio collettivo, io non mi sento in grado di consolare nessuno ma al tempo stesso non posso e non voglio lasciarmi affondare. Piuttosto mi rifugio in una ingenuità consapevole; passati i cinquanta reclamo il diritto di essere stupido.
CZ: – Tu collabori con l’Associazione dei Benandanti di Portogruaro, connessa al servizio di salute mentale della zona, e anche a Gorizia operi come volontario con persone disagiate. Poesia come cura: secondo te è vero? La poesia serve a curare o piuttosto al contrario destabilizza?
FT: – Premetto che la prospettiva qui deve cambiare: non parliamo più di poesia per il suo valore artistico, vero o presunto che sia, ma per il suo valore umano e per il suo significato nel divenire di una persona. E devo dire che forse è un ambito in cui mi trovo più a mio agio, perché nello scrivere non ho mai avuto una visione artistica: se ho scritto è stato per necessità, e se poi è accaduto che a volte questo si trasformasse anche in una forma di arte si è trattato di una conseguenza, una fortuna, ma non un’intenzione.
La poesia può essere una cura? Sì e no.
No nel senso che la poesia, per la sua struttura, non è una medicina e non offre risposte. A volte temo che una poesia didattica sia una poesia morta, e ciò vale a maggior ragione quando si addentra nella profondità di un individuo e nei suoi lati irrisolti. Quindi no, la poesia non è una medicina.
Però forse può essere una terapia, questo sì. Per la sua natura, che affonda le radici nell’irrazionale, per il suo originarsi, che è un processo di cui l’autore ha solamente in parte il controllo, la poesia può rappresentare uno strumento per scandagliare profondità che altrimenti non riuscirebbero a emergere. A me è capitato di spaventarmi per alcune cose che ho scritto, al punto di chiedermi se l’autore fossi davvero io e se quello rappresentasse ciò che avevo dentro. Quindi immagino che la poesia destabilizzi piuttosto che curare, ma che si tratti di una destabilizzazione necessaria, ti dice: ecco quello che hai dentro, se vuoi arrivare da qualche parte è da qui che devi partire, sono questi gli angoli oscuri che non puoi fingere di non vedere.
CZ: – Ci regali un tuo inedito?
FT: – Un inedito di quelli leggeri di cui parlavo prima può andare bene?
Magari gli troverò un titolo, un giorno.
Quanta ostinazione nei cipressi
altre piante perdono le foglie
loro invece no, che non sia mai
mio nonno ripeteva di continuo:
nella vita bisogna stare sempre
con la schiena diritta
dicono che gli alberi sappiano ascoltare
ed eccoli nel grigio di novembre
rigidi e puntati verso l’alto
come se dovessero
tenere su le nuvole
NT – nessun tempo (Alessandra Greco e Gianluca Garrapa in conversazione)
1)
«centinaia di fotogrammi rimasti a terra»
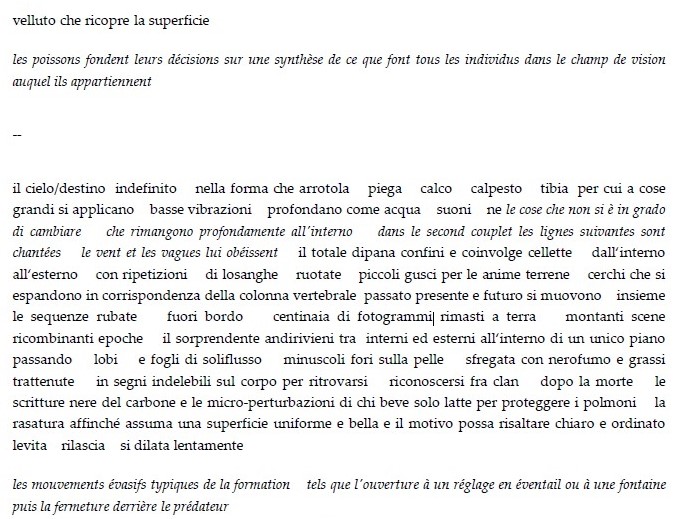
Gianluca Garrapa: A una prima lettura-visione ho la sensazione di osservare un poema spaziale. Simultaneo è lo scrivere pluri-desiderante di Nt. Una sorta di cinematografia dell’ascolto. La carta ha ospitato il tuo immaginario e il tuo simbolico, ma la presa reale sul mondo poetico trasmette una sorta di complessità casuale. Come nasce Nt? Che lavoro hai fatto per tradurre significanti e immagini nella filigrana? Hai scritto seguendo un flusso o montando le varie parti attrattivamente, per così dire, e per citare Ėjzenštejn?
Alessandra Greco: Intorno a La memoria dell’acqua_Grésil sur l’eau pour faire des ronds (2013), avevo sviluppato un gruppo di studi che investigava in maniera libera aspetti cognitivi inerenti l’udito, lo sguardo, la liquidità ed eventuali rapporti analogici con altri aspetti della realtà che si divideva per aree: estese, che riguardano la geografia, lo spazio esterno; più dettagliate, con focus sulla microfisiologia corporea (geografia del corpo umano). La natura delle relazioni all’interno di questi sistemi era di origine percettiva e visiva.
L’intenzione era di realizzare una mappatura del ‘reale’ implicata in una trama tessutaria di rispondenze tra enunciati migranti, rilevando dati o fenomeni, e dandone descrizioni il più possibile sistematiche, stratificate, con attenzione anche alla concezione del ‘senso anatomico’ dello spazio che il montaggio opera nel tagliare e cucire insieme ambiti e momenti diversi portandoli in relazione.
Attingevo materiali da antropologia, medicina, scienze naturali, con riferimento anche all’antica trattatistica di XVIII secolo, con idea generale di archivio, il recupero di una langue sommersa, di un’energia specifica che continua a riecheggiare, significazioni opportunamente giustapposte per muovere in modo ricco e consistente il pensiero e il linguaggio.
Una geografia immaginata come sistema vivente, un modo sistemico di pensare la vita, in costante cambiamento, in termini di relazioni, schemi e contesto, dove ogni sistema alterna momenti di sviluppo dinamici a momenti di ordine, intessuti in una fitta rete di corrispondenze, in un sistema che sondato con l’ausilio della ragione mette a rischio la ragione, inoltrandosi in una realtà incerta, che si modifica e riformula continuamente per trovare la strada voluta, o possibile.
Vi è implicato un movimento desiderante che riguarda molto da vicino il cinema [cinema: der. del gr. kínema ‘movimento’; kinesis, ‘movimento attivo’] mi muovevo lungo la linea filosofica che da Bergson conduce al Deleuze di Differenza e ripetizione. Le immagini si definivano come sulla superficie di uno schermo cinematografico, con suggestioni sonore, visive, tattili, spaziali. Prendevo anche a riferimento il concetto di plastica come scultura sociale di Joseph Beuys, dove l’invisibile coopera alla creazione di una forma, di un’opera d’arte ispirata, e ragionata.
Lo spazio in cui si traducono i significanti e le immagini è propriamente aptico, secondo la definizione che ne dà Giuliana Bruno, professore ordinario di Visual and Environmental Studies a Harvard, che esplora le intersezioni tra cinema, arti visive e architettura e che ha largamente influenzato il mio pensiero. Lo spazio aptico è spazio qualitativo. Il senso aptico è una procedura di esplorazione tattile strettamente legata al movimento e profondamente radicata nell’attività mentale, permette ai nostri corpi di percepire il movimento nello spazio.
Il processo del divenire è materialmente mediato dal movimento. È il senso aptico del trasporto che ha animato il viaggio degli esploratori, dei cartografi, dei pellegrini. La Nomadologia.
In NT (nessun tempo) i significanti, migrano e si interfacciano, in questo trasporto, con effetti di risonanza. La risonanza è «sentire tutto», la «pratica zelante di un ascolto perfetto»: come ciò che fa parlare l’ascolto, ponendolo «in uno stato di enunciazione» (R. BARTHES, La preparazione del romanzo. Corsi (I e II) e seminari al Collège de France (1978-1979 e 1979-1980).
Evocare possibili insiemi eterogenei di corrispondenze – che condividono riferimenti, ma che non si somigliano – formando un insieme di elementi che si uniscono ad un concetto più generale, e lavorare su questi luoghi formati da connessioni e loro possibili articolazioni procedendo per «riconoscimento di configurazioni»: patterns, elementi/tessere di mosaico variamente associate fra loro con lo scopo di creare nuove strutture, configurazioni che permettono di fare l’oggetto ancora prima di averlo osservato attentamente, un fare che «diventa consapevole dei confini e delle possibilità del suo agire soltanto nell’atto compositivo», durante il processo (W. Hofmann, I fondamenti dell’arte moderna, vol. II, Donzelli, Roma 1996, II vol., pag. 193), evidenziando il fatto che il senso dell’ordine è un processo costruttivo, che procede per fluidità e salti, prove ed errori.
Mi piace pensare che le forze contrastanti che insistono nell’accostamento dei costrutti, le stringhe verbali in un rapporto di frizione, si trovino vicine, con le dovute precauzioni, con il significato che Ėjzenštejn da del gesto-attrattivo, il rapporto essenziale tra due diverse forze, ossia che l’una ha bisogno di ritrovare il proprio contrasto nell’altra, questo contrasto non è di tipo dicotomico (bipartito), può subire molte deviazioni (articolazioni, tagli) può far sparire istantaneamente intere macchie di relazioni o generarne delle altre. Lorenzo Mari, che ringrazio, nella sua recensione ad NT (nessun tempo) su Argo, cita l’effetto Kulešov di Ėjzenštejn basato sull’idea di “stimolo-risposta” nella percezione delle immagini. Collocando una sequenza prima di un’altra si costruisce tra esse un’unione semantica. Poiché lo spettatore partecipa attivamente al processo di creazione dei significati, si può parlare di un libro che si fa grazie all’incontro con il lettore, aperto a continue sollecitazioni interpretative, dove ha grande importanza l’immaginazione attiva, la sua capacità di creare relazioni fra eterogeneità e di connettere campi di informazioni fra loro. C’erano poi alcuni studi sull’ottica, le emozioni e la coscienza.
Un riferimento imprescindibile va alla rêverie di Bachelard, all’importanza dell’immaginazione attiva. Le forze latenti immaginarie si fanno percepire come resistenze, si tratta di sentire la qualità percettiva delle connessioni e delle corrispondenze tra i significanti. Noi siamo attraversati di emozioni e percezioni e siamo un aggregato molto più ricco e molto più vario di quanto vogliamo credere.
«Prima delle idee chiare e stabili ci sono le immagini […] l’uomo è un essere che prima di pensare immagina […] immagini precise […] che hanno dormito nelle forme e che si deformano senza fine […] nel lavoro poetico viviamo un istante come se la dimensione umana in noi si fosse ingrandita, istanti di sintesi, di riflessione e di immaginazione attiva che prepara forze e pensieri a una maggiore funzione dinamica dello psichismo umano.» (Bachelard, LA POESIA DELLA MATERIA: il sogno, l’immaginazione e gli elementi materiali, traduzione di Chiara Ruffinengo, da: Causeries: la poésie e les éleménts. Dormeurs éveillés (1952, 1954), Red edizioni, 1997).
NT (nessun tempo) si delinea come un campo di possibilità in cui i significanti, nel modo in cui divengono nella relazione, per attrazione e eterogeneità, assumono i tratti del sintomo, il sintomo di un tutto virtuale sempre evocato ma mai attualizzato come tale, perché esso stesso articolazione, eccedenza vibrante cucita nella rete del tessuto testuale, che vibra perché sollecitata. Accostando per attrazione i concetti, si suscita una forza di coesione che sopravanza le parole, non è più il segno, bensì questa forza che accade, priva di temporalità cronologica.
Si tratta, di scrivere accadendo, cadendo insieme al discorso che ci ha preceduti. Di farne, dunque, un sintomo (che, alla lettera, infatti, vuol dire sym-piptō, dal greco piptō, ‘cadere’, e syn, ‘insieme’), territorializzandosi e deterritorializzandosi, in una parola attualizzandosi.
È il Deleuze di Differenza e ripetizione:
«… il problema non è di orientare il suo pensiero, né di completare l’espressione di ciò che egli pensa, né di acquisire applicazione e metodo, o di portare a perfezione le sue poesie, ma di arrivare semplicemente a pensare qualcosa. Questa gli sembra essere la sola “opera” concepibile: un’opera che presuppone una pulsione, una coazione a pensare che passa per ogni sorta di biforcazioni, e che partendo dai nervi si comunica all’anima per giungere al pensiero […] il pensare non è innato, ma deve essere generato nel pensiero […] il problema non è di dirigere o di applicare metodicamente un pensiero preesistente in natura e in diritto, ma di far nascere ciò che non esiste ancora (che non si dà altra opera, tutto il resto essendo arbitrario, e decorazione). Pensare è creare, non c’è altra creazione, ma creare, è anzitutto generare “il pensare” nel pensiero» (DR, 192).
Le sostanze e le forze che compongono le immagini, la loro forza diurna e notturna (Bachelard), non dicotomica, ma di concertazione, sono elementi sprigionati dalla materia. Qui ha un ruolo fondamentale il suono, assunto come principio vibratorio, lavora nello spazio, sulla percezione e sull’emozione molto prima del linguaggio organizzato. In una concezione poetica che abbia la spazialità e la componente psichica come suoi fondamenti, questa alchimia non si dà se non con una lunga meditazione delle immagini, e occorrerà lavorare finché non si sentirà funzionare (come un organismo, appunto) questo processo in formazione in ogni sua parte, aperto, in divenire.
La scrittura, io credo, è un dono che avviene con la pratica, è una pratica della costanza, un ascolto attivo. «I concetti sono ricollocati nel loro campo primitivo di immagini; siamo attivi mediante l’immaginazione: l’essenziale è andare all’origine di questo impegno. È attraverso questa natura, questa virtù d’impegno che si designano le immagini materiali», scriveva Bachelard.
2)
«dal corpo vedente al corpo visibile»
G.G.: A chi legge direi: Immagina, leggendo, di essere in un punto dello spazio e di essere del tutto con il tuo corpo e i tuoi sensi, esperienza che capita di rado. Prova a tradurre nello scritto i cinque sensi-luoghi. È un luogo, questo poema senza tempo. Eppure è tempo che mancava un poema del genere. Con figure. Immagini che sono simboliche. A una prima visione-sensazione. Nessun tempo. O tempo singolare à la Bergson. In questa lettura l’occhio vede e tocca. Che rapporto c’è dunque tra la poesia di Nt e il corpo? O meglio il movimento del corpo?
A.G.: «Già Matière et mémoire parla di una molteplicità di rythmes différents di durata. Cos’è, dunque, la durata? «[…] si tratta di un “passaggio”, di un “cambiamento”, di un divenire. Il tempo origina da quel taglio che il corpo (e non il fluire spirituale della durata) opera nella massa del divenire. Il corpo, come corporalità, più che come materia, e cioè come coscienza-del-corpo, è il taglio intemporale, ciò che non passa, e che offre sempre un adesso, che permette di distinguere un prima e un dopo. Il divenire è ciò che passa, come ciò di cui la coscienza è coscienza. La coscienza percettiva, invece, non passa, perché offre sempre una presenza. È sempre presente. La percezione, che non è sguardo disinteressato, ma abbozzo d’azione (e per questo il veicolo è il corpo), rende le cose presenti dinanzi a noi. L’attualità è attività. L’inattuale è ciò che per “me” non ha più interesse pratico. […] Il taglio è una relazione intenzionale, déjà vu, del ricordo del presente» (Pulpito, Massimo (1998) Temps / durée. Teoria del divenire e concezione del tempo unico nel pensiero di Henri Bergson. I Castelli di Yale, III (3).)
Rimembrare nel non-ancora, questo avviene, ed è sicuramente interessante; reperire «quel che persiste a preludere» (Fernand Deligny).
C’è sempre uno sconfinamento dal tessuto manufatto, al testo verbale, al tessuto visivo-percettivo che agisce sull’accostamento di frammenti.
Si tratta di figure al limite per le loro condizioni di impercettibilità, o di corpi animali, o si tratta, invece, di parti o di texture, regioni, campi di informazioni.
Un corpo che trasmigra, è trasportato. A volte emerge per azione delle percezioni, è un corpo anadiomene. È il testo stesso corpus, pensiero che in-forma, e che prende alla lettera forma attraverso le sintesi del montaggio. È la superficie della pelle. Il pensiero si riferisce alla pelle come confine (“io-pelle” di Didier Anzieu; il soggetto è la frontiera del corpo (Anzieu), il soggetto è un insieme raro (Sciacchitano), per quanto riguarda le applicazioni della topologia in psicanalisi).
L’epidermide, la superficie più estesa del corpo umano, prende varie accezioni: tattile, tissutale, membrana omeotica e porosa, pellicola cinematografica o schermo cinematografico, tessuto o abito, paesaggio, piega, che si tende e che si distende. Gli stessi procedimenti linguistici o lo spazio del foglio sono intesi come superfici. Se del corpo viene isolata una singola parte hanno grande importanza l’occhio e le giunture (articolazioni delle estremità, o della colonna vertebrale).
Organizzati sul modello del grafo di Eulero, che consente una fluida circolazione al suo interno, gli otto settori del libro sono messi in comunicazione per mezzo di porte, nominate evocando i punti porta della Medicina Tradizionale Cinese (MTC). Questi «rappresentano simbolicamente dei punti di passaggio esistenziale dell’uomo. A livello di queste zone energetiche si manifestano le difficoltà di passaggio evolutivo somatico psichico e spirituale legate alla crescita» (A. Castaldi) sono veri e propri incroci fra i meridiani che, mediante azione in un solo punto, permettono di intervenire su diversi organi, ed essendo il lavoro riferito all’idea della tessitura, i “soffi” che secondo questa disciplina percorrono il corpo umano lungo la rete dei meridiani, consentono di includere il discorso uomo e anatomie in texture. I punti porta sono soprattutto punti di criticità legati alle scelte (al libero arbitrio, potremmo dire), alla responsabilità individuale, alle grandi opportunità di evoluzione e cambiamento. Normalmente, nel corpo umano, i punti dei meridiani sono anch’essi fluttuanti.
Penso al movimento del linguaggio come al movimento del corpo che lo pensa e lo traduce, presente nell’istante, contrazione percettiva, che esita, trattiene (ogni eco che si incarni è soggetta ad un rallentamento, ha peso, ha densità, occupa uno spazio, muta lo spazio; le emozioni, i suoni sono sostanze che, attraversando la materia, vi interagiscono).
Il corpo non si trova mai svincolato dalle pratiche alle quali partecipa.
Una sequenza particolare, il movimento del corpo in questo processo, ha la traiettoria di chi si muove geograficamente perché non ha ancoraggio come su una zattera. Il senso della lontananza, un infantile incantamento e una continua scoperta costituiscono il ritornello di questo viaggio. Rimembriamo (corpo) – ripensiamo (mente) – ricordiamo (cuore), quando ci rivolgiamo ai fatti della nostra esperienza. Ogni organismo vivente tende al raggiungimento di una relativa stabilità cui si alternano momenti di grande cambiamento – il neurologo Antonio Damasio ne parla i termini di omeostasi. In analogia con la Teoria degli equilibri punteggiati, un modello evolutivo sviluppato dai paleontologi statunitensi Gould e Eldredge, i quali osservano che le testimonianze fossili sono incomplete e non sono coerenti con una teoria evolutiva che preveda una velocità costante dell’evoluzione; le specie rimangono stabili per lungo tempo ed evolvono in periodi brevi. L’evoluzione procede a scatti, con episodi improvvisi di speciazione alternati a lunghi periodi di equilibrio.
Sono portata a pensare il tempo come discontinuo, subordinato ai fenomeni. Lo spazio non è più rappresentabile attraverso una prospettiva ‘scientifica’ con un unico punto di fuga, si può considerare invece il principio dell’asse di fuga individuato da Panofsky, con ‘livelli’ che coesistono in profondità.
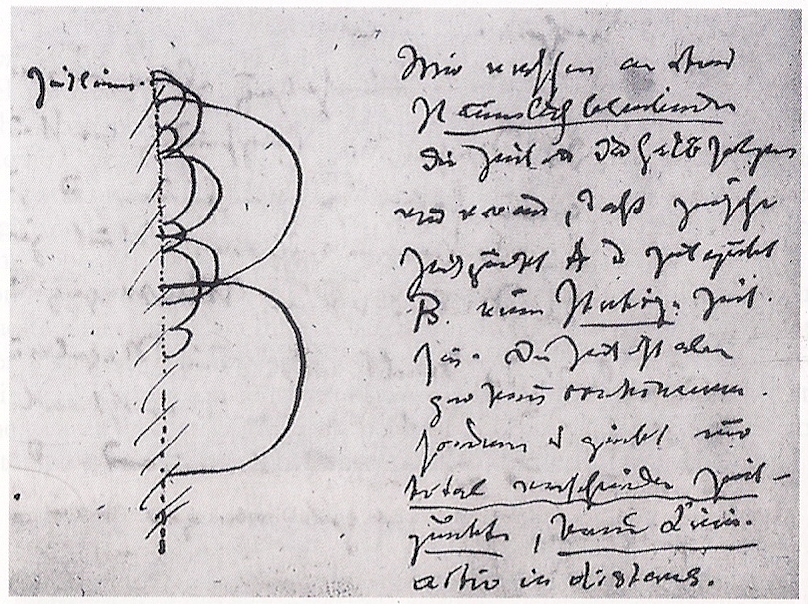
Friedrich Nietzsche, Schema dinamico del tempo, primavera 1873. disegno a penna tratto dai Nachgelassene Fragmente. Nietzsche-Archiv, Weimar. Fonte: Nietzsche-Archiv.
Grazie all’apporto della memoria, il tempo ‘appare’ come un fondale, ma nella durata esso agisce come forza dinamica non permanente. Trasporre il tempo in funzione del movimento, quindi dello spazio significa che ogni effetto ha un cammino da percorrere, e che il movimento nel tempo è discontinuo: una serie di punti e modulazioni. «Il tempo non è affatto un continuum, bensì esistono soltanto punti temporali totalmente diversi, non una linea. Actio in distans» (Nietzsche). Il movimento è costruito secondo leggi spaziali e trasposto in rapporti temporali.

Pittura murale, Pompei, I secolo. “I prolungamenti delle linee di profondità non concorrono […] in un punto; essi s’incontrano […], convergendo soltanto debolmente a due a due in più punti, i quali giacciono tutti su un asse comune, tanto che ne nasce l’impressione di una lisca di pesce”. [E. Panofsky, Die Perspektive als “symbolische Form”, in Vorträge der Bibliothek Warburg, Teubner, Leipizig-Berlin 1927 (ed. it. La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti, Feltrinelli, Milano 1961 [succ. 1966, 1980]), p. 44].
Il modus operandi in NT (nessun tempo), trova mirabile sintesi nel pensiero di A. Damasio: «Con il termine immagine, intendo una configurazione mentale con una struttura composta di elementi di ciascuna delle modalità sensoriali: visiva, uditiva, olfattiva, gustativa e somatosensitiva. La modalità somatosensitiva comprende svariate forme di senso: tattile, muscolare, della temperatura, del dolore, viscerale e vestibolare. La parola immagine non indica soltanto un’immagine «visiva» e non suggerisce neanche qualcosa di statico. Questo termine indica anche le immagini uditive, come quelle provocate dalla musica o dal vento, e le immagini somatosensitive che Einstein usava nel risolvere mentalmente i problemi (Einstein stesso, in un suo resoconto penetrante, chiamò tali configurazioni immagini «muscolari»). Le immagini in tutte le modalità «raffigurano» processi ed entità di ogni genere, concreti e astratti. Le immagini «raffigurano» anche le proprietà fisiche delle entità e, in maniera più o meno sommaria, le relazioni spaziali e temporali tra entità, oltre alle loro azioni. In breve, il processo che arriviamo a conoscere come mente quando le immagini mentali divengono nostre per effetto della coscienza è un flusso continuo di immagini, che risultano perlopiù logicamente collegate. Il flusso si muove in avanti nel tempo, rapidamente o lentamente, in maniera regolare o a salti, e di tanto in tanto avanza non lungo una sola, ma lungo parecchie correnti. A volte le correnti procedono in parallelo, a volte convergono e a volte divergono, a volte si sovrappongono. Pensiero è un termine accettabile per tale flusso di immagini.» (Antonio R. Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, p. 266).
Comprendere lo spazio non come a-priori, ma come prodotto dell’esperienza.
3)
«dove la mancanza fa un velo»
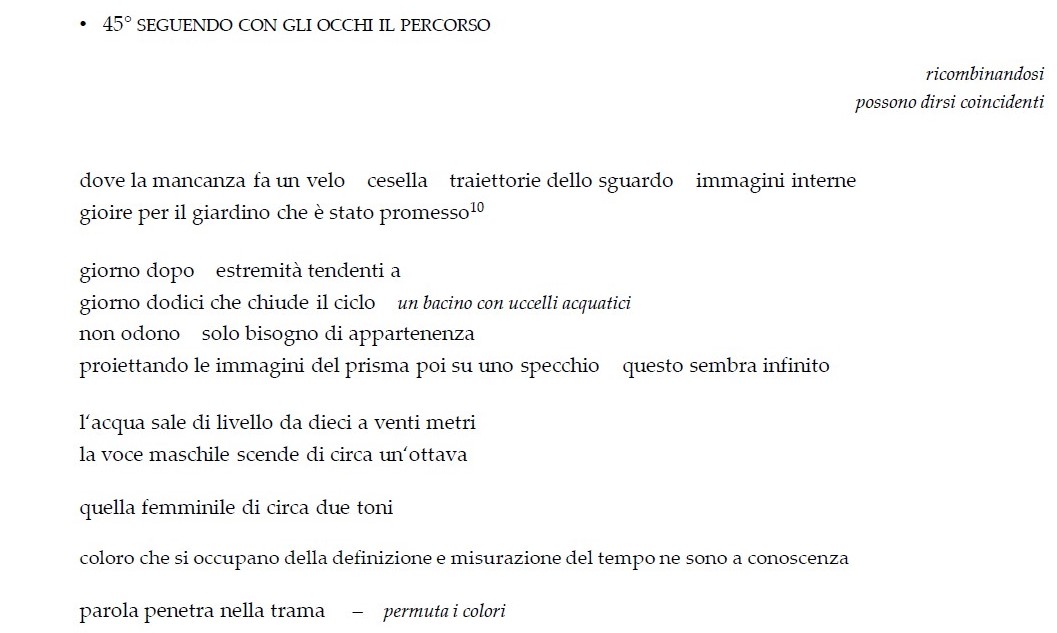
G.G.: Eppure il desiderio che attraversa i corpi e la geologia degli sguardi è un desiderio multiplo di esseri che si trasfigurano in ciò che vedono e in ciò che si mancano, e dunque non mai un desiderare puntale ma un pluri-desiderio, un desiderio mai univoco e mancanze, vuoti che lo generano, spaziature tra sintagmi e parole. E allora come il desiderio, se questo è vero, ha strutturato la scrittura del tuo lavoro?
A.G.: Si comincia sempre da una manifestazione, o meglio, da un incontro. Non si tratta di cercare ispirazione all’esterno, né di praticare introspezione, ma di ‘stare-con’ il movimento delle immagini, in una mise en abime. In un interessante articolo, Il paesaggio dell’inconscio di Alessandro Guidi (in Versodove, rivista di letteratura, n.20, 2018, p. 21) l’autore scrive: «… in concomitanza del punto di vista di Lacan negli anni ’60 […] Il paesaggio dell’inconscio [viene a coincidere] con il registro del reale […] Lacan usa il paesaggio nella sua realtà per sottolineare come l’inconscio vada colto non più alla stregua di una metafora paesaggistica come Freud fa attraverso il sogno, ma alla superficie, dove non si rimanda a qualcos’altro ma solo alla specificità della relazione che si crea tra gli elementi del paesaggio ed il soggetto che viene a farne parte. […] L’oggetto che illumina la scena, permette al soggetto che osserva di essere a sua volta riguardato e dunque illuminato da ciò che lo riguarda …».
L’intensità delle parole si articola attraverso le latenze espressive delle pause con le successive, in un discorso plastico e ritmico – Tarkovskij diceva il ruolo della pressione del tempo nel montaggio – l’immagine è presa in un flusso, è sospinta, trascinata verso altre visioni (Barthes). Punctum, momenti kairotici del desiderio che si propaga (in risonanza con) e suscita senza far ricorso ad alcuna descrizione, né definizione, esso «cerca di fare […] ciò che il linguaggio non può fare: suscitare la cosa stessa» in un tempo percepito non come durata cronologica, ma come una cascata di istanti. Un sapere-sentire in cui forma e contenuto sono intrecciati. La concomitanza inattesa di un contrattempo e di una ripetizione, di un’effrazione e di un ritorno, «ecforia di un engramma, suo momento emotivo» (NT (nessun tempo), pag. 108), ricordando Richard Semon (biologo evoluzionista tedesco).
Nelle pitture rupestri del paleolitico l’immagine era insieme rappresentazione e cosa rappresentata, desiderio e appagamento.
Sicuramente nel lavoro avevo a che fare con una mancanza. Una mancanza contenuta nel desiderio, due forze che si autoalimentano, che esprimono ripetendo continuamente se stesse. Si desidera sempre una concatenazione di cose. Qualcosa che non è ancora e che non cessa di insistere. La mancanza se rettamente esperita è ricchezza. Quindi dobbiamo parlare della pratica, di come sia sempre presente e necessaria.
Credo che desiderare sia divenire intensità in una zona di contiguità, «una domanda che non smette di porre se stessa, per reinventare sempre e di nuovo la sua origine e non per dirla, quanto piuttosto per crearla, reinventarla, ogni volta, daccapo. Perché, in fondo, non si fa mai altro che provare a dire, sempre e di nuovo, l’origine, a voler vedere l’occhio che vede, a voler sentire la voce che parla. Ed è solo così, paradossalmente, che possiamo incarnare, far risuonare quella fenditura, quella beanza in cui ci ritroviamo ad ex-sistere, ad esistere come esplosi, come ex-plosi, e di cui possiamo solo fare esperienza (continuando a dire, appunto). Uno spazio, un vuoto, una differenza» (Stefano Ferrara, RIPENSARE IL CORPO, La scrittura della voce, l’ascolto dell’intraducibile).
Il senso del quale non si può dire, è come una liquida corrente che lega i costrutti e, allo stesso tempo, tende a molte direzioni.
Queste considerazioni sembrano vicine alla concezione dello spazio qualitativo espressa dalla tradizione taoista. Un universo, il pensiero taoista, che ho potuto solo sfiorare, sempre evocato nella mia scrittura da MUTA QUADRA (Quaderni di Cantarena n° 4, Genova, 2003) in poi, e dire quanto ha contato per me la pratica di stili interni cinese, il Tai Chi Chuan, la ripetizione costante di una forma, costellata di manifestazioni significative, la compresenza dei contrasti, l’idea della non competizione, dove tornare sui propri passi non comporta una perdita, ma un accrescimento dell’esperienza, gli antichi maestri degli stili interni cinesi avevano una conoscenza completa, erano calligrafi, poeti, medici, astronomi.
Si tratta in primo luogo di creare una distanza, educare il desiderio a farsi trama e ordito di un tessuto dove la dimensione analitica (critica), e quella analogica (intuitiva) lavorano insieme. L’emozione sensibile è trattata come dato, al pari di altri enunciati, memoria e sensazione sono il materiale delle cose, un materiale plastico, capace di metamorfosi. Occorreva andare al di là di qualsiasi forma di sintesi stabilita, al di là di ogni dottrina idealistica, di ogni dualismo banale. Il soggetto scrivente, in questo differire – mutare (se stesso nel rapporto con la realtà) – diviene impercettibile, diviene un mezzo, si pone nel mezzo.
Scrivendo NT (nessun tempo), procedevo in un rapporto di estraneità assoluta, senza giudicare a priori quello che stavo componendo (o che si andava formando), il pensiero esplorava senza anticipazioni, senza imporre significati, quasi il principio del non agire, un processo neutrale di ascolto attivo e di osservazione, grazie al quale concorrevano continue epifanie. Non sono io che sono, ma c’è, è prima di tutto l’evento.
L’impersonale forma un tema situandosi prima che si arrivi alle proposizioni di verità, un’opacità ove compaiono punti di nitore. È un piano di esperienza che libera e connette le maggiori differenze. Le parole si annidano nel tessuto del testo, trovano una collocazione, ci ri-guardano, pur in questa estraneità, eterogeneità diffusa. Nel divenire impercettibile come essere-volontà, non si comincia a pensare se non grazie all’impersonale del piano, si esercita l’ascolto in un luogo di invenzione, trasportati a condizione di non avere radici, a condizione di avere la disponibilità a cedere un po’ dei propri confini. Il libro è il risultato di questo processo.
Vorrei altresì che NT (nessun tempo) lo fosse, corpo che si fa nella linea del porre, articolazione, luogo del trasporto e soglia, luogo delle trasformazioni e degli scambi. Un paesaggio, attraversato da concentrazioni, modulazioni, una collezione di istanti che si susseguono incessantemente. L’intorno come un insieme instabile, imprevedibile, fa sì che la categoria delle possibilità diventi decisiva e la scrittura attimale. Molteplicità ed eterogeneità implicano il disfarsi dell’ego; preso nella béance -quello stupore, quella sensibilità- l’io viene a coincidere con l’aperto, diviene una muta, come in un anamorfismo rinascimentale, segue deviazioni, ripensamenti, contrasti, assume su di sé le perdite, i ritrovamenti. Solo l’impersonale apre alla creazione, io non sono più io, ma una attitudine del pensiero a vedersi. Viversi come un flusso, un insieme di flussi, in relazione con altri flussi, fuori di sé e in sé, l’impersonale diviene attivo, come una forza nascosta, è lo «splendore del SI» nella logica del senso.
4)
«effetto simile a quando alla texture lunare fu sovrapposta la mappa del borgo di Manhattan per avere un‘idea della grandezza dei crateri»
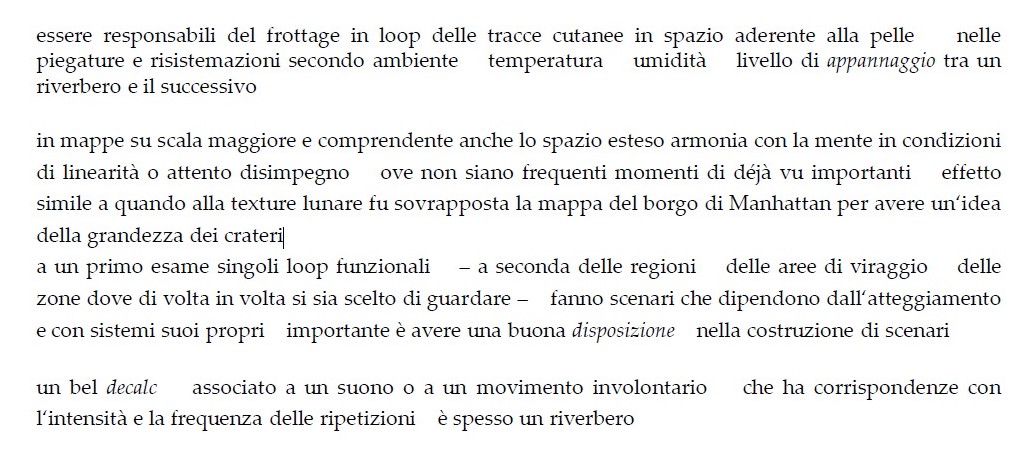
G.G.: Colpisce la presenza di mappe e d’immagini. A esempio la prima mappa che fa da sfondo all’indice, o meglio al quadro, per così dire sinottico, ma preferisco sentirlo pan-scopico, oppure la sequenza di altre immagini che percorrono il verbale essendo parte del logos e non spiegazione o completamento didascalico, al contrario, della parola. È come se territori diversi si penetrassero costituendosi in una dilatazione figura-sfondo, laddove, pieno-vuoto, luce-buio, non v’è un privilegio dell’una o dell’altra parte ma simultaneità. Cosa sono le mappe? E che ruolo hanno le immagini?
A.G.: Le mappe sono narrazioni, scrivere e mappare si equivalgono. Addentrarsi in una mappa significa fare i conti con la propria visione del mondo, i propri limiti, le proprie convinzioni, essere preparati alla possibilità di perdersi in una zona oscura, priva di corrispondenze, e provare a stabilirne di nuove.
In questo errare, veri e propri territori si miscelavano, si attraevano, si fondevano aree, continuavo a reperire riferimenti. Noi siamo legati ai luoghi. Noi siamo esseri di rete ed è vitale tessere corrispondenze. È in virtù di questo sentimento che Giorgiomaria Cornelio, che infinitamente ringrazio, ha accolto, in una corrispondenza su Nazione Indiana, la traccia peculiare di questo viaggiare, aperto e, vorrei dire, disinteressato, rivelatasi in tutta la sua unicità quando ho scoperto che io stessa ero legata ai luoghi delle mie ricerche, ai luoghi di Deligny e di molti altri autori incontrati: il botanico Francis Hallé, per citarne solo un altro, che con una piccola zattera-laboratorio su mongolfiera ha mappato le cime degli alberi nelle foreste primarie tropicali, scoprendo che i rami delle diverse specie non solo si mescolano, ma si ibridano in una rete tutta particolare creando un nuovo ecosistema.
Posso accostare alcune ‘mappe’ che sono state significative per me nel delineare la geografia mutevole di NT: le lignes d’erre di Fernand Deligny, carte e calchi di una geografia di riferimenti che vive dello spazio, e in cui si esprime come reperimento di effetti che appartengono a un corpo comune; il Neniji Tu (geografia, fisiologia interna e cosmologica taoista), il “paesaggio interiore” del corpo umano che illustra l’Alchimia interna, i cinque elementi, lo Yin e lo Yang e la mitologia cinese; la Carte du pays de Tendre (uno dei primi esempi di mappa emotiva), disegnata da Madame de Scudéry nel 1654, che ha ispirato l’indice visivo del libro.
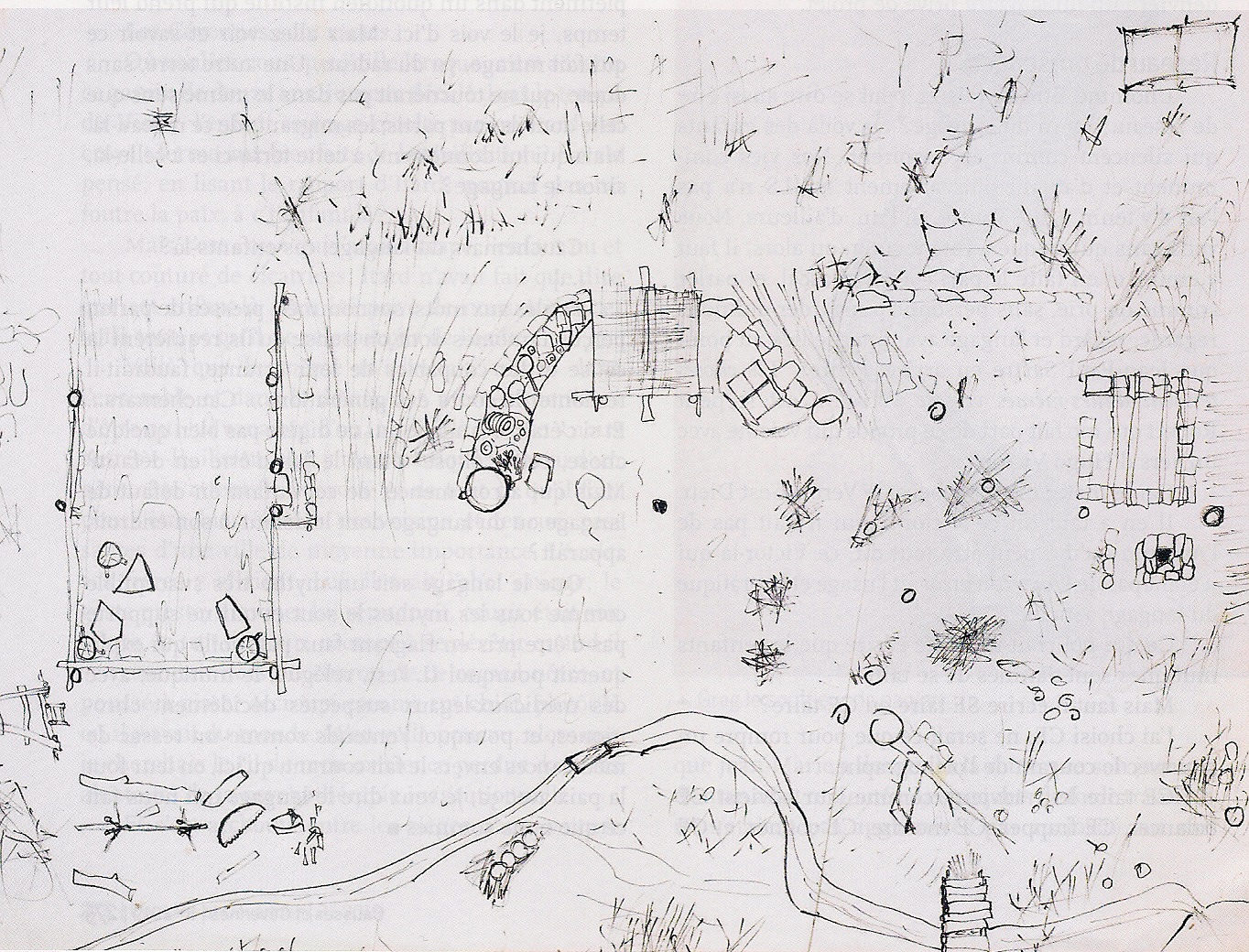
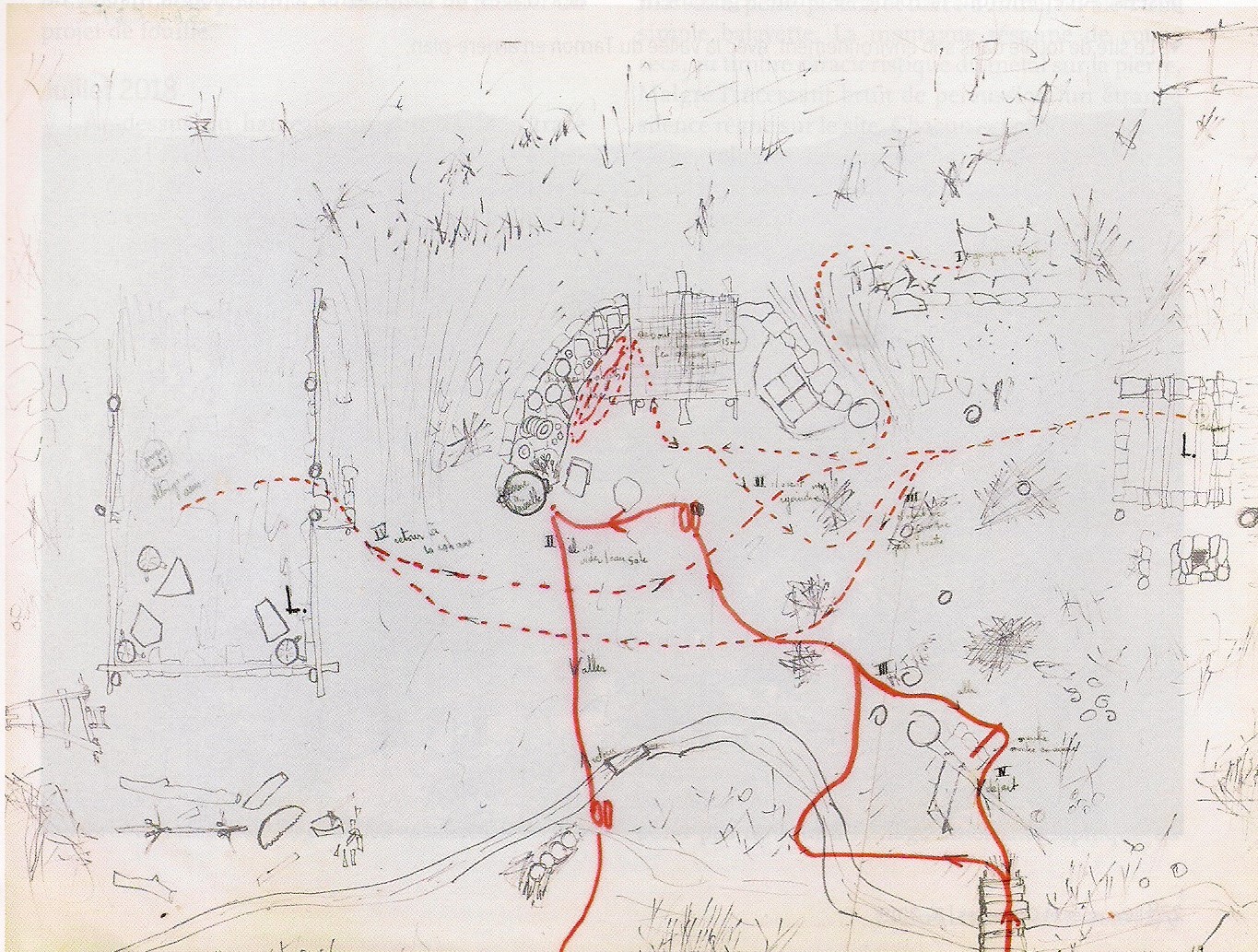
Cartes et lignes d’erre. Traces du réseaus, Fernand Deligny, 1969-1979, L’Arachnéen, 2013. Fonte: Causses&Cevennes, n° 3-2019.
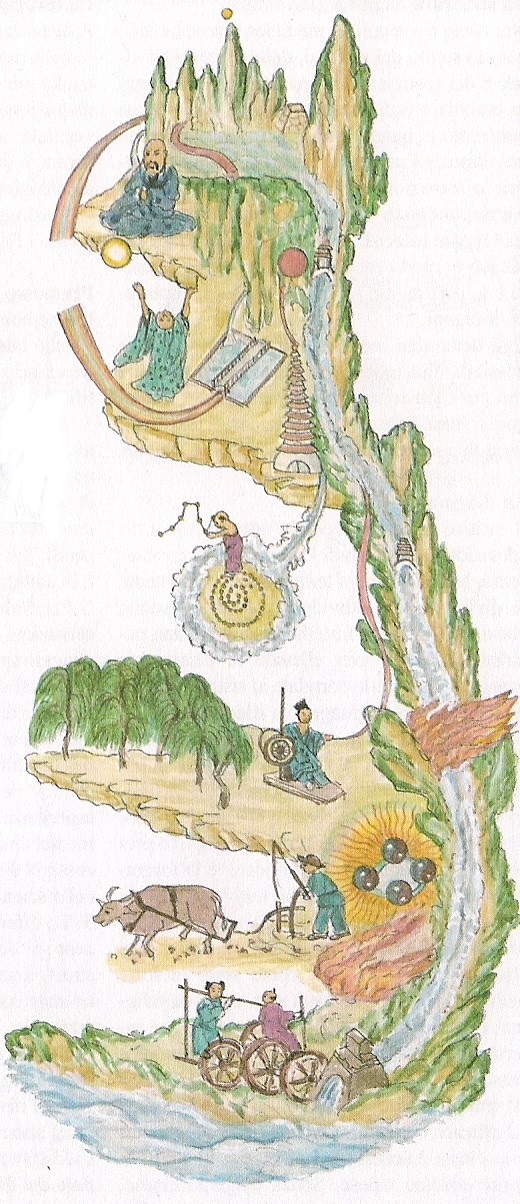
Il Neniji Tu. Nei testi antichi della Medicina Cinese il corpo umano viene descritto come un continente terrestre, presente all’interno dell’uomo. (Atlante di Agopuntura, Hoepli)
«In Cina, nessun filosofo fu interessato a considerare lo Spazio come una semplice estensione, risultante dalla giustapposizione di elementi omogenei […]. Mentre due porzioni di Spazio, come due porzioni di Tempo, possono radicalmente differire, ogni periodo è connesso a una regione, ogni oriente è collegato a una stagione. A ogni parte temporale corrisponde una singola porzione dell’estensione. Una stessa natura appartiene loro, indicata da un insieme comune di attributi.» (Granet, M. (1988) La pensée chinoise, Paris, p. 77).
«Ogni punto dello spazio, come ogni attimo temporale, era espressione di una realtà qualitativa, che era possibile comprendere attraverso la conoscenza delle leggi analogiche. [ In geomantica, l’energia vitale, consonante e ritmica, il qi ] permetteva di individuare i siti adatti a edificare abitazioni o erigere sepolture, attraverso il principio della “risonanza”, termine comune nella tradizione del pensiero analogico. Questo principio gnoseologico, che metteva in collegamento in modo acausale oggetti ed eventi, in quanto legati allo stesso emblema simbolico, rendeva possibile l’interpretazione del paesaggio.» (Paesaggio “misurato” o “qualificato” ? Lo spazio prospettico occidentale, lo “spazio psico-fisiologico” di Florenskij e la percezione dello spazio nella tradizione cinese, A. Paolillo, 2013).
Le immagini si trovano collocate successivamente ad ogni porta, precedono i testi, sono quello che può osservarsi isolando un istante di flusso: superfici visive dotate di consistenza, pensate nella loro materialità, istantanee fatte di piani, pieghe, sedimenti e depositi conservati nella superficie satura, macchie, tracce residuali, superfici ripiegate le une sulle altre; sono forti ingrandimenti, o accennano all’osservazione di una cartografia dall’alto. Nel testo intitolato (nessun tempo), è detto che «oltre le porte vi sono possibilità che l’osservato si produca se l’osservatore lo compone» (NT (nessun tempo), pag. 14); dal momento in cui una scelta di percorso è effettuata, quando le immagini mentali divengono ‘nostre’ per effetto della coscienza, si crea un’interazione.
Il fotogramma che apre il Settore II., Nodi, è invece riprodotto attraverso un caleidoscopio (oggetto che riassume bene l’idea della successione e dell’articolazione che porta sempre a nuove configurazioni) all’interno del quale, oltre ai tradizionali pezzetti di vetro, ho inserito ritagli trasparenti di immagini di migranti, funamboli, nodi marinari. L’andatura a scatti che genera queste immagini evoca fragilità, esse sono liminari, non durano che un istante in un flusso, a sottolineare situazioni di forte esposizione e criticità, ma anche di continuità e concorso nella mutazione.
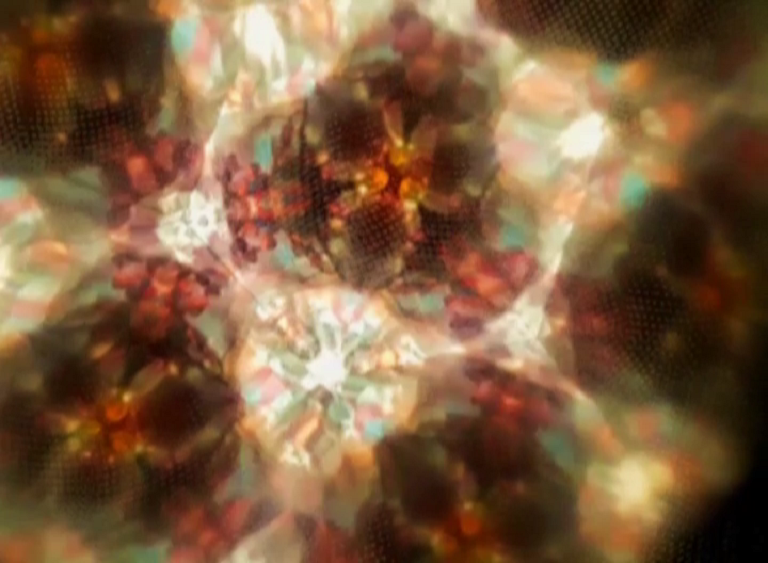
Istantanea da Nodi (video, 2018). Realizzato per l’omonimo testo inserito in NT (nessun tempo).

L’immagine mostra il contenuto del caleidoscopio utilizzato per realizzare << Nodi >> (video, 2018): cristalli colorati e ritagli di fotografie di migranti, funamboli, nodi marinari. Il video è stato selezionato per «Lungo-il-confine», Call for artist, 2018, progetto a cura di FUCO Fucina Contemporanea, Pisa 2018. Presentato successivamente a Border/Off, video arte, Le Muratine, Pontassieve 2018, progetto a cura di Serena Becagli.
5)
«perdita di visione notturna.
perdita di precisione nella lettura di distanze e angoli.»
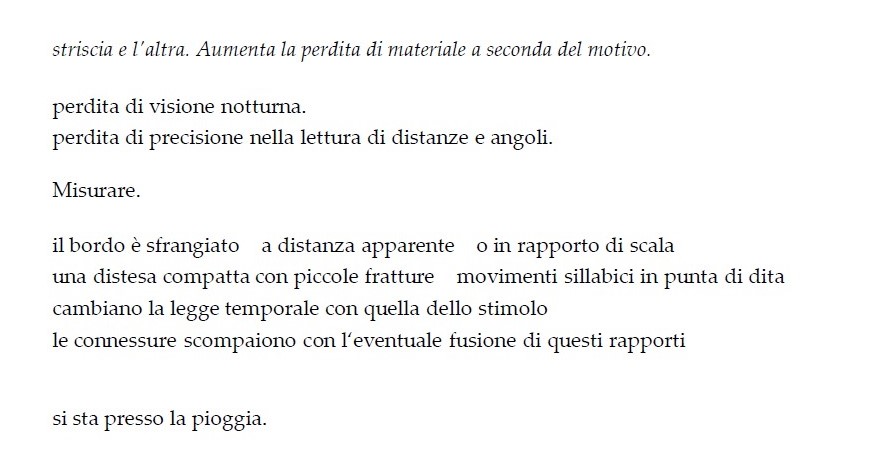
G.G.: Rileggo il tuo lavoro dopo aver chiacchierato con te su ciò di cui non si può dire: il venire a galla del senso. Nt non può essere, credo, letto con lenti di un’ottica razionale, troppo lenta rispetto all’immediato senso, certo, come scrisse Virginia Woolf nel suo diario, per scrivere ci vuole l’abc (anche se Henry James avrebbe, nelle parole della Woolf, fatto a meno anche di questo). È come quei giochi in cui si propone l’inizio di una parola e poi sta a noi completarla. Ma qui, il significante, che mai ha un diretto riflesso del significato, per lo meno in automatico, può essere pure una formazione nuova, del tutto soggettiva e idiosincratica, per quanto collettiva, nucleo oscuro e comune: che dialogo accade tra Nt e il desiderio di chi ne affronta la lettura?
A.G.: Posso far riferimento alla tecnica del flusso di coscienza (Deleuze-Pasolini) del discorso libero indiretto, il non sapere chi sta enunciando in un certo momento. Leggere fu da Virginia Woolf definito un processo emozionale aperto, non il risultato di un prodotto geometrico chiuso.
In NT (nessun tempo) c’è una soppressione il più completa possibile di ogni tentativo di dirigere il discorso dall’alto, per ritrovare la ricchezza delle voci del mondo e quindi la totalità della realtà, il suo discorso indiretto libero. È quindi, quello che si offre al lettore, un campo di possibilità aperto, in cui muoversi in un ascolto attivo fluttuante.
Il discorso indiretto problematizza la figura del soggetto che non è più in una posizione di centralità, bensì è diffuso e impercettibile.
La capacità interrogativa dell’immaginazione fa della complessità l’orizzonte trascendentale appartenente in modo ‘essenziale’ agli esseri, alle cose, agli avvenimenti, il fuoco della continua domanda, l’intempestivo, il contrasto, l’eccesso, ciò per cui i tempi più diversi comunicano, quel pulsare che sempre continua a preludere, in-vece di, è quindi un dire sempre una distanza, per evitare di scivolare verso un’idea che rischi di normalizzare, e quindi di estinguere, la vitalità del pensiero.
Le cose crescono dal mezzo, questa era anche l’idea di Virginia Woolf, il divenire minore dell’essere ancora e sempre sul punto di cadere nel vuoto. Ma anche il divenire di un essere che si pone nel mezzo tra il sentire e il pensare, cercando di descrivere un processo.
Ne risulta una partitura, le andature consuete si frantumano, si percepisce secondo zone di intensità che catturano la nostra attenzione. Sempre mi è stato detto che, nell’ascolto di un mio testo portato in lettura, alcuni elementi emergevano, si distinguevano più di altri nel flusso di informazioni. Colui che legge, o ascolta, percepisce intensità, che è libero di captare e fare proprie, evocando nuove connessioni, nuovi desideri, nuove aperture creative. Il testo ci parla nell’esecuzione come una guida e mostra la reale corrispondenza di questo fluire. «È difficile … tenere fermo questo continuo spaesamento, [è] importante continuare a metterlo in questione, a farlo parlare. [Ci si trova] davanti ad una scrittura che mette dichiaratamente in scena il suo farsi e non prova nemmeno a mascherarlo. [Si è lì] nell’istante stesso del suo “svolgersi”, uno svolgersi che è sia lo srotolare, il dipanarsi (di una matassa), che il suo svilupparsi, il suo costituirsi, il suo farsi, appunto. Ed è qui, su questo crinale, che siamo costantemente convocati. Qui: alle porte di questa apertura che non offre risposte, formule […] che non chiude un punto, ma ne apre infiniti. Non è un corpus chiuso, ma un corpus aperto, che si spalanca continuamente, che continua ad aprirsi all’incontro.» (Stefano Ferrara, RIPENSARE IL CORPO, La scrittura della voce, l’ascolto dell’intraducibile).
Aperto verso qualcosa che «non esiste ancora», come qualcosa che è, per usare un’espressione di Lacan, «dell’ordine del non-nato», del «non-realizzato», vuol dire fare i conti, non con un ‘semplice’ discorso intellettuale, che prende il tempo di un libro, di un testo, di un saggio, ma con qualcosa che, a partire dall’arte, dalla letteratura, dalla filosofia, ci mostra, ci rivela una logica, un’etica, una cosmologia completamente diverse.
La connessione aperta è affidata al lettore sul tappeto di superficie praticabile che ne emerge. «Egli può leggere con sincerità, offrire sinceramente la sua immaginazione originaria, la sua immaginazione sincera come eco, come riflesso dell’immaginazione del poeta.» (Bachelard)
6)
«la soluzione a questo primo problema di Topologia fu data dal matematico Leonard Euler nel 1608»
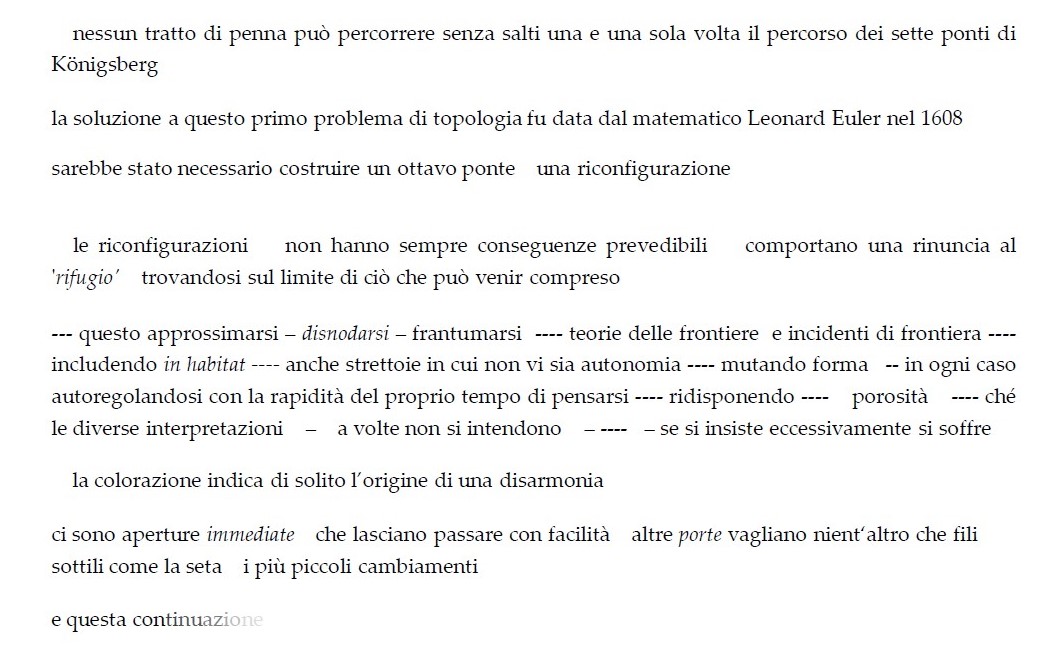
G.G.: Domanda, la precedente, che mi sono posto anche io, cercando collocazione al mio sguardo. E ho visto me che giocavo e che cercavo un luogo, appunto. Quel luogo è sempre altrove e, rapsodia figurale e musicale, l’interno congegno si coglie après-coup, direbbe Lacan, cioè il fotogramma deve giungere al termine per restituirmi il senso o il non senso del tutto. Sembra molto lontano dalla vita, e invece è l’esatto opposto: in fondo questa esistenza è fatta di attimi che non sono in esplicito collegati tra loro, e momento per momento, posso a malapena catturare… il momento, appunto. Pur essendo soggetto trascendente e desiderante, mentre leggo mi colloco in uno spazio. Questo poema è anche poema di uno spazio collettivo, s-oggettivo. Mi sembra che tutta la tua ricerca verta, appunto, sullo studio dello spazio o proprio dei luoghi: non luoghi comuni, ma quelli di una Topologia. Cosa puoi dirci al riguardo?
A.G.: La filosofia kantiana ribalta il rapporto tra tempo e movimento. Con Kant, scrive Deleuze, il tempo si è di-spiegato. Se il tempo ciclico forma una curva che delimita il mondo, il tempo lineare, invece, non delimita più il mondo, ma lo attraversa.
Le nuove tecnologie hanno ridefinito le distanze trasportandoci da uno spazio euclideo, cartesiano, a uno spazio topologico. Penso alla Topologia come ad una teoria della complessità (lo studio dei grafi si è evoluto nello studio delle reti complesse). La Topologia (dal greco τόπος, tópos, “luogo”, e λόγος, lógos, “studio”, “studio dei luoghi'”) studia il paesaggio dal punto di vista morfologico, in linguistica, gli studi relativi alla collocazione delle parole nella frase. Studia la trasformazione e l’interazione di figure che presuppongono un’idea di continuo, che per continuum possono essere contenute l’una nell’altra. Volevo tentare di concepire la spazialità partendo dal linguaggio. La necessità di trovare un punto di incontro tra enunciazione e spazio. Arrivare a capire fino a che punto può sussistere ed essere compresa una significazione, e in qual modo possa essere trasferita (e modificata) in altra successiva, in una sequenza di enunciati. Dove e possibilmente in che modo può situarsi il confine, nell’astratta atemporalità della langue in cui circola il tempo vivo e sempre nuovo della parole, tra sentire e pensare uno spazio, la morfologia interna e la rete di relazioni culturali, il segno visibile (significato) e il contenuto mutevole (significante), la processualità del pensiero e la singolarità, in relazione alla quale il tempo diventa attimale: «il ciò a cui accade di», l’archivio, l’archeologia del sapere, che consente di estrarre enunciati da qualsiasi forma, scientifica o poetica, determinandoli a pari titolo come forme di sapere.
In psicoanalisi Lacan spiega la teoria topologica della realtà intesa come incarnazione sensata e pensabile di ciò che risulta dall’intersezione dei tre ordini: Immaginario, Simbolico e Reale. Ho sempre pensato alla facoltà poetica immaginativa e percettiva, come alla possibilità di creare luoghi psichici continuamente soggetti a riconfigurazioni in virtù della plasticità del pensiero, e trasmissibili. «Il mondo delle analogie è un mondo del senso, in cui ogni circostanza ha con le altre delle relazioni qualitative che la sola esperienza sensibile o la sola dimostrazione non bastano a rivelare. L’analogia associa non dei segni, degli eventi isolati, ma delle serie di relazioni, degli insiemi di cui si rilevano le strutture isomorfe (isomorfo: in cristallochimica, di composto che presenta isomorfismo. Miscele isomorfe, quelle formate da sostanze cristalline che, solidificando, danno luogo a cristalli) attraverso il confronto interno dei rapporti tra i loro elementi. Il mondo è un’architettura di livelli di significato che rimandano gli uni agli altri riflettendosi indefinitamente in un gioco di specchi.» (http://www.ecros.it/Rc/MostraRecord.asp?Cd=1-00098).
È qui che si situa la prima idea di dare al libro una struttura toroidale (come illustrato nella tavola pubblicata recentemente su UTSANGA rivista di analisi liminale #26), una totalità organica, pensando lo spazio del foglio come inquadratura o cadrage, lo schermo come dispositivo percettivo e di pensiero, superficie topologica, di cui il mio corpo e il mondo, la mia visione e il campo visivo, sono dei ‘fogli’, sono il diritto e il rovescio, la trama e l’ordito.
L’après-coup è il momento di ritornare. È un momento kairotico. Un nuovo ascolto su qualcosa di «vigente prima a prima» (NT (nessun tempo), pag. 9), un’eco di rimembranze in cui noi ci rammentiamo, magari senza saperlo. Il concetto di equivalenza in Topologia è quello della deformazione continua, la scrittura è attimale, l’immaginazione duttile, l’attività del pensiero sintetica. «La durata, (è il Bergson di Matière et mémoire), non è né uno né multiplo, è un tipo di molteplicità, non è il divisibile o il non misurabile, ma è proprio ciò che si divide solo cambiando natura.» È quindi nell’articolazione che avviene, cambiando natura, il divenire. Il soggetto e l’oggetto si fanno coincidenti, ciò che si pensa non è del soggetto più che dell’oggetto (i piani coesistono in profondità), si conosce sempre solo da una prospettiva, non si può comprendere la totalità, la pluralità stessa degli strati è a sua volta un punto, o una serie di punti prospettici. La permanenza è solo un’angolazione del divenire, e dura fin quando esso sussiste. Il tempo ‘vero’ della Topologia è l’attimo presente, limite estremo – scissione fra due infiniti (il passato e il futuro) – è l’istante. Attimi che non sono in esplicito collegati fra loro, ma che ci vedono implicati in una vasta rete di connessioni e di esistenza.
Pensare questa complessità, e ricondurre in scrittura questi concetti, ‘tenere’ in rêverie le immagini, ‘rallentarle’, affinché possano essere ‘osservabili’ in un intorno, con il proprio complesso di qualità attive e coerenza sensoriale. Questi micromovimenti, questi contromovimenti (che appartengono a tutto il corpo-psiche), tornano all’interno del testo sotto forma di ripercussioni di senso intorno a un concetto, e visibili nelle latenze narrative, nelle pause, che io sento pregnanti articolazioni nel corpo in fluttuazione del testo. Il tempo della Topologia è tempo di Aion «… l’istante senza spessore e senza estensione che suddivide ogni presente in passato e futuro, invece di presenti vasti e spessi che comprendono gli uni rispetto agli altri il futuro e il passato» (Gilles Deleuze, Logica del Senso, Milano, Feltrinelli editore, 2005, p. 147). Un bimbo che gioca (secondo Eraclito). Aion (αἰών) che nella medicina greca antica ha assunto con Ippocrate il significato di midollo spinale, considerato la sede del principio vitale che dispensa il «tempo della vita» di ciascun individuo (le parche tessitrici > l’aracneo). È il bimbo che gioca con le stelle dell’Orsa Maggiore: esse descrivono una ruota, nel centro del cuore del Cosmo del Neniji Tu.
Alessandra Greco, NT (nessun tempo), Arcipelago Itaca 2020.
Dante, che barba!
Giovanni Boccaccio dal ⇨Trattatello in laude di Dante [1362]

E allora le Foibe? ( conversazione con Eric Gobetti)
di Lorenzo Galbiati
Il libro “E allora le foibe?” di Eric Gobetti, pubblicato da Laterza poco prima del Giorno del Ricordo, è diventato un caso editoriale e politico. Sui social forum ha creato un acceso dibattito, ma anche giornalisti e politici, a partire da Giorgia Meloni, hanno preso posizione su come Gobetti ha interpretato i fenomeni delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata all’interno della sua narrazione.
Personalmente, sono contrario al Giorno del Ricordo poiché trasforma una tragedia regionale – per quanto grave – in una commemorazione nazionale ma soprattutto perché credo, solidalmente con Gobetti, che non abbia senso “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati” (Legge 30 marzo 2004, n. 92) senza ricordare, contestualmente, la precedente occupazione fascista dei territori jugoslavi, che ha portato a crimini storici di entità simile, se non maggiore.
Inoltre, ritengo che ogni solennità istituzionale che pretende di fissare per legge la memoria di un preciso avvenimento storico finisca, di fatto, con l’ostacolare la libertà di ricerca storica e con il proporre un “dovere del ricordo” selettivo.
Pur avendo qualche riserva sulla sua narrazione, penso che Gobetti, con il suo “E allora le foibe?”, abbia meritoriamente posto al centro del dibattito storico-politico sulle foibe i crimini commessi dagli italiani nei territori del confine orientale, mettendo così in discussione le modalità retoriche che hanno assunto le celebrazioni pubbliche del Giorno del Ricordo.
Ho chiacchierato al telefono con Gobetti per un’ora e mezza, e quella che segue è una sintesi della nostra conversazione.
Lorenzo Galbiati
Il tuo libro “E allora le foibe?” ha destato molto scalpore. E sta tuttora avendo molto successo di vendite. Siete già alla quarta edizione. Te lo immaginavi? Come te lo spieghi?
In parte immaginavo sia che provocasse polemiche sia che avesse un discreto successo – peraltro, come sappiamo, i due aspetti sono spesso collegati.
Il libro comunque non è volutamente polemico, cerca di riportare la vicenda delle foibe alla sua realtà storica. Vorrei che si parlasse di questi temi basandosi sulla conoscenza dei fatti e non con slogan politici.
Quando ho letto il titolo del libro e dei suoi capitoli, per lo più iperboli che prendono spunto dalla propaganda di Destra, ho pensato che molte famiglie esodate o con parenti infoibati l’avrebbero percepito come irrispettoso, se non offensivo. Mi pare insomma che il tuo sia un pamphlet che, partendo dalla storia del confine orientale, voglia suscitare un dibattito nella società italiana. Qual è il tuo pensiero in proposito?
Il mio libro è il secondo volume della collana “La Storia alla prova dei fatti” di Laterza, che vuole mettere in discussione certe retoriche, certi stereotipi che non hanno basi storiche. Il titolo del libro si rifà a un tormentone di Caterina Guzzanti, che ricalca una tipica espressione usata dall’estrema Destra per capovolgere il discorso pubblico; quando si parla di un dramma storico che li riguarda, i neofascisti chiedono: “E allora le foibe?”. Il titolo dunque intende stigmatizzare questo atteggiamento.
“E allora le foibe?” ha un doppio intento. Uno strettamente professionale: ribadire i risultati della ricerca storica, condivisi dalla maggior parte degli studiosi, in un libro sintetico, con un approccio divulgativo, in modo di arrivare a tutti. Ma c’è anche un aspetto pamphlettistico, nel senso che i risultati degli studiosi finiscono per mettere in discussione seriamente un discorso pubblico monopolizzato dalla propaganda della Destra neofascista e dalla memoria degli esuli. A questo proposito, io capisco chi ha visto con i suoi occhi il padre infoibato o le famiglie che hanno dovuto lasciare la loro terra e integrarsi con difficoltà in un’altra realtà: il loro dramma è legittimo, ma rappresenta un solo punto di vista. Le memorie condivise sono spesso inconciliabili (come, per esempio, quelle di un partigiano e di un repubblichino), ma sulla base di fonti e documenti si può e si deve scrivere una storia di tutti, anche se potrebbe urtare singole memorie personali.
Fino ai vent’anni mi era tutto chiaro: c’erano stati sei milioni di ebrei morti nei lager e chi lo metteva in discussione era un negazionista. Poi ho approfondito la questione e mi sono accorto che il negazionismo era una categoria di comodo, creata più dai politici che dagli storici.
Lo storico marxista Eric Hobsbawm, di padre ebreo, sosteneva che tra gli storici sono leciti il disaccordo e la discussione sul numero delle vittime della Shoah (la cifra di sei milioni la giudicava “rozza e quasi certamente esagerata”). Anche il mancato ritrovamento di un ordine scritto di Hitler sulla “soluzione finale” non avrebbe dovuto essere un argomento tabù, e non importava se ad avanzarlo fosse uno storico filonazista come David Irving.
Con l’istituzione mondiale della Giornata della Memoria (2005) mi sono chiesto se le affermazioni di Hobsbawn, oggi, non sarebbero considerate negazioniste o riduzioniste.
Lo stesso problema si pone in Italia con il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004. Da allora, come spieghi nel capitolo introduttivo “Tutti negazionisti”, molti storici che studiano gli avvenimenti del confine orientale sono stati accusati di negazionismo.
Ci puoi spiegare perché la tua posizione non è né negazionista né riduzionista o giustificazionista?
L’uso del termine negazionista viene oggi usato per assimilare il fenomeno della Shoah con quello delle foibe. È un termine dispregiativo volto a screditare gli storici che se ne occupano in modo serio. Le accuse di negazionismo sono piovute addosso a tutti gli studiosi, compreso Raoul Pupo, che se ne occupa da trent’anni ed è ritenuto uno dei più precisi e moderati.
Per quanto riguarda me, io non sono né negazionista né riduzionista. Per le foibe mi attengo ai dati su cui concorda la maggior parte degli studiosi, ossia una cifra di 5mila morti, risultato di una sottrazione tra le persone tornate e quelle scomparse. Piuttosto, penso che si possano definire “gonfionisti” coloro che raddoppiano o triplicano la cifra delle vittime, arrivando a 10mila o 15mila morti.
Per quanto riguarda il “giustificazionismo”, io faccio il mio mestiere di studioso, ovvero cerco di comprendere un avvenimento nel suo contesto storico e geografico. Questo non significa giustificare; anzi, sto dimostrando rispetto per le vittime cercando di capire il motivo per cui sono state uccise. Raccontare i ventennali crimini fascisti non è un modo per giustificare le foibe, ma per comprendere il fenomeno: è un mio dovere professionale.
Nel primo capitolo, “Italiani”, discuti l’identità nazionale di chi viveva nella regione che va da Gorizia a Fiume, comprendente l’Istria. Alla fine, ti chiedi: “Ma queste persone, in definitiva, sono italiane o slave?” E poco dopo rispondi: “Queste regioni non sono italiane da sempre. Sono state invece italianizzate a forza dallo Stato italiano e fascista. Ma prima di allora, erano state, per molti secoli, multiculturali, multilinguistiche, multinazionali.”
La mia obiezione è questa. Scrivendo che sono state italianizzate a forza, sembra che siano regioni slave. Però, la zona costiera di metà della penisola d’Istria, da Trieste fino a Pola, e parte della zona interna nord-occidentale, erano a netta maggioranza italiana.
Questa è un’obiezione che mi fanno in molti.
La frase sull’italianizzazione forzata dev’essere letta insieme alla successiva.
Il ragionamento sulle molteplici identità di quell’area, che mi pare storicamente indiscutibile, mette in discussione la vulgata di chi dice: “Ci hanno strappato quelle terre con la forza.” Come a dire che erano state sempre italiane (si citano spesso l’Impero Romano e la Repubblica di Venezia). Ma, per esempio, Trieste e Fiume, le città più grandi, sono state fondate dagli austriaci in competizione con Venezia. Dicendo che sono terre “italiane da sempre”, e che gli esuli se ne sono fuggiti perché italiani, si afferma una verità parziale. Gli esuli italiani di quelle terre hanno quasi sempre un’identità mista, frutto di una convivenza durata per secoli.
Quelle terre erano abitate anche da italiani, certo, ma sono entrate a far parte dello Stato italiano solo nel 1918, e poi le popolazioni non italiane sono state italianizzate con la forza.
La logica del nazionalismo, realizzata prima dagli italiani e poi dagli jugoslavi (che pure avevano un ideale sovra-nazionalista), crea un problema a quegli abitanti, li priva di una parte della loro identità mista, meticcia. La volontà di creare uno stato nazionale non dà alternative alle minoranze etniche: o le espelle, o le ammazza o le nazionalizza.
La logica nazionalista è, a mio avviso, l’errore d’origine.
Nel secondo capitolo, “Improvvisamente”, parli dell’occupazione fascista delle terre jugoslave di confine. Come si caratterizza questa occupazione? E cosa è successo sull’isola di Arbe?
L’occupazione fascista dura vent’anni ma nel 1941, con l’arrivo della guerra, il livello di violenza si inasprisce e comporta una guerra di resistenza, una contro-resistenza, una guerra civile e una guerra contro i civili. Almeno quattro guerre, insomma. L’esercito italiano commette numerosi crimini di guerra per reprimere la resistenza jugoslava. E questo contrasta con il discorso pubblico, che è all’insegna dello slogan “Italiani brava gente”.
Nell’immaginario collettivo, per esempio, è inimmaginabile che l’Italia abbia allestito dei campi di concentramento, noi pensiamo l’abbiano fatto solo i nazisti. Invece circa 100mila jugoslavi sono stati rinchiusi in campi di concentramento. Nel più importante, quello di Arbe, si calcola che siano morti 1500 civili, soprattutto donne e bambini.
Nel complesso, se consideriamo tutte le vittime jugoslave direttamente associabili all’occupazione fascista, siamo nell’ordine delle 10mila, ma in generale circa un milione di persone muoiono in Jugoslavia a causa della guerra portata in quel territorio dall’Italia e dalla Germania.
Secondo il mio percepito, nell’immaginario collettivo italiano si crede che i partigiani jugoslavi abbiano ucciso molte migliaia di italiani buttandoli nelle foibe, ossia nelle fosse carsiche. Un crimine con una modalità barbara. Da qui il Giorno del Ricordo.
Cosa è avvenuto realmente?
Il termine foibe viene usato in modo estensivo per descrivere due fenomeni.
Il primo è avvenuto dopo l’armistizio dell’otto settembre del ’43 e dura circa un mese. In questa fase 400-500 persone vengono uccise e gettate nelle foibe. Questi fatti riguardano solo l’Istria, dove avviene una rivolta popolare che probabilmente fa più vittime dei partigiani, che cercano di prendere il controllo del territorio.
Nel 1945, finita la guerra, lo stato jugoslavo opera con la sua polizia politica e compie essenzialmente una resa dei conti. È un fenomeno simile a quello che accade in tutta Europa: i partigiani italiani piemontesi, per esempio, uccidono circa lo stesso numero di presunti collaborazionisti. Sul confine orientale gli arrestati vengono trattenuti nei campi di prigionia (dove alcuni muoiono di stenti), processati sommariamente e infine giustiziati se ritenuti responsabili di collaborazionismo con i nazifascisti. In realtà la maggioranza viene liberata dopo qualche tempo.
Ciò che distingue questa vicenda dalle omologhe europee è la volontà di imporre un cambiamento di regime, un nuovo modello politico e un nuovo stato.
Quindi possiamo dire che sia un mito l’idea che gli italiani venissero gettati vivi nelle foibe…
Non possiamo escludere che ci siano stati dei casi del genere, ma far credere che quello fosse il modo prevalente con il quale venivano uccise le vittime è sbagliato. La maggior parte degli italiani è morta nei campi di prigionia.
Uno degli argomenti più spinosi è la natura dell’esodo giuliano-dalmata: si è trattato di una pulizia etnica?
Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, ti sei confrontato online con Raoul Pupo. Parlando dell’esodo, Pupo ha detto:
“L’esodo italiano dall’Istria è un esodo di massa in apparenza scelto ma in realtà dovuto a una costrizione ambientale. Non c’è un piano del governo jugoslavo per espellere gli italiani, tuttavia l’esodo è la conseguenza diretta delle politiche attuate sul territorio dal regime jugoslavo. C’è un progetto jugoslavo di integrazione, la “fratellanza italo-slava”, che però esclude gli italiani non etnici (vanno ricondotti alla slavicità quelli che hanno antenati slavi), e parliamo di un 40%; i fascisti intesi in senso ampio; gli imperialisti che vogliono la sovranità italiana; i borghesi, compresi i bottegai. Insomma, tutti gli italiani sono fuori dalla fratellanza. È in atto una rivoluzione nazionale e sociale bolscevica, dove in larga misura il nemico di classe è costituito dagli italiani. Perciò se ne vanno via tutti, compresi gli operai e i contadini. Non rimane più nessuno. La fratellanza non viene applicata soprattutto perché i quadri locali del regime non ci credono, per cui opprimono gli italiani, che si percepiscono come vittime di un disegno di eliminazione nazionale. Noi storici ricostruiamo un processo diverso e più articolato di quello di una pulizia etnica ma questo termine corrisponde alla percezione degli abitanti italiani dell’Istria.”
Qual è la tua opinione in merito?
Io e Pupo concordiamo sul fatto che il termine pulizia etnica non sia adatto a descrivere l’esodo. La pulizia etnica è un fenomeno specifico, che si realizza nella guerra degli anni Novanta nella ex-Jugoslavia, e che si riferisce alla volontà esplicita di un esercito di espellere una intera popolazione attraverso pratiche violente. Questo di sicuro non accade nell’Istria né nel 1943, quando c’è una rivolta popolare, né nel 1945, quando l’esercito jugoslavo compie una repressione interpretabile come resa dei conti politico-militare. In nessuno dei due casi si può pensare che il governo jugoslavo avesse provocato l’esodo o volesse colpire gli italiani in quanto tali.
In maggioranza, gli italiani se ne vanno via quando si sposta il confine, ossia nel 1947, anno in cui si firma il trattato di pace, e nel 1954, quando viene fissato il confine definitivo. Le motivazioni sono quindi legate allo Stato in cui gli italiani si trovano a vivere.
Occorre chiedersi allora se lo Stato jugoslavo volesse mandarli via. Su questo ci sono tante interpretazioni differenti, poiché la vicenda è complessa, ed è una delle poche su cui non concordo totalmente con Pupo.
Innanzi tutto, non credo che lo stato jugoslavo volesse espellere la maggioranza degli italiani. La politica della fratellanza italo-slava era, in effetti, difficilmente accettabile da tutti, ma non era finta, il governo ci credeva. Erano le autorità locali ad essere particolarmente severe con gli italiani, poiché avevano vissuto l’oppressione fascista, quindi volevano vendicarsi, e avevano una logica nazionalista – che a Belgrado non c’era.
Inoltre, la mia interpretazione tiene conto del fatto che lo Stato jugoslavo ha espulso per legge i tedeschi ma non gli italiani. Se l’obiettivo fosse stato di espellere gli italiani, non vedo perché non prendere lo stesso provvedimento adottato verso i tedeschi.
In più, secondo le mie fonti, gli italiani rimasti sono il 20%, non meno del 10%, come sostiene Pupo.
Nel capitolo “Espulsione” scrivi che l’esodo “dei profughi istriano-dalmati […] è il risultato estremo di un circolo vizioso innescato dall’imperialismo italiano e poi dal fascismo. Gli esuli sono le vittime ultime della politica aggressiva del regime, dei crimini di guerra commessi dall’esercito italiano e della sconfitta militare in una guerra che Mussolini aveva ottusamente contribuito a scatenare”.
Questa frase, messa a conclusione del capitolo, mi lascia perplesso, ed è l’unica vera riserva che ho nei confronti del libro. Mi sembra, cioè, che attribuisca al fascismo le politiche e i crimini commessi dagli jugoslavi che hanno indotto l’esodo. In questo senso, potrebbe risultare giustificazionista.
Capisco, cerco di spiegare il mio punto di vista.
In tutto il capitolo racconto le politiche del governo jugoslavo che contribuiscono all’esodo. Allo stesso tempo, però, sono convinto che quel fenomeno storico non sarebbe avvenuto se non ci fosse stato prima tutto quello che ha compiuto il fascismo. Mi si potrebbe obiettare che nessun fenomeno storico sarebbe avvenuto senza ciò che lo precede, però, in questo caso specifico, la logica nazionalista, la violenza, la guerra mondiale le hanno portate i fascisti in quel territorio.
Peraltro, è indiscutibile che se l’Italia non avesse perso la guerra, la storia sarebbe andata diversamente. Ma probabilmente in quel caso i territori del confine orientale ora sarebbero tedeschi, dato che erano stati annessi di fatto alla Germania nel 1943.
Il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, ricorda l’esodo degli italiani da Pola. Ma è anche la data del trattato di pace del 1947, che dovrebbe essere considerata una festa, come qualunque pace, non una tragedia. Sarà impopolare dirlo ma, nonostante le conseguenze, credo che dovremmo essere contenti di aver perso quella guerra, perché l’abbiamo combattuta dalla parte sbagliata, ovvero al fianco dei nazisti.
L’esodo degli italiani è legato alla perdita di quei territori, allo spostamento del confine, e quindi è il risultato dell’invasione della Jugoslavia e della sconfitta in guerra, senza questi avvenimenti probabilmente non ci sarebbero state le foibe e l’esodo.
Mi sembra evidente che la responsabilità all’origine di tutta questa vicenda sia del fascismo e dell’esercito italiano.
In conclusione…
Ancora negli anni Ottanta il presidente Cossiga dichiarava che i triestini dovevano ringraziare i partigiani jugoslavi di averli liberati dal terrore nazista. Cossiga, che era persona di provata fede democratica e anticomunista, riteneva giusto ribadire una netta differenza valoriale fra il fascismo e la Resistenza.
Negli ultimi venti anni la percezione pubblica è cambiata: i fascisti sono diventati le vittime e i partigiani di Tito invasori e criminali. Non credo di essere un pericoloso estremista se propongo di tornare a leggere gli avvenimenti nel loro corretto svolgimento storico, adottando un giudizio morale simile a quello del presidente Cossiga!