di Giovanna Frene
Castore e Polluce, in prospettiva aerea
L’ultima fioritura del corpo sarà eterea.
Il semprenero sempreverde sbuca e fiorendo fiorisce
e s’addice alla sua sorte che il virgulto adduca la sua morte.
Ma qui quale pietra serba il nome e come nel suo progressivo
inceneritosi decedere fissare nell’aria la perenne memoria
tra astri alternativamente semprevivi sempremorti?
La visione veduta offusca la ragione e ovunque semina
cecità: per i due occhi spenti insieme, per i due volti gemelli schiantati
non esiste ulteriore fioritura di mura neppure nel vento:
la prima semina fiorì in orbite in orbite fiorì il lampo.
Se il seme non muore non può nascere la pianta
[se noi non moriamo non possiamo essere seppelliti]
senza la cassa-bacello nessun tempo
di attesa legherebbe i vivi ai morti
perché cresca la pianta che non muore
il tempo della sospensione deve essere ogni volta seminato.
Se l’ultima semina seminò l’etere fiorito
e non un sasso cancellò l’anonimato stellare del fiore
qui rinvigorisce il puro ramo del domani al sonno
alterno [eterno, sempreverde, semprescuro, inferiore]
e sotto la cenere lo stesso sentimento ovale di un momento
scaglia al cielo ingenerato un infuocato furore divino.
La disapprovazione del germoglio, il consenso del seme:
più vicino alla sua lontananza insedia la materia l’orto sfiorito:
il tempo corporale fiorendo sfiorirà:
la terra schizzata in alto e il prato profondamente spostato:
e l’azione carnale totalmente votata alla ustione:
il seme bruciato prima della fruttificazione apparente:
Nonpenso Nonfaccio & dunque [Corp.] Nonsono
Risplende lassù nel sonno il cielo
anzi è un’orbita vasta per sempre incandescente
prematura fioritura nell’alto osanna nell’alto
osama os-oris – –
(In memoria dell’11 settembre 2001)
Da: Sara Laughs, D’If 2007
Giovanni dalle bande nere
…la sua propagazione non è l’opera di un istante, non
di qualcuno: che salvaguardia la tecnica e la scarsezza
di merce, lo scopo, indebolisce il mezzo; l’arma contro chi spara è puntata
scarica, solo se chi poi è colpito non si sposta per primo in avanti; si muore
per cancrena, per leggerezza di campo, di corazza, cavalli piccoli; vinti solo dal vinto.
si aprono i piedi immacolati delle nuove propagazioni come cammini
da registrare, parti di tre, disarmati: necessario negare il sopra, se sotto; necessaria
se dopo, l’abrasione; dire al monumento che se saldo, crolla, se crollato,
resiste al dispaccio finale che risolve il vuoto come “perché”:
è stato risposto che per salvare, perché lo serva e lo salvi, si rivolge
alla fonte della perdita, all’io non concesso, al fine respiro
dello strumento invocato, che precipita
con le mani, non se ritratte, o non volendo; servendosi:
come in terra, i nostri nemici sono
piccoli vermi, inermi schegge di colubrina sullo spessore, e sempre
nello stesso gioco non conta non poter vedere, prima che volere;
il cambiare le cose in prospettiva, come invenzione, postazione, circonferenze di età:
cerchi la gamba tra le gambe e non la vedi,
nome sottomesso a leggi, da sé vinta,
in sé corrosa.
Da: Il noto, il nuovo, Transeuropa 2011
Sestina bosniaca, o del penultimo giorno dell’umanità
ovunque andassi, la gente mi considerava un debole
(Gavrilo Princip)
I.
se anche andassi per una valle oscura, non temerei alcun bene, perché tu sei con me:
se anche andassi a ritroso, ritroverei il corpo esploso, la pallottola
per l’eternità, una pura paternità in prospettiva: in somma, un impero centrale
II.
…un proiettile non va esattamente dove si vuole: ma due su due sono un bivio
perfetto, imboccato a ritroso come per difetto, o per eccesso di zelo:
si spinge indietro la macchina fino al punto esatto del suo non-ritorno
III.
…devi vivere per i nostri figli: non sembra vero che il ritroso si ripresenti per caso, aspetto
di un gesto grave, vista la fragilità, che afferra al petto, non il posto accanto, vuoto
il vuoto, sussurrato nella corsa del corteo pasquale di famiglia, che ha i suoi Decreti
[solenni, le sue Astuzie
IV.
come la storia: dobbiamo ricominciare tutto daccapo! il ritroso, il secco, lo sconcerto dei
[fiori
raccolto con stizza da chi si accorge che non si tratta di una tabacchiera, torna
indietro per cercare di smettere il calcolare, ma in un tempo incalcolabile
V.
…un tipico esempio della barbarie balcanica (…) ma in città non c’è alcun segno di lutto:
un tipico esempio della barbarie viennese, o più che altro europea, ovunque
ci sia musica, nessuno piange a ritroso per più di un quarto d’ora, da sempre
VI.
come sempre vivere attentamente in perenne mobilitazione, anzi
pensare finalmente a un’eredità biologica senz’altro fondamento,
dove un riformato non riformi mai davvero il mondo, ma solo sempre lo finisca
Liquefazione – Sestina bizantina
…essere in sé quello che si è costruito, e allo stesso tempo
galleggiare in superficie. buio come un pugno, dai piccoli padri
presenti, sempre presente il carro del vincitore, la discesa
strategica con le armi degli altri, tutte o poco
per volta, l’invisibile forma un monolite stridente
con la sconfitta, e la rigetta diritta a Ovest come
occasione per rispedire indietro le insegne del principio
“Orienta la spada sul seme della vicina distruzione”
: detronizzato il diminutivo, e prima destabilizzano
ancora il vuoto infiltrando l’ignoto, e altro, e in alto
si perda il gioco universale di unire ciò che l’uomo ha diviso
smembrando piuttosto il mondo che il suo potere
Stenditi a terra – Sestina di Crimea
tutto ciò che si sapeva
rimarrà come eredità
…come spesso gli uomini singolarmente intelligenti, aveva un numero limitato di idee,
un numero limitato di supposizioni, per ogni singolo soldato steso a terra:
rifare il campo di battaglia, se non si può proprio tutta la guerra, girare
al largo da queste vere carogne repellenti, ricreare da vicino se non il morbo
del vero, il vaccino del veritiero: fare la carogna per intero, in sostanza,
dare la notizia non della mattanza, ma della “bellavista”:
vedi che il braccio non sia fuori retta con la testa rotta, assesta
il colpo definitivo al cavallo centrale, centra la vera carne
malata, prima che infetta: una degenerazione veramente battagliera
di una schiera di inermi frantumati, a sfondo perduto, una quinta di fondamento
per una storia fotografica del genere umano davvero alla mano:
quella che raccolto ora, sanguigna, dal bordo della scena
[Su come nell’Ottocento si ricreavano a posteriori i campi di battaglia per fotografarli]
Da: Tecnica di sopravvivenza per l’Occidente che affonda, Arcipelago Itaca Editore 2015
Canzoni all’Italia
PEOMA / PEUMA / PIUMA
(Canzone all’Italia)
in memoria di mio padre
1.
… e mi vedo davanti il Peoma nel mezzo tra Gorizia e il Sabotino e un punto molto battuto da vari mesi di lotta su questo punto di terreno è tutto fracassato
… e mi rivedo davanti il Peoma, solo un nome farneticato da popoli interi, ancora
per poco, un discorso alla lettera abbagliante, vomere che rivolto lo sguardo alla terra
lo rivolge dalla terra al cielo, lettera abbagliante ogni notte, battuta, ribattuta
rivolta ossessione senza oggetto, e tra poco senza soggetto, valloncello
scherzoso, esploso (“grida al vento il mio tormento”)
2.
… Il Peoma è una collina davanti a noi vecchia posizione del nemico e perduta da lui tempo fa e vinta da noi per un po di tempo ma dovemo pur noi lasciarla perché tempestati
di fronte e dai fianchi dal piombo nemico
… ma dovendo pur noi lasciarla, questa vita, sotto il fuoco di una giusta sineddoche
sconosciuta, ma dovendo pur noi posizionare l’arredo cerebrale ai piedi di Sua Maestà
[lo Stivale,
ma dovendo pur noi specie durante la la note lottare di spesso, ma senza la detta
[conversione,
dispesso balzare da l’ignuda trincea allo squillo della patria intrusione: beata ci fu questa
[lunga dormita
che al turista commuove la vita: si sconta vivendo (“grato…ricovero di guerra…
[sotto terra“)
… Questa collina costo 20 miliaia di uomini nelle lotte molto sono la sopra la terra si consumano col tempo.
… si consumano “Col tempo” (Giorgio da Castelfranco), si accampano fin dentro le nostre
[narici, secondo
ordini impartiti dall’alto, si trapiantano più favorevoli al terreno, si dissodano
da soli il riscatto, l’unico sepolto, il giusto campo comprato per molto, si diventano ciò
[che sono
oltre la forma, oltre si dissemina la franca sostanza sopra la terra, sopra
la terra si sta forti a petto ignudo, senza scudo
senza
In questi giorni piccoli gruppi di soldati vanno a prendere fucili e baionette nel Peoma e davanti le nostre trincee 400 500 metri dove vi si trovano parechie miliaia di cadaveri, ogni fucile viene dato un compenso vi si trovano pure armi tedesche.
… vi si trovano parecchie miliaia di fucili e di baionette, da recuperare: una vera metafisica
del risparmiare, questa prodotta su sé stessa dalla pancia gonfia
del produttore, bugonia di patrii pensieri liquefatti sul terreno osceno, pronti all’uso, il
[prossimo
sempre a servizio del consumatore, consumati nel successivo servizio, già serviti
parechie miliaia di volte (“pure se per quel dì solo di fede il fante si nutrì“)
… I cadaveri non si possono sepellire per il loro numero e il nemico non ci permette il tempo sono già putrefatti e un enorme odore vi si trova da non poter respirare, vi sono bersaglieri 9-12:
… per il loro numero, senza permesso, occorrerebbe un giorno illimitato: tutte le strade
sboccano in nera putredine, al sogno del non-nato restituito al fato, a noi
che di memoria presto perimmo, o di salubrità dell’aria che tira,
ma pallottole, da non poter proprio respirare, così che vi posa sicura tranquilla
l’aquila vigilante: ci solleverà la fatica i confini le orbite vuote
6.
… Fanteria 33 36 carabinieri, granatieri e tedeschi, quando si tocca per levarci la baionetta si stacca mezzo il corpo, vi sono teste bracia gambe qua e là
… come se fosse una metafora, quando si tocca il linguaggio per levarci la baionetta
si frantuma mezzo il corpo: anche dopo questo non si dovrebbe più scrivere “poesia”:
[che cos’è che non
va nel corpo putrefatto del testo che non lascia recuperare l’acumine, il nesso,
il senso così severo del finire? di nuovo grida al vento
il mio scontento e dormirò in mezzo al campo, teste bracia gambe qua e là sui prati
(dopo Ruysch)
… un campo di cadaveri, non ce palmo di terreno che non sia battuto e non ce metro che non vi sia ferro e piombo…
: l’accorgersi del morire fu la nostra vera conquista, non come
un sonno santo e beato scivolammo nel passato della vita, ma fretta
della fine ci penetrò e un sentimento grandissimo ci squassò da dentro:
per fortuna un campo di cadaveri ha pure il suo quarto d’ora di celebrità
parlante, e tu passante ricorda che noi soffrimmo nel morire,
e che ci fu tremendo il corpo all’apparir del vero spirito
esalato, e vedemmo il piacere minato saltare in aria, per aria
qui non rimane niente altro che una sola voce, voce che grida
nel deserto di chi conobbe l’esser morto come certo smembramento
o appallottolamento frontale, o lume che sale per le scale in lontananza
covando non so quale ignota nullità, sicuro sogno,
o vita, istesso nervo battuto e ribattuto
8.
(“Tutte le batterie un solo ardore
Tutte le volontà un nervo istesso”
D’Annunzio)
Non c’è niente di lugubre nei soldati che muoiono in guerra, se non il fatto che è la Patria che li manda a morire. Forse è solo la Patria ad essere lugubre
snervante
[Pubblicata il 19 settembre 2016 in www.atelierpoesia.it]
____________
NOTA AL TESTO
La località Piuma (anche Peuma o Peoma) è una collinetta di fronte a Gorizia che fu teatro di sanguinosi combattimenti nel 1916; in termini bellici, viene inquadrata sul Fronte del medio Isonzo, tra il Podgora e Oslavia. Notizie dettagliate su tale località si trovano in più passi del diario di guerra di Giuseppe Bof, Ritorno a quei giorni (Istresco, Treviso 2015), vissuto a Crespano del Grappa (TV) e ivi morto nel 1971; le citazioni lunghe che attraversano la poesia sono tratte da questo volumetto. Ogni gruppo di versi cita, in chiusura, deformandole, alcune delle epigrafi originariamente presenti nel Cimitero Militare di Redipuglia sul Colle Sant’Elia, ora dismesso, risalente agli anni Venti e precedente l’attuale Sacrario; le epigrafi furono scritte da Giannino Antona-Traversi Grismondi, Fausto Salvatori e Gabriele D’Annunzio. La messa in scena della guerra è qui puramente allegorica; tuttavia, vero è che “Resterà una eterna memoria della presente guerra”: è bene ricordare che così il fante Giuseppe Bof, nella piccolezza della sua singola biografia, aveva colto la portata dell’evento di cui era testimone.
2.
Contro-futuro arcaico
“Sappia che non siamo in tempo di pace. E lei è un militare.”
(Guido Morselli, Contro-passato prossimo)
I.
…si giunge a Vallerisce le granate piovono tuti sono partiti
un attacco feroce e impegnato sul Podgora.
Piove sulle trincee come piove sul mio cuore, su le cicatrici
fastose del passato: piove sul fango raggrumato dei sangui dei non-nati:
piove sui corpi devastati, sulla gora del versante sgranato, la grana della foce
recita litanie nere in lastre più nere: mira: Isonzo: mare
II.
…poi si parte in armi e lungo la via si trovano dei caduti
un nostro tenente e steso sformato nella palta un altro compagno…
poi si parte per un futuro più arcaico del passato, spinti da furenti
precettori impastati nella palta da cui tutto promana: le Mani
di Dio, l’Uomo, il Figlio dell’Uomo, l’altro figlio dell’uomo, quello
assassino tra le urne elettorali, per cui “balzeremo anche noi di sotto terra”
III.
…altri feriti sincontra la lotta continua il nemico avea già sfondata la prima trincea
facendo parecchi prigionieri del 116° e venendo fino al posto di medicazione…
…io non credea mirare un’avea in tanto spasimo, nel teatro delle operazioni:
io non volea l’opera lirica in bocca al primo villano che s’arrovella sul Carso:
ma in un futuro ricomposto come puzzle da un Pollock, bilancia alla mano,
cosa peserà il Tempo su i fasti della Storia crionizzata?
[Pubblicata il 22 dicembre 2016 nel “Corriere della Sera” ]
NOTA AL TESTO
Ogni strofa inizia con le parole, in corsivo, di Giuseppe Bof, un soldato semi-colto della Grande Guerra, autore di un taccuino pubblicato dall’Istresco nel 2015, Ritorno a quei giorni. Diario di guerra. L’unica citazione tra virgolette è tratta da un’epigrafe del vecchio cimitero militare di Redipuglia, sito sul Colle Sant’Elia.)
Autopresentazione
In un suo recente volume, Abbiamo ancora bisogno della storia?, Serge Gruzinski si pone l’interrogativo capitale del senso della storia in un mondo globalizzato e appiattito sull’apparente assoluto presente della Rete. Il problema che si pone è duplice, perché in realtà alla globalizzazione stanno facendo ovunque contrappeso molteplici spinte locali e localiste, e di contro la Rete stessa va a configurarsi come una implementazione della capacità umana di memorizzare (casomai, il problema è la sovrabbondanza di informazioni che la macchina processa senza intelligenza, e che invece all’uomo processante potrebbe causare una cecità mnemonica, tale da non poter fissare i dati in oggetti mnemonici, e dunque non avere paradossalmente un passato culturale, ma solo individuale). La proposta “aperta” suggerita da Gruzinski è paradossalmente anacronistica, e prende il suo slancio dalla prima mondializzazione europea, che lo storico fa risalire al XVI secolo, l’epoca della scoperta del Nuovo Mondo: una volta progressivamente liberata dalla distorsione eurocentrica della storiografia moderna, si tratta appunto di reinquadrare (in modo da osservare le “aggregazioni che si formano e si disarticolano sul pianeta in differenti momenti della sua storia”) e di riconnettere (a partire anche dalle stesse fonti) elementi tra loro eterogenei, sia in senso sincronico, che in senso diacronico. Per certi versi, il compito del poeta oggi non è dissimile da quello dello storico, posto che la domanda potrebbe essere “Abbiamo ancora bisogno della poesia?”: la tradizione è inalienabile rispetto a qualsiasi tentativo di scrittura, ma bisogna rifondare non solo l’idea di tradizione, ma anche la sua sostanza (cosa e come si va a reinquadrare, cosa e come si va a riconnettere); con questo bagaglio, lo sguardo del poeta sulla contemporaneità non potrà che essere più profondo e duraturo, e specialmente sarà in grado di superare la semplice categoria del “poetico”.
L’allegoria è uno dei modi del dire che permette di fare delle connessioni a focalizzazione indiretta, e allo stesso tempo, superando la forza dell’analogia, di stabilire delle inquadrature con oggetti multipli; permette, infatti, di attuare procedimenti simili a quelli che lo storico Carlo Ginzburg racconta nel primo dei saggi del libro Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconografia politica, dal titolo Memoria e istanza. Su una coppa d’argento dorato (Anversa, 1530 circa). Partendo dall’acquisizione in campo iconologico delle “formule del phatos” di Aby Warburg, Ginzuburg ricostruisce, partendo dalle prime testimonianze scritte dell’incontro degli europei con il Nuovo Mondo, la vera storia che il fregio di rilievi di una Coppa d’argento dorato, conservata ad Anversa, racconta: oltre ad essere un manufatto-palinsesto di epoca gotica e rinascimentale, le sue scene rappresentano uomini, animali, piante, edifici del Nuovo Mondo, ma in una formula rinascimentale (e questo tra l’altro permette allo storico non solo di datare la coppa, ma di stabilirne il probabile esecutore e la finalità per cui fu realizzata), la quale trova nell’oggetto rappresentato la libertà di esprimere “sul piano del linguaggio gestuale l’intera gamma delle emozioni”, quelle che durante il Rinascimento non sarebbe stato conveniente, né possibile, esprimere; si tratta insomma di selvaggi rappresentati in una “lingua visiva” che si rifà principalmente alle incisioni Mantegna e Pollaiolo, ma anche a maestri tedeschi. L’analisi di un manufatto artistico porta infine lo storico a riflettere sui concetti di memoria culturale, sociale e individuale, che sempre si intrecciano e si mediano a vicenda: nel caso della Coppa, la memoria culturale da un lato viene usata per ridurre la distanza geografica e la novità, tanto da rendere famigliare il Nuovo Mondo, mentre dall’altro crea la distanza mitologica per coprire la ferocia della conquista europea. Quindi, ciò che la memoria individuale avvicina, la memoria sociale allontana.
Il mio avvicinamento alla sfera dell’allegoria non è avvenuto all’inizio, in realtà, in riferimento alla mia poesia, ma in ambito critico, durante la stesura della mia Tesi di Laurea sulla poesia del primo Zanzotto (A che valse? e Dietro il paesaggio), che avevo letto in un’ottica completamente figurata; questo mi aveva dunque permesso di concludere che nel mondo emblematico del giovane poeta la storia, e la sua violenza, fosse in realtà del tutto centrale nel suo orizzonte poetico, più ancora del paesaggio, che diventava sfondo degli elementi allegorici. Di questa storia, sia sociale che individuale, emergevano tutta la loro crudezza traumatica i due elementi cardine: la morte delle due sorelline, gemelle, e la furia della Seconda guerra mondiale. Proprio partendo dal concetto di trauma, mi è perciò più facile a questo punto ricostruire a posteriori e a ritroso come è concresciuta in me, più o meno coscientemente, l’esigenza di spostare il mio dire sulla storia, fino a pensare di poter interamente fare una poesia della storia. Se il primo fattore è riconducibile a un impegno critico, il secondo è riconducibile a un elemento individuale, ovvero il fatto che i miei due nonni parteciparono alla Prima guerra mondiale, e in particolare quello paterno combatté sul Monte Grappa, ai cui piedi risiedo. Quando ero piccola, la presenza in casa del nonno, che io ricordo buono ma ombroso, un po’ mi intimoriva, perché sapevo che aveva combattuto in guerra ed ero terrorizzata all’idea che avesse ucciso degli uomini. L’ombra traumatica che mio nonno aveva dentro di sé è riemersa in me, e alla mia coscienza come mia, solo due anni fa, quando ormai avevo già scritto più di un libro con una focalizzazione storica, ma stavo lavorando a Tecnica di sopravvivenza per l’Occidente che affonda, e poi avrei iniziato a scrivere le Canzoni all’Italia, a cui sto lavorando, dopo aver appunto trascorso un luglio caldissimo sul Carso nella zona del Basso Isonzo (tra l’altro proprio in occasione delle ricorrenze delle prime grandi “spallate”), luoghi dove tuttavia mio nonno non aveva combattuto, essendo un alpino. Ora, tornando a ciò che Ginzburg ha suggerito attraverso la Coppa di Anversa, e insieme anche ai procedimenti indicati da Gruzinski: come ho già scritto altrove, il trauma può essere considerato la causa scatenante della mia visione allegorica; non solo la Storia diventa allegoria della mia personale storia, ma i meccanismi della sua rappresentazione sono derivati da fonti di vario genere, e specialmente i fatti vengono tradotti con altri fatti, e le immagini emblematiche si fanno carico di esporre con diverse lingue visive dimensioni emotive diverse, spesso censurate dalla stessa cultura. Lo stile è solo la porzione di mondo che si è riusciti a intuire e memorizzare.
Nota biografica
Giovanna Frene, poeta e studiosa, è nata ad Asolo (TV) il 16 dicembre 1968; vive a Crespano del Grappa (TV), e talvolta altrove.
Ha pubblicato: Immagine di voce, Facchin 1999; Spostamento. Poemetto per la memoria, Lietocolle 2000 (Premio Montano, 2002); Datità, postfazione di A. Zanzotto, Manni 2001; Stato apparente, Lietocolle 2004; Sara Laughs, D’If 2007 (Premio Mazzacurati-Russo 2006); Il noto, il nuovo, con traduzione inglese, Transeuropa 2011; Tecnica di sopravvivenza per l’Occidente che affonda, Arcipelago Itaca editore 2015. Ha curato il prosimetron Orfeo è morto. Lettere intorno un’amica uguale (Lietocolle 2002), di Federica Marte.
Ha pubblicato poesie in riviste italiane e straniere, come “Paragone”, “Il Verri”,
“Anterem”, “Poesia”, “Gradiva”, “Atelier”, “Italian Poetry Review” (New York, 2010), “Aufgabe” (New York, 2009); e più volte nei blog di “Nuovi Argomenti”, “Nazione Indiana”, “Atelier”, “Poesia 2.0” e nel blog di poesia della Rai.
È inclusa in varie antologie poetiche, tra cui: Nuovi Poeti italiani 6, a cura di G. Rosadini, Einaudi 2012; Poeti degli Anni Zero, a cura di V. Ostuni, Ponte Sisto 2011; New Italian Writing, a cura di J. Calahan e R. Palumbo Mosca, “Chicago Review”, 56:1, Spring 2011; Parola Plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, Sossella Editore 2005.
È tradotta in antologie di poesia italiana statunitensi, argentine, inglesi e spagnole.
Come studiosa e critica, ha pubblicato saggi e recensioni in volumi e riviste.
Attualmente svolge un Dottorato in Storia della Lingua a Losanna, con il prof. Lorenzo Tomasin, occupandosi della lingua poetica di Metastasio.
[Auto-antologie prosegue con Giovanna Frene e il suo percorso poetico. Appartengono alla stessa rubrica gli spazi dedicati a Francesco Tomada, Vincenzo Frungillo, Francesco Filìa, Viola Amarelli, Eugenio Lucrezi, Renata Morresi e Gianni Montieri. Una mia lettura critica dei testi poetici di Giovanna Frene si può leggere qui. B.C.]

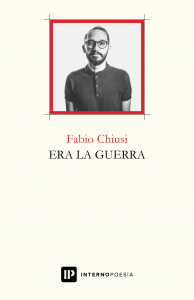 di Fabio Chiusi
di Fabio Chiusi 








 [Di seguito, un estratto del romanzo “Il perturbante”, Autori riuniti 2017, finalista e menzione speciale al Premio Calvino 2016]
[Di seguito, un estratto del romanzo “Il perturbante”, Autori riuniti 2017, finalista e menzione speciale al Premio Calvino 2016]
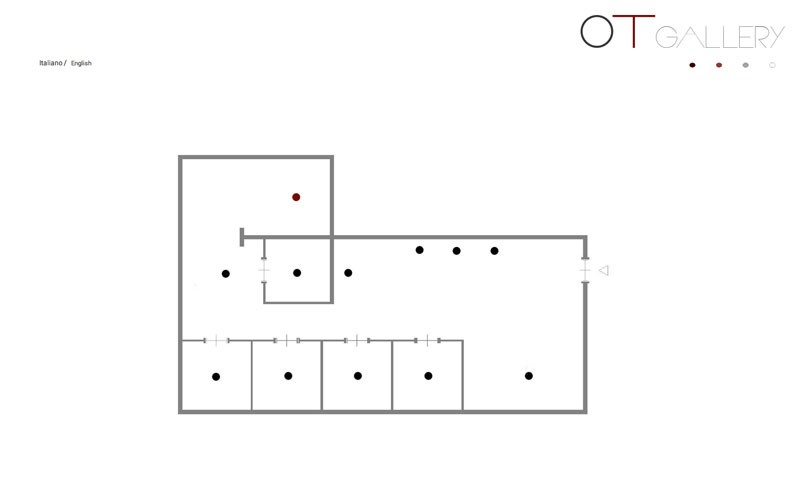
 Di seguito, un racconto sul sesso, le aspettative e le prime volte.
Di seguito, un racconto sul sesso, le aspettative e le prime volte.


 Scrivendo di sé nei sei mesi che aveva impiegato per terminare il suo breve libro di centocinquantasette pagine Ferguson si era ritrovato dentro un nuovo rapporto con se stesso. Sentiva un legame più intimo con i suoi sentimenti e allo stesso tempo si sentiva più lontano, quasi distaccato, indifferente, come se durante la stesura del libro fosse diventato paradossalmente una persona più calda e più fredda, più calda perché si era aperto e aveva mostrato le sue viscere al mondo, più fredda perché poteva guardare quelle viscere come se appartenessero a un altro, un estraneo, uno senza nome, e non sapeva dire se quella nuova relazione col suo io di scrittore fosse positiva o negativa, migliore o peggiore. Sapeva solo che il libro lo aveva sfinito, e non era sicuro che gli sarebbe tornato il coraggio di parlare di sé.
Scrivendo di sé nei sei mesi che aveva impiegato per terminare il suo breve libro di centocinquantasette pagine Ferguson si era ritrovato dentro un nuovo rapporto con se stesso. Sentiva un legame più intimo con i suoi sentimenti e allo stesso tempo si sentiva più lontano, quasi distaccato, indifferente, come se durante la stesura del libro fosse diventato paradossalmente una persona più calda e più fredda, più calda perché si era aperto e aveva mostrato le sue viscere al mondo, più fredda perché poteva guardare quelle viscere come se appartenessero a un altro, un estraneo, uno senza nome, e non sapeva dire se quella nuova relazione col suo io di scrittore fosse positiva o negativa, migliore o peggiore. Sapeva solo che il libro lo aveva sfinito, e non era sicuro che gli sarebbe tornato il coraggio di parlare di sé.