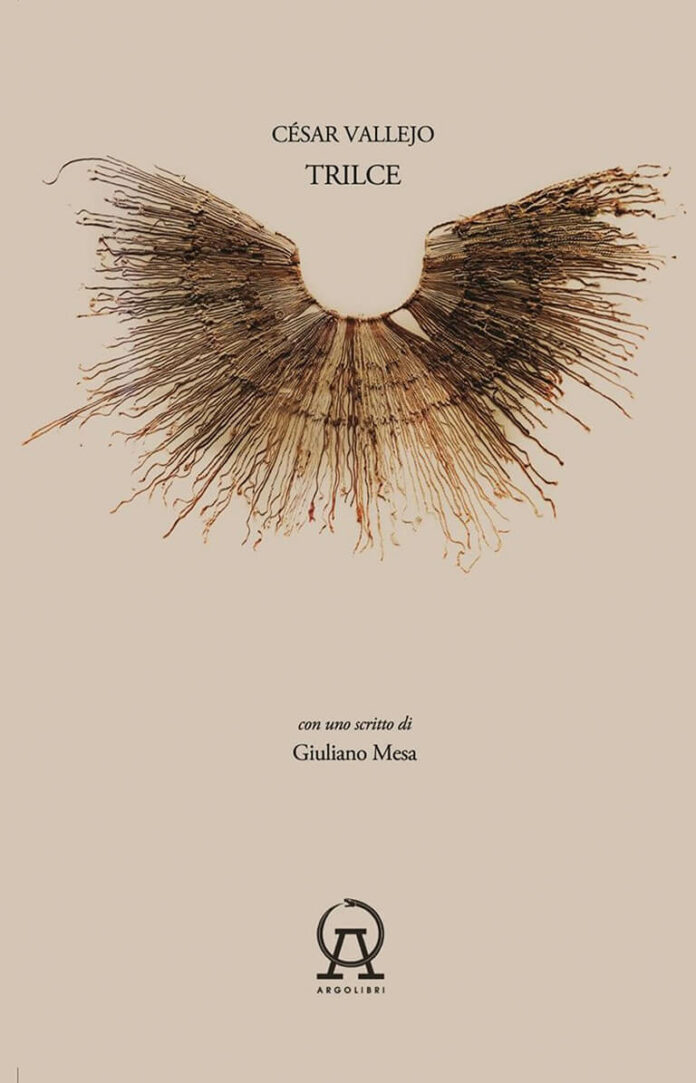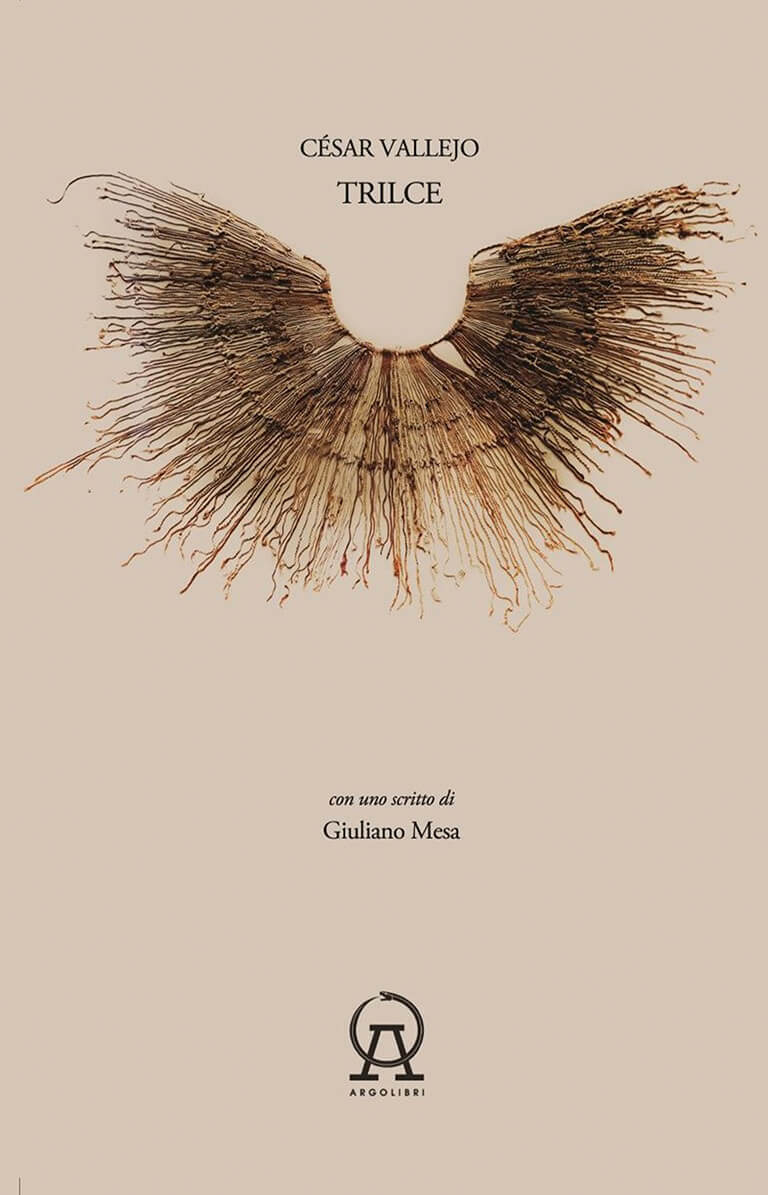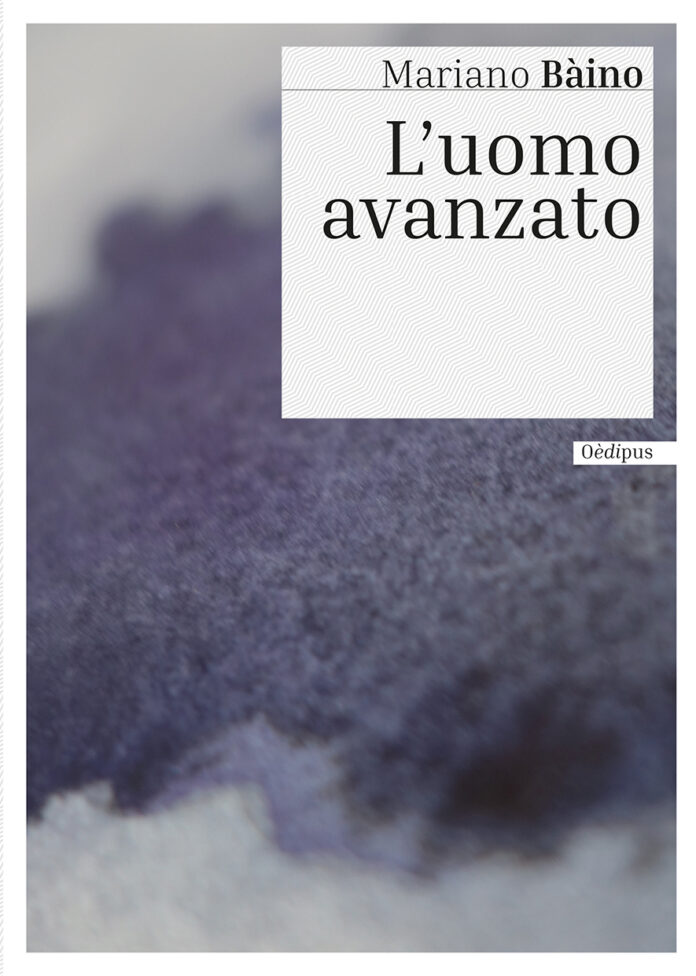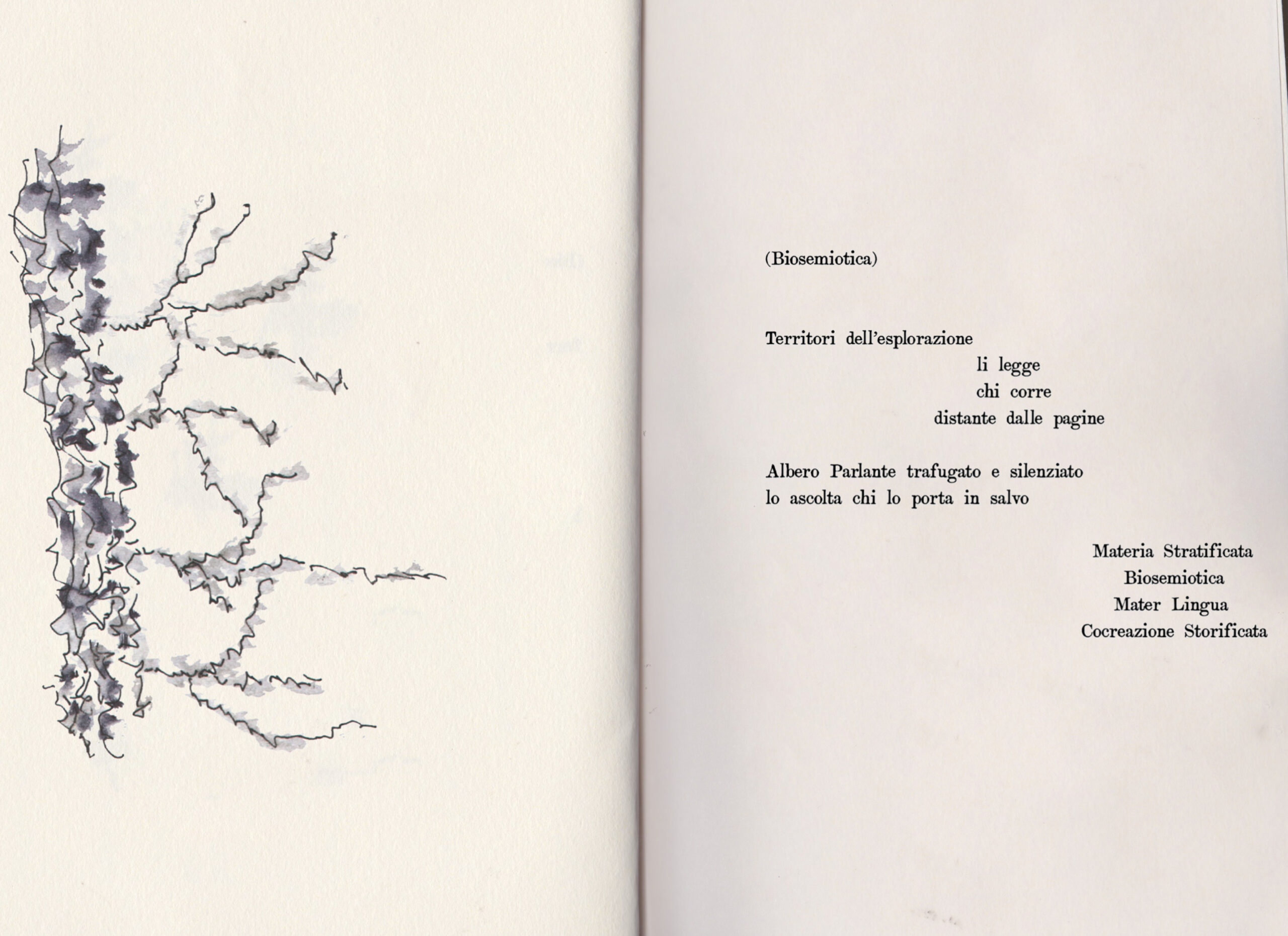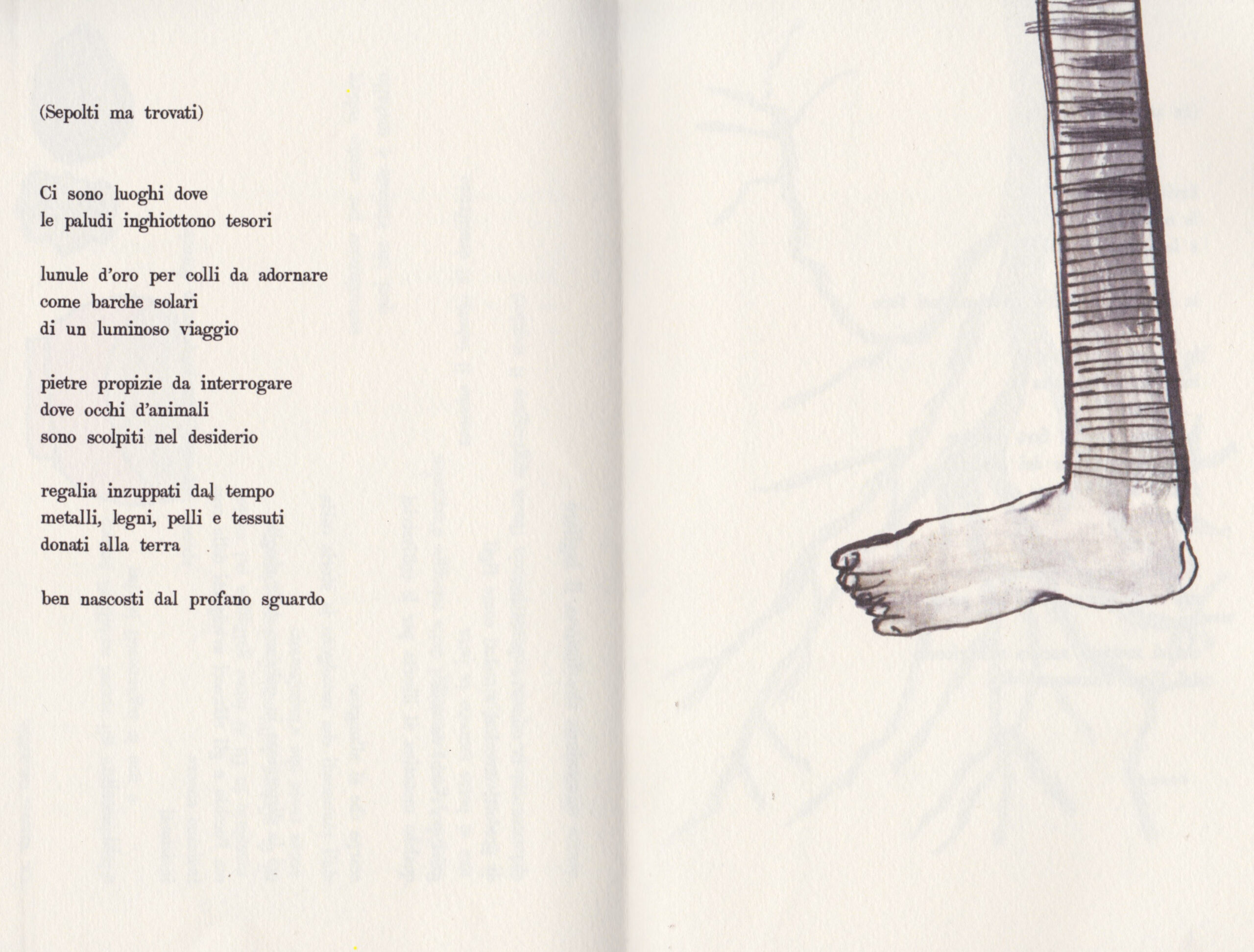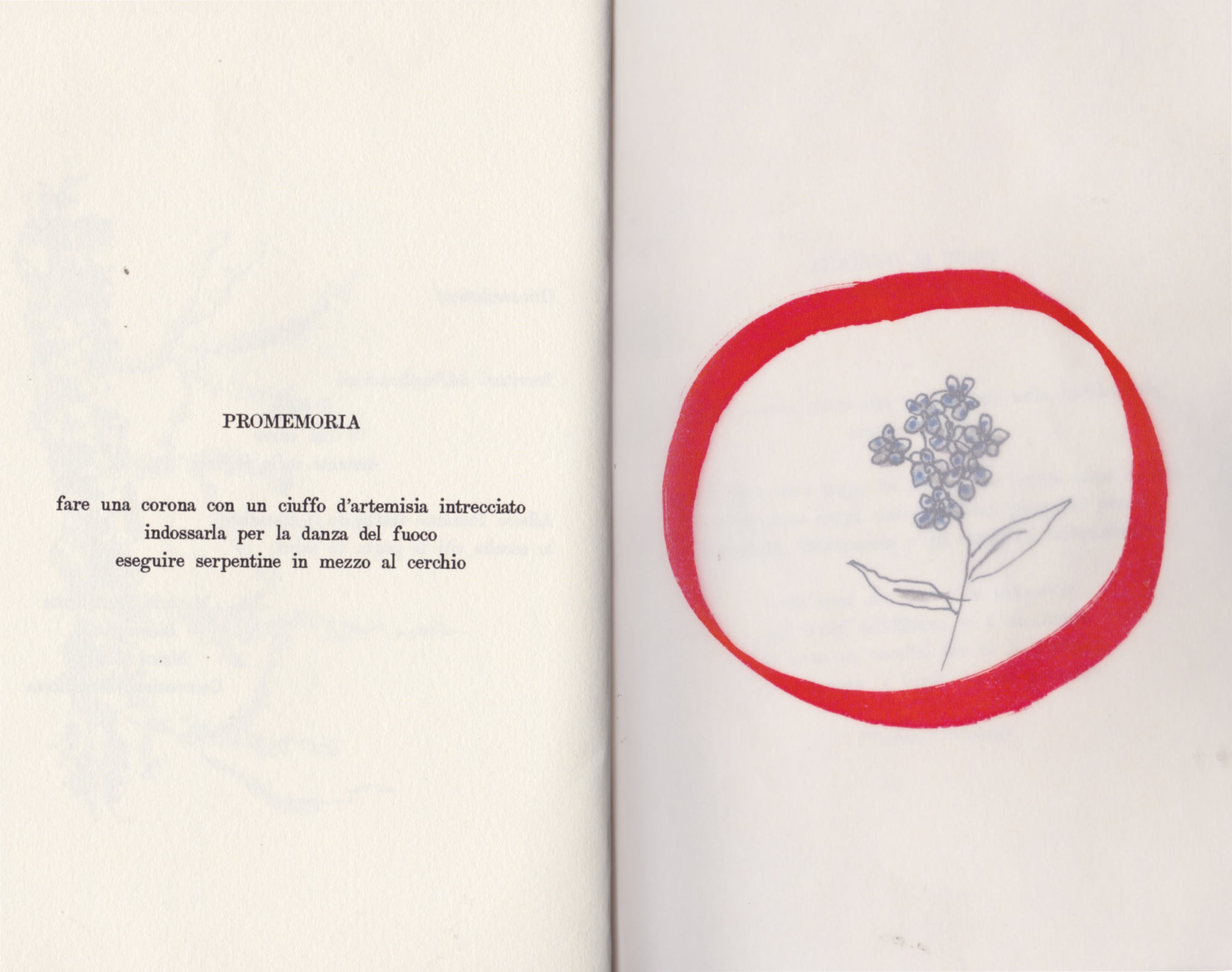Di Andrea Inglese
Forma e struttura della tecnologia seguono gli imperativi del rapporto sociale, e non l’inverso. Per questo persino gli apparecchi sono geneticamente penetrati dalla forma sociale.
Robert Kurz
L’universo del design industriale gravita in massima parte intorno al tema sensibile del servizio reso al fabbisogno di competenza necessario agli utenti strutturalmente incompetenti. Sotto questo profilo un utente è sempre un idiota che vorrebbe comprare sovranità.
Peter Sloterdijk
È diventato chiaro a tutti il “valore” dei dati, inteso come un sistema di informazioni al quale attingere per analizzare il presente, prevedere il futuro, cercare di conoscere meglio le condizioni di vita di ciascuno e di tutti.
Franco Pizzetti
Una minoranza di persone, in paesi come l’Italia e la Francia, ha denunciato una dittatura sanitaria, che avrebbe permesso una sorta di esperimento medico-scientifico di massa, e questo sarebbe avvenuto grazie all’apporto dei media, che si sono fatti propagandisti del governo, per manipolare la maggioranza del paese. Trovo tale lettura dei fatti non condivisibile su alcuni punti importanti, ma essa invita a riflettere su di un fatto indubitabile: da anni è in atto un esperimento di massa da parte di soggetti privati e pubblici, ma è di natura biometrica e politica, ed esso non avviene attraverso la propaganda frontale delle TV e della carta stampata, ma insidiosamente, attraverso il flusso informale d’informazioni che passa per i nostri social network. Di questo esperimento, poi, non siamo solo le vittime, ma i collaboratori premurosi e iperattivi, nutrendo dei nostri dati algoritmi dalla dubbia efficacia e aziende monopoliste, dedite alle molteplici pratiche illegali.
- Smartphone e tabù
Questo intervento ha poco da spartire con tutto ciò che, all’insegna di un fantomatico Umanesimo 2.0, dovrebbe decantare il felice sposalizio tra cultura umanistica e mondo digitale. D’altra parte, non è più un tema di moda da diversi anni, dal momento che la preoccupazione di tutti oggi è come continuare a servirsi sempre più diffusamente delle piattaforme informatiche, senza rimanerne schiacciati in un modo o nell’altro. È anche vero che una minoranza battagliera ha denunciato, in reazione alla gestione statale della pandemia nel nostro o in altri paesi, una svolta autoritaria, ovvero la perdita delle libertà individuali e l’instaurazione di una nuova forma di dittatura. Credo che queste persone, indipendentemente dalle loro motivazioni personali o appartenenze ideologiche, abbiano fissato con veemenza il dito, distogliendosi dalla luna. Quanto agli altri, cioè a noi tutti, la luna delle tecnologie elettroniche la guardiamo ancora con occhi acquosi e commossi, come figurine romantiche d’inizio Ottocento. Sappiamo che ha un lato oscuro, ma ognuno di noi si guarda bene dal formularne delle critiche in pubblico. Libertari o marxisti, ecologisti radicali o lucidi conservatori, cinici utilitaristi o liberali disincantati, noi gente di formazione umanistica ci guardiamo bene dal fare i bifolchi e gli oscurantisti. Si può criticare tutto – specialmente la democrazia –, strapparsi le vesti per i cataclismi climatici a venire, giurare di mangiare solo bacche e radici, ma delle tecnologie non si parla male in pubblico. Günter Anders lo aveva già constatato il secolo scorso: il tabù delle nostre società evolute e progressiste è la tecnica. Abbattete ogni pregiudizio, mettete sotto accusa ogni forma di vita, ma non toccate il mio smartphone!
2. La tesi della “dittatura sanitaria”: incompletezza e confusioni
La recente crisi pandemica ha contribuito ad allarmare una minoranza che, percependosi incompresa e perseguitata dalle istituzioni, ha denunciato la realizzazione di una forma di dittatura inedita, la dittatura sanitaria. Attraverso il cavallo di Troia della salute, nome supremo del bene pubblico, lo Stato e i governi sarebbero responsabili di aver dato il colpo di grazia alle nostre libertà di cittadini, imponendo forme di coercizione e di controllo di massa. Questa lettura della dittatura sanitaria, intesa non in senso metaforico ma in senso letterale, raccoglie adesioni in frange della popolazione eterogenee dal punto di vista ideologico: adepti delle medicine alternative, marxisti, libertari, neofascisti, populisti di varia sfumatura, ecc. Malgrado la radicalità di questa variegata minoranza nel rifiutare la prevaricazione delle istituzioni, una maggioranza della popolazione ha accettato di farsi vaccinare, e una parte consistente dei vaccinati considera il green pass come una sorta di male minore rispetto all’eventualità di nuove ondate pandemiche e di conseguenti confinamenti della popolazione. La denuncia della dittatura sanitaria tocca diversi problemi, tutti importanti ma non tutti ugualmente controversi. Inoltre, questi problemi vengono confusi spesso tra loro: esistenza del virus, nocività del virus, utilità dei vaccini, nocività dei vaccini, governo politico della crisi, obbligatorietà della vaccinazione, legittimità costituzionale del passaporto sanitario… (Tra le altre cose, questa veemenza contro l’imposizione del vaccino è essenzialmente eurocentrica, dal momento che, ad esempio, solo il 4% della popolazione africana è stata completamente vaccinata rispetto al 61% della popolazione residente in paesi ad alto reddito, secondo una stima delle Nazioni Unite. E il Sud Africa sta lottando per poter produrre da sé i vaccini sul proprio territorio, con l’ambizione di diffonderli su tutto il continente africano, liberandosi dalla dipendenza nei confronti delle case farmaceutiche statunitensi ed europee).
C’è comunque un punto incontestabile su cui gli allarmisti hanno portato l’attenzione: il modo in cui le istituzioni trattano i dati che riguardano lo stato di salute dei cittadini, grazie al potere di calcolo e scambio delle piattaforme e degli apparecchi elettronici. Di questo mi sembra importante parlare, ma al di fuori dell’ambito specifico della salute pubblica e di quello eccezionale della crisi pandemica. Vorrei ricordare come da anni sia in atto una forma di sfruttamento di massa degli utilizzatori mondiali delle piattaforme web e dei molteplici servizi informatici a esse legate, e come questo sfruttamento prepari, simultaneamente, le condizioni per forme non solo di controllo, ma di neutralizzazione della politica. Appare allora singolare che la massima allerta sulla situazione della nostra democrazia venga lanciata in occasione di una reale urgenza sanitaria, quando per anni la presenza nelle nostre vite delle tecnologie informatiche, anche da parte della minoranza oggi scandalizzata, è stata vista come poco o nulla problematica[1].
- Due scandali fondamentali (rivelazioni Snowden 2013 e l’inchiesta su Cambridge Analytica del 2018)
Da quando Edward Snowden, nel 2013, ha rivelato le pratiche di saccheggio sistematico e illegale di dati personali realizzato dalla NSA (Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti), tutti hanno capito che non è necessario essere i tanto commiserati cittadini di qualche Stato autoritario o dittatoriale come la Cina, per essere sottoposti a un regime di spionaggio capillare, e di trasparenza coatta che ricorda le distopie primonovecentesche di uno Zamjatin (Noi è del 1924). Possiamo essere invidiatissimi cittadini di democrazie liberali ad alto reddito medio, ed essere sottoposti a una metodica sorveglianza telematica, senza che questo crei disagi maggiori, almeno fino al giorno in cui scopriamo di essere stati considerati non come innocui studenti, lavoratori o pensionati, ma alla stregua di presumibili terroristi in atto di preparare qualche terrificante attentato. Non ci ha rasserenato neppure scoprire che i fedeli amici Facebook e Google, che da sempre garantivano l’opacità e l’anonimato nel trattamento dei nostri dati personali, si siano rivelati solleciti collaboratori dello spionaggio statunitense platealmente incostituzionale. Da quel fatidico giorno, tutti siamo diventati utilizzatori meno citrulli dei nostri apparecchi elettronici, e abbiamo richiesto ai GAFAM promesse di rispetto della privacy più altisonanti e convincenti. Abbiamo dovuto aspettare il 2018, però, per scoprire che, nell’uso illegale dei nostri dati, peggio della NSA poteva fare una società di consulenze inglese, Cambridge Analytica, grazie alle sempre sollecita complicità di Facebook. Le inchieste di giornalisti di media mainstream, quali il quotidiano The Guardian o il settimanale The Observer[2], hanno permesso di comprendere il ruolo cruciale che i dati personali hanno avuto nell’orchestrazione di efficacissimi programmi di propaganda mascherata, in grado di determinare l’esito di un referendum nazionale – quello sulla Brexit nel Regno Unito – o di un’elezione presidenziale – quella statunitense del 2016. Non siamo più di fronte, in questo caso, a una forma di sorveglianza globale orchestrata dalla superpotenza del pianeta, ma alla possibilità che partiti o singoli candidati siano in grado d’interferire in modo occulto sul meccanismo del voto libero, ossia sul fondamento delle società democratiche. Neppure un appello alla più abusata ragion di Stato può qui giustificare alcunché. In effetti, l’affaire Cambridge Analytica sta alle nuove tecnologie e alla crisi del processo democratico, come l’affaire dei subprime stava alla nuova economia (finanziaria) e alla crisi economica del 2008. Per capire come funziona il capitalismo del XXI secolo e quali minacce comporta, oltre a quelle ampiamente indagate dal marxismo e dal pensiero critico novecentesco (alienazione, sfruttamento, rapporti di potere, ecc.) è indispensabile studiare queste crisi, cominciando con l’individuare gli attori in gioco.
- Ideologie, saperi, tecniche
Per rendere intellegibile l’accusa di manipolazione di massa che è stata sollevata nel caso delle elezioni statunitensi del 2016 e del ruolo in esse svolto da Cambridge Analytica, bisogna mettere in campo almeno sei attori distinti: i finanziatori, gli scienziati, i raccoglitori di dati, i propagandisti, i candidati politici, gli utilizzatori – fonte di tutto il processo, in quanto fornitori gratuiti di dati, e obiettivo finale di esso, in quanto elettori-bersaglio. Il finanziatore di Cambridge Analytica, società privata, è il miliardario statunitense Robert Mercer, grande sostenitore dell’estrema destra politica e culturale, che ha costruito la sua fortuna nel mondo dell’intelligenza artificiale e in quello della finanza. All’origine stessa di CA vi è dunque un imprenditore che sostiene una specifica ideologia, e che non dissocia gli obiettivi commerciali da quelli politici. Lo scienziato è Aleksandr Kogan, un americano di origine moldava che, all’epoca dei fatti, lavora al Dipartimento di psicologia sperimentale dell’Università britannica di Cambridge. Lo statuto “disciplinare” di Kogan è fluido, ma abbraccia il campo della psicologia, della psicometria e dalla “scienza dei dati”. Inoltre ha un profilo professionale ibrido: è scienziato ma anche imprenditore. (In atri termini, siamo di fronte a un tipico membro di quella che un po’ pomposamente viene chiamata la tecno-scienza). Kogan infatti realizza un programma, This is your digital life, in grado di raccogliere i dati personali di 270.000 utilizzatori americani di Facebook con il loro consenso, per costituire dei profili psicologici di base (“personalità”). Partecipare al questionario implica una minima remunerazione e un accordo esplicito. In realtà, il programma raccoglie – con il benestare di FB – anche tutti i dati dei contatti ignari (amici, ecc.) di questi utilizzatori consapevoli. E questa seconda cerchia si estende a milioni di account. L’enorme massa di dati è poi venduta a Cambridge Analytica, che li utilizza al servizio della campagna elettorale pro-Trump, mettendo in opera uno specifico tipo di propaganda.
Fermiamoci, però, un attimo su Kogan e la sua app. Il tipo di lavoro di Kogan è quello che si riassume in formule come questa: “Se ha accesso a 300 dei tuoi like, l’algoritmo ti conosce alla fine meglio di tua madre o di tua moglie”. Ora questo è il tipico enunciato che richiederebbe di essere verificato scientificamente, ma sarebbe già complicato capire che cosa davvero significhi e come eventualmente potrebbe essere verificato. Quello che in realtà conta, è che un tale enunciato venga “preso come buono” (in attesa di eventuali e future prove scientifiche) sia da coloro che approvano l’uso di questo “riduzionismo” psicologico, sia da coloro che temono di finire troppo facilmente e troppo precisamente catalogati. Il sapere “scientifico” mobilitato da personaggi come Kogan trae il suo prestigio non da una verità a monte (d’ordine sociale o psicologico), ma dalle promesse più o meno mantenute a valle di qualche efficacia applicativa (la modificazione di un comportamento). Poco importa che le “personalità di base” corrispondano a una realtà oggettiva della psiche umana; conta soprattutto quello che esse ci permettono di fare sulle persone. D’altra parte, questo è il cuore della faccenda di Cambridge Analytica: “raccogliere ed elaborare i dati personali degli individui ci permette di prevedere i loro comportamenti”, dicono a braccetto scienziati e tecnici; in realtà l’uso di tali dati non è predittivo, ma condizionante. Nelle mani di politici o imprenditori, i dati personali servono per modificare i comportamenti (degli elettori o dei consumatori). La scienza psicologica sostiene, grazie alla potenza di calcolo delle macchine e alla massa di dati disponibile, di aver individuato le chiavi del comportamento umano (conosciamo le leggi, e quindi prevediamo i fenomeni); dietro questo paravento ideologico, i profili psicologici così elaborati forniscono strumenti ulteriori per azioni di vera e propria manipolazione, promosse da aziende, gruppi politici, ed eventualmente Stati e governi.[3]
Facebook è colui che ha permesso a Cambridge Analytica di avere in mano non solo i dati dei 270.000 sottoscrittori dell’applicazione This is your digital life, ma degli 87 milioni di account che erano collegati a quei primi 270.000. Ogni volta Mark Zuckerberg, coinvolto in inchieste parlamentari negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha giocato la carta di colui che non sa e non capisce quello che è successo, scaricando la responsabilità sugli altri (nel caso specifico Cambridge Analytica). Da questa vicenda, però, abbiamo imparato tutti almeno una cosa: chiunque abbia un piano sufficientemente malvagio e sufficientemente finanziato, per ottenere un’immensa quantità di dati su ogni utilizzatore di Facebook (si parla, per il 2021, di 2,80 miliardi di utenti attivi ogni mese), fa una telefonata a Zuckerberg e può tentare di convincerlo. Noi non sappiamo se ci riuscirà, come ci sono riusciti in passato la NSA o Cambridge Analytica, ma sappiamo che Zuckerberg, lui, quella manna di dati che ci riguardano, ce l’ha pronta. Sono dati che lui possiede, non noi. E, se non gli bastassero, ogni nostro nuovo click sulle sue piattaforme – ogni nostro contenuto, condivisione, like, ecc. – va ad arricchire la manna.
Cambridge Analytica è stata la filiale “presentabile” di una casa madre, SCL Group, che per lungo tempo ha preferito restare nell’ombra. Si tratta di una società fondata alla fine del secolo scorso dall’americano Steve Bannon, ideologo della destra sovranista mondiale e celebre direttore della campagna presidenziale di Trump, e dall’inglese Nigel Oakes. SCL è stata una macchina di propaganda che offriva molteplici servizi, lavorando anche nel settore militare per clienti quali il Ministero della Difesa britannico o la Nato. Una delle specialità di SCL erano le Psychological Operations Group – le PSYOPS –, ossia operazioni di condizionamento di massa, realizzate in un contesto bellico. Uno degli ex-dirigenti pentiti di Cambridge Analytica, Brittany Kaiser (autrice di La dittatura dei dati, Harper Collins, 2019) ha confermato pubblicamente che Cambridge Analytica, nelle campagne per la Brexit e in quella presidenziale pro-Trump, utilizzava tecniche di condizionamento militare, per convincere gli indecisi (definiti i persuadables). Ciò che rende la propaganda messa in atto da Cambridge Analytica, però, ancora una volta, non è tanto la sua pretesa “scientificità” – questo è il loro argomento di marketing –, ma la sua capacità di passare inosservata, di non lasciare tracce, d’introdursi nel flusso della comunicazione in gran parte privata che scorre sulle piattaforme informatiche senza annunciarsi come tale, senza logo. In altri termini, non solo chi è l’obiettivo di questa propaganda ignora di essere sottoposto ad essa – a differenza di quanto accade anche nei casi di massiccia propaganda politica o pubblicitaria –, ma è poi impossibile verificare e documentare gli autori, l’origine, l’itinerario, la persistenza di tali contenuti propagandistici. Tutto entra in modo anonimo nel circuito delle piattaforme e tutto si disperde nei rivoli degli account privati, per poi eventualmente scomparire al momento opportuno.
Nel caso delle elezioni presidenziali USA del 2016, malgrado sia difficile misurarne l’impatto reale, l’obiettivo di Cambridge Analytica è stato chiaro: bombardare di contenuti un numero limitato di elettori perplessi nei pochi Stati del paese che avrebbero deciso la vittoria dell’uno o dell’altro candidato. E sappiamo che, in definitiva, 70.000 elettori in tre soli Stati (Wisconsin, Pennsylvania e Michigan), hanno determinato la vittoria di Trump (Usa 2016: Clinton +3 milioni di voti, per Trump decisivi 3 Stati – America 24).
Le attività di propaganda mascherata da realizzare sulle piattaforme, come quelle di Cambridge Analytica, non sono di per sé finanziate esclusivamente da soggetti politici conservatori o di estrema destra. Innanzitutto, come spesso accade in questi casi, le nefandezze in ambito militare, politico ed economico si sperimentano di preferenza nei paesi del Sud del mondo, ed è stato questo il caso sia della casa madre SCL Group che della sua filiale apparentemente più presentabile CA. La storia di queste due società – dei loro finanziatori, dirigenti, clienti privilegiati – mostra però una chiara preferenza ideologica, come il caso di Steve Bannon dimostra, essendo stato il fondatore di SCL, il vice presidente di Cambridge Analytica, il direttore della campagna di Trump e, dopo la vittoria di quest’ultimo, il capo stratega della Presidenza per i primi sette mesi. Questa constatazione vale anche per il tipo di tecniche che queste società mettono a disposizione. Tra gli strumenti di propagandata mascherata, vi è quello, ad esempio, dell’astroturfing, che consiste nel simulare iniziative di cittadinanza o movimenti spontanei dal basso, grazie alla creazione mirata di falsi account, forum, petizioni sul web. Non solo tecniche del genere minacciano il genuino processo democratico, ma anche richiedono, per essere efficaci, finanziamenti importanti che sono prerogativa dei soggetti economici più forti.
5. Facebook promette connessioni tra persone, ma noi vi cerchiamo soprattutto la nostra espressione individuale
Veniamo ora a coloro che forniscono quotidianamente la materia prima che permette il rafforzamento di queste realtà – dalle piattaforme elettroniche agli scienziati che lavorano su progetti di intelligenza artificiale, dalle società di consulenza e di comunicazione alle forze politiche che ne costituiscono la clientela. Noi utilizzatori del web, dei motori di ricerca, dei social network, di Amazon, ecc., costituiamo la base di una complessa piramide, che per esistere commercialmente, tecnicamente, politicamente, deve poggiare sulle nostre attività telematiche quotidiane, deve insomma trarre dai nostri comportamenti abituali il “petrolio del nuovo secolo”, ossia informazioni su quello che facciamo e quello che acquistiamo, su quello che pensiamo e quello che sentiamo. Per lungo tempo non ci siamo troppo interrogati su questo generoso accordo: le piattaforme come Facebook ci fornivano un servizio gratuito, un servizio per altro tra i più benevoli e desiderabili, quello di connettere le persone tra loro. Ma la semplice connessione non è bastata né a Facebook né a noi utilizzatori. Un’occhiata all’evoluzione della piattaforma (delle sue tecniche e dei vari re-design della sua pagina) mostra che il servizio si è articolato intorno a elementi come il tasto like (lanciato nel 2009), gli stickers e #Hashtags (2013), le cinque nuove Facebook Reactions (2016), a cui si aggiunge, in piena pandemia, la nuova Care Reaction (il pianeta che stringe un cuore nel 2020). Questo naturalmente è solo uno degli assi evolutivi del servizio gratuito che Facebook mette a disposizione della sua comunità mondiale, ma è anche uno dei più interessanti.
È paradossale che il mito di Facebook come grande “connettore” debba ormai coabitare con le immagini angoscianti del grande “divisore”. Da più parti si è sottolineato come il modo di funzionare di Facebook (ma ciò vale anche per altre piattaforme come Youtube) accentui le polarizzazioni ideologiche e le visioni riduttive della realtà (se ne parla, ad esempio, nel documentario The social dilemma). Di questo paradosso, però, siamo tutti coscienti, dal momento che tendiamo ormai ad associare il nostro account al concetto di filter bubble, ossia di bolla che gli algoritmi rendono ermeticamente chiusa nella sua soddisfacente autoreferenzialità. D’altra parte, questa chiusura o questa alta selettività ha una controparte importante: più siamo in un terreno protetto più siamo disposti a esprimerci liberamente. Le “bolle filtranti” ci permettono di essere noi stessi ogni giorno e in una sfera ibrida tra privato e pubblico. E se dobbiamo ringraziare Facebook per la gratuità dei suoi servizi, dovremmo riconoscergli oggi un interesse molto più indirizzato alla nostra autentica espressione di sé di fronte agli altri, che alla semplice connessione con gli altri. I bottoni che riguardano le nostre presunte emozioni sono stati pensati, disegnati, e installati per questo preciso motivo. Non basta far circolare foto, testi scritti (ricordi, opinioni, ecc.), tracce musicali, materiali giornalistici o di studio; a partire dal 2009 e ancor più dal 2016, è importante far circolare anche le nostre “emozioni”.
Anche in questo caso, bisogna chiarire di ciò che stiamo parlando. Quale sia un’autentica e soddisfacente espressione delle nostre emozioni è una faccenda assai complessa, e di certo nessuno crede davvero che il tasto Wow o Grrr offrano un equivalente del nostro vissuto emotivo o del modo in cui esso è modulato attraverso i quadri culturali d’appartenenza. Facebook, basandosi in parte su dei saperi scientifici (le Big Six dello psicologo statunitense Paul Ekman) e sul design grafico, ha proposto ai suoi utilizzatori una grammatica di stati emotivi, che sono ovviamente convenzionali e ai quali, quindi, gli utilizzatori si devono adattare. Il successo di questa grammatica non è quindi dato da una presunta adeguazione con quanto avviene nella psiche umana, ma dalla diffusione su larga scala della convenzione, dalla riuscita, insomma, dell’adattamento richiesto all’utilizzatore. Senza la buona volontà di quest’ultimo, le Facebook Reactions non avrebbero avuto lunga vita. Ognuno di noi si è adattato con minore o maggiore reticenza all’uso di queste ulteriori opzioni comunicative. Non è sorprendete, dal momento che Facebook sposa da tempo un nostro desiderio profondo, che è quello di esprimere noi stessi, e quindi ogni nuovo strumento, ogni nuova funzionalità, non può che incontrare una disposizione favorevole da parte nostra, e qualsiasi forma di scetticismo, di postura critica, finisce immancabilmente per dissolversi, sotto la pressione dello spirito gregario.
Ciò che, tra le altre cose, favorisce nostra docilità nei confronti delle nuove tecnologie e dei quadri comunicativi che finiscono per imporci è che noi tendiamo a darne una lettura principalmente psicologico-moralistica. Per un certo numero di anni abbiamo parlato dell’indecente impudicizia, del chiassoso esibizionismo, del compiaciuto narcisismo che l’uso dei social aveva fatto emergere. Poi abbiamo anche smesso di parlarne, dal momento che un certo esibizionismo sui social è divenuto in qualche modo una regola, una forma di vita condivisa pacificamente, e quindi inutile da criticare. Ognuno ha imparato a gestirlo, a dosarne la quantità, senza doverlo sciaguratamente soffocarlo. Tale diagnosi, però, rimaneva alla superficie, o meglio si rivolgeva come sempre alle debolezze (o colpe) dell’individuo, piuttosto che all’ampiezza e alla ragione d’essere di un sistema. L’atteggiamento moralistico permetteva (e continua a permettere) di difendere un mito essenziale: la neutralità della tecnica. Il tabù dell’ineluttabilità del progresso tecnologico ha come corollario l’idea che una nuova tecnica sia uno strumento, la cui buona o cattiva applicazione dipende dalla bontà o cattiveria del suo utilizzatore, ossia dal suo grado di maturità psicologica, integrità morale, consapevolezza politica, ecc. In L’industria culturale nel XXI secolo. Sull’attualità del concetto di Adorno e Horkheimer, una conferenza del 2010, Robert Kurz, filosofo d’ispirazione marxista, mostra come l’evoluzione dei GAFAM si possa leggere come una tappa ulteriore dell’industria culturale novecentesca e dell’ideologia che la legittima. In altri termini, è l’evoluzione sociale – il rapporto tra capitale e lavoro, quale si è definito attraverso l’offensiva neoliberista che dura ormai da quarant’anni – che precede e determina l’interpretazione tecnologica. Ovviamente ricordare che i nostri strumenti di comunicazione ed espressione di sé quotidiani sono impregnati di ideologia, e veicolano una visione del mondo, dei rapporti umani, dei nostri fini, non neutra, non astorica, non apolitica, non innocua, ci pone in un certo imbarazzo. Ci ricorda la fragilità della nostra buona volontà, del nostro grado di consapevolezza, persino del nostro impegno nel voler rendere la società migliore. Noi ci siamo talmente abituati a guardare la tecnologia come uno specchio del futuro, di qualcosa che deve ancora essere costruito, e di cui noi siamo attivi costruttori, che dimentichiamo facilmente come essa venga dal passato, sia stata pensata e costruita – decisa – da piccole cerchie di persone, e ci venga trasmessa come un’eredità indiscutibile da introdurre nelle nostre vite e da far fruttare.
“We built Facebook to help people stay connected and bring us closer together with the people that matter to us”, scrive Mark Zuckerberg in un post del 2018. Mia nonna (e come lei molte persone nate nella prima metà del secolo) avrebbe potuto rispondere: “Ma come ti permetti?”. Che cosa ne sai tu, e ne vuoi sapere tu, delle persone a cui io, abitante tra gli altri del pianeta, tengo in modo particolare? Cosa c’entri tu? E perché mai le relazioni umane per me più importanti (quelle dense di affetti) dovrebbero avere bisogno del tuo aiuto per esistere? Se, però, ci immaginiamo di essere, o siamo davvero divenuti una moltitudine atomizzata di individui che fa fatica a capire cosa la tiene assieme, se insomma i significati collettivi, come i progetti che ad essi si articolano, sono divenuti sempre più oscuri e misteriosi, allora è non solo utile, ma indispensabile che qualcuno si occupi non solo di connetterci tra di noi – povere isole che siamo – ma anche di permettere agli affetti di circolare (a partire dalle emozioni più elementari), in modo che lo stare assieme virtuale abbia una qualche vaga analogia con lo stare assieme conviviale, ossia quello radicato nei corpi.
In un altro passo della sua conferenza, Kurz fornisce un’interpretazione generale della nostra irresistibile tendenza a esprimere noi stessi sulle piattaforme elettroniche:
“Gli individui si comportano sempre di più come se fossero i loro stessi attori nel loro proprio teatro. Questa pseudo-vita virtuale non ha semplicemente una funzione compensatrice rispetto alla miseria dei rapporti sociali reali, ma in maniera ideologica e immaginaria è elevata al rango di “autentica” realtà riguardo alla quale l’esistenza sociale e materiale appare come una semplice appendice e come già quasi irreale.”
Pochi oggi si lasciano ancora persuadere dal gergo “dialettico” di Kurz e dalle vetero gerarchie ontologiche, che pretendono contro ogni evidenza post-moderna di dare priorità alle relazioni umane incarnate piuttosto che a quelle immateriali. Nessuno vuole “svalorizzare” grazie a una semplice formula concettuale una larga fetta di interazioni con il proprio prossimo che passa per l’account Facebook, bottoni “emozionali” inclusi. E questo è in parte comprensibile. Ognuno di noi può impegnarsi a dimostrare che le interazioni “virtuali” sono una continuazione con altri mezzi di rapporti sociali autentici con persone in carne ed ossa, o ne costituiscono eventualmente l’anticamera. Quello che però difficilmente si può ignorare è il meccanismo compensatorio (leggi consolatorio) che sta alla base della nostra non episodica attività sui social network. Di questo ho provato io stesso a scriverne proprio su Nazione Indiana (https://www.nazioneindiana.com/2021/04/30/di-lavoro-non-ne-parliamo-per-favore/), mettendo l’accento sulla nostra scarsa felicità lavorativa e sul modo di esorcizzarla in pubblico attraverso i social: “Ognuno si rimbocchi le maniche, e quando è uscito dal buco nero del lavoro salariale, vada altrove, sui social network ad esempio, a strofinare, laccare, addobbare la propria identità. Tutti abbiamo una vita fuori dal lavoro: bisogna pur farne qualcosa, esibirla, fotosciopparla, brandirla come la prova di un’esistenza degnamente umana e individualizzata.”
Dopo quarant’anni di offensiva neoliberista come sta il nostro lavoro salariato? Forse i nostri rapporti sociali sono radiosi, ma è difficile che le imprese o le istituzioni in cui lavoriamo, o cerchiamo di lavorare, siano altrettanto radiose nei nostri confronti. Naturalmente è possibile che tutta questa faccenda di un’offensiva ideologica, organizzativa e politica sfavorevole ai lavoratori, ai loro diritti e garanzie, ai loro valori e ideali professionali, sia stata una delle grande bufale del nuovo secolo, una delle più riuscite fakenews di matrice marxista. Se non fosse che di questo fenomeno storico esiste ormai una variegata e multidisciplinare letteratura. E poi basta leggersi i propri contratti di lavoro, per sciogliere ogni dubbio.
Naturalmente si potrebbe fare un’analisi più fine incentrata sul nesso splendore dei social e miseria del lavoro, includendo altre categorie: dai disoccupati a coloro che cercano di trasformare le piattaforme in una forma di reddito. In ogni caso, noi umanisti – disoccupati, precari o pienamente occupati – siamo quelli che maggiormente, io credo, viviamo un rapporto ambivalente con le nuove tecnologie: non ne godiamo direttamente i frutti economici e professionali, non ne siamo gli ideatori e gli architetti, non possiamo che fungere da retroguardia affannata, pronta a giurare sulle proprie capacità di aggiornamento (leggi sforzi di adattamento). Siamo coscienti di un ritardo cronico, di un’obsolescenza fatale legata alla nostra formazione; non ci resta, quindi, che saltare sul treno costi quel che costi e, nei casi migliori, esibire una sbrigliata attitudine multimediale. Percepiamo che, anche solo sul piano del lavoro intellettuale e creativo di ciascuno, tali ambienti sono una minaccia fortissima. Ci succhiano attenzione in modo osceno, indirizzandola su contenuti incredibilmente semplici e spesso irrilevanti. Acuiscono invece di saziarli i nostri bisogni di riconoscimento sociale. Disperdono e dissipano invece di concentrarle le nostre energie conviviali o critiche. Ma è terribilmente costoso rinunciarvi. La dipendenza dallo smartphone viene a completare il quadro.
Per inciso, sarebbe un errore illudersi che i “nativi digitali” siano stati risparmiati dal demone dell’ambivalenza, come se la loro familiarità con le piattaforme elettroniche non fosse frutto di un doloroso e conflittuale processo di socializzazione, ma un portato genetico. D’altra parte, l’ambiguità semantica connessa alla formula “nativi digitali” è la spia più evidente che siamo penetrati su di un terreno ad alto tenore ideologico. Il termine “nativo” in questo caso indica l’esperienza di un apprendimento o di un adattamento a un ambiente (linguistico o climatico) che avviene dalla nascita, ma esso viene volentieri inteso secondo una ben diversa accezione, quella di disposizione innata. Per il bene dei nostri figli, ci piacerebbe illuderci che essi scivolino senza attriti, ferite, conflitti nell’ambiente digitale, così come un gatto che salta da un muretto all’altro guidato da un istinto infallibile. La realtà è purtroppo diversa, come hanno cominciato a denunciare diverse inchieste sulla salute dei giovani utilizzatori di social (Ansia e depressione: gli effetti dei social sui giovani. ”Instagram è il peggiore” – la Repubblica / Association between Social Media Use and Depression among U.S. Young Adults (nih.gov).
6. Lavoratori del clic: alienati, sfruttati, ma contenti
“Nel quadro di un’economia del contributo, i molteplici link cliccati dagli internauti partecipano all’elaborazione di basi di conoscenza e di risultati statistici, sfruttati dalle piattaforme sulle quali essi agiscono. L’espressione digital labor designa l’attività degli utilizzatori così sfruttati (che noi proponiamo di tradurre con “lavoratori del clic”): i contributori di wiki, gli autori di commenti, gli iniziatori e gli intermediari di reputazione, i creatori di contenuti per i social network, gli operai che realizzano in serie attività che gli algoritmi non possono ancora industrializzare (…) e ben inteso tutti gli internauti dal momento in cui cliccano semplicemente su di un like, un cuore, ecc. Il lavoro effettuato costituisce un’attività a bassa intensità e richiede una competenza minima che, grazie all’industrializzazione di questo processo applicato a milioni di utilizzatori, produce un forte valore economico a beneficio esclusivo del proprietario della piattaforma numerica.”
Potremmo, ad esempio, partire da qui. Potremmo cominciare a considerarci lavoratori inconsapevoli del clic e, come tali, anche sfruttati e alienati. Un’analisi approfondita del nostro “lavoro in rete”, e della nostra capacità di mobilitare anche il livello più intimo delle emozioni e successivamente degli affetti, sollecitati delle piattaforme elettroniche, è presentata dai ricercatori universitari Camille Alloing e Julien Pierre in Le web affectif, une économie numérique des émotions, libro del 2017. Certo, questo non corrisponde al nostro punto di vista. Noi, soggettivamente, in quanto utilizzatori, siamo impegnati in strategie personali per trarre da Facebook e Google tutto quanto va a nostro vantaggio. E se le strategie paiono funzionare, se proviamo soddisfazione o otteniamo premi simbolici o addirittura materiali, non facciamo che infittire la nostra presenza. Se le cose vanno meno bene, cerchiamo di cambiare strategia. In ogni caso, ci sentiamo vincenti e sovrani nella nostra attività in rete. Dal punto di vista delle piattaforme, però, l’unico scacco possibile è la nostra latitanza dalla rete, il nostro assenteismo dal clic, la nostra decisione scriteriata di lasciare intatta, inutilizzata una qualche funzione. L’unico scacco Facebook lo conosce quando recidiamo il filo dell’attenzione e abbandoniamo lo schermo per andare a preparare una cena, per discutere con un amico senza smanettare contemporaneamente con lo smartphone, per sederci accanto a un figlio per leggergli qualche pagina di un libro, per impegnarci in una litigata di coppia. In tutti gli altri casi Facebook e le altre piattaforme sono pienamente vincenti, perché noi produciamo dati per le loro elaborazioni statistiche e perché ci esponiamo alla pubblicità dei loro clienti. Ed è questo che garantisce i loro introiti, il loro successo materiale, economico. La nostra continua disponibilità a fornirgli informazioni sulla nostra vita (i pensieri, i gusti, i movimenti, le emozioni, i bisogni, ecc.) permette anche l’evoluzione, il progresso, l’applicazione a raggio sempre più vasto dei loro algoritmi. Non vi è posizione più asimmetrica. Noi forniamo loro la materia prima (tutte le informazioni che permettono di costruire dei profili di consumatori e di elettori e di cittadini di future città intelligenti e securizzate) e, nello stesso tempo, contribuiamo a raffinarla almeno in forma elementare questa materia, grazie ad esempio alle Facebook Reactions o alla pratica di qualche nuova funzionalità. Loro in cambio ci permettono di dispiegare le nostre singole strategie, sempre fallibili e provvisorie. La gratuità è la loro forza di attrazione maggiore: nessuno nel mondo, quale sia la sua condizione sociale, potrà esitare nel mettersi al lavoro del clic.
La migliore controprova di questa nostra condizione di sfruttamento viene dal recente documento – febbraio 2020 – della Commissione Europea in materia di trattamento di dati. S’intitola Una strategia europea per i dati. Negli anni passati, l’Europa – avendo rinunciato a investire in proprie piattaforme informatiche – si era concentrata sulla protezione dei dati personali e sul diritto alla privacy. Ora vuole passare da semplice agente regolatore a protagonista attivo nella raccolta, gestione e circolazione dei dati non personali per quanto riguarda il territorio europeo[4]. (Per intenderci, i dati non personali sono quelli che già costituiscono il business legale di tutte le piattaforme dei GAFAM, quando non intervengono eventi “criminali” come la sorveglianza generalizzata della NSA o la propaganda mascherata di Cambridge Analytica.) Il punto che più m’interessa è messo in luce in un articolo dedicato a questa nuova iniziativa europea. L’autrice, Federica Maria Rita Livelli, parlando dei Data Trust, sorta di collettori e gestori paneuropei di dati, scrive a un certo punto:
“I cittadini raccoglieranno “dividendi per i dati”, che potrebbero includere pagamenti monetari o non monetari da società che utilizzano i loro dati personali. In questo modo i Data Trust faranno riferimento a circa 500 milioni di cittadini europei che diventeranno fonti di dati, dando origine al più grande mercato di dati del mondo. Inoltre, i dati – sia creati dai cittadini europei sia generati su di essi – saranno conservati in server pubblici e gestiti dai Data Trust. Si ipotizza che tali Data Trust potranno supportare le imprese e i governi europei, potranno riutilizzare ed estrarre valore dalle enormi quantità di dati prodotti in tutta l’area europea e, al contempo, permettere ai loro cittadini di beneficiare delle stesse proprie informazioni. La documentazione del progetto, tuttavia, al momento, non fornisce informazioni chiare sui compensi da destinarsi ai singoli individui.” (Corsivo mio).
Voi forse non lo sapevate con chiarezza, ma i membri della Commissione Europea, non certo dei marxisti incalliti, loro lo sanno fin troppo bene che, in un’economia mondiale basata sui dati, coloro che questi dati li producono attraverso attività in rete o come utilizzatori di servizi elettronici hanno diritto a dei dividendi. Ciò è talmente chiaro ai dirigenti europei, che si guardano poi bene dal fornire alcuna precisazione su quanto e come pagare il nostro lavoro del clic.
Oltre a essere sfruttati, però, noi, proprio come i vecchi operai novecenteschi, siamo anche alienati. Una frase di Peter Sloterdijk ci introdurrà al problema: “I più comuni macchinari del mondo contemporaneo – gli orologi, le automobili, i computer, il parco strumenti dell’elettronica di consumo, gli utensili di precisione e altre cose del genere – per la maggioranza degli utenti non sono altro che superfici luccicanti che risultano inaccessibili al loro interno se non in modo dilettantesco e distruttivo.” A questa opacità della macchina, va aggiunta – nel caso delle piattaforme informatiche – l’opacità degli algoritmi che organizzano le informazioni che mi giungono o che utilizzano i dati che io fornisco. Vi è tutta un’attività di spostamento, elaborazione, circolazione di dati che ho materialmente prodotto, ma di questa attività non ho né conoscenza né posso in alcun modo controllarla. Inoltre, non sono io che ho deciso di esprimere le mie emozioni attraverso stilizzate, gialle, faccine tonde, ma mi sono adattato a esprimerle attraverso quella grammatica, e non sono io che utilizzerò in qualche modo i milioni (miliardi) di faccine tonde prodotte ogni giorno, tra le quali ci sono anche le mie.
Ed è così che sfruttati e alienati nel nostro quotidiano digital labor noi non abbiamo neanche il diritto di rivendicare dividendi e controllo, di lamentarci almeno, di mugugnare, perché, come dice la canzone di Dario Fo:
E sempre allegri bisogna stare
Che il nostro piangere fa male a Mark Zuckerberg
Fa male a Larry Page e a Jeff Bezos
Diventan tristi se noi piangiam
Questa riflessione non si conclude con un inno luddista alla “sconnessione permanente”, anche se verrà il giorno in cui i comuni mortali faranno davvero piangere Zuckerberg, Page, Bezos e diversi altri, facendo degli scioperi dall’utilizzo delle piattaforme e degli smartphone. E inoltre è una riflessione che lascia fuori alcune questioni importantissime: quella del controllo dei cittadini e quella dello strapotere degli algoritmi, con la progressiva esautorazione dell’essere umano da tutta una serie di decisioni e iniziative quotidiane. A me interessava correggere solo certe formule a effetto, ma molto imprecise, come “dittatura digitale”. La realtà è diversa: non sono gli algoritmi che ci vengono imposti dall’alto, non sono i social media che ci manipolano occultamente; siamo noi che ci sottoponiamo docilmente o addirittura con foga al loro strapotere. E lo facciamo perché, nonostante tutti i disincanti, le consapevolezze, le diffidenze, siamo figli di un’idea di progresso che, in mezzo a tutte le decostruzioni postmoderne, svetta ancora come un intatto monumento imperiale. Lo facciamo a maggior ragione noi umanisti, perché temiamo di essere tagliati fuori in modo umiliante da tutto quanto ha successo e produce ricchezza (per pochi). Lo facciamo perché soccombiamo umanamente al fascino velenoso dell’automazione: l’irresponsabilità e la futilità ci rendono più leggeri e spensierati. Lo facciamo, infine, perché siamo malgrado tutto – lavoratori poco o tanto pagati – alla ricerca di un riconoscimento sociale, che può essere ottenuto grazie alla costruzione di identità sottili e liquide, in gradi di nasconderci come veli che coniugano opacità e brillantezza. Veli che ci occultano, ma dietro uno sfavillio accecante.
Glosse
[1] Chi ha letto in termini dittatoriali la gestione della pandemia ha dovuto lasciare in ombra l’esistenza autonoma del virus, che agisce indipendentemente dalle strategia politiche o economiche che una società o una parte di essa mette in opera. Gli allarmisti raccontano una vicenda che si snoda grosso modo intorno a tre personaggi: Big Farma (la sete di profitto), lo Stato (la sete di controllo) e la popolazione (le sete di sicurezza). (I mass-media vengono visti come una sorta di organo di propaganda perfettamente integrato allo Stato). Non tutti giungono a negare l’esistenza del virus, ricorrendo a più o meno implausibili scenari complottisti, ma quasi tutti minimizzano quello che il virus fa o ha fatto alla gente. Possiamo discutere molto a lungo sulle caratteristiche e la portata dell’azione del virus, ma quello che m’interessa sottolineare è che la narrazione della crisi pandemica implica almeno quattro personaggi principali: Big Farma, lo Stato, la popolazione e il virus. A meno di considerare che il virus sia un’invenzione immaginaria di Big Farma e/o dello Stato per sottomettere la popolazione mondiale a un consumo coatto di certi prodotti farmaceutici, bisogna constatare che Big Farma come lo Stato e la popolazione reagiscono all’azione traumatizzante del virus, e certamente lo fanno poi secondo strategie proprie.
Per ciò che riguarda invece il nostro quotidiano uso delle tecnologie informatiche – e le conseguenze che questo implica in termini economici, politici ed ecologici – lo scenario pertinente è riducibile a tre soli protagonisti: i GAFAM, le grandi aziende private monopoliste delle tecnologie e dei servizi informatici, lo Stato, che è simultaneamente cliente dei GAFAM e loro regolamentatore, e la popolazione che gode dei vantaggi e degli svantaggi della rivoluzione informatica. In realtà, anche in questo caso si potrebbe includere un quarto personaggio – l’ambiente – e considerare l’impatto che su di esso hanno le nuove tecnologie. Va precisato, però, che a differenza di quanto accade nella situazione pandemica, qui l’ambiente reagisce a un’iniziativa (di consumo energetico, d’inquinamento, ecc.) esclusivamente umana. Non è comunque di questo aspetto che mi voglio occupare, ma delle conseguenze che queste tecnologie hanno sulle nostre vite a livello individuale e collettivo.]
[2] Ormai, per darsi una divisa antisistema convincente, è bene parlare dei media mainstream come se si parlasse di un comparto globalmente squalificato, quasi si trattasse dell’ufficio propaganda di Goebbels. In realtà mai come oggi un certo giornalismo mainstream ha ancora la capacità di fungere da efficace contropotere, come il caso delle inchieste di Carole Cadwalladr sui rapporti tra Cambridge Analytica e Facebook ha mostrato.
[3] In realtà, nessuno è in grado di misurare l’efficacia della manipolazione occulta in circostanze come quelle delle elezioni statunitensi del 2016. Nessuno può dire con certezza: Trump ha vinto grazie al bombardamento mirato di Cambridge Analytica su un certo numero di elettori indecisi. Questo è innanzitutto ciò che Cambridge Analytica vendeva ai suoi clienti: la possibilità di ridare credito, attraverso le tecnologie informatiche, al mito della pubblicità subliminale, che si era sgonfiato assai rapidamente nel corso degli anni Sessanta (si ricordi il caso di James Vicary). L’incertezza sugli effetti di tale propaganda non permette però di minimizzarne la pericolosità. Mi sembra ragionevole, quanto ha detto a proposito Christopher Wylie, informatico ed ex-impiegato di CA, durante l’inchiesta realizzata dal Parlamento britannico: “Nel mondo dello sport, quando c’è certezza di sostanze vietate nel sangue di un atleta (doping), non ci si rompe il capo per determinare se la dose sia stata determinante per la vittoria oppure no. Si squalifica, e basta”. Sullo scandalo Cambridge Analytica, un altro approfondito documentario prodotto da Netflix: The Great Hack, 2019.
[4] “Poiché, però, è evidente che nella competizione globale digitale è essenziale, sia per le tecniche di Intelligenza artificiale che per qualunque altra attività legata all’ecosistema digitale, il possesso di dati che, in questo sistema, sono prodotti in quantità sempre più elevata dagli stessi operatori, utenti e fornitori di servizi, la UE ha man mano affiancato la sua attenzione alla tutela dei dati personali in conformità con i suoi valori fondamentali con una attenzione non meno rilevante e significativa al possesso dei dati, alla loro raccolta e alla loro utilizzazione.” Il futuro dell’Europa si regge sui dati. Pizzetti: “Così l’UE ha cambiato approccio” – Agenda Digitale Corsivo mio.












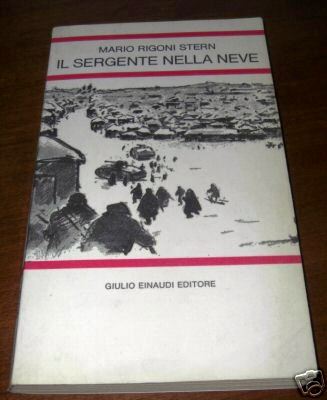
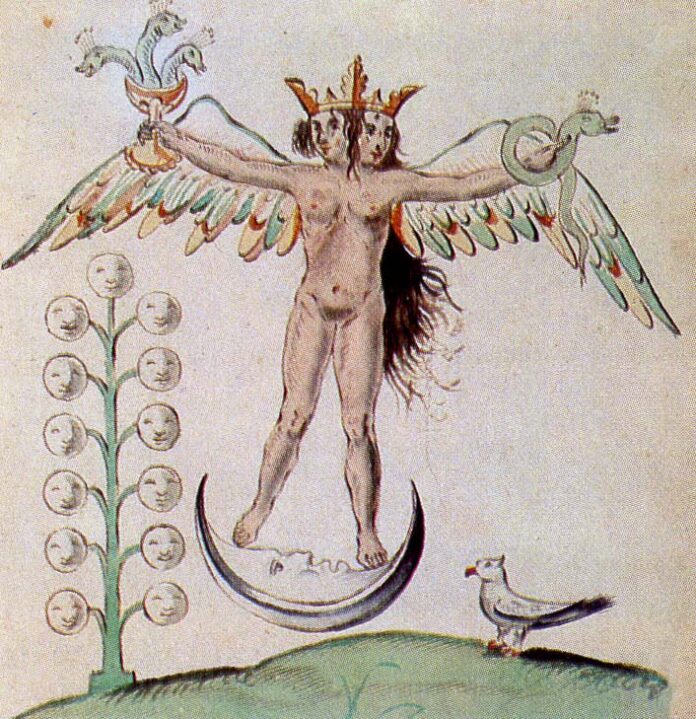
 La questione
La questione
 Come se l’inverno esistesse davvero
Come se l’inverno esistesse davvero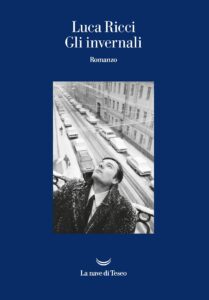 La recensione ideale a un libro di Ricci, infatti, per me, dovrebbe essere composta solo da frasi estratte da un libro di Ricci perché, come nel plastico di Shining, il recensore si trova in ogni istante “guardato” dal testo di cui cerca di raccontare qualcosa del testo stesso. Elogi o stroncature (È un brutto libro! Capolavoro!) sarebbero sempre, punti esclamativi inclusi, materiali meta-testuali; ne risulta che i suoi libri sono oggetti sfuggenti, quando si cerca di afferrarli con strumenti che non siano essi stessi ibridi e letterari (filosofici, narratologici, antropologici forse). L’ossessione per la scrittura tramite la scrittura di ossessioni è la traccia, la voce, propria della letteratura ricciana.
La recensione ideale a un libro di Ricci, infatti, per me, dovrebbe essere composta solo da frasi estratte da un libro di Ricci perché, come nel plastico di Shining, il recensore si trova in ogni istante “guardato” dal testo di cui cerca di raccontare qualcosa del testo stesso. Elogi o stroncature (È un brutto libro! Capolavoro!) sarebbero sempre, punti esclamativi inclusi, materiali meta-testuali; ne risulta che i suoi libri sono oggetti sfuggenti, quando si cerca di afferrarli con strumenti che non siano essi stessi ibridi e letterari (filosofici, narratologici, antropologici forse). L’ossessione per la scrittura tramite la scrittura di ossessioni è la traccia, la voce, propria della letteratura ricciana. Con Gli Autunnali Ricci aveva detto, almeno implicitamente, “Se proprio volete un romanzo ve lo scrivo, anzi ve ne scriverò quattro!” Con quella spavalderia (quella che spesso manca alle donne…) tipica del “maschio bianco”, di più, del giocatore di poker che rilancia, al buio. Con Gli estivi, però, la formula, una volte entrato nel gioco-romanzo come un cavallo di Troia pieno zeppo di racconti, ha preso la strada di una proliferazione dei generi dentro la forma stessa del romanzo. Un romanzo play-list di stili. Negli Invernali, oggi, viene esplicitata l’esplosione della forma romanzo, ormai sformato dal mercato editoriale, approdato a mera didascalia in copertina. Romanzo è quel che tu metti dentro una confezione con su scritto “Romanzo”.
Con Gli Autunnali Ricci aveva detto, almeno implicitamente, “Se proprio volete un romanzo ve lo scrivo, anzi ve ne scriverò quattro!” Con quella spavalderia (quella che spesso manca alle donne…) tipica del “maschio bianco”, di più, del giocatore di poker che rilancia, al buio. Con Gli estivi, però, la formula, una volte entrato nel gioco-romanzo come un cavallo di Troia pieno zeppo di racconti, ha preso la strada di una proliferazione dei generi dentro la forma stessa del romanzo. Un romanzo play-list di stili. Negli Invernali, oggi, viene esplicitata l’esplosione della forma romanzo, ormai sformato dal mercato editoriale, approdato a mera didascalia in copertina. Romanzo è quel che tu metti dentro una confezione con su scritto “Romanzo”.

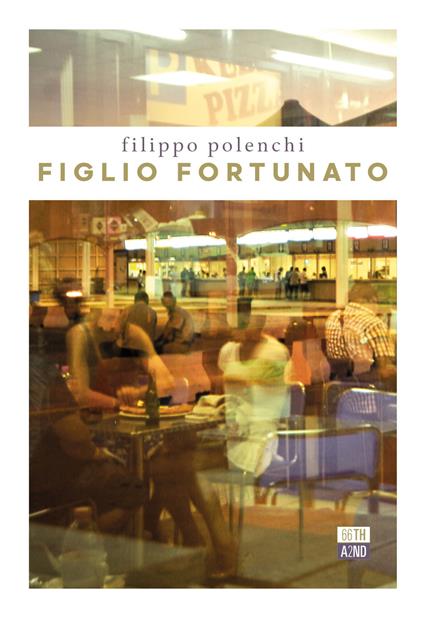












 Adorno è stato un critico ed esegeta della musica di estrema finezza, competenza e capacità di analisi, e la lettura dei suoi scritti (specialmente – ma non solo – quando parla di musica) è sempre proficua. D’altra parte, c’è pure qualcosa di irritante nel suo pensiero, qualcosa che non quadra anche se difficile da mettere a fuoco. Molta critica musicale ha approfittato di una debolezza in questo pensiero per metterlo da parte integralmente, accusandolo di non capire davvero la musica esterna al mainstream della musica colta occidentale. E in effetti, i giudizi di Adorno sul jazz, sul rock, sul pop e su tutto quello che non appartiene alla linea di sviluppo che passa attraverso Schönberg e poi le avanguardie del dopoguerra sono sbrigativamente liquidatori, quando non esplicitamente denigratori: “lurida fiumana” viene anche definita la musica di consumo nella Introduzione alla sociologia della musica.
Adorno è stato un critico ed esegeta della musica di estrema finezza, competenza e capacità di analisi, e la lettura dei suoi scritti (specialmente – ma non solo – quando parla di musica) è sempre proficua. D’altra parte, c’è pure qualcosa di irritante nel suo pensiero, qualcosa che non quadra anche se difficile da mettere a fuoco. Molta critica musicale ha approfittato di una debolezza in questo pensiero per metterlo da parte integralmente, accusandolo di non capire davvero la musica esterna al mainstream della musica colta occidentale. E in effetti, i giudizi di Adorno sul jazz, sul rock, sul pop e su tutto quello che non appartiene alla linea di sviluppo che passa attraverso Schönberg e poi le avanguardie del dopoguerra sono sbrigativamente liquidatori, quando non esplicitamente denigratori: “lurida fiumana” viene anche definita la musica di consumo nella Introduzione alla sociologia della musica. Un’analisi in termini dialettici di questo tipo, tuttavia, può essere applicata anche al Rock, ci spiega Maurizi, mostrando come ci siano state in più occasioni nella musica extracolta istanze liberatorie, di vario tipo, e poi come quelle stesse evoluzioni siano state riassorbite a vantaggio dell’industria culturale – per poi trovarsi ancora riproposte da altri, destinati a loro volta a un nuovo riassorbimento, e così via. Quello che Adorno aveva condannato in blocco viene qui analizzato più finemente, rivelando come la medesima dialettica che muove la musica di tradizione colta abbia luogo pure qui.
Un’analisi in termini dialettici di questo tipo, tuttavia, può essere applicata anche al Rock, ci spiega Maurizi, mostrando come ci siano state in più occasioni nella musica extracolta istanze liberatorie, di vario tipo, e poi come quelle stesse evoluzioni siano state riassorbite a vantaggio dell’industria culturale – per poi trovarsi ancora riproposte da altri, destinati a loro volta a un nuovo riassorbimento, e così via. Quello che Adorno aveva condannato in blocco viene qui analizzato più finemente, rivelando come la medesima dialettica che muove la musica di tradizione colta abbia luogo pure qui.