[Anche Nazione Indiana aderisce all’iniziativa: L’ULTIMO GIORNO DI GAZA 9 maggio – L’Europa contro il genocidio*. Si legge nel comunicato stampa: Una giornata solo per Gaza, la prima di un percorso per “rompere il silenzio colpevole” su quello che da un anno e mezzo, senza sosta, sta succedendo sulla Striscia e anche sulla Cisgiordania. “Perché la strage, perché il genocidio, abbiano fine. Ora”. La data scelta dai promotori di una lettera pubblica per un’azione diffusa, dal basso e online, ha un preciso significato. È il 9 maggio, la giornata in cui tradizionalmente si celebra l’Europa e il suo processo di unificazione. Non è certo casuale. “Senza il mondo Gaza muore. Ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire. Noi, italiani, europei, umani.” Ci sembra importante aderire, tanto più che questo sito ha ospitato molto presto sia testimonianze provenienti da Gaza sia riflessioni intorno a quello che stava accadendo anche tra noi (occidente) e quella parte del mondo che, pur lontana, è intimamente e tragicamente legata alla nostra storia. a. i.]
di Andrea Inglese
1. L’inverno dell’anno 2024-2025 sarà ricordato da alcuni di noi, come l’inverno in cui abbiamo percepito la storia presente come un incubo da cui è impossibile risvegliarsi. Ci siamo cioè ritrovati in una condizione che conoscemmo alcuni anni fa, e precisamente durante la pandemia mondiale di Covid: una condizione d’inadeguatezza radicale nei confronti di ciò che accadeva nel mondo circostante. Questa inadeguatezza ha qualcosa di più destabilizzante dell’impotenza politica, ossia della percezione che la società a cui apparteniamo, nel suo insieme, stia imboccando una via pericolosa e distruttiva, e che forze ben più grandi delle nostre la spingono in tale direzione. L’inadeguatezza radicale non ci dice semplicemente che non abbiamo le forze necessarie per opporci a un’ingiustizia, a un avversario sleale ma più forte di noi; ci rende anche consapevoli di una nostra debolezza costitutiva, del fatto che comunque sia non siamo abbastanza forti come vorremmo. In una tale situazione, di sconfitta personale e collettiva, possiamo salvaguardare almeno qualcosa d’importante: ossia la responsabilità di dire che quel che vediamo, viviamo, ascoltiamo, è un incubo, e non una concatenazione normale di eventi. E inoltre dobbiamo anche riuscire a dire che questo incubo non è frutto di un fenomeno naturale, e al di sopra della nostra volontà, come la legge della gravitazione terrestre, ma un insieme di decisioni umane accompagnate da un insieme di discorsi, di frasi scritte o dette.
2. Questo inverno sarà memorabile per una regressione generale delle politiche sul clima, perché è il terzo anno di una guerra alle porte dell’Europa dopo l’invasione russa dell’Ucraina; perché ci siamo resi conto che, nel giubilo generale, i sistemi d’Intelligenza artificiale hanno iniziato a funzionare nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche, senza che i lavoratori o i cittadini abbiano avuto l’occasione di esprimersi su queste scelte; perché, con la nuova presidenza Trump, gli Stati Uniti hanno radicalizzato la loro posizione di dominio mondiale senza egemonia, alimentando il caos a livello geopolitico. Infine questo è l’inverno in cui, anche i più recalcitranti di noi, i più scrupolosi nell’uso del linguaggio, si sono resi conto che il massacro della popolazione palestinese di Gaza esigeva di essere descritto attraverso l’uso del termine “genocidio”. E da due mesi questo genocidio si è fatto ancora più evidente, perché alla guerra delle bombe si è aggiunta la guerra della fame. Israele ha infatti imposto alla Striscia di Gaza un assedio totale (di terra, aria e mare), ossia il blocco di ogni possibile aiuto medico e umanitario destinato a sollevare la situazione di una popolazione di sfollati, stremata dalla fame e dalla sete, e sottoposta a massicci bombardamenti. Una popolazione che, secondo le stime più recenti, dall’8 ottobre 2023 conta 52.418 morti e 118.091 feriti.
La decisione del blocco completo è conseguenza della rottura unilaterale, voluta dal governo Netanyahu, degli accordi firmati tra Israele e Hamas il 15 gennaio, accordi che prevedevano l’uscita dal conflitto in tre fasi (Cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza: quando scatta la tregua). Dopo l’insediamento di Trump, tali accordi non erano più considerati vincolanti, dal momento che lo stesso presidente americano, ricevendo Netanyahu alla Casa Bianca in febbraio, annunciava un nuovo piano incentrato sullo “spostamento” in Egitto o in Giordania della popolazione palestinese e l’occupazione statunitense di Gaza per scopi turistici e commerciali.
3. Nel 1868, durante le Guerre Indiane che conduceva spietatamente, il generale Philip Henry Sheridan, di fronte a un gruppo di capi delle tribù native, pronunciò una frase che divenne famosa: “Gli unici indiani buoni che abbia mai visto erano morti”. Oggi, l’azione del governo Netanyahu, dopo un anno e sette mesi di guerra praticamente ininterrotta contro Hamas, può essere letta attraverso un calco della macabra frase di Sheridan: “Ogni palestinese buono di Gaza è un palestinese morto”. Questa frase costituisce il nucleo ideologico e genocidario che sottende l’impresa di distruzione della Striscia (edifici e infrastrutture) e di uccisione, ferimento, denutrizione della sua popolazione. La guerra globale contro Gaza si è poi accompagnata all’annessione di sempre nuovi territori in Cisgiordania.
Dopo la strage del 7 ottobre, ogni volta che si parlava della sicurezza di Israele, si ometteva quasi sempre di dire che la sicurezza in questione non era quella di un paese con delle frontiere definite internazionalmente, ma quella di un paese occupante, minacciato di conseguenza da un popolo in lotta per l’autodeterminazione. Un circolo vizioso ha così giustificato per più di mezzo secolo il principio secondo il quale Israele, per poter esistere incolume, deve occupare dei territori palestinesi, anche se poi è innanzitutto questa occupazione che minaccia la sicurezza dei suoi cittadini. Dopo 57 anni di ciclica insicurezza, però, l’estrema destra e i sionisti religiosi al governo hanno deciso di affidarsi a un piano di pulizia etnica, che li metta per sempre al riparo da qualsiasi azione militare o terroristica perpetrata in nome della libertà del popolo palestinese. E l’equazione macabra che hanno stabilito non è un iperbole diffamante o antisemita, ma una formula che si situa nel cuore della propaganda governativa: 1) Hamas è un nemico assoluto da annichilire, in quanto ridotto esclusivamente alla sua componente terroristica e armata; 2) il popolo palestinese non annichilendo esso stesso Hamas, ne è complice; 3) il popolo complice di un gruppo terrorista è esso stesso terrorista. Durante i primi mesi di bombardamenti, quando ancora si poteva parlare in modo plausibile di obbiettivi militari, la propaganda israeliana presentava il popolo palestinese (i civili), come ostaggi e vittime di Hamas. E anche le istituzioni internazionali, entro certi limiti, concordavano con questa narrazione. Oggi, però, di fronte a montagne di detriti e montagne di cadaveri, appare chiaro che, per l’esercito israeliano, con il consenso di una maggioranza delle popolazione israeliana, ogni palestinese sulla Striscia di Gaza – che sia vecchio, donna o bambino – è considerato come puramente e semplicemente “annientabile” in quanto terrorista attivo o potenziale.
4. Forse noi, qui, nella zona di pace occidentale, siamo riusciti tutto sommato a dormire. I bombardamenti, gli incendi, i parenti sepolti sotto le macerie, erano cosa lontana, più intravista che vista. Ma non abbiamo dormito bene. Io non ho dormito bene. Gli stessi incubi notturni assumevano le fattezze di quello che il telegiornale non mi diceva del tutto, ma che la parte inconscia di me, inconscia e forse “sociale”, assorbiva con grande precisione. Passeggiate a Milano, in mezzo a palazzi che iniziano a crollare come castelli di carte e senza apparente motivo. Prigionieri che sbucano fuori da scale ripide e buie che portano in seminterrati; prigionieri con ancora le tracce addosso delle sevizie e dei giorni di fame.
La nostra inadeguatezza non ha smesso di seguirci come un’ombra cupa, e ha inevitabilmente avuto un tremendo effetto demistificante: ma a che servono, di fronte a tutto questo, i rituali di pace, i giorni della memoria, le nostre credenze su una giustizia possibile, su delle istituzioni almeno in parte affidabili, il rispetto per gli innocenti, l’amore per le opere d’arte o le opere letterarie? Ha qualche senso il vivere insieme? L’umanità è qualcosa d’altro che cecità, sonnolenza e furore?
Di fronte all’orrore della distruzione del popolo palestinese non ho potuto che toccare con mano la mia estrema impotenza. Ma chi può qualcosa di fronte a un esercito che non fa entrare a Gaza né i giornalisti né gli aiuti umanitari e che minaccia la vita delle ONG neutrali e disarmate o degli stessi impiegati delle Nazioni Unite?
Ma all’impotenza politica, in quanto cittadino isolato e insignificante, si è poi affiancata la vergogna di non poter dire, e quindi di non poter pensare quello che stava accadendo. Quello che Ilan Pappé, in un articolo del 24 aprile, definisce “L’Occidente ufficiale” ha cominciato a bloccare il discorso, a creare un sentimento d’incertezza diffusa e ingiustificabile, capace di minare anche le constatazioni, le reazioni emotive, i ragionamenti più evidenti. Pappé parla molto bene di questa cosa, introducendo il concetto di “panico morale”. Scrive Pappé:
“Questo fenomeno è noto nella ricerca recente come Panico Morale, molto caratteristico delle fasce più coscienziose delle società occidentali: intellettuali, giornalisti e artisti.
Il Panico Morale è una situazione in cui una persona ha paura di aderire alle proprie convinzioni morali perché ciò richiederebbe un certo coraggio che potrebbe avere conseguenze.”
Comunque sia, io ho sentito che almeno su questo piano qualcosa andava fatto. Sul piano del linguaggio, del discorso. Bisognava trovare un modo di entrare nel campo che l’Occidente ufficiale aveva “minato”, camminarci dentro, anche senza avere né arte né parte. È quello che hanno fatto anche gli studenti un po’ dappertutto nel mondo. Coloro che “mancano di sapere” e frequentano le istituzioni educative (scuole, università) per acquisirlo dai “detentori ufficiali” del sapere. Di fronte all’urgenza della situazione si sono detti che in quel campo minato avrebbero dovuto camminarci, a rischio di fare errori, di sbagliare parole, di concatenare male qualche argomento, di dimenticare qualche fatto importante.
Così, con la scrittura, ho cercato di fare anch’io, come un certo numero di altri individui che come me subivano l’impotenza politica, ma non volevano vergognarsi di non riuscire a pensare per eccesso di prudenza. Ognuno ha trovato un modo per fare esistere la popolazione palestinese e le sue sofferenze al di fuori del quadro troppo ristretto, troppo deformato, che l’Occidente ufficiale aveva reso disponibile.
Oggi anche Nazione Indiana partecipa a questo invito per fare esistere la sofferenza del popolo palestinese e per denunciare il genocidio in atto a Gaza.
Linko quindi di seguito interventi diversi già pubblicati. Abbiamo anche delle testimonianze dirette, come quella di Yousef Elqedra, poeta palestinese che ha vissuto a Gaza dall’inizio della guerra fino a poche settimane fa. I suoi testi sono stati tradotti da Sana Darghmouni e proposti da Renata Morresi.
Memorie da Gaza #1 | NAZIONE INDIANA
La trappola e il diniego. Riflessioni a margine della guerra | NAZIONE INDIANA
Memorie da Gaza #2 | NAZIONE INDIANA
Memorie da Gaza #3 | NAZIONE INDIANA
Memorie da Gaza #4 | NAZIONE INDIANA
Memorie da Gaza #5 | NAZIONE INDIANA
La sineddoche israeliana e la contestazione studentesca | NAZIONE INDIANA
Voci della diaspora: Anna Foa e Judith Butler | NAZIONE INDIANA
L’altro volto della resistenza | NAZIONE INDIANA
L’esodo da Gaza – non cercavamo la vita quando lasciammo Gaza | NAZIONE INDIANA
*
Dal comunicato stampa di L’ULTIMO GIORNO DI GAZA 9 maggio – L’Europa contro il genocidio.
A promuovere la vera e propria ‘chiamata a raccolta’ sono, in ordine alfabetico, Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Giuseppe Mazza, Tomaso Montanari, Francesco Pallante, Evelina Santangelo. E a sostenere la lettera pubblica sono oltre centocinquanta persone che appartengono a diversi mondi professionali e culturali. Tutte accomunate dall’urgenza, dal tempo che sta finendo.
Chi vorrà partecipare a #UltimogiornodiGaza può inviare comunicazioni sulle iniziative a una e-mail
dedicata: 9maggioxgaza@gmail.com
Di seguito, la lettera pubblica.
L’ULTIMO GIORNO DI GAZA
9 maggio – L’Europa contro il genocidio
#ultimogiornodigaza #gazalastday
Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa: ma è anche l’ultimo giorno di Gaza. Perché il tempo sta
finendo, per questa terra nostra. Questa terra del Mediterraneo, il mare che ci unisce.
Per questo, in quella giornata in cui ci chiediamo chi siamo, vi chiediamo di parlare di Gaza,
di farlo ovunque vorrete. E di farlo, tutte e tutti, sulla rete: su siti, canali video, social. E
sempre con l’hashtag #GazaLastDay, #UltimogiornodiGaza.
Senza il mondo Gaza muore. Ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire. Noi,
italiani, europei, umani.
Per rompere il silenzio colpevole useremo la rete, che è il solo mezzo attraverso cui
possiamo vedere Gaza, ascoltare Gaza, piangere Gaza. Perché possano partecipare tutte e
tutti, anche solo per pochi minuti. Anche chi è prigioniero della sua casa, e della sua
condizione: come i palestinesi, i palestinesi di Gaza lo sono. Perché almeno stavolta nessuna
autorità e nessun commentatore allineato possa inventarsi violenze che occultino la violenza:
quella fatta a Gaza.
Sulla rete, e non solo. Per chi vuole mettere in rete ciò che succede nelle piazze e nelle
comunità che si interrogano, assieme, su come fermare la strage.
Con la consapevolezza che noi siamo loro. E che a noi – italiani ed europei – verrà chiesto
conto della loro morte. Perché a compiere la strage è un nostro alleato, Israele. Per ripudiare
l’Europa delle guerre antiche e contemporanee, per proteggere l’Europa di pace nata da un
conflitto mondiale, esiste un solo modo: proteggere le regole, il diritto, e la giustizia
internazionale. E soprattutto guardarci negli occhi, e guardarci come la sola cosa che siamo.
Umani.
Aggiungiamo tutte le parole che vorremo usare all’hashtag #ultimogiornodigaza
#gazalastday.
Senza scomunicarne nessuna, senza renderne obbligatoria nessuna. Per chiamare le cose con il
loro nome.
Ora è il momento di costruire una rete di senza-potere determinati a prendere la parola. E il
9 maggio è la prima tappa di una strada assieme.
Perché la strage, perché il genocidio, abbiano fine. Ora.
Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Giuseppe Mazza, Tomaso Montanari,
Francesco Pallante, Evelina Santangelo




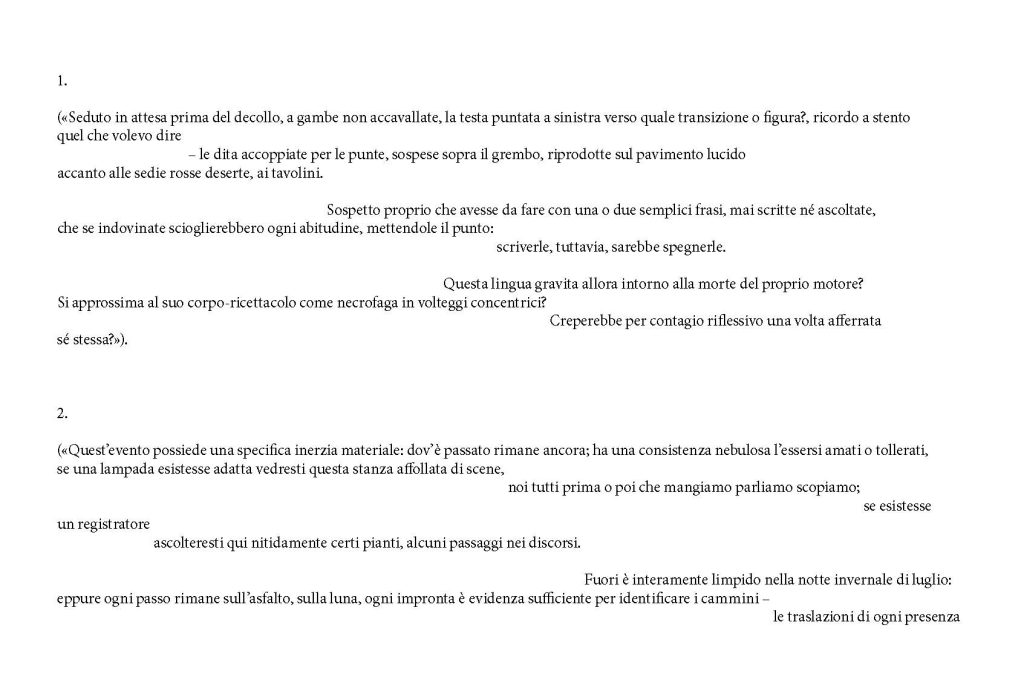
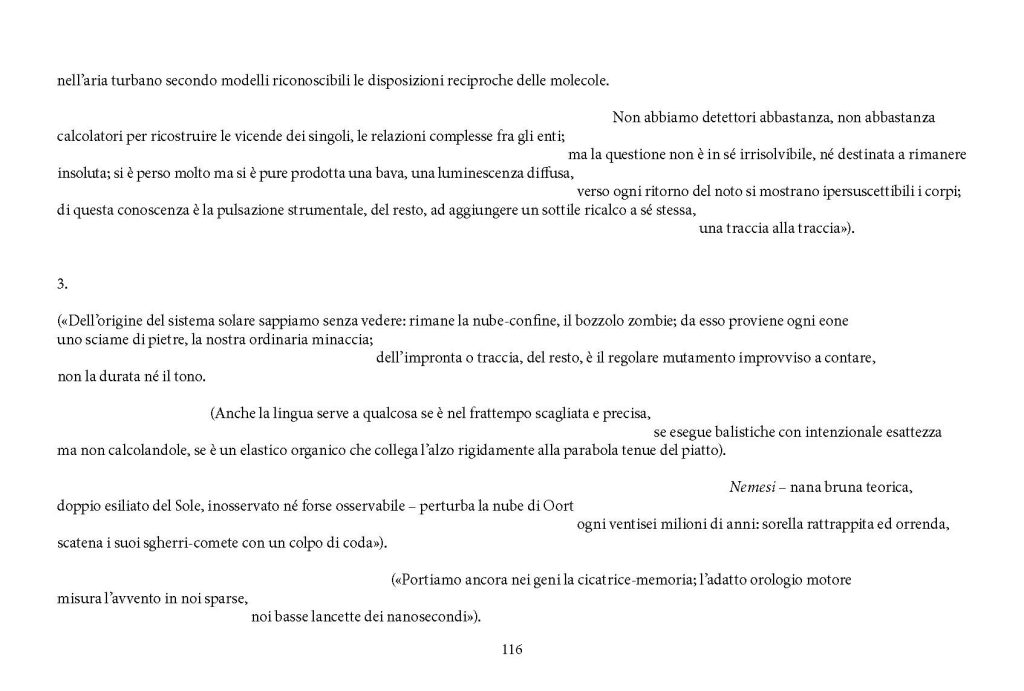
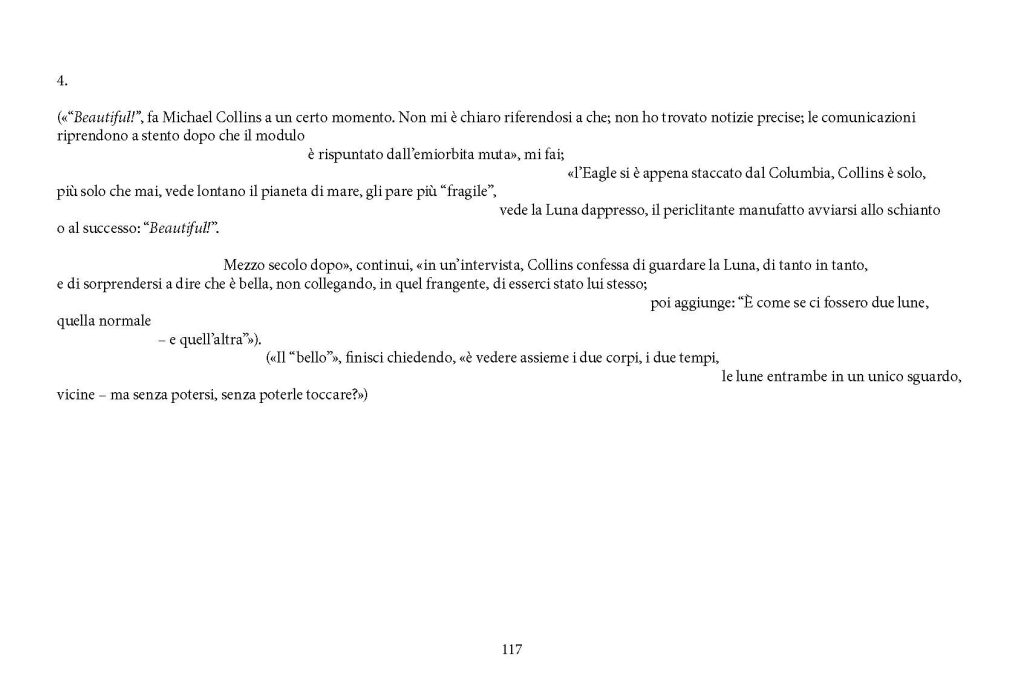
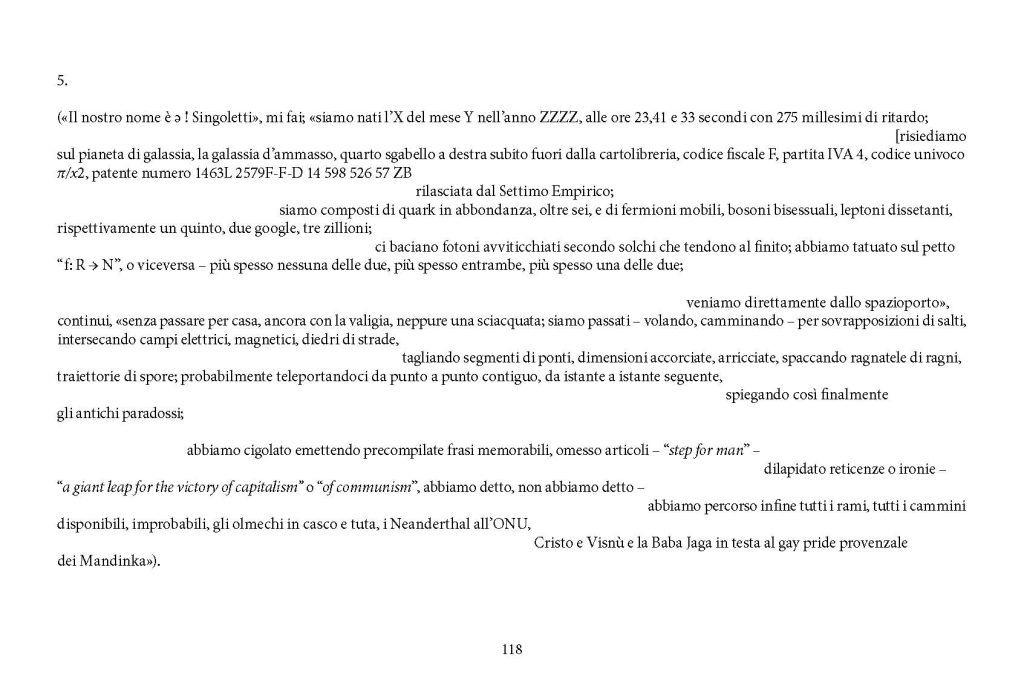
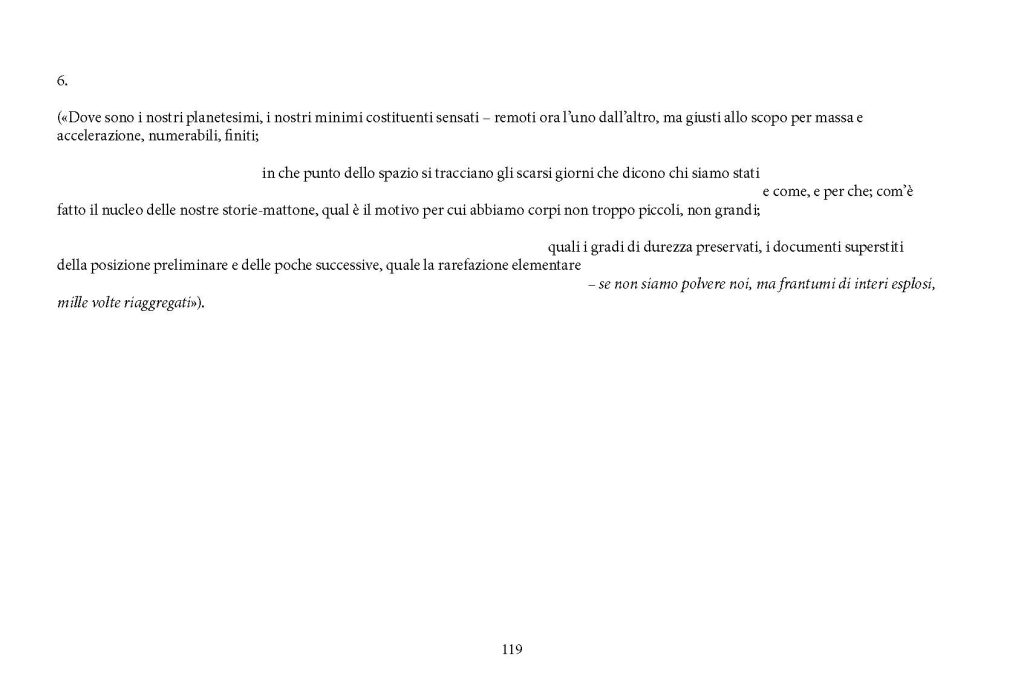
























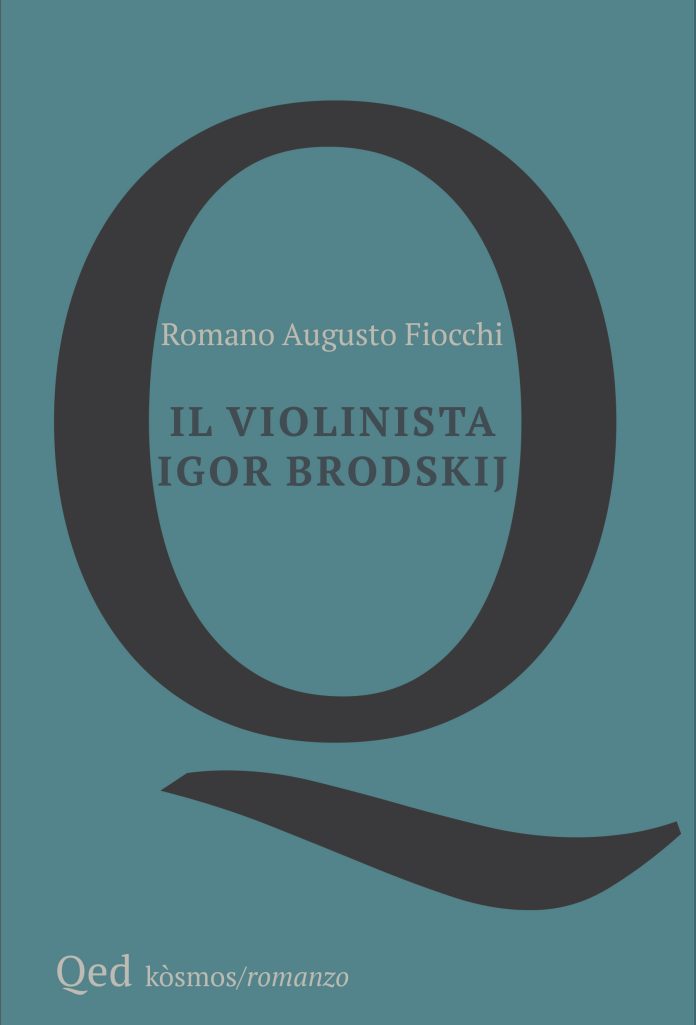
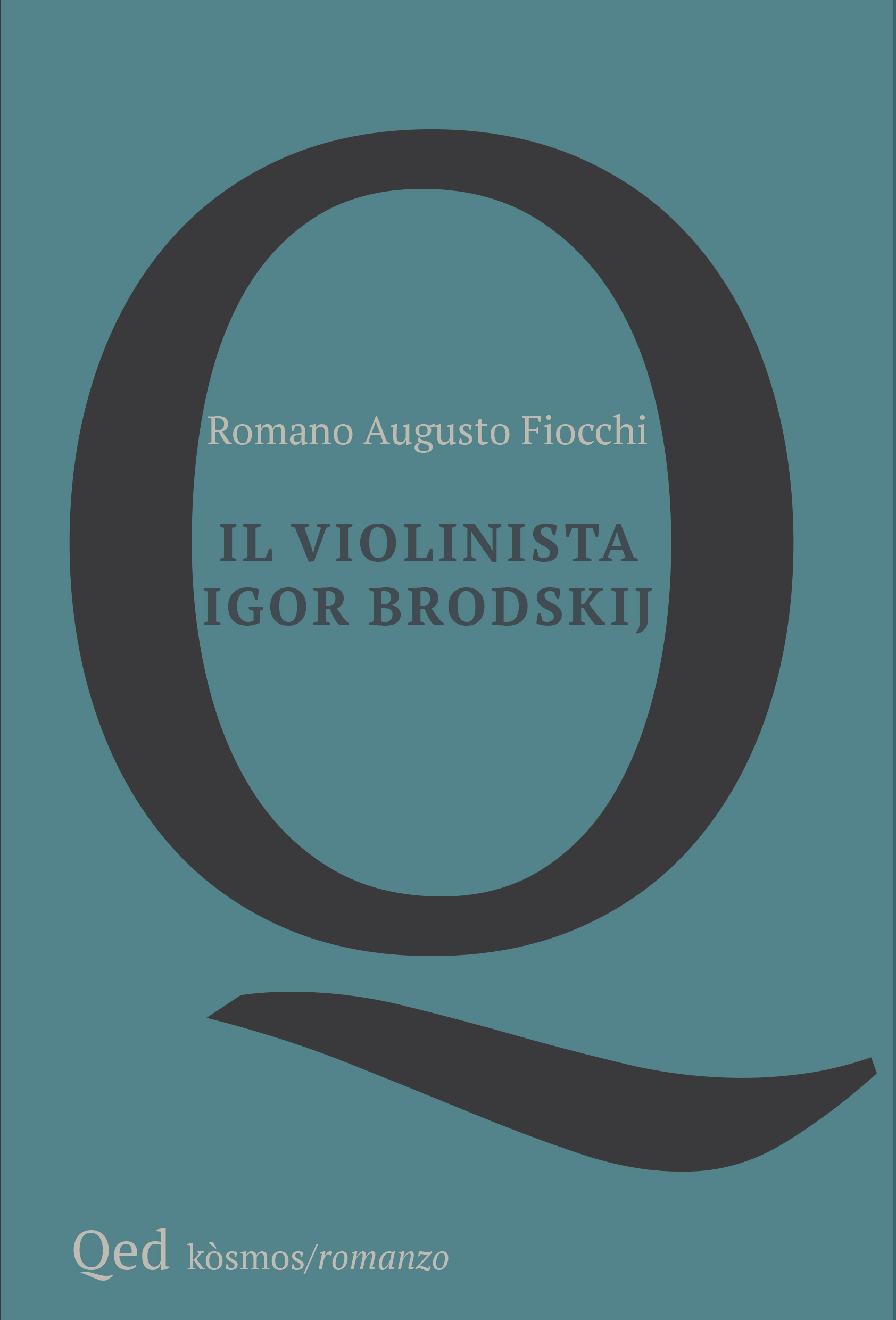 (il 15 marzo, per i tipi della nuova, piccola e agguerrita Qed, è uscito “Il violinista Igor Brodskij”, il nuovo libro di Romano Augusto Fiocchi, nostro amico e collaboratore. Ve ne anticipiamo l’incipit, sperando di incuriosirvi. G.B.)
(il 15 marzo, per i tipi della nuova, piccola e agguerrita Qed, è uscito “Il violinista Igor Brodskij”, il nuovo libro di Romano Augusto Fiocchi, nostro amico e collaboratore. Ve ne anticipiamo l’incipit, sperando di incuriosirvi. G.B.)









