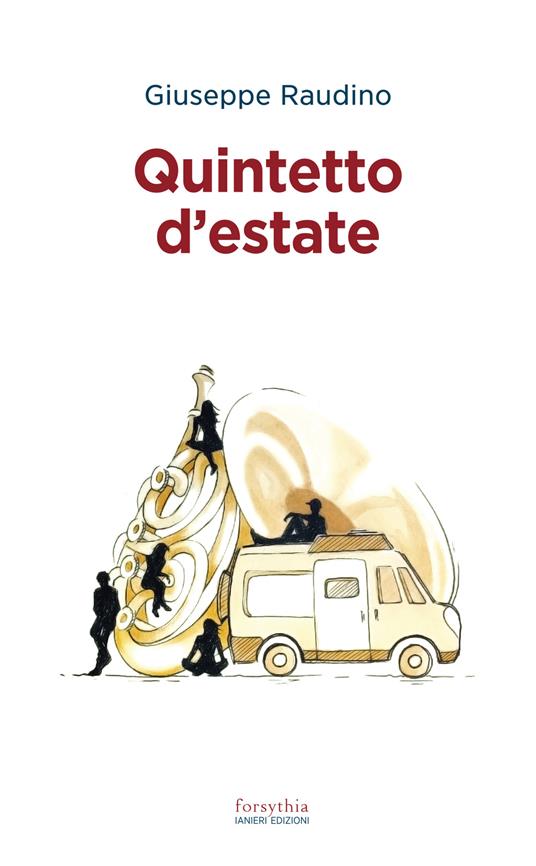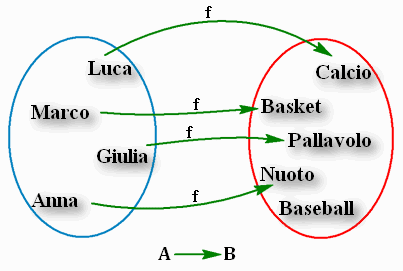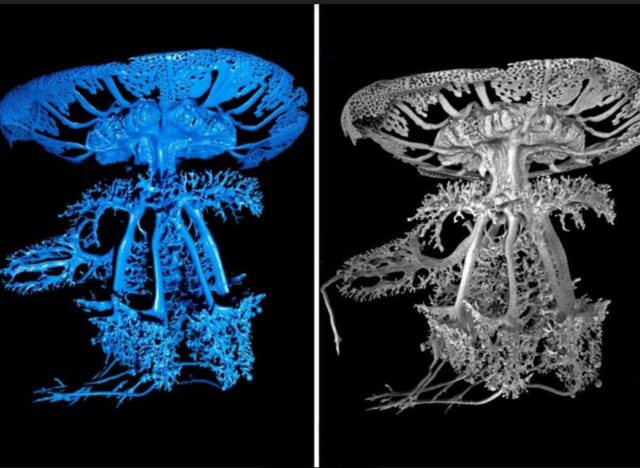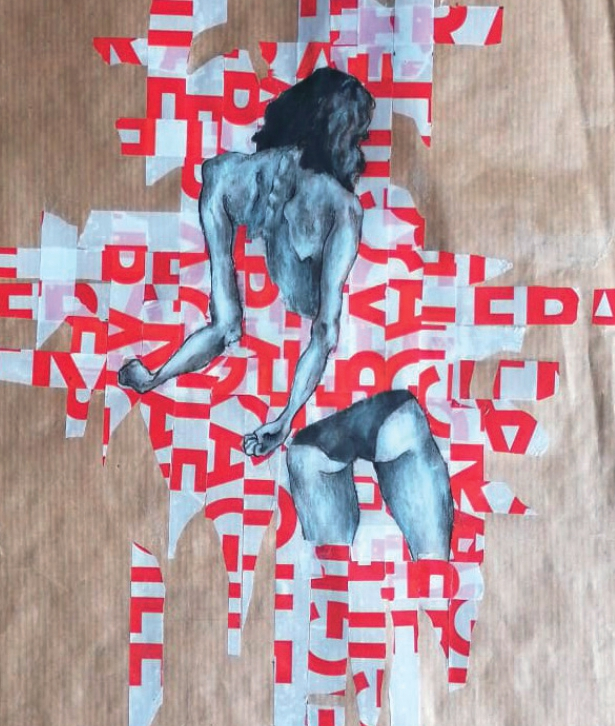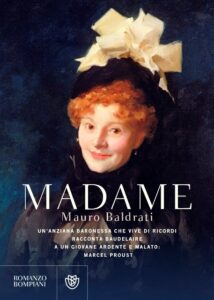di Ornella Tajani
Daniel Mendelsohn, versatile come Ulisse

[Quest’anno il Premio Malaparte è stato assegnato a Daniel Mendelsohn. Pubblico qui di seguito il testo scritto da Giuseppe Merlino in occasione della premiazione. ot]
di Giuseppe Merlino
Daniel Mendelsohn, come Ulisse, uno dei suoi personaggi prediletti, è “versatile”, polytropos in greco antico. È un grecista, studioso dei poemi omerici, dell’Odissea soprattutto, il più romanzesco dei due poemi; è un appassionato di teoria letteraria, ed è un narratore avvincente; i suoi romanzi intrecciano narrazione e riflessione con scioltezza, audacia ed eleganza. Non esita a mostrare la sua letterarietà e anche la sua inclinazione saggistica. Il grande modello moderno di questo genere narrativo è il romanzo di Proust che affiora di tanto in tanto nei suoi libri.
Parlerò subito del suo libro più recente, tradotto in italiano da Norman Gobetti, per Einaudi, nel 2021. Il titolo è Three Rings. A tale of Exile, Narrative and Fate, Tre anelli. Una storia di Esilio, Narrazione e Destino.
L’esilio è quello frequente nella storia del popolo ebraico, ma include anche tutti gli esili provocati dalle persecuzioni e aggressioni nella storia occidentale, da Enea in poi. Della narrazione dirò solo qualcosa del modo di narrare di Mendelsohn, che intreccia il più possibile i molti fili di una trama, seguendo il consiglio di Aristotele che oppone la densità tematica e l’intreccio dei tempi di un “episodio” alla consecutività richiesta dalla cronologia della Storia, e valuta i vantaggi della “varietà”. Quanto al destino, questa parola (opposta alla parola caso) indica il sogno, segreto e sperato, che nelle vicende umane si nasconda un senso o un disegno, riconoscibile almeno retrospettivamente.
Questo l’indice del libro: Le Lycée français, L’educazione delle fanciulle, Il Tempio. I tre titoli, discretamente sibillini, nascondono tre nomi, tutti celebri in letteratura, e almeno tre libri. Le Lycée français evoca Erich Auerbach, filologo magistrale, autore, in condizioni speciali, di un capolavoro della critica novecentesca (1942-45): Mimesis, ovvero “Il realismo nella letteratura occidentale” da Omero a Proust. L’educazione delle fanciulle nasconde un autore più remoto, un aristocratico del ´600 francese, arcivescovo di Cambrai, François de Salignac de La Mothe-Fénelon, e un libro immensamente celebre in Europa e nel Levante che si intitola Les Aventures de Télémaque (1687), scritto per un Delfino di Francia e che fu all’origine della disgrazia a Corte del mistico arcivescovo e superbo prosatore. Fu esiliato nella sua diocesi al confine con la Germania, extremi hominum, come avrebbe potuto dire Ovidio esiliato a vita sulla riva del Mar Nero. Vengo al terzo capitolo, Il Tempio: il nome proprio qui è quello di un grande scrittore tedesco contemporaneo, autoesiliato in Inghilterra per un senso di colpa ereditario, legato al padre ufficiale della Wehrmacht. Il libro commentato è un libro di vagabondaggi e d’incontri nella campagna inglese sulle “tracce di una distruzione universale”; il titolo, Gli anelli di Saturno, evoca subito una malinconia radicale che è uno stile di pensiero.
Non sono biografie parziali, sono piuttosto dei biografemi, e cioè una scelta di gusti, pose, intonazioni, sintomi o locuzioni che accennano a una personalità più che definirla; che ricercano il gesto intellettuale originario da cui è scaturita l’opera. Ciascun capitolo pone una questione che si espande negli altri capitoli alla ricerca di connessioni. La forma di connessione più amata da Mendelsohn è la digressione, e cioè un procedimento che funziona cogliendo le coincidenze, le affinità, le parentele, le analogie tra il discorso principale e quelli contigui e possibili; è un’irruzione nata nei depositi della memoria e dal magnetismo di alcune parole che risvegliano un’idea accessoria e la rendono subito irrinunciabile, garantendo sempre però il ritorno al racconto principale, temporaneamente sospeso. Esemplari come microdigressioni, sono le lunghe frasi ipotattiche di Proust ricolme di incisi e subordinate allacciate le une alle altre, anche con sostanziali divagazioni e che, poi, con un meccanismo impeccabile, quasi astronomico, si ricongiungono alla frase principale sospesa, avendo però abbracciato una più vasta porzione di mondo.
Il Lycée Français, ovvero l’esilio turco e l’opera lì scritta da Erich Auerbach, riprende la questione con cui si apre Mimesis nel capitolo “La cicatrice di Ulisse”. La questione si formula così: l’Odissea (la voce greca) descrive, rischiara e nomina tutto quello che è materia del suo raccontare; nessun dettaglio è trascurato, ogni oggetto merita di essere nominato e qualificato, ogni azione è notata e limpidamente descritta. Versione ottimista della letteratura. Tutto è conoscibile e dicibile. La Bibbia (la voce ebraica, l’altra voce originaria) è reticente, laconica, muta sui dettagli, lacunosa, opaca, addirittura oscura: è una voce da interpretare, da commentare, da completare. È opinione di Auerbach che questa sia la voce più adatta a rappresentare la vita e la realtà come si presentano. L’episodio biblico portato ad esempio è la richiesta di Dio ad Abramo di sacrificare il figlio Isacco; il racconto è stringatissimo, i dettagli sono aboliti e i motivi taciuti. Versione pessimista, enigmatica della letteratura.
L’educazione delle fanciulle è un trattato di Fénelon ma non è l’oggetto di questo capitolo; l’oggetto è un altro, sono Le avventure di Telemaco: “continuazione laterale” dell’Odissea. A Telemaco sono dedicati i primi quattro libri del Poema antico, poi silenzio su Telemaco, finché non lo ritroviamo a Itaca, dove intanto è sbarcato Ulisse, in incognito, dopo venti anni di guerra e peregrinazioni. Silenzio fino al libro XV dedicato ai ritrovamenti familiari, cautamente dilazionati da Ulisse avvertito della fine di Agamennone. Fénelon riempie questo silenzio raccontando un grand tour istruttivo di Telemaco, lungo il Mediterraneo, accompagnato da Mentore, in realtà la dea Atena, e istruendo allo stesso tempo il suo regale lettore, il Delfino di Francia, su come debba essere un buon re: pacifico, sobrio, generoso, casto e misericordioso. Quel che non era Luigi XIV, che lo punì. Si trovano così in questo celebratissimo libro: uno speculum principis, un romanzo di formazione, un romanzo d’avventura e un romanzo familiare con un’enfasi speciale sul rapporto padre e figlio.
Faccio anch’io una digressione: nel 1922, un giovane e brillantissimo Louis Aragon pubblicò una riscrittura “correttiva” del libro di Fénelon con lo stesso titolo e con intenti di parodia, un burlesque, insistendo su audaci combinazioni erotiche tra ninfe e dee e Telemaco, e inventando una lingua già surrealista, a derisione, forse per invidia, della bella armonia classica di Fénelon. Sul filo del nome Fénelon, Daniel Mendelsohn devia, da equilibrista, verso un amico di Proust, Bertrand de Salignac-Fénelon, diplomatico in sede a Istanbul (dove l’esule Auerbach, negli anni ´40 del Novecento, scrive il suo capolavoro, in fuga dalla Germania. Insegnò in quella Università che era priva, però, di una biblioteca per la ricerca, carenza che si rivelò provvidenziale per non venire soffocato da una schiacciante bibliografia), e dunque questo discendente del dolce arcivescovo è un altro être de fuite, come lo sarà Albertine e oggetto di un’amicizia amorosa appassionata da parte di Proust, non ricambiata come è fatale negli amori proustiani. Bertrand de Fénelon è, come si dice, l’“originale” di un seducente personaggio della Recherche: Robert de Saint-Loup, il coetaneo al quale il Narratore deve la prima esperienza di un’entusiasmante amicizia e del suo tenebroso rovescio, la delusione; la doppiezza è iscritta nello stesso cognome dell’amico: saint e loup!
La Turchia sarà evocata in altre digressioni, e soprattutto per la traduzione in turco e il successo in quei luoghi delle Avventure di Telemaco, al punto da rendere Telemàk un nuovo nome per bambini ottomani. E non parlerò delle pagine dedicate all’esodo di eruditi bizantini verso l’Italia, dopo la conquista turca di Bisanzio che riaprì l’Occidente allo studio della Grecia antica, con memorabili edizioni di Omero, di Platone e dei tragediografi, e con preziosissimi manoscritti.
Il terzo capitolo s’intitola Il Tempio, quello di Gerusalemme, distrutto due volte dalle fondamenta. Lo scrittore di cui si parla in questo capitolo è G.W. Sebald, e il libro è Gli anelli di Saturno. La questione fondamentale che pone Sebald è “la futilità di qualsiasi tentativo di ricollegarsi al passato, ancor meno di ricostruirlo, e men che mai di ricostruire quel che è stato distrutto dal tempo e da altre forze”. Questo doppio sentimento di vacuità e di fallimento viene raccontato con due esempi di passione ossessiva per il modellismo, poi scomparsa di colpo o esauritasi per malinconia. Il primo caso riguarda il giovane Mendelsohn, modellista accanito del Partenone; diventato adolescente la nuova passione “ossessiva” divenne la letteratura antica. Il progetto di una resurrezione restaurata del monumento da febbrile divenne insensato, e il modello superfluo. Così accade anche all’agricoltore inglese che è molto avanti, come racconta a Sebald, nella ricostruzione (quanto mai ipotetica) del grande Tempio e che è oppresso da un senso di fallimento e di stare costruendo una cosa morta.
In un giro ininterrotto di digressioni, Sebald perlustra un universo deperito, entropico e morente. Un’immagine definisce bene questo universo sminuito: in una grande casa disadorna e trascurata e in un parco diventato foresta, vive un’aristocratica famiglia anglo-irlandese, impoverita, e prigioniera di un’accidia insormontabile, lì Sebald incontra delle giovani ragazze che, con degli scampoli di sontuosi broccati cuciono meravigliosi copriletti che poi disfano per ricominciare daccapo; sembra il gesto di Penelope, ma quello che manca è l’attesa; qui il tempo è bloccato nella ripetizione.
Accennerò ora agli altri due libri di Daniel Mendelsohn: Gli Scomparsi, Einaudi 2018 (The lost. The search for six and six million); e Un’Odissea, un padre, un figlio e un’epopea, Einaudi 2018 (An Odissey. A Father, a Son and an Epic).
Gli Scomparsi raccontano la ricerca dello scrittore, ostinata e tortuosa, per ritrovare nello sterminato massacro di ebrei a metà del Novecento, notizie certe sulla vita e la sorte di sei suoi familiari rimasti troppo a lungo nella cittadina polacca in cui vivevano da molte generazioni. Sei vite su sei milioni di scomparsi. La disperata (disperata perché si dispera di avere un risultato, pur interiorizzando tutto l’orrore della storia) ricerca è fatta di incontri con i pochi sopravvissuti di quella comunità; con la loro fragile memoria, e poi di archivi e di visite nei luoghi stessi degli avvenimenti; qui Mendelsohn, claustrofobico, fa un’esperienza mortifera, si cala nella cantina sotterranea di una casa, terribilmente angusta, dove si erano nascosti il suo prozio e la figlia per giorni e giorni, muti ed immobili; poi, forse traditi, erano stati scoperti e massacrati. Il racconto è accompagnato dalle voci familiari dei nonni, detentori di ricordi e affabulatori di un passato lieto e onorevole, e dalle voci sapientissime di antichi rabbini che aiutano a decifrare i passi più ardui della Bibbia.
Il filo in più, quello riflessivo e intellettuale, è costante nei racconti di Mendelsohn.
Infine, Un’Odissea. Un padre, un figlio e un’epopea: un professore di letteratura greca tiene un seminario sull’Odissea in un college americano, a un piccolo gruppo di giovani matricole. Sorprendentemente, il padre ottantenne chiede di partecipare al seminario. Nel corso del semestre il lettore incomincerà a conoscere questo padre e lo stesso accadrà al figlio narratore. Egli lo conoscerà nella sua ostilità a Ulisse, al quale rifiuta lo statuto e la statura di eroe: Ulisse è bugiardo, infedele, ingeneroso, egoista! Per la franchezza con cui si esprime, e per l’intimità con cui entra nella storia ottiene un gran successo con gli studenti, e il figlio dovrà rivedere le sue idee sul padre. Il ritratto ne varietur che il figlio ha in mente è quello di un uomo non espansivo, distante, severo, laborioso, pignolo sui doveri, con un accento del Bronx; un matematico apprezzato ma senza interessi per le arti. Molti elementi di questo ritratto saranno smentiti dal suo successo nel Seminario e da quello, addirittura mondano, durante la crociera che padre e figlio faranno insieme “sulle tracce di Ulisse”. L’Odissea è il filo che imbastisce tutto il racconto ed è un buon terreno per ribaltare il rapporto tra padre e figlio, in un alternarsi di ammirazione e di irritazione, di pregiudizi e di rivelazioni. Tra il seminario e la crociera, con la mediazione di Ulisse il padre mostra la sua parte nascosta e il figlio finalmente la vede: la pudicizia degli affetti, la timidezza del corpo, la discrezione dei gesti, il gusto della perseveranza e dello sforzo, una fame intellettuale mai davvero saziata e una giovinezza istruita dal dolore.
Premio Malaparte – Capri 2 ottobre 2022
Quintetto d’estate
di Giuseppe Raudino
L’assiolo non accennava a smettere. Il suo verso copriva perfino il suono incalzante delle spazzole sul piatto. Un sorso e poi un altro ancora lo riportarono a quella notte d’autunno inoltrato, quando il ritmo della serata veniva scandito anche dal percussionista che accompagnava Chet Baker. Ileana non aveva voluto allontanarsi dalla stufa – si era infreddolita sulla moto – e diceva di essere stanchissima. Allora Stefano scostò le due poltrone e srotolò un materassino proprio sul pavimento davanti alla stufa, adagiandoci sopra due, tre plaid.
Ileana aveva deciso.
«Vieni qui» disse dopo essersi seduta sul materasso e vedendo lui che stava per tornare sulla poltrona.
Stefano si sedette dietro di lei e l’abbracciò. Le baciò i capelli. Poi scostò i capelli e le baciò il collo, vicino alla nuca. Ileana rabbrividì, come se le vibrazioni latenti di quando erano arrivati avessero avuto un’impennata, al pari di un motore silenzioso al quale si dà bruscamente gas.
Al secondo bacio andò meglio; al terzo i brividi cominciarono a diminuire e il desiderio a crescere. Mentre Stefano le sfilava il maglione, Ileana afferrò una coperta e la mise sulle spalle di entrambi. Quasi nudo, Stefano si alzò per infilare l’ultimo ciocco di legno nella stufa e richiudere velocemente lo sportellino, per poi tornare subito da Ileana, che nel frattempo si era sdraiata e lo invitava su di sé tendendo appena le braccia.
«Fa’ in fretta, ché sento freddo» comandò lei. «Vieni a scaldarmi».
Per il ragazzo fu un ordine dolcissimo da eseguire, come se qualcuno lo avesse costretto ad assaggiare un miele prelibato. Mentre facevano l’amore, i loro occhi si incrociavano sporadicamente; quando il suo sguardo vagava altrove, si posava sul rame dorato dei suoi capelli, che in quel momento parevano avere un profumo melato, e sulla fronte, dove mancava l’incavatura del naso. L’affanno del respiro, insieme col calore della stufa troppo vicina, accesero le sue guance come la buccia di certe mele appetitose.
Solo dopo l’amplesso, il corpo di Ileana cadde in una quiete profonda. Non tremava più, non era più scossa dall’incertezza che ogni slancio verso una nuova storia comporta.
***
Arrivarono senza soste intermedie a Messina. Lo Ionio, alla loro destra, li aveva accompagnati per quasi tutto il tempo, offrendo il suo azzurro intenso come segno di profondità e potenza. Al di là dello stesso mare, a cinquecento chilometri, c’erano la Grecia e le sue isole, Zante, Itaca e Cefalonia, che fanno da guardia all’ingresso del golfo di Patrasso, collegato al lungo porto di Corinto. Proprio da Corinto, guidati da Archia, erano partiti i primi coloni che avrebbero fondato Siracusa sull’isola di Ortigia ventisette secoli prima.
Il maestro, che amava Siracusa e la sua storia, gettando uno sguardo al mare, si chiedeva quali misteriosi segreti fossero sepolti lì sotto per sempre e di quali affascinanti avventure erano state testimoni le onde che sospinsero le triremi greche alla conquista della Magna Grecia.
Imbarcato il camper sul traghetto, salirono tutti sul ponte per sgranchirsi le gambe. Il maestro si avviò sulla fiancata est della nave e si affacciò per ammirare meglio il mare. Sull’altra fiancata, il Tirreno non lo interessava, voleva soltanto respirare il profumo dello Ionio, immergersi nei suoi colori e ammirare le sue profondità tenebrose. Il vento sullo stretto spirava caparbiamente.
Ileana si avvicinò al maestro, che si accorse di lei per il profumo di gelsomino misto a cedro e muschio. Ileana parve che al maestro fosse spuntata qualche lacrima di tristezza o di malinconia, non una di quelle che vengono fuori da occhi arrossati per il troppo vento.
«Eccoti, bella» le disse cambiando espressione, dopo essersi strofinato gli zigomi con il polso «ci mancavi tu a completare il quadro ionico dell’antica Grecia».
Il maestro aveva questo modo di porsi: enigmatico, pieno di sensi nascosti. Chi si accontentava della superficialità lo ascoltava e basta, senza capire, ma i suoi veri allievi erano invitati a tirar fuori da lui la conoscenza, facendo domande.
«In che senso, maestro?» chiese Ileana, ma gli altri quattro si erano già avvicinati perché non era l’unica ad aver sentito quell’affermazione e a voler conoscere il seguito.
«Questo pomeriggio in autostrada gettavo qualche occhiata al mare, e in primo piano avevo i piedi di Calliroe. Lo sapete che ha un piede greco, vero? L’avevate notato? Si vede anche quando indossa i sandali. Ecco, allora ho collegato subito il piede al mare greco. Poco fa mi è capitato di ascoltare Martina che utilizzava una sferza di parole dialettali che derivano dal greco: ’ntamatu, vastasu, babbiari. Ora, mentre guardo Messina allontanarsi, sullo sfondo ci sono la città e il suo mare, e in primo piano il tuo profilo, Ileana, un profilo elegante, fine, gentile. Un profilo greco. Ci avete mai fatto caso che tutto ciò che è comunemente ritenuto greco ha un’accezione di bellezza e armonia? Il naso greco e il piede greco sono considerati belli. Peculiari, ma belli. Almeno da chi se ne intende, come la totalità dei pittori classici. Trovatemi un quadro in cui la bellezza femminile venga dipinta senza che i piedi e il profilo siano alla greca».
I ragazzi già smanettavano col cellulare per scaricare immagini di dipinti di Tiziano e Caravaggio per zoomare sulle dita dei piedi e sui nasi.
«Ha ragione, maestro» disse Fabrizio.
«Eh già» disse il maestro con tono sardonico, «ma non lo sapevi che il maestro ha sempre ragione? Specialmente quando ha torto».
Stefano si guardava bene dal commentare: mezza parola sbagliata avrebbe potuto liberare tutto il sarcasmo del maestro, che lo avrebbe fulminato e coperto di ridicolo.
«Comunque, c’è anche un’altra cosa, oltre al profilo greco di Ileana: il flauto. Le navi da guerra greche, le temute triremi, avevano a bordo un flautista, chiamato aulete, che, suonando, dava il ritmo ai rematori. Immaginate quanto poteva essere difficile per centocinquanta rematori muovere i remi in perfetta sincronia. La musica aiutava i greci anche nelle cose pratiche della vita. Il mondo senza musica sparirebbe».
«Che tipo di flauto usavano i greci?» chiese Fabrizio.
«Te lo spiego quando non ci sono le ragazze» ironizzò il maestro.
La sirena del traghetto suonò con prepotenza e si impose violentemente alle orecchie di tutti i passeggeri. Come tanti rumori del mondo caotico e moderno, la sirena penetrava i timpani senza dare scampo agli ascoltatori non consenzienti, allo stesso modo del traffico o delle chiacchiere da bar.
NdR: il brano che precede è tratto da “Quintetto d’estate”, di Giuseppe Raudino (Ianieri Edizioni, 2022)
“L’Arbulu nostru” di Giuseppe Cinà
di Daniele Ventre
L’àrbulu nostru (La Vita Felice ed., gennaio 2022) non è la prima prova poetica di Giuseppe Cinà, che per i tipi di Manni aveva dato alla luce, nel 2020, A macchia e u jardinu. Protagonista di entrambe le sillogi è l’ulivo, la pianta mediterranea già totem di Atena, santificata da una tradizione plurimillenaria che va dalla tradizione omerica ai Vangeli. La trama armonica di entrambe le opere è il dialetto siciliano, che sottende, in parallelo alla trama di archetipi che si addensa intorno all’ulivo, una tradizione perfettamente simmetrica: la Sicilia è la terra della reinvenzione teocritea della campagna; è la terra in cui le sonorità del dialetto (greco) dorico teocriteo, con i suoi chiaroscuri fonetici, si sono poi tradotte, nelle ecloghe del Meli, in un dialetto neolatino, in cui le opposizioni fonemiche fra vocali chiare e vocali chiuse sono altrettanto forti e nette.
Che sia questo, come per altri autori in vernacolo siciliano (si pensi ad Alessio Di Giovanni) il senso profondo della scrittura siciliana di Cinà, lo ha chiarito a suo tempo l’autore a margine de A macchia e u jardino: la scelta di tale codice espressivo: “…è stata solo in parte ricercata, per il resto è emersa naturalmente in corrispondenza ai due motivi poetici dominanti: la natura e il dialetto. Il racconto della natura, qui intesa come comunità di viventi, si sostanzia nel continuo confronto tra selvaggio e domestico … A sua volta, il dialetto viene posto al centro delle scelte formali della composizione piegando i versi alle parole e alle cadenze proprie del siciliano…”.
Questa spontanea dimensione poietica della tradizione siceliota non è, per Cinà, architetto e urbanista poi tornato, dagli anni ’90, alle sue origini, una veste esteriore: si tratta piuttosto di una dimensione esistenziale rivissuta e ricreata nel quotidiano, da quando l’autore ha intrapreso la coltivazione del suo uliveto presso la Riserva dello Zingaro. Prima ancora che attraverso la parola, è nella sua ridefinizione esistenziale, nel suo attuarsi attraverso il lavoro che Cinà ha percorso un cammino à rebours dalla fluidità ipermoderna alle radici del modello ad albero dei miti di fondazione delle culture umane.
In quest’ottica, quello di Cinà è effettivamente un ritorno di matrice odissiaca e ciclica, un nostos nel pieno senso della parola: non è il nostos di tante nostalgie ideologiche fondata su identità tossiche strumentali e oppositive, ma è il ritorno creativo, ciclico, sottotrama dei ricorsi storici vichiani rifondatori di civiltà, o in senso più lato è una riscoperta di radici gravide di futuro. Il nostos antico, nel senso pieno, non ha nulla a che vedere con il degrado insito nella reazione, ma è sempre prospettivo, poiché è ristabilimento di una durata nel solco vitale dell’ordine di natura.
Se in A macchia e u jardino, la contrapposizione fra il “selvaggio” e l’antropizzazione (più o meno virtuosa) del paesaggio si ipostatizzava nella dialettica fra la scomposta macchia mediterranea e l’armonia cromatica e architettonica verde dei giardini, ora è l’ulivo come tale il correlativo oggettivo di una dialettica potenzialmente distruttiva ed esclusiva fra natura arborea, implicitamente divina e “datrice di beni” (per richiamare una formula omerica ed esiodea) e paese guasto, male umanizzato, dell’antropocene. Testimoniano l’evolversi di questa dialettica le quattro sezioni di cui L’arbulu nostru si compone, e i loro ominosi titoli in esergo: 1) Semu ancora vivi, dàmunni aiutu!; 2) In campagna li filosofi abbunnàvanu; 3) L’aùgghia e lu filu di la natura sempri nnammurata; 4) Nna li marchiggi di la fàvula ingannatura unni si joca na partita truccata.
Il tema della terra desolata e del sacrilego dell’uomo è centrale nei versi di Cinà: “A dda èbbica l’alivi sacri èranu chiossà/li tirreni unni criscìanu ora sunnu/sdisulati…”, versi de L’imputato di sagrilèggiu in cui risuonano come ipogrammi, ma denudate di ogni connotazione comico-realistica, parole cavate da Petronio e dai suoi colliberti (Satyr. 44: religiosi non sumus. agri iacent), ma anche da Lucano (Phars. I, 29: desuntque manus poscentibus arvis). Il sacrilegio dell’uomo contemporaneo come devastatore della natura, si rivela come desolazione di un paese guasto, ma è in altri momenti dell’opera che rivela la sua natura profonda. In “Lu filòsofu”, troviamo ad esempio un Empedocle che nell’atto di insegnare agli acragantini la sua segreta sapienza tramata di visioni orfiche: centrale in questa sapienza è anzitutto l’idea del tempo, di cui l’uomo ha una percezione soggettiva distorta e distorcente: “(…) Nuatri pinzamu a lu futuru comu siddu avìssimu/ a campari sempri ma manciamu allafannati/ comu siddu avissimu a mòriri dumani/ e unn addunamu comu fui lu tempu,/Pinzamu di aviri un principiu e na fini,/ ma lu fattu è che li cosi murtali un nàscinu/e un mòrinu mai ma càncianu e scàncianu/spartènnusi e mmiscànnusi perennementi/secunnu ca l’amuri li junci e l’òdiu li contraponi…” La filosofia di Empedocle è qui perfettamente rievocata, nella sua oscillazione pendolare fra furente contesa e intima connessione della philía, ma sottotraccia non è questo il nucleo tematico effettivo; piuttosto Cinà sembra evocare un peccato di hybris basato sulla torsione ontologica per cui l’uomo si vede sconnesso, reciso dal fluire della physis, e quindi è in preda alla lotta fra quello che sotto altro cielo i buddhisti chiamerebbero attaccamento all’impermanenza e una pretesa di eternità malsana e malintesa. Ne deriva all’uomo un senso indebito di appropriazione, invasione e stupro della realtà naturale. Se l’olivo è la fondazione arborea del flusso di tutto ciò che vive, della “natura’nnammurata” (Zagara d’alivu), che fa da teatro alla democrazia spontanea delle comunità primordiali la cui attività si centra attorno alla rotazione molitoria dei palmenti del frantoio (Lu cuntastori de lu parmentu), l’azione dell’uomo moderno recide, abbatte, tronca questa continuità, come in Motosega Stihl MS 170 (“li rami/càdinu nna lu celu ca si sbalanza/comu un sipariu a fini tragedia”).
Se si pensa che un capitolo essenziale della storia dell’ulivo è rappresentato dall’orazione Per l’ulivo sacro di Lisia, in cui si dibatte della colpa di aver sradicato un sēkós, ovvero un tronco di olivo sacro posto al limite del campo, è facile intendere quale sia il senso profondo di quest’ultimo testo, nell’economia complessiva dell’opera di Giuseppe Cinà: il tronco abbattuto (iam fracta cacumina, per citare Virgilio) è il senhal della violazione nichilistica e annientatrice dell’azione umana, nel tempo della desolazione. L’uomo separa ciò che non deve essere separato, e viola, nel contempo, la separatezza del sacro, che con il sēkós, il ceppo d’olivo sacro divisorio dei campi, ha in comune la radice indoeuropea *sak-, quella a partire dalla quale il sacro stesso si definisce come spazio a sé rispetto alle verità ordinarie. Ne L’Arbulu nostru, si inscena così la tragedia definitiva della morte del divino, o meglio del suo assassinio per mano umana armata di tecnologia deviata dal suo scopo primario.
Florinda Fusco: portatemi un cielo adesso

«Io so bene che alla mia collana
manca quel grano che voi chiamate padre»
La casa editrice Argolibri ha recentemente pubblicato il Il compleanno e altre opere di Florinda Fusco. Nel libro, oltre all’inedito Il Compleanno, è contenuta la trilogia Tre opere (Linee, Il libro delle madonne scure, La Signora con l’ermellino).
Ospito qui alcuni testi in anteprima da Il compleanno.
0.5
Il mio compleanno
è
la festa
del patrono
senza
fuochi
d’artificio
né
zuccheri
filati –
il mio corpo
è
la statua
del santo
in processione –
sguardo impassibile,
diretto
altrove.
Un abito
conservato
per l’occasione,
aggrovigliato
di nascite
e di morti.
Il mio riflesso
si piega
verso di me
e mi dice:
«Nasconditi qui
fa silenzio,
in me
puoi
trovare
rifugio» –.
Al centro
di un cerchio
di bocche
sorridenti
e deformate
una candelina,
sempre la stessa,
si moltiplica
e si espande,
una massa stellare
che per sbaglio tocca
la soglia
dell’al di là.
0.20
Lasciate
che viva
nel fondo
dell’acqua –
lasciate
che
il tempo
imiti
il lento
il movimento
delle alghe.
Lasciate
che
tenti
ancora
di parlare
ai pesci.
E se
mi rubate
anche
la parola
non date nome
alla mia bocca
chiusa.
0.26
E
se
la terra
promessa
è quella
su cui
tutti camminiamo,
su quel vassoio,
portatemi
un cielo
adesso.
“Funzione” è più facile di “formula”, meno spavento, però . . .
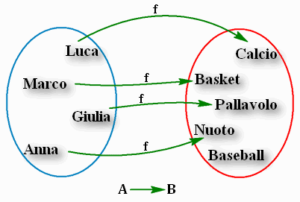
di Antonio Sparzani
Esplorando le parole che stanno alla base della matematica (e anche alla base delle scienze che ne dipendono fortemente, quali ad esempio la fisica), affrontiamo un’altra parola chiave, la parola funzione: come si è formata quell’idea di funzione che si utilizza tipicamente in matematica e nelle scienze che ne dipendono, ma ormai largamente anche nel linguaggio comune?
È un’idea, e una parola, che sono emerse un po’ alla volta, alla fine di una serie di slittamenti di significato, quelli che nell’evoluzione temporale delle lingue sono così frequenti, ancorché imprevedibili, cui anche la matematica stessa ha contribuito. Il punto di partenza sembra essere il verbo latino fungor, il quale originariamente indica l’adempiere un dovere, il ricoprire una mansione: consulatu fungi significa, per i latini di età classica, “esercitare il consolato”.
A. Primo passo: da qui segue che si può usare la parola per dire che si esercita una mansione di un altro, se ne ricopre il ruolo, tipicamente, sempre nel latino classico, fungi maternis vicibus significa “far le veci della madre”. Da questa direzione di significati deriva l’italiano fungere che incorpora già ‘le veci’, “fungere da sostegno” sta per “fare quello che fa un sostegno”, anche se lo scopo originario non era quello, “fungere da madre” significa esercitare le mansioni della madre pur non essendo la madre, si può equivalentemente anche dire “fare la funzione di un sostegno”, o “della madre”, rispettivamente. Dunque la parola funzione indica qui un passaggio di azione da una cosa ad un’altra, o da una persona ad un’altra, una sostituzione, un prender su di sé la figura di qualcos’altro. Secondo la Costituzione italiana nel caso di impedimento del Capo dello Stato, il presidente del Senato ne assume le funzioni (in questo momento sarebbe una vera iattura): vuol dire che egli, pur non essendo il capo dello stato eletto, ne assume il ruolo, prende su di sé l’onere – e l’onore – della carica.
B. Secondo passo: a questo punto si è verificato un nuovo, e fondamentale, spostamento di significato all’interno della storia della matematica, a partire dagli ultimi decenni del secolo XVII. Descrivere, seppur in modo molto schematico, questo frammento di storia della matematica ci permetterà di cogliere un’altra istanza di quella dicotomia estensione/intensione così frequente nella logica (e cui spesso si dedica troppo scarsa attenzione). In una prima fase, che si può far simbolicamente coincidere con l’opera di Newton (ricordate che i suoi Principia sono del 1687), l’idea che una qualche grandezza possa dipendere da un’altra, possa cioè variare al variare di un’altra, è limitata al caso in cui quest’ultima grandezza sia il tempo; Newton non usa ancora la parola funzione, ma usa la parola latina fluentes per indicare queste entità che hanno la caratteristica di cambiare col tempo. La parola funzione, o per meglio dire la sua versione latina functio, appare per la prima volta nella storia della matematica in un manoscritto di Leibniz del 1673 intitolato Methodus tangentium inversa, seu de functionibus, nel quale ancora si parla del calcolo di certe speciali caratteristiche di una curva piana (quali la sottotangente, la sottonormale e altre, che qui poco importano), che rivestono un certo ruolo nell’andamento della curva, e dunque ancora la parola rimane nell’alveo del significato di ‘ruolo’. Leibniz si serve invece per indicare la dipendenza dell’ordinata di un punto della curva dalla sua ascissa, della parola relatio, ‘relazione’. Ma nel prosieguo del manoscritto, ecco che l’autore si serve della parola functio per indicare appunto in generale come queste varie caratteristiche della curva variano lungo di essa, in quanto il suo scopo, nel manoscritto, è quello di risalire dal variare di queste caratteristiche alla forma della curva – di ricavare dalle functiones la relatio; nello stesso senso allargato Leibniz continuerà ad usare la parola in altri lavori del 1692 e del 1694.
C. Terza tappa. Occorre guardare a un personaggio chiave immediatamente successivo a Leibniz, il matematico e fisico svizzero Johann Bernoulli (Basilea 1667-1748), maestro di Eulero. È a lui che si deve la prima definizione formale di che cosa sia una funzione in quanto quantità composta di grandezze variabili:
Définition. On appelle fonction d’une grandeur variable une quantité composée de quelque manière que ce soit de cette grandeur variable et de constants.
L’aspetto interessante di questa definizione, oltre a quello di essere un primo tentativo di formalizzare la parola funzione all’interno delle matematiche, è quello di identificare una funzione con una espressione formale. Ad esempio x² ; (3x)ⁿ-x³ ; (x-1)/(x+1) ; (purché nella terza espressione, si intenda x ≠ −1, altrimenti perde senso l’espressione, uno zero non può stare al denominatore) sono tutte espressioni legittime, o, meglio, ben formate. Dunque, in questa prima fase della ricerca di cosa è funzione, si adotta un atteggiamento tipicamente connotativo, intensivo: per assegnare una funzione occorre che sia data una espressione che permetta di calcolarla. Essa non è certamente unica, ad esempio le espressioni (x − 1)(x + 1) e x² − 1, chiaramente diverse in quanto espressioni, danno luogo agli stessi valori: per x = 2 forniscono entrambe il valore 3, per x = −1 danno entrambe il valore 0 e lo stesso accade per qualsiasi altro valore attribuito alla x; ma si vede allora che, secondo la definizione di Bernoulli esse sono funzioni diverse, in quanto composizioni di simboli diverse; tuttavia si vorrebbe in maniera naturale identificarle in quanto portano appunto agli stessi numeri a partire dagli stessi numeri. Questo spinge ad adottare una definizione di funzione che badi non tanto alla sua espressione formale, ma al risultato che si ottiene per ogni valore della variabile.
D. Quarta tappa. Già nel XVIII, e poi più decisamente nel XIX secolo comincia ad affermarsi la tendenza a generalizzare la definizione di funzione, svincolandola dall’esigenza di una sua rappresentazione analitica; la prima vera formulazione di questo tipo è dovuta a Eulero (Leonhard Euler, Basilea 1707 – San Pietroburgo 1783, che molto profitto aveva tratto dagli insegnamenti di Bernoulli) e suona così:
Se alcune quantità dipendono da altre quantità in modo tale che se queste ultime vengono cambiate allora le prime anche cambiano, allora queste sono dette funzioni delle seconde. Questa denominazione è della più ampia natura e comprende ogni metodo per mezzo del quale una quantità può esser determinata da altre. Se perciò x denota una quantità variabile allora tutte le quantità che dipendono dalla x in un qualsiasi modo, o sono da questa determinate, sono dette funzioni di x.
Quest’idea non fu immediatamente condivisa dai matematici europei, ma dopo qualche decennio cominciò ad affermarsi definitivamente, nelle opere di Lagrange, Lacroix, Fourier e – infine – di Lobačevskij e Dirichlet. Da questi pur rapidissimi cenni storici si dovrebbe poter dedurre almeno che l’idea che sta alla base del concetto di funzione è quella di dipendenza di una grandezza da un’altra, o da varie altre. Si noti tuttavia che la parola ‘dipendenza’ può alludere – connotativamente – ad un modo causale formalmente esprimibile nel quale una grandezza y è determinata da un’altra grandezza x – la direzione di marcia di un’auto dipende strettamente dai movimenti dello sterzo – oppure questa dipendenza può essere più astratta e casuale: provate a pensare di associare ad ogni intervallo di un minuto della notte dal 10 all’11 agosto 2022 il numero di stelle cadenti visibile a occhio nudo in un fissato quadrante del cielo boreale: è chiaro che anche questa funzione è perfettamente definita e determinata, ma è molto meno chiaro come si possa in qualche modo risalire dal valore della variabile indipendente (l’intervallo di un minuto) a quello della funzione (il numero di stelle cadenti in quel minuto), se non mediante una accurata osservazione. È chiaro che in quest’ultimo caso la funzione è data in modo squisitamente estensivo: si osserva – e si trascrive poi eventualmente in un grafico – il valore corrispondente ad ogni minuto; mentre nel caso dello sterzo c’è sicuramente modo di calcolare – e quindi anticipare – la direzione di marcia in termini dell’angolo di rotazione dello sterzo.
Concludiamo per il momento che in matematica la parola ha assunto un significato diverso da quello che ha nella lingua comune, nella quale, ad esempio, le funzioni di una persona, o di una macchina sono ciò che questa persona, o macchina deve fare per assolvere i suoi compiti; siamo ancora alla fine del passo A di cui sopra. Nella figura che vedete all’inizio la funzione associa ad ognuno dei quattro, ragazze e ragazzi, il suo sport preferito, scelto in un altro insieme, quello degli sport, che non tutto deve necessariamente essere “coperto” dalla funzione in questione. Ma credo che tornerò sul ruolo delle funzioni nel linguaggio scientifico.
La regina del fuoco
di Maria Gaia Belli
Molto molto tempo fa, quando il cielo era più alto della dorsale, la bambina Pauni viveva in un villaggio sulla montagna.
Suo padre cacciava nei boschi per la lunga estate, portava a casa carne e pellicce in abbondanza. Sua madre tesseva la lana e cuciva le pelli, spezzava con le mani la legna per il fuoco, poi scendeva al fiume a prendere l’acqua e la portava in tre secchi, due con le mani, uno in equilibrio sulla testa. La donna teneva sempre Pauni con sé, perché vedesse e imparasse. Le mostrò come muovere veloci le dita sul telaio, come pulire il nervo di bue facendoselo passare tra naso e bocca, come scegliere i sassi asciutti per accendere il fuoco, e tutto quello che serviva per badare alla casa sulla montagna.
La bambina crebbe in salute e altezza. Quando ebbe i seni e il sangue tra le gambe, suo padre la portò al centro del villaggio, perché un uomo la scegliesse. La scelse un cacciatore. Divenne suo marito e Pauni andò a casa con lui.
Venne la lunga estate. L’uomo prese i cani e le armi e partì per i boschi, la donna rimase a casa. Ogni giorno accendeva il fuoco, spezzava la legna per mantenere viva la fiamma. Raccoglieva i panni sporchi e li portava al fiume, dove li strofinava con la cenere e li pestava con i piedi, poi li allargava ad asciugare al sole. Riportava il secchio pieno fino a casa, poi sedeva al telaio finché durava la luce del giorno.
La casa di Pauni era lontana da quella di sua madre e nessuno veniva mai a trovarla. Una mattina, come ogni giorno, andò al fiume. La sera prima si era punta il dito con l’ago, e il dito si era gonfiato. Aveva le nocche e i piedi scorticati per il tanto strofinare la cenere; le dolevano il collo e le gambe, e il sole batteva forte sulla testa. Pauni era stanca, così si stese sotto l’ombra di un salice e si addormentò.
Mentre dormiva, suo marito tornò dalla caccia e trovò il fuoco spento. Vide che non c’erano panni puliti né cibo pronto, allora uscì a cercare sua moglie. Arrivò al fiume e trovò i panni sporchi e i secchi vuoti e Pauni che dormiva sotto il salice. L’uomo raccolse un bastone e la picchiò sulle gambe e sulla schiena.
La ragazza si svegliò nel dolore, urlò e pianse, ma l’uomo era arrabbiato e il bastone duro. Per la paura, Pauni si buttò in acqua. Il fiume, che la conosceva, ebbe pietà di lei; la prese e la portò lontana dal marito. Le tolse i vestiti e le lavò il corpo, poi la lasciò ad asciugare al sole in una valle lontana.
Abitava in quella valle una famiglia di draghi neri. Il figlio maggiore, quel giorno, era fuori a caccia. Mentre volava sul fiume, vide la ragazza addormentata, gli piacquero i suoi lunghi capelli scuri, scese dal cielo e la raccolse. La portò sulla vetta della montagna, nella tana di sua madre, dove vivevano con lui cinque sorelle. Vedendolo tornare con la preda, le giovani draghesse gli andarono incontro, sbattevano le ali e gli leccavano il muso con gioia. Ma lui le scacciava, finché non venne sua madre a dirgli:
«Sei uscito a caccia e sei tornato con la carne. Perché non lasci che le tue sorelle mangino?».
«Questa non è carne» disse il drago. Posò la ragazza con delicatezza, perché i capelli neri splendessero alla luce della neve.
«Da tempo ormai mi chiedi di trovare una compagna per dare nuovo sangue alla famiglia» disse il drago alla madre. «Io scelgo questa femmina dalla bella criniera».
«Questa femmina è carne» rispose la madre, e le sorelle si avventarono su di lui.
Mentre i draghi litigavano, Pauni si svegliò e capì che la sua vita era in pericolo, così finse di essere morta. Ma presto fu incuriosita e iniziò ad aprire gli occhi. Vide il giovane drago che lottava con tutta la forza delle ali e dei denti per difenderla, e il suo sangue che bagnava la neve bianca. Le sue ali erano grandi e scure come le nubi del temporale, e la coda forte come l’acqua della cascata. Subito la ragazza se ne innamorò. Si alzò in piedi e si rivolse alla madre:
«Ti prego, di’ alle tue figlie di non uccidere il fratello per causa mia! Ti mostrerò da me quanto valgo».
«Piccola femmina» disse la madre «Sei nuda e senza ali. Cosa puoi valere? L’unica cosa che vogliamo è la tua carne».
«So tessere le stoffe da vendere al mercato» disse Pauni, e prese da terra i ciuffi di pelo caduti dal collo del drago, e subito mostrò come farne un filo.
«Non teniamo in nessun conto il denaro e viviamo coperti dalle pellicce con cui siamo nati» disse la madre.
«So spezzare la legna con le mani e farne armi» disse Pauni, raccolse un bastone e lo spezzò in tante parti.
«I nostri denti spaccano le rocce come fossero ossa di scoiattolo» disse la madre. «E ora succhieremo anche il tuo midollo».
«Ho un’ultima cosa da mostrarti» disse Pauni. «Se nemmeno questa ti piacerà, potrete mangiarmi».
La ragazza si accucciò, fece un mucchio di legna e pelo, scelse da terra due pietre asciutte e cominciò a batterle. Richiamate dal rumore, le sorelle smisero di combattere e si avvicinarono a guardare.
Quando ebbe battuto le pietre sette volte, tra le mani di Pauni nacque la scintilla. Il pelo secco nutrì la fiamma, che subito si levò alta sopra la legna. Le sorelle, spaventate, volarono via. Persino la madre indietreggiò. Solo il giovane drago nero, che riposava a terra dopo aver lottato, non si mosse, ma guardava il fuoco con grande curiosità.
Pauni raccolse un legno che bruciava e glielo portò, lo avvicinò al muso e il fiato caldo del drago si tramutò in un grande fuoco, che rischiarò la valle e sciolse la neve.
La madre, che era rimasta in silenzio per la paura, si riebbe. Chiamò a sé le figlie e le sgridò, perché erano fuggite come cerve. Chiamò il figlio e gli leccò le ferite. Infine si rivolse a Pauni:
«Piccola femmina nuda, il tuo potere è grande. Donacelo e in cambio ti darò mio figlio e un nome da drago, vivrai nella mia casa e le mie figlie ti serviranno.»
Pauni accettò e rimase nella tana, a fabbricare il fuoco per i draghi. Le sorelle le diedero la propria criniera per cucire una pelliccia e i propri denti come corna. Le insegnarono a cambiare le braccia in ali, a volare sulle valli e a cacciare nei boschi. Le diedero un nome nuovo, e tutti gli animali iniziarono a chiamarla Regina.
Passarono le stagioni. Con il potere del fuoco, i draghi erano divenuti padroni della montagna e ogni creatura dei boschi li temeva. Stanchi di vivere nella paura, i capi degli animali si incontrarono in segreto.
«Prima i draghi volavano in cielo e noi correvamo sulla terra, spartivamo la carne del cervo e del coniglio. Ora vengono di notte con il fuoco, bruciano le nostre tane e i nostri cuccioli, prendono per loro tutta la carne della montagna» dissero il lupo e la volpe.
«Bruciano il bosco per spingerci nella valle e lì ci massacrano. Gli alberi sono carbone e il nostro cibo è cenere» dissero i cervi e i cinghiali.
Tutti aspettavano la parola dell’orso, che prima del fuoco era l’unico animale di cui i draghi avevano paura. L’orso pensò per molto tempo, infine decise:
«Chiediamo aiuto agli umani, poiché loro sanno comandare il fiume».
Andarono al villaggio degli uomini e promisero loro pelli e carne in abbondanza per cento anni, se avessero tolto il fuoco ai draghi. Gli uomini scelsero cinque cacciatori e li mandarono quella stessa notte sulla montagna.
Lungo la strada, trovarono un giovane drago che viaggiava lontano dalla tana, lo presero di sorpresa nel sonno e lo uccisero. Ballarono sopra la sua schiena, poi, prima che facesse giorno gli tagliarono la lingua, la punta della coda e delle ali e buttarono tutte queste cose nel fiume. Pregarono il fiume di spegnere il fuoco, e credendo che il fiume li avesse ascoltati, fecero ritorno a casa. Ma il fiume, che ricorda ogni volto che ha guardato nelle sue acque, si rigirò fino alla sorgente in cima alla montagna, e da lì chiamò Regina.
«L’uomo che avevi per marito stanotte ti ha ammazzato un figlio» le disse.
Regina non pianse, non si strappò i capelli né pestò i piedi. Tornò alla tana, dove il suo compagno dormiva accanto al fuoco. Si sdraiò sotto la sua ala e finse di dormire.
«Dove sei stata?» chiese lui.
«A contare le stelle» disse lei, perché lo amava molto e non voleva addolorarlo con la morte del cucciolo.
Quando la luce dell’alba toccò l’entrata della tana, Regina si alzò, mise la pelliccia sulle spalle e le corna in testa. Andò nel bosco, trovò un lupo e lo uccise. Si rotolò tre volte nel suo sangue, gli leccò il muso e disse:
«Indicami il villaggio degli uomini, perché vi andrò e lo brucerò fino alle radici, mangerò le loro ossa bianche e di loro non resterà niente».
Il naso del lupo diventò il suo e Regina poté vedere dove gli uomini avevano calpestato il bosco. Seguì l’odore di letame e carne bollita, di frutta marcia e pidocchi, finché non arrivò in vista del villaggio. Le case dei cacciatori odoravano di sangue. Regina accostò l’orecchio ai tetti e sentì il fiato di bambini addormentati. Sentì la vibrazione dei fili tesi nel telaio, colpi di tosse, una risata sottovoce. Non ricordava niente di questi suoni, così fabbricò il fuoco e andò a posarlo su ogni tetto del villaggio. Quando ebbe finito, spiccò il volo, per poter guardare dall’alto ciò che aveva fatto.
Per primi scapparono gli uomini, senza darsi pena di donne, vecchi e bambini. Poi uscirono le donne, con fazzoletti intorno alla bocca e i figli caricati sulle spalle. I cani abbaiarono e i vitelli piansero. Il fumo, pian piano, faceva scendere il silenzio.
In quel momento, una vecchia, che la notte non poteva dormire per i dolori, tornava dal fiume con i secchi dell’acqua. Vide il cielo fattosi nero e la donna che volava sopra il fuoco. La sua pena fu grande, e il secchio le cadde dalla testa.
«Pauni!» chiamò. «Che cosa hai fatto?»
Regina riconobbe la voce di sua madre e il suono del suo nome di bambina. Ripensò alla mano sulla guancia, e al bastone sulla schiena. Ricordò che le urla nel bosco erano voci di persone, e seppe distinguere le urla dei gatti dal pianto dei neonati.
Mentre volava come un drago ricordò di essere una ragazza. Le sue ali tornarono braccia e cadde dal cielo dentro il fuoco.
Le donne del villaggio intanto erano corse al fiume, avevano preso l’acqua e già spegnevano l’incendio. Quando restò solo fumo, trovarono la ragazza morta sotto la cenere. La presero e la portarono lontana nel bosco, dove gli uomini scavarono una buca alta sette metri. Qui la deposero, vi versarono sopra acqua fredda e sigillarono la tomba con tre grosse pietre.
Quella notte i draghi vennero a cercarla, ma non riuscirono a trovare il suo odore da nessuna parte. La cercarono per molti giorni e molte notti, usarono il fuoco per chiamarla nei boschi scuri e nelle grotte buie. Quando l’ebbero consumato tutto, tornarono alla tana sulla montagna, ma qui, senza Regina che lo curava, trovarono il fuoco spento.
Il suo compagno rotolò pietre asciutte e legna secca davanti all’entrata della tana, si strappò il pelo della criniera coi denti e sedette ad aspettarla. Aspettò per tutta la lunga estate, per tutto il lungo inverno, e per tutte le stagioni che vennero in mezzo, finché lui stesso non diventò pietra e il ghiaccio lo coprì. Il bosco tornò verde e le tane abitate. Il tempo trasformò il fuoco in una storia, e i draghi in animali come tutti gli altri.
Purgatorio / Dynamo
[È da poco uscito il nuovo numero della rivista “CONTAINER: osservatorio intermediale”, prodotta da Daniele Poletti e Diaforia edizioni. Un materiale ricchissimo in 84 pagine. Per ordinarla, scrivere a:info@diaforia.org. Di seguito il mio contributo. a. i. ]
.
di Patrick Beurard-Valdoye
Traduzione, note e presentazione di Andrea Inglese
Presento qui la traduzione di un testo di Patrick Beurard-Valdoye « Purgatorio / Dynamo », apparso sul sito Remue.net. È un estratto da Lamenta des murs (Lamenta dei muri), ossia l’ottavo volume del Ciclo degli esili, la cui pubblicazione è prevista per il 2023 presso Flammarion. Beurard-Valdoye ha realizzato a oggi, nell’ambito delle poesia contemporanea francese, un’opera impressionante per mole, coerenza, e ricerca formale.
Il “ciclo degli esili” tratta dell’Europa come luogo di persecuzioni e traumi collettivi e, nello stesso tempo, d’irriducibile molteplicità di culture e popolazioni. L’opera poetica di Beurard-Valdoye si è cristallizzata intorno a grandi snodi storici, di cui esplora parallelismi, intersezioni, coincidenze, che sempre fanno emergere, nel corso di eventi maggiori, destini particolarissimi, vicende individuali, in grado di pulsare con estrema forza e nettezza anche nel marasma generale. Nel testo che presentiamo, l’elaborazione poetica emerge alla confluenza di quattro linee “testimoniali”. Vi è una linea biografica, familiare, rappresentata dall’esperienza del padre soldato; vi è una linea storico-documentaria, che riguarda le diverse testimonianze sulla battaglia di Dunkerque, particolarmente cruciale nelle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale; vi è l’interpretazione cinematografica dell’evento, realizzata nel 2017 da uno dei maggiori registi contemporanei, Christopher Nolan, con Dunkirk; vi è infine la vicenda dell’internato Antonin Artaud che, nella Francia occupata dai nazisti, si rapporta agli eventi e ai personaggi politici secondo il suo punto di vista allucinato e delirante. Per Beurard-Valdoye la scrittura poetica non si pone agli antipodi delle forme narrative o storico-documentarie, ma le ripercorre a contropelo, inserendosi nei molteplici interstizi, riempiendo le lacune o, come è stato scritto, costituendo “la memoria insonne delle pagine bianche della storia”.
Concludo questa brevissima nota con uno stralcio tratto da un’intervista apparsa sul sito Poezibao il 7 ottobre 2010. Qui l’autore ci parla delle diverse dimensioni dell’azione poetica, che egli unifica sotto il concetto di “arti poetiche”, concetto che dovrebbe interessare i lettori di una rivista Container, che si propone un approccio della letteratura e dei suoi margini all’insegna della complessità.
«All’origine dei miei libri, c’è un progetto. Ed è il progetto che determina in seguito la forma letteraria, e non l’inverso. Si costruisce allora qualcosa che definisco dispositivo. Tutte le forme – o tutti i media – possono essere esplorate se contribuiscono a elaborare il progetto: il testo poetico in versi, il testo poetico in prosa ritmica, la poesia visiva, la poesia-lista – che chiamo “teorie” –, la prosa documentaria, così come qualsiasi forma da inventare se nessuna delle precedenti è adeguata. Il “narrato” (le narré) è una di queste, mi sembra. A ciò si aggiunge il dispositivo della performance (io preferisco parlare di “recital”), che agisce o reagisce sulla scrittura. Questo insieme è ciò che chiamo “arti poetiche”. Respingo, ben inteso, come un certo numero di colleghi, l’abituale e retrograda classificazioni in generi letterari, che è l’espressione di una volontà mercantile. Mi sorprende sempre osservare come i nostri predecessori continuino a stabilire un segno d’equivalenza tra poesia e verso. Li considero leggermente in malafede. È vero che quasi tutti non si definiscono poeti ma: scrittori. Parola che non significa in fondo più niente. Chi non è scrittore? Cosa abbiamo da spartire con i nostri ministri, i nostri presidenti o i nostri amministratori di beni, che sono – loro soprattutto – scrittori.”
*
Follia, … distruggimi, affinché possa dimenticare che esisto, affinché cessi di essere
GUSTAV MAHLER [in margine alla partizione della Sinfonia n° 10]
1
flutti rabbiosi cimitero mobile
stiva inondata in balia degli affondamenti
brodogorgo bistro basso ostinato
enorme bara gremita
lo schiacciafondo dietro la faccia del mare
la cattura nel maestrale della storia
respirate infatti primariamente
massa che siete di poveri pazzi squassati
dividete e conservate i soffi
ingabbiati – non è più il momento
di rubare branchie durante la caduta
qualcosa come un tic tac d’orologio
il tempo è troppo maschile
qualche disperato s’arrampica
sul relitto del Nova Scotia
non trova che immagini indelebili
finiscono ma finiscono su fisarmonica
e sax fanno danzare il drappello
si frastornano vento soffia Manica
smembrata in suoni di conchiglia
un sergente voltafacciando balza
pistola in pugno per freddare
i suonatori di fiati
non colpisce chiunque un’onda
furiosa agguanta l’ossesso
tutti storditi una faccia requiem
per quale demenza seppelliscono il peggio
ne sono davvero scampati?
*
2
al campo dei superstiti di Dunkerque
i Francesi seduti in gruppo nel mezzo
gli Inglesi gli stanno attorno in piedi
tutti avviliti davanti alla radio
ARMISTIZIO CON ONORE
si mettono a scalpitare sul posto
a battere i piedi a singhiozzare
poltiglia folle di tristezze
gli Inglesi si sono ritirati
il terreno non è di sabbia e l’arca
d’alleanza ha fallito
per la replica
bisogna rilavorare il discorso
della tigre shakespeariana
rifinire la traduzione migliorare
la sua resa in bocca volgere di nuovo
rimestare tutta la chiacchiera
senza scoppi di pianto
prima dell’uscita dallo studio
FRANCESI SONO IO CHURCHILL
CHE VI PARLO
Michel Saint-Denis alias Duchesne
L’ex-Dynamo è al timone della parola
NOI ATTENDIAMO L’INVASIONE
I PESCI PURE
*
3
i superstiti muti del Dynamo tra i quali
mio padre avrebbero apprezzato che
su grande schermo il nemico fosse
senza volto senza la forza
vuota del proprio campo di morte
o alla maniera di un resoconto di missione
restava il nemico innominato
trattato da bandito nei collegamenti tra Spitfire
la vita si era abbassata d’una tacca
non avrebbero sopravvissuto a Dunkirk
alta definizione che risveglia l’olfatto
di un’epopea inodore
e poiché lo spettacolo costruito stava in piedi
i loro nervi avrebbero ceduto
erano necessari questi eroi sepolti
a una profondità di sei piedi
nel terriccio del loro cimitero
nella sabbia fine delle bray-dunes
nel ferro ossidato dei relitti inghiottiti
senza tic tac d’orologio
nella necropoli sotto le stele
lasciati in pace con la loro identità
di tipi-rattrappiti cucita addosso
una scritta schiaffata
in faccia al passante
fate respirare queste pietre parlanti
questi betili armati in cemento soffiante
e quel che dei resti è restato
nei limiti dell’incerto
presunto ISOLA soldato maggio-giugno 1940
presunto PASCALE Jules soldato 1-6-1940
ignoto Spagnolo 2-6-1940
ignoto maresciallo d’alloggio o sergente maggio-giugno 1940
presunto MAZZA Joseph secondo artigliere 35° R. A. D. 29-5 / 3-6-1940
ignoto fuciliere deceduto il 02-06-1940 a Bray-Dunes
ignoto allievo marinaio maggio-giugno 1940
ignoto soldato tra il 30-5 e il 3-6-1940
ignoto fuciliere algerino maggio-giugno 1940
ignoto L. G. soldato 7° R. I. giugno 1940
presunto ANGUS A marinaio 29-5 / 3-6-1940
ignoto soldato S. D. T. M. 29-5 / 1-6-1940
BOUZEGHTA BONDJENA detto AMMAR soldato presunto 23-6-1940
presunto GAILLARD Marc soldato 137° R. I. 27-5-1940
presunto SAUMAR soldato 121° R. A. maggio-giugno 1940
ignoto presunto capoguardia giugno 1940
tutti “poveri cristi”, evidentemente!
scovate allora anche il patronimico dei piloti
tedeschi dei 180 aerei abbattuti
helios! helios! segno-nel-cielo
le truppe – l’occhio alle virgole
nell’azzurro – si rallegrano
ma solo la prima volta dice Saint-Denis
quanto alla R.A.F. e ai suoi planes
costruiti in segreto
i dirigenti inglesi non ne conoscevano
– neppure il Re – i piani
e questo silenzio dava slancio
e una speciale confidenza ai fighters
l’internato Antonin Artaud per altro
voleva mettere L’Avallo-dei-Tedeschi
sulla via grazie a uno schema uno dei suoi
scarabocchi d’iniziato soltanto un po’ folle
IL PRINCIPIO È STATO TRASFERITO AD UN PUNTO
MOLTO PIÙ OCCULTO DEL CIELO
*
4
della traversata Artaud parla a Prevel
il reale in viaggio
da Dunkerque a Vera Cruz
ma la memoria fa brutti scherzi
il vero fluttua si
presenta fibra per fibra
cianciando nel vivo
per Artaud non si dà purgatorio
solamente inferni e limbi
lui non è a Dunkerque
se da Anvers spedisce carezze alla madre
nell’attesa dell’Albertville
che ha forme imponenti – scrive –
massiccio tozzo e fornito
d’un alto e ampio fumaiolo
in quanto ha molta importanza
per Artaud il fumaiolo dei piroscafi
lo spettro del troppo-tardi sempre incombente
l’Albertville è requisito
per evacuare le truppe da Dunkerque
armato di due mitragliatrici
con munizioni scadute e due
cannoni 75 mm della guerra
precedente che gli artiglieri
trovano assai imprudente utilizzare
questo il materiale d’altronde il fucile Berthier
di mio padre era privo di munizioni
e le cinque cartucce disgraziate
distribuite ai compagni facevano
sempre cilecca – la Battaglia di Dunkerque
era anche questo e i singhiozzi di mio padre
lingua rasoterra trombetta da fantoccio
*
Note al testo
“Dynamo” è l’operazione di ritirata strategica realizzata dalle truppe alleate francesi e inglesi, bloccate al nord dall’avanzata rapida e irresistibile delle truppe naziste. L’operazione si svolse sulla spiaggia di Dunkerque tra il 26 maggio e il 4 giugno del 1940. In una situazione estremamente difficile, le navi alleate riuscirono a portare in salvo in Gran Bretagna circa 338.000 soldati, di cui 115.000 francesi. In cielo si affrontarono senza sosta gli aerei della RAF e quello della Luftwaffe..
La “tigre shakespeariana” è Churchill che prepara, assieme a Michel Saint-Denis, una versione in francese del suo discorso diffuso dopo l’armistizio tra Francia e Germania (22 giugno 1940). Michel Saint-Denis, attore e drammaturgo francese, attivo a Londra dal 1935, durante la Seconda Guerra Mondiale dirige Radio Londra sotto lo pseudonimo di Jacques Duchesne.
Dunkirk è il film di Christopher Nolan uscito nelle sale nel 2017.
“L’Avallo-dei-Tedeschi” si riferisce a Pierre Laval, ministro del regime di Vichy, a cui si rivolge Artaud in una delle sue lettere. Quest’ultimo è internato tra il 1938 e il 1942 nell’ospedale di Ville-Evrard, vicino a Neuilly-sur-Marne.
*
Folie … détruis-moi avant que j’oublie que j’existe, que je cesse d’être
GUSTAV MAHLER [en marge de la partition de la Symphonie n° 10]
1
flots en rage cimetière mouvant au
hasard des naufrages cale inondée
tourbouillon bistre basse obstinée
énorme bière bondée
l’étueffond derrière la face de mer
l’emprison du noroît de l’histoire
respirez en effet primordialement
tas de pauvres fous cahotés que vous êtes
répartissez et conservez les souffles
encastrés l’heure n’est plus à
voler dans votre chute les branchies
quelque chose comme un tic tac horloger
le temps est trop masculin
quelques éperdus se hissant
sur l’épave du Scotia
ne trouvent qu’images indélébiles
tombent mais tombent sur accordéon et
saxo font danser l’escouade s’étour
dissent le vent siffle la Manche se
démonte en sons de conque
un sergent voltefaçant bondit révolver
au poing va brûler la cervelle
d’instrumentistes à vent
n’atteint quiconque une vague
furieuse empoigne le forcené
tous abrutis au visage requiem
par quelle démence enterrent-ils le pire
en sont-ils vraiment revenus
2
au camp de rescapés de Dunkerque
les Français sont assis en groupe au milieu
les Anglais debout à l’entour
tous cois devant la radio
ARMISTICE DANS L’HONNEUR
se mettent à piétiner sur place
trépigner sangloter
compote de chagrins folle
les Anglais se sont retirés
le terrain n’est pas de sable et l’arche
d’alliance s’est échouée
pour la réplique
il faut retravailler le discours
du tigre shakespearien
peaufiner sa traduction améliorer
sa mise en bouche translater
baratter tout baratin
sans éclats de sanglots
avant la sortie du studio
FRANÇAIS C’EST MOI CHURCHILL
QUI VOUS PARLE
Michel Saint-Denis alias Duchesne
l’ex-Dynamo est au gouvernail de la parole
NOUS ATTENDONS L’INVASION
LES POISSONS AUSSI
3
les rescapés muets de Dynamo dont mon
père auraient apprécié que
l’ennemi sur grand-écran fût
sans visage sans la force
vide de son propre champ de mort
or à l’instar d’un rapport d’opération
il restait l’ennemi l’innommé
traité de bandit dans les liaisons entre Spitfire
la vie avait baissé d’un cran
ils n’auraient pas survécu à Dunkirk
imax réveillant les odeurs
d’une épopée qui ne pue pas
et puisque le spectacle charpenté tenait bon
leurs nerfs auraient craqué
il fallait ces anonymes héros enfouis
six pieds en dessous
dans le terreau de leur cimetière dans
le sable fin des bray-dunes
dans le fer oxydé d’épaves dégluties
sans tic tac horloger
dans la nécropole sous les stèles
fichées en paix avec leur
identité de rabougre cousue
d’une écriture plaquée sur
la face du passant
faites respirer ces pierres parlantes
ces bétyles armés en ciment sifflant
et ce qui des restes resta
aux termes de l’incertain
présumé ISOLA soldat mai-juin 1940
présumé PASCAL Jules soldat 1-6-1940
présumé GARCIA Espagnol 2-6-1940
inconnu Espagnol 2-6-1940
inconnu maréchal des logis ou sergent mai-juin 1940
présumé MAZZA Joseph canonnier servant 35° R. A. D. 29-5 / 3-6-1940
inconnu tirailleur décédé le 02-06-1940 à Bray-Dunes
inconnu matelot mai-juin 1940
inconnu soldat entre le 30-5 et 3-6-1940
inconnu tir. alg. mai-juin 1940
inconnu L.G. soldat 7° R. I. juin 1940
présumé ANGUS A marin 29-5 / 3-6-1940
inconnu soldat S. D. T. M. 29-5 / 1-6-1940
BOUZEGHTA BONDJENA dit AMMAR soldat présumé 23-6-1940
présumé GAILLARD Marc soldat 137° R. I. 27-5-1940
présumé SAUMAR soldat 121° R. A. mai-juin 1940
inconnu présumé quartier maître juin 1940
tous des gentils cuideriez-vous
dégotez donc aussi le patronyme des pilotes
allemands aux 180 avions descendus
helio helio signe-en-ciel
les troupes vers la voûte aux virgules s’égaillaient
la toute première fois dit Saint-Denis
quant à la R. A. F et ses planes
construits dans le secret
les dirigeants anglais pas même
le Roi n’en connaissaient les plans et
ce silence donnait des ailes
aux fighters une assurance spéciale
l’asilaire Antonin Artaud d’ailleurs
voulait mettre L’Aval-des-Allemands
sur la voie par un schéma l’un de ses
gribouillis d’initié juste un peu fou
LE PRINCIPE A ÉTÉ TRANSFÉRÉ À UN POINT
BEAUCOUP PLUS OCCULTE DU CIEL
4
de la traversée Artaud parle à Prével
le réel en voyage
de Dunkerque à Vera Cruz
mais la mémoire joue des tours
le vrai fluctue il
se présente fibre par fibre
discutaillant dans le vif
pour Artaud il n’est de purgatoire
seulement les enfers et les limbes
lui n’est pas à Dunkerque
s’il envoie d’Anvers des caresses à sa mère
dans l’attente de l’Albertville
formes imposantes écrit-il
massif trapu et muni
d’une haute et large cheminée
car pour Artaud la cheminée a
beaucoup d’importance sur les bateaux
le spectre du trop-tard rôdant toujours
l’Albertville est affrété
pour évacuer les troupes de Dunkerque
armé de deux mitrailleuses
avec munitions périmées muni
de deux canons de 75 de la guerre
d’avant les artilleurs trouvent
bien imprudent d’essayer
ce matériel d’ailleurs le fusil Berthier
de mon père était sans munitions
et les cinq malheureuses cartouches distribuées
aux copains ne convenaient jamais
la Bataille de Dunkerque c’était ça aussi
et les sanglots de mon père
langue en rase-mottes trompette en fantoche
Circolarità senza ritorno ne “Le meduse di Dohrn” di Carmine de Falco
di Daniele Ventre
—
“Le Meduse di Dohrn è un’opera interamente Covid-free, che si è stratificata negli anni ed è frutto di innumerevoli incontri…”. Esordire, nella recensione e nell’analisi di un’opera in versi, citando l’incipit della postilla finale di ringraziamento dell’autore può suonare quantomeno anomalo, eppure poche formule critiche (se si escludono i precisi sondaggi testuali della fulminea postfazione al libro che dobbiamo a Ferdinando Tricarico) sono più illuminanti di questa definizione che l’autore stesso, Carmine De Falco, dà della sua raccolta, uscita due anni fa per i tipi di Bertoni ed. e oggetto, nel settembre scorso, di nuovi eventi di presentazione e lettura pubblica, dopo lo stop della pandemia.
La stratificazione e la contaminazione di esperienze critico-letterarie ed esistenziali sono due cifre distintive dell’attività letteraria di De Falco: costituiscono la radice della sua peculiare militanza poetica (di qui fra l’altro l’occasione della consonanza con un poeta par excellence militante, come Tricarico, post-fatore dei versi) e la misura dell’aderenza alla realtà (giustamente messa in evidenza da Luca Ariano nella prefazione al volume) ne plasma il suono e la sostanza, come per effetto pressorio di forza tellurica su roccia metamorfica o dolomia in emersione. Il lento lavorio di sedimentazione, stratificazione, emersione/emergenza tettonica, compressione e metamorfosi è in effetti la natura stessa del processo di elimazione che ha agito sui versi de Le Meduse di Dohrn, titolo che fa delle meduse della stazione zoologica “Anton Dohrn” della villa comunale di Napoli, e allusivamente del proliferare di meduse nel golfo di Napoli, la marca e la traccia dell’atmosfera da apocalisse climatica e ambientale che segna il secolo attuale, figlio storico aberrante del Novecento dell’atomo e della Luna.
Le tre sezioni in cui la raccolta si ripartisce si saldano in quella tragedia annunciata in tre atti che è, come si è appena detto, il declino geofisico e biologico del pianeta. Il degrado del clima e del bioma segue in parallelo il disfarsi della civiltà umana, ne è il portato, il teatro, la causa e l’effetto che rafforza la causa. La prima sezione, Poesie dei dopo disastri annunciati, assume sin dalle parole dell’esergo in corsivo, la struttura di un romanzo distopico in versi. La degradazione glaceologica della distesa gelata di Okjökull, primo ghiacciaio islandese a deliquiare dalla sua natura di ghiacciaio propriamente detto, è il primo istante di un processo per cui “nei prossimi 200 anni tutti i nostri ghiacciai seguiranno il medesimo destino”. L’esergo è una lettera a un anomalo “tu” lirico di questo remoto futuro, l’unico che saprà effettivamente se ciò che era necessario fare adesso per il cambiamento climatico, è stato effettivamente messo in opera. La sezione che così si inaugura, si incentra sull’immagine del ritorno distopico, discronico e disontologico al caos primitivo, all’indistinto, a un’impropria concordia degli elementi. Simbolo e correlativo oggettivo di tale dimensione post-catastrofica è lo “sfero” empedocleo evocato in “Perma-nere è parola umana” (pag. 19). Il feroce neikos, conflitto endemico, biologico e climatico, si conclude nell’estinzione dell’umano: un’estinzione che è, alla lettera, nirvana dell’ecosistema ridotto, per precisare la citazione da Empedocle, a “sfero rotondo che di sua avvolgente solitudine gode” (fr. 31 DK). In questo sub-antropocente, o post-antropocene, la natura apocalittica del messaggio alla base del primo quadro della tragedia delle Meduse di Dohrn si palesa nell’enunciato per cui “Nel lungo l’umano è destinato/a non ritornare, resta solo il divino/.” L’orizzonte è il superamento delle “macerie antropoceniche” verso intelligenze articiali che guarderanno all’uomo attuale come all’enigma di un creatore dalla psykhé imperscrutabile. Più avanti il cyborg, il robot futuro, l’evoluzione imprevista della biologia artificiale, quasi richiamo del Bradbury di Where Robot Mice and Robot Men Run Round in Robot Towns interagisce con questo muto interlocutore, creatore destruente, che è l’uomo, lo Shiva della techne e del bioma. “Il robot ti chiede:/ perché mi fai questo?/ È programmato per lamentarsi/ e stimolare il tuo moralismo un tanto al chilo… Non basta saper programmare/ per semplificare i conflitti, le colpe…”: così in “Il robot ti chiede” (p. 39), questo abnorme e inopinato complesso di Frankenstein assume connotati metafisici ed etici imprevisti, e la creatura bio-meccanica, come nelle Visioni di Robot asimoviane, si pone come sostituto moralmente più degno del suo feroce e grezzo predecessore, in una sorta di redenzione estropiana, oltre la catastrofe.
Un altro elemento di coalescenza della natura dello sfero planetario degradato, affiora qua e là fra le pieghe delle Poesie dei dopo disastri annunciati, ed è l’avvolgimennto vorticoso del tempo su se stesso. Il tempo arrotolato a coclea si fa dimensione implosa nel subatomico, ma anche coclea di ascolto e risonanza della natura del reale al principio della seconda sezione, Quadre danesi: così in “La città si allarga bassa” (p. 51), le strutture urbane della Metropolis à la Fritz Lang che in ogni selva di grattacieli è possibile ravvisare, stanno “a testimoniare/ l’offesa dell’arrivo, dell’essere arrivati/ Capsula di metallo e vetro verticale/ che sinuosa ammica a futurismi che furono”. La dinamica di evoluzione temporale sottesa ai verbi e ai sostantivi deverbali, in questi versi, oscilla continuamente fra durata attuale (“arrivo”), sostantivazione-ipostatizzazione-congelamento dello stato derivante da un perfetto logico-resultativo (“l’essere arrivati”), paradosso di una figura etimologica fra passato remoto e derivato di un residuo di participio prospettivo-destinativo (“futurismi che furono”). Non è un caso che per tutte le situazioni poetiche di Quadre danesi, dopo questo esordio, si assista alla presentificazione delle cose, eleaticamente blindate e candite nel presente gnomico (e nella sua variante resultativa del passato prossimo): così accade per esempio nei lunghi versi atonali di “15 Gennaio 2018 // Trianglen 3,4 TH // (p. 54). Coclearità temporale e presentificazione, che agivano sottotraccia, come sottofondo costante dei “dopo disastri annunciati”, costituiscono insieme il tema sinfonico/disfonico dominante di Quadre danesi, attraversando e unificando le diverse note della tastiera linguistica di De Falco, dall’inglese tramato di fair play aziendale al napoletano, passando per gli esotismi dei toponimi scandinavi. Così la Metropolis del tempo imploso dei “futurismi che furono” ritorna come immagine di metropoli nordica evocata in vernacolo in “Te si miso into’ stritto” (p. 75 s.): “Ma pe ttramente ca sta struttura ‘e stu palazzo/ s’arravoglia attuorno attuorno, i veco ‘o viento… venì a sunà a morte…”). Il vernacolo ha per De Falco e la sua trasmigrazione nord-europea il sapore di un nostos, di un ritorno, ma in realtà questo ritorno non è compiuto. Di fatto, la struttura di Quadre danesi segue il classico schema della Ringkomposition, ma la circolarità è, appunto cocleare, futurismo che fu, futuro passato che non si invererà, ciclicità senza ritorno.
La chiusa delle Quadre, con il suo richiamo alla quotidianità vernacolare, apre a una dimensione più terrena e di più concreta prossimità esistenziale, quella delle Sature, titolo di evidente sapore montaliano della terza e ultima sezione de Le meduse di Dohrn”. Le indicazioni cronologiche e bibliografiche presenti qua e là nella raccolta indicano la sua natura sedimentaria, a cui abbiamo accennato al principio: in Sature l’arco temporale delle poesie aggregate è disseminato nello spazio di oltre un ventennio, dal Grande paesaggio napoletano all’Assolato blues del sud, fino ad arrivare ai componimenti recenziori. Ciò che però colpisce, in Sature, è il salvataggio di quel che resta della dimensione storica umana nelle periferie del mondo e della modernità liquefatta (più che liquida). I luoghi evocati definiscono una costellazione di realtà urbane, dimensioni normative e modi di vita para-moderni, o se si vuole sub-moderni e dunque potenzialmente sottratti, per loro natura intrinseca, alla deriva della metropolis verso il collasso. Si tratta di una salvezza parziale, su piani ideali, dato che il mutamento climatico in atto rischia di travolgere tutto. Nello stesso tempo, però, gli spazi di Sature evocano, se ci si permette un’analogia storica impropria, quelle comunità periferiche che sarebbero sopravvissute alla crisi dell’età del bronzo, e più tardi del mondo antico, come spore in ibernazione destinate a germogliare nella classicità ellenica e nel rinascimento. Un testo emblematico in tal senso è A Livingston nessuno fa il bagno, già da noi in precedenza esaminato come esempio di una dimensione poetica ed esistenziale alternativa parallela, a una certa chiave di lettura del postmoderno e della ricerca letteraria.
Questa è però solo una delle chiavi di lettura di Sature, che in tutto il libro è la sezione che meno si presta, se mai vi si prestano le altre due, al tentativo di racchiuderne gli stimoli e le prospettive in una formula conclusiva. L’aggregato verbale e cosale, stico-prosastico come quello del Mazzonis di Vocazione del superstite, di Grande paesaggio napoletano, con mescidanza di vernacolo e lingua standard da maniera del gruppo ’93 rivisitata e ripensata (p.79), cede il passo ai versi atonali de “Le formiche argentine”, in cui forse non è del tutto azzardato leggere una mini-contro-parodia omaggio de Le api migratori di un Raos, per poi transitare verso il tono, fra l’operetta morale e il grande idillio decostruito, di “Dialogo tra albanesi su un kosovaro in Finlandia”, chiudendosi subito dopo nella contro-lirica di “immaginaria immensa nave da crociera”, quasi riscrittura frammentaria, da anti-Alceo, della nave del mondo umano come deriva sociale, salvo riaprirsi alla franca satira del neoliberismo e dell’impero debitorio della Troika (pp. 84 s.) a cui succede, giocoforza, il panorama carnale e sessuale mercificato di “Amazzoni esili e giovani”, e ancora, procedendo, il richiamo al Pagliarani di Rudi (“posso dirlo, Rudi è morto”), la contrapposizione fra la sognante Livingston del Guatemala e il gelo del consumismo tecnologico (“Non credi sia perverso sapere/ che hai trentasei milioni di colori” p. 91). Emblema di queste molteplici forme dell’esistente (e dei loro agganci metatestuali e intertestuali) è forse Quadretti impoetici di condizioni diverse e umane (pp. 104-106) a riassumere nel suo titolo ominoso il senso ultimo di questa sezione così disseminata, posta in coda, figlia dell’ontogenesi di de Falco come poeta a partire dall’assimilazione delle fasi di transizione fra la fine del secolo breve e l’inizio del secolo folle. Da questo punto di vista è proprio il terzo e ultimo quadro, culminante in una voluta dichiarazione di impoeticità, a definire la circolarità senza ritorno de Le meduse di Dohrn come quella dimensione in cui si dispera dell’antico progetto calviniano di proteggere, far durare, espandere con le unghie e con i denti, e con volontà resistenziale, i luoghi che nell’inferno globale ancora inferni non sono. Come rifugi dalla peste della modernità degradata e declinante e del suo cambiamento climatico (e delle pandemie che poco dopo l’ultimazione del libro avrebbero preso l’abbrivo), non si può più escogitare nel locus amoenus di una villa boccacciana l’ideale location salvifica dello spirito. Solo in brevi assurdi istanti tanto quotidiani quanto improbabili è dato all’uomo trovare rifugio dalla disgregazione cosmica che egli stesso ha avviato.
Radio days: Mirco Salvadori, Arlo Bigazzi & Vittorio Nistri
 Non c’è gusto in Italia ad essere felici
Non c’è gusto in Italia ad essere felici
di musica, perduta indipendenza, tenebra e rivoluzione Pt. 2
di
Mirco Salvadori in conversazione con Arlo Bigazzi e Vittorio Nistri
Assortimento Dolci Fini, Fondantes, Confetture, Frullati Conserva, Cioccolata, Galanterie di zucchero. Si assumono ordinazioni in Torte Croccanti Pasticcini. La mia sovrabbondanza glicemica inizia a sussurrarmi che il viaggio in una delle capitali della Mitteleuropa, antica realtà che segretamente continuiamo a celebrare come fase di incanto culturale prima della caduta, forse finirà al pronto soccorso causa coma diabetico. È un rischio che bisogna correre, quando il richiamo delle Galanterie di zucchero supera di gran lunga il canto delle Sirene di mitologica memoria. A ben pensarci il vecchio Ulisse da queste parti ancora tiene banco e non nelle fattezze dell’eroe di Itaca ma in quelle di un romanzo la cui stesura era iniziata in questa città e proprio in questa via, in un violentemente ventoso luogo affacciato sul mare con tutto il suo carico di pietra carsica sulle spalle.
Uso il navigatore azzerando in un attimo la scenografia mentale che avevo allestito per l’evento, la sola città nella quale riesco a muovermi senza perdermi è la mia Venezia e raggiungere questa via da un lontano parcheggio vista mare, risulta per me operazione concretamente angosciosa. Perché poi due toscani abbiano deciso che Trieste e quel caffé in particolare dovevano essere il luogo del nostro incontro, continua a risultarmi un mistero.Miracolosamente sono giunto in Largo della Barriera Vecchia, forse agevolato dalla fantomatica proiezione digitale di James Joyce che sembra mi aiuti ad aprire la porta di un caffé in stile liberty da lui frequentato nei primi anni del ‘900. Ad attendermi due reduci di epoche che ora sembrano remote, due musicisti che hanno attraversato incolumi e ancora attivi gli oltre cinquant’anni che ci dividono dagli anni ’70, periodo che sarà in qualche modo presente nella conversazione a venire.

Ma chi sono i due avventori che vedo già avvolti in un fitto e stranamente pacifico dialogo, seduti nell’antico sfarzo liberty della Pasticceria Caffé Pirona di Trieste? Chi segue queste pagine Arlo Bigazzi: musicista, produttore, regista e scrittore teatrale nonché co-fondatore della storica etichetta discografica Materiali Sonori ha già avuto modo di conoscerlo in una conversazione tenuta a bordo di un vetusto battello a vapore lungo un fiume dimenticato . È con lui e con un altro irriducibile libertario che di nome fa Vittorio Nistri : musicista membro di formazioni antagoniste quali Deadburger Factory e Ossi, da molti soprannominato “My Name Is R.I.O.” e non certo per un suo improbabile amore nei confronti dei Duran Duran, ma per il suo viscerale attaccamento agli Henry Cow e al loro Rock In Opposition, che andremo a continuare quella conversazione che verteva sull’indipendenza artistica e sulla sua estrema difficoltà nel viverla al giorno d’oggi.
“Buongiorno signori e ben ritrovati all’alba di un nuovo inverno della ragione, con il sordido triumvirato che nel giro di sole poche ore, già ha sfregiato gli ideali verso i quali tutti noi poniamo da sempre fede e osservanza. Urge placare lo stato d’ansia con il più naturale dei calmanti: mi si portino le Galanterie di zucchero accompagnate da cioccolata calda e panna montata e non badate ad un mio possibile improvviso stato di assenza, chiamate il 118 e ci penseranno loro.
Mantengo sempre un bel ricordo della cioccolata calda con panna, solitamente andavo a berla in un bar famoso proprio per quella bevanda e soprattutto per la panna montata che lì si produceva, densa e croccante di mille granelli zuccherini dispersi al suo interno. Erano gli anni ’70, periodo dal quale immagino giungiate anche voi.”
Con di fronte l’inseparabile chinotto del Bigazzi e le nostre due cioccolate fumanti, iniziamo questo confronto, una conversazione che ha come fine ultimo il riconoscersi, pur nelle diversità di vedute e professionali, come appartenenti allo stesso pensiero ancora e sempre critico e resistente nei confronti di una realtà che ha come compito l’annientamento dell’indipendenza artistica con la sua vigorosa forza esplosiva.
MS: Mentre, provocando stupidamente me stesso affondo il cucchiaino nella soffice bianca materia zuccherina, parto rivolgendovi la prima sollecitazione che riguarda proprio l’attitudine diffusa nei ’70: la provocazione. Abbiamo ben presente che significassero quegli anni ma oggi si possono in qualche modo attualizzarli, renderli nuovamente vivi ed efficaci come un tempo? Come può svilupparsi una nuova forma di provocazione in una realtà nella quale proprio le provocazioni sono soggetti principali usati dalla cultura massificata? Quale il loro ruolo e la loro possibilità d’impatto?

AB: Non credo che oggi si possa sviluppare una qualsiasi forma di provocazione in ambito culturale, almeno nei modi di come credo tu voglia sottintendere. Penso sia anche inutile. Perché provocatori lo furono i futuristi e i dadaisti, come nella popular music lo furono Elvis Presley, Frank Zappa o The Fugs, tanto per fare qualche nome noto ma oggi, rimanendo nell’ambito musicale, provocatori sono considerati anche Achille Lauro, che si “battezza” a Sanremo, e Damiano dei Måneskin che si esibisce vestito da dottor Frank N. Furter, che tra l’altro era una provocazione in uso una cinquantina di anni fa. Nella loro musica, però, sono piuttosto conformi a quanto già passa l’industria, quella che ti suggerisce, ti vende, ti rende di moda la trasgressione. Parlare di provocazione, trasgressione o quel che vogliamo, non credo abbia più tanto senso. Oggi la provocazione è creata e controllata dal Sistema, che dovrebbe essere il soggetto provocato, e ha l’impatto che l’industria decide debba avere. Atteniamoci alla definizione della Treccani: provocatore è «chi provoca o ha provocato, specialmente all’ira, a un comportamento aggressivo, a una reazione violenta». Forse, alla fin fine, è meglio non provocare ma restare interiormente incazzati e sopravvivere al Sistema. Questa potrebbe essere considerata un’ottima provocazione.
VN: Concordo in pieno con Arlo. Aggiungo che pure i social, dove la provocazione (specialmente nelle sue accezioni più gratuite, becere e regressive) “porta like”, hanno contribuito non poco ad affossare la valenza positiva che in passato veniva associata a questo termine. Ormai anche il più decerebrato degli haters, dopo essersi visto arrivare un licenziamento o una citazione in tribunale (magari per avere inneggiato allo stupro della Carola Rackete del giorno), farfuglia di default: «Non pensavo sul serio quello che ho scritto, voleva solo fare una provocazione».
Per continuare a trovare un senso positivo alla parola provocazione, forse bisognerebbe rimodularne l’obiettivo.
Oggi, per shockare sul serio qualcuno, l’unica sarebbe bruciargli l’iPhone. Né ha più senso continuare a pensare che la provocazione possa creare “scandalo nei benpensanti”, nell’era della patetica brama social dello “scandal du jour”.
Invece potrebbe avere ancora un senso una provocazione a pensare.
Per esempio, in questo periodo storico ossessionato dall’individualismo, una possibile valenza antagonista dell’arte potrebbe essere provare a stimolare una riflessione focalizzata sul noi invece che sull’io-me-myself.
Altro esempio: ell’epoca del culto della velocità, vedo un’attitudine controculturale in un’arte che possa indurre, fosse anche solo per qualche ora, a rallentare il passo, ad approfondire qualche stimolo, a lasciarlo sedimentare dentro di noi.

MS: Dopo le vostre risposte, seduti come agenti provocatori in un antico caffé triestino, mi sento proprio come un agitatore d’epoca intento a stendere un manifesto di incitamento al pensare mentre tra me e me canticchio: Largo all’avanguardia Pubblico di merda Tu gli dai la stessa storia
Tanto lui non c’ha memoria Sono proprio tutti tonti Vivon tutti sopra i monti. Volendo riprendere la conversazione proprio da questo testo, un tempo si era parte della controcultura giovanile che esternava il suo credo attraverso l’estetica e la musica. C’erano coloro che esibivano la propria appartenenza attraverso la forma e altri che rifiutavano le divise agendo comunque con decisione e spirito decisamente “punk” sulla sostanza. Erano soprattutto i figli della classe operaia, spinti da reali esigenze che andavano ben oltre gli estetismi. Quale può essere oggigiorno l’espressione di appartenenza, forse la qualità e il tipo di proposta musicale e quindi culturale, che si propone?
VN: Non so se capita anche a voi, ma a volte dentro di me sento di (o mi illudo di) saper riconoscere, con sufficiente chiarezza, cose che avrei difficoltà a definire o razionalizzare. In particolare, mi sembrano ben discernibili determinate “scelte di campo”, ancorché mi sia difficile mettere a fuoco criteri “oggettivi” per l’attribuzione a quel campo.
Nella maggioranza del cosiddetto indie italiano, così come in alcuni recenti trend musicali aggreganti (ovvero, nei quali trovano identificazione determinati gruppi di ascoltatori), “avverto” nitidamente l’estraneità al concetto stesso di controcultura. Vi ravviso invece piena adesione alla narrativa dominante: spesso come estetica, sempre come valori o disvalori veicolati.
Per contro, non ho dubbi nell’ascrivere alla “controcultura” (quasi fosse l’undicesima categoria aristotelica) opere come – faccio tre esempi di dischi recentissimi, tutti usciti nel 2022 – l’omonimo esordio di The Afrorack (aka Brian Bamanya: sintesi modulare made in Uganda, elettronica autenticamente anticolonialista e anti-global), The Liquified Throne Of Simplicity degli sloveni Širom (immaginifici, inventivi, fuori da ogni binario) o Romance dei newyorchesi Oneida (r’n’r quintessenziale, purissimo, archetipicamente rumoroso, mille miglia lontano dalle parodie di rock che troppo spesso riempiono gli stadi). Così come ravviso la medesima “alterità” in artisti italiani come i folletti OoopopooiooO, o l’omaggio multimediale di Arlo a Majakovskij, o i monumentali commentari sociali dei Maisie.
Se mi venisse chiesto di esporre i “criteri” coi quali giungo a tali giudizi, sarei in difficoltà (il criterio della “qualità” è opinabile per definizione, quello dell’argomento trattato è banalizzante e riduttivo, ecc), però, dentro di me, proprio non ho dubbi.

AB: Penso che in campo musicale sia piuttosto irreale definire la qualità, a patto che non si decida che sia esclusivamente la tecnica esecutiva a stabilirlo. Chi stabilisce la qualità di una proposta musicale? La musica inuit fatta esclusivamente da un tamburo, una voce e suonata su micro scale non è di qualità? Il punk, che può essere suonato fregandosene della tecnica strumentale, non ha valore culturale? La musica ambient, fatta di poche note, lunghissimi reverberi e che da decenni è sempre uguale a se stessa, è una proposta che ha una valenza culturale? E il liscio di Secondo Casadei come lo vogliamo considerare? Va suonato bene – perché altrimenti non lo suoni e non fai danzare i ballerini – ma è certamente diverso dal liscio che alcuni eseguono utilizzando le basi MIDI. L’heavy metal, che devi essere un ottimo musicista per poterlo suonare, cos’è? Per mia opinione sono espressioni culturali, certamente non accademiche, ma che possono racchiudere lo stesso spirito di appartenenza perché l’unico spirito di appartenenza che ci può tornare utile è “aprire la mente”. Magari volgendo lo sguardo a un mondo più equo, che poi lo identificherei con quella “scelta di campo” di cui accennava Vittorio, e con un’evidente onestà intellettuale che stia alla base e che mi sembra fondamentale come requisito. Pretendere di definire la qualità di un genere musicale, di una musica mi sembra pretestuoso. Non esistono la “musica bella” e la “musica brutta”. Esiste piuttosto la musica di cui ho bisogno – magari in un determinato momento della giornata o vita – e la musica di cui non ho bisogno. Si dovrebbe partire da questo banale concetto, da questi due “generi” per poi discernere di musica e magari del suo valore culturale.
MS: Freno il mio disaccordo sull’immobilità del comparto Ambient pensando per esempio all’ultimo lavoro di Giulio Aldinucci. Ma riprenderemo l’argomento in un’altra conversazione, magari. Parto con una breve digressione. Ricordate quando si usavano termini a non finire e si confondeva controcultura con sottocultura. Poteva per esempio il punk essere sottocultura rock o forse la vera sottocultura era quella delle Timberland, dei paninari con i Moncler e Drive In a seguire?
AB: Considero ancora controcultura quelle espressioni che si pongono in opposizione ideologica alla cultura dominante e che non stanno nei meccanismi dell’ex-industria culturale. Oggi è chiamata dell’intrattenimento.
Per definirle quelle espressioni, si usava anche la parola “alternativa” proprio perché in contrasto con i meccanismi dell’industria. Per capirsi, agli inizi, io pensavo di suonare “musica alternativa” come pensavo che Materiali Sonori fosse un’etichetta discografica alternativa. È un termine ormai totalmente in disuso. Peccato. Adesso penso soltanto di fare musica e non mi pongo il problema.
Per sottocultura, invece, ho sempre inteso quelle espressioni di basso livello che stanno dentro il Sistema, che preservano lo status quo della società in modo ancora più volgare, offrendo una visione del mondo guasta e che non porta nessuna riflessione, ma solo uno svago malsano e un totale disimpegno sociale. La cinematografia dei pierino e delle giovannonecoscialunga sono sottocultura, per provare a sintezzare il discorso con un esempio semplice.
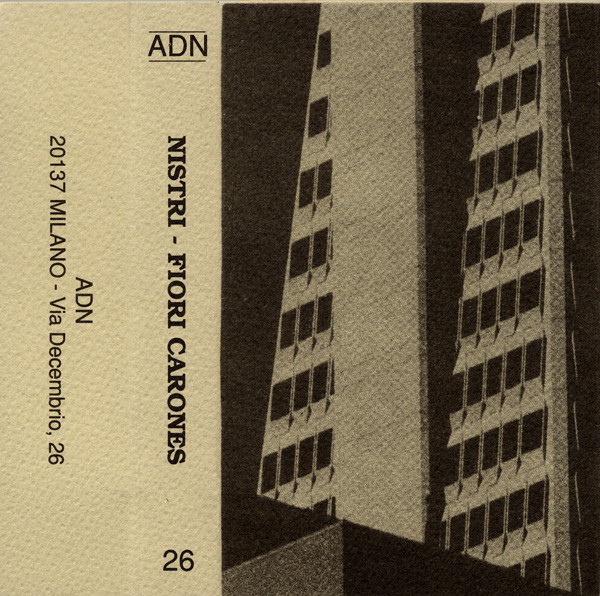
VN: sottoscrivo ogni parola di Arlo. A me il termine “alternativo” comunque piace ancora – è talmente obsoleto da essere di nuovo futuribile.
AB: Concordo. Dovremmo riprendere a usarlo più spesso.
MS: Giungiamo quindi a un tema centrale che un tempo in area di controcultura si dava per certo e oggi in modo scontato e dalla maggioranza di strutture e persone delegate alla diffusione musicale e quindi culturale (repeat) si vende come reale anche se in realtà, proprio non lo è: l’indipendenza musicale che, per come la vedo e per come ripeto ormai da parecchio tempo, è quasi o del tutto scomparsa alla fine degli ’80 con qualche strascico residuale nei primi ’90. Oggi si vendono i Verdena come summa dell’indie, quando in realtà il loro ritorno su disco avviene su Capitol Italia. Come la mettiamo?
AB: Cosa non è e cosa è indie è difficile da affrontare e lo ritengo ormai pure inutile. Non determina niente. Il Clan di Celentano era un’etichetta indipendente tanto quanto lo erano I Dischi Del Sole di Ivan Della Mea e Giovanna Marini e l’Alternative Tentacles dei Dead Kennedys, quindi penso che non lo si debba impiegare per definire un particolare genere o movimento musicale. Poi credo che oggi sia usato per definire quel genere musicale che mi sembra sia soltanto un pop un po’ scarso, fatto un po’ malino, senza tanta ricercatezza sia negli arrangiamenti sia nei contenuti. Non me ne intendo molto, ma mi sembra che stia un po’ così: «Volevo essere David Bowie ma non ci sono riuscito». In ogni modo, per definire “musica indipendente” rimango basico: è indipendente chi produce e distribuisce i propri lavori autonomamente. E questo può essere considerato un valore, ma il contenuto non ne è caratterizzato, se non in quella certa libertà del suonare quello che ritieni più opportuno, senza restrizioni o condizionamenti.
VN: Oggi la parola indie viene usata per tutto e il contrario di tutto – dalla canzoncina melodica sanremese al più apocalittico drone-maker.
Di questo argomento avevo discusso un annetto fa con l’amico Diego Alligatore (di Frigidaire e Smemoranda), per un contributo ad un progetto di libro poi accantonato (spero solo temporaneamente). Mi permetto di recuperare qualche riflessione che avevo fatto in quell’occasione.
Dunque… io credo che l’attuale vaghezza della parola indie sia un tassello di quel processo di svuotamento di significato a cui sono andati incontro – non solo in ambito musicale, ma culturale in senso lato, e pure politico e sociale – svariati termini che, per tanti anni, avevano identificato nuclei precisi di soggetti, convinzioni, comportamenti, lotte, innamoramenti, scelte esistenziali… e che poi, nel mondo cosiddetto post-ideologico (diciamo, a partire dagli anni ’80), si sono un po’ per volta allontanati dal loro senso originario, fino a smarrire ogni effettiva capacità di identificazione e di aggregazione.
Pensiamo ad esempio alla parola “sinistra”, che ha visto, tra i suoi presunti leader, figuri come Blair o Renzi, i quali hanno incarnato l’esatto contrario di ciò che, prima della “fine delle ideologie”, si intendeva per “sinistra”.
O alla parola libertà, che, a partire dal ventennio berlusconiano, è stata fatta coincidere con la licenza di perseguire illimitatamente il proprio tornaconto, anche a danno di altri individui e del contesto sociale tutto. Col risultato che oggi questo termine viene usato anche per veicolare valori antitetici a quelli dei Padri Costituenti, che pure di lotte per la libertà se ne intendevano più di noi. (Si veda l’accresciuta “libertà” di licenziamento, o di non assunzione stabile, che ha minato le sicurezze dei lavoratori in un modo che mal si concilia con una “repubblica fondata sul lavoro”).

AB: Sono d’accordo e anche in questo caso sono basico: “sinistra” per me è chi propone una società alternativa a quella capitalista, altrimenti è soltanto uno che vorrebbe migliorare alcuni aspetti di una società che si basa per forza di cose sull’iniquità e la disuguaglianza. Così come indipendente andrebbe considerato solo chi non fa compromessi e uso di capitali provenienti dall’industria. Ma sinceramente non so più se oggi abbia un senso usare il termine “indipendente” come un valore.
VN: Anche le parole cultura e competenza sono attualmente oggetto di una percezione valoriale esattamente opposta a quella del passato. Mezzo secolo fa, il diritto allo studio per tutti era oggetto di aspre lotte politiche, perché l’istruzione era vista come un tassello fondamentale per l’emancipazione sociale. Oggi invece molte persone avvertono studio e cultura quasi come un disvalore: una roba da ridicoli “professoroni”, lontani dal genuino sentire popolare – e oltre a tutto superflui, giacché ai loro denigratori basta digitare in rete cinque minuti per sentirsi ferrati su qualsiasi argomento, quanto e più di chi ha dedicato una vita intera a studiarlo.
Ecco, nel suo piccolo, la parola indie ha subito un analogo distacco dal suo significato originario.
Per cui ci capita di sentirla usare sia per etichette come Snowdonia e musicisti come Bruno Dorella (che da tutta una vita si sbattono, con coerenza e dedizione, per portare avanti musiche “altre” e circuiti genuinamente underground), sia per artisti il cui repertorio un tempo sarebbe stato senza esitazione considerato musica leggera o mainstream (donde la congenialità a canali promozionali quali Sanremo e X Factor).
Sì, davvero “grande è la confusione sotto il cielo”. Eppure eppure… anche se una parola ha cessato di identificare in modo univoco ciò che rappresentava in passato, per me è un errore pensare che sia per forza venuta meno la realtà che quella parola esprimeva.
Torno al primo degli esempi. Da anni ci sentiamo ripetere che la distinzione tra destra e sinistra è superata dai tempi. È un’affermazione mendace, perché confonde capziosamente l’uso annebbiato e ambiguo che di tali termini oggi viene fatto (…difficile in effetti considerare il PD un partito di “sinistra”…) con la realtà economica e sociale, che ancora oggi, né più né meno che in qualunque periodo storico, vede contrapposti gli interessi di parti differenti della società.
Ogni volta che un governo decide come utilizzare le risorse economiche del paese, può farlo con un occhio di riguardo ai ceti più bisognosi o a quelli dominanti. Questa, comunque la si voglia chiamare, è ancora oggi una scelta di sinistra o di destra. Se, per esempio, agisci a favore della qualità della sanità e dell’istruzione pubblica, e in genere del welfare state… se ricerchi meccanismi che possano incentivare le imprese ad assumere a tempo determinato… se combatti le infiltrazioni mafiose nella cosa pubblica…. stai facendo una cosa di sinistra. Se fai scelte opposte, stai facendo una cosa di destra. La realtà dice il vero più di ogni parola.
Approfondendo e in parte contraddicendo quando diceva Arlo, analoghe considerazioni sono possibili per il termine indie. Non ha volore perché ci sembra divenuto troppo vago, equivoco, omnicomprensivo? Pazienza, lo si può anche abbandonare e sostituire con qualche altro. Ma l’appannamento di un termine non implica la scomparsa delle realtà che quel termine designava.
La realtà è che ancora oggi esistono, tra coloro che fanno musica, attitudini differenti. Non tutti i musicisti sono uguali, non tutti si pongono gli stessi obiettivi né si muovono sulle medesime coordinate. E ancora oggi ci sono tanti musicisti e appassionati che si ostinano a tenere in vita quello spirito che un tempo identificavamo, appunto, con la parola indie.
MS: Sostituisco gli Skiantos con Qualcuno Era Comunista di Gaber nel mio ipotetico immaginario di riferimento dopo aver ascoltato le vostre risposte. Penso sconsolato a concertazzi tipo quelli del Primo Maggio romano, capaci di radere al suolo qualsiasi idea anche romantica noi si avesse della sinistra, mi chiedo quale quindi è il ruolo di noi musicisti, produttori, giornalisti in una realtà che non possiede più uno diffusa ideologia di “pensiero contro”, ma comunque continua a muoversi in una modalità underground (altro vocabolo su cui ci sarebbe da esprimere parere a mio avviso negativo, se ancora usato nelle modalità originarie; anzi per cortesia fatelo e dite la vostra).
AB: Il ruolo è di fare cose e cercare di proporle a un pubblico, limitato o vasto che sia. Perché è quello che sappiamo fare. Almeno per me è così. Non mi pongo la domanda se sono underground e che ruolo debba avere una cultura underground. So di esserlo da sempre. Ho scelto di non stare con l’industria, di starne ai margini, pur avendo “peccato” un paio di volte, la prima pubblicando dati in licenza alla Sire/Warner Bros International, la seconda facendo distribuire i dischi Materiali Sonori dalla CDG/Warner. Ma non me ne pento. Mi ha aiutato a comprendermi e a capire quello che faccio e da che parte stare. L’industria discografica non fa per me. E ti giuro che non è come la volpe con l’uva. L’industria discografica ha dei meccanismi, delle regole ai quali mi adatto poco bene. E poi, in fin dei conti, non amo per niente come funziona il sistema capitalista per cui ho cercato di trovarmi una collocazione indipendente, dove potessi esprimere quello che mi andava di esprimere. In fin dei conti, come ha detto Venturi Venturino, scultore nativo di Loro Ciuffenna, paese dove oggi abito, «io non mi sono mai sentito né uno scultore, né un pittore, né un musicista, né un poeta. Io mi sono sentito e mi sento semplicemente un uomo che esprime; esprime per sé e per gli altri». E lo faccio con quanto ho a disposizione. Il mio ruolo? Fare e proporre. Tutto qui.
VN: Underground era in origine una parola onesta e chiara, indicante un’attitudine “altra” rispetto ai (dis)valori della narrazione dominante. Il fatto che oggi la si senta spesso usata a proposito di “wanna-be-mainstream”, del tutto consustanziali all’ideologia imperante, è l’ennesima conseguenza di quel processo di svuotamento dei significati nel mondo “post-ideologico” del quale parlavo poc’anzi.
Tale processo non significa che non esista più un “pensiero contro”. Arlo ha ogni ragione nel dire: «so di essere underground da sempre». Se le parole possono essere usate in modo contraddittorio, i comportamenti (e, nel caso di artisti, le loro produzioni) chiariscono meglio di ogni definizione le reali scelte di campo.
Non conosco lo scultore di Loro Ciuffenna ma la sua frase è bellissima. Mi permetto anche io una citazione, e pure doppia. Si tratta di due frasi dello scrittore Antonio Moresco, che mi sembrano così “giuste”, e tra loro complementari, da averle usate entrambe nel booklet del più recente album della Deadburger Factory.
La prima: «C’è molto buio intorno a noi e a volte sembra di vivere in un paese e in un mondo di morti. Che chi lo può e lo vuole tenga almeno accesa la sua lucina. Poi si vedrà».
La seconda: «Non si combattono solo le battaglie che si è sicuri di vincere, si combattono tutte le battaglie che sentiamo nostre e che ci sembrano giuste. Si combattono addirittura le battaglie che si è sicuri di perdere. Perché altrimenti assumiamo a poco a poco l’anima di ciò contro cui vorremmo combattere».
Mirco, alla tua domanda su quale possa essere oggi il ruolo di quanto rimane del “pensiero contro”, non trovo risposte migliori di queste: sbatterci per quello che ci sembra giusto (battaglia persa in partenza? Probabilmente si, ma fanculo); e tenere accesa una lucina – poi si vedrà.
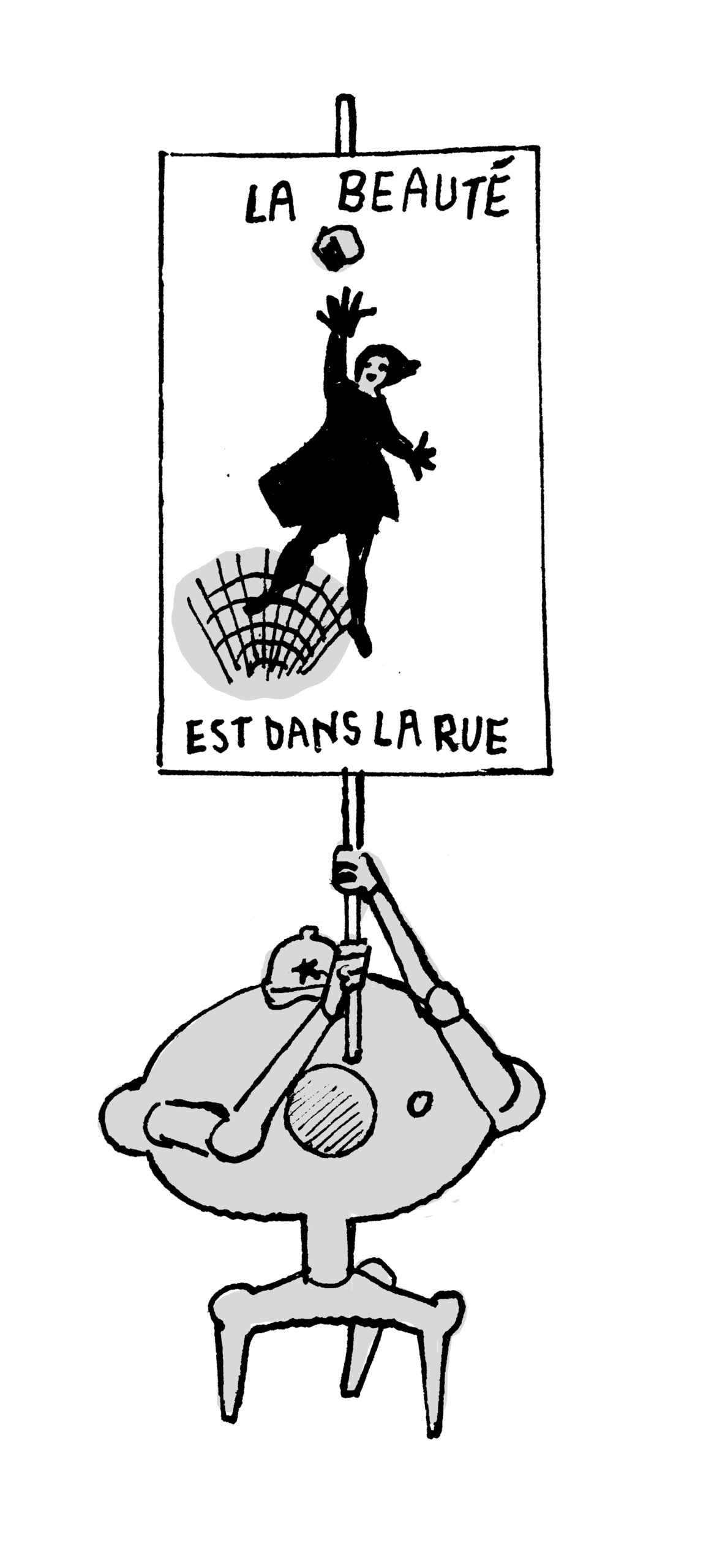
MS: Avviandoci verso la fine di una conversazione che potrebbe continuare ore, amerei togliermi un’altra curiosità chiedendovi cosa ne pensate del sistema di consorterie, sempre pensiate esistano, che iterano le proposte concertistiche o le proprie manifestazioni con le solite playlist di nomi evitando di proporne altri di reale valore artistico, forse perché troppo indipendenti o autonomi, artisti o musicisti o anche giornalisti che mai passeranno a ritirare un premio fedeltà in qualche manifestazione rigorosamente venduta come indie.
AB: Dipende a quali consorterie ti riferisci. Se legate ai meccanismi e alle regole del Sistema, ci sono sempre state e sempre ci saranno. Se pensi alle consorterie diciamo alternative, sono combattuto: o si è maggiormente radicalizzato l’io con il «mi basto e mi avanzo perché sono migliore di te», oppure si tratta di stanchezza, di perdita di curiosità. Perorare una causa per forza d’inerzia. In ogni modo, in questo momento storico, poiché siamo incapaci di proporre alternative culturali se non legate al passato e quindi superate e inefficaci, sta vincendo il Sistema.
MS: Si Arlo, mi riferivo alle consorterie dei circuiti culturali cosidetti alti, colti o anche quelle che si dedicano anima e corpo al pensiero sempre e comunque alternativo: l’indie-rock. Le altre, le istituzionalizzate le do ovviamente per scontate.
VN: Sì, le consorterie ci sono sempre state, originate da interessi economici o paraocchi mentali o meschinerie assortite. Però c’è sempre stato anche chi si è dato da fare per promuovere le proposte artistiche nelle quali credeva. Quello che oggi è cambiato è che le cose si sono fatte più difficili (e ancora meno remunerative) per chi cerca di promuovere proposte “altre”, giacché il pubblico potenzialmente interessato ad esse si è molto ristretto rispetto al passato.
È una conseguenza delle mutate modalità di fruizione. La possibilità di ascoltare gratuitamente in rete tutta la musica del mondo non ha allargato gli orizzonti degli ascoltatori, bensì, paradossalmente, li ha ristretti.
L’asserita neutralità del Web («ci puoi trovare tutto il meglio e tutto il peggio, sta a te scegliere») è illusoria. Di fatto, la fruizione in Rete è più congeniale alle proposte banalizzate e massimamente semplificate. Per dire: in politica, la comunicazione social è più consona a chi procede a colpi di slogan (facili, immediati e mendaci) che non a chi vorrebbe affrontare le complessità del reale con disanime ponderate e approfondite (ma che non arriverebbero a nessuno, non essendo comprimibili nei 280 caratteri di Twitter o nei pochi secondi di Tik Tok).
E similmente, per la musica, la Rete è più congeniale a melodie e ritmi facili, che possano piacere al primo ascolto (e, mi raccomando, entro i primi venti secondi di ascolto, altrimenti l’ascoltatore medio skipperà passando a qualcos’altro), che non a brani che richiederebbero, almeno inizialmente, un po’ di tempo e di attenzione.
Tutto questo massifica e mediocrizza il gusto degli ascoltatori, premiando le proposte più standardizzate (si può dire ‘pre-digerite’?).
Alla luce di quanto sopra, promuovere musiche “altre” oggi è probabilmente diventato, come dice Moresco, «combattere una battaglia che si è sicuri di perdere». Il fatto che alcuni si ostinino ugualmente a farlo a me sembra prezioso e bellissimo: a loro tutta la mia stima e la mia gratitudine.
MS: Non badate al mio iterato assaggio ad alto potenziale glicemico, piuttosto date retta a ciò che ora percepisco: è come un’onda di commozione che invade questa terza tazza di cioccolato caldo appoggiata sul tavolino. Io sento di appartenere agli ostinati descritti dal Nistri: loser, esseri orgogliosamente perdenti che insistono comunque nel perseverare diffondendo contenuti per nulla recepibili dai più. Per questo mi viene spontaneo chiedervi quale visibilità – e non mi riferisco a classifiche o similia – potrà mai ottenere chi si occupa di suono non convenzionale in totale indipendenza, in un paese per giunta vittima dei luoghi comuni scambiati per illuminati asceti abbarbicati sull’Appennino o antichi rockettari un tempo anche bravi artigiani imprigionati ora nel malefico artifizio del “come eravamo”.
AB: Com’è sempre stato: avranno una scarsissima visibilità sui grandi media, a patto che non siano considerati un grazioso oggetto esotico da fagocitare e poi esibire in qualche estroso circo mediatico. D’altra parte, o stai alle regole del Sistema o ne stai fuori. In fin dei conti, se il suono non è convenzionale, non potrà mai avere una grande diffusione. Sta nelle regole del gioco.
VN: Sottoscrivo, aggiungendo però che non è mica obbligatorio che un musicista indipendente debba essere “imprigionato nell’artifizio del come eravamo”.
È cosa buona e giusta coltivare un certo tipo di attitudine che ha le sue radici in stagioni passate, ma secondo me bisognerebbe poi cercare di usare quell’attitudine per approcciarsi al tempo e alla realtà in cui viviamo qui e adesso.
Nel momento in cui smette di confrontarsi con il mondo che lo circonda, lo spirito “contro” smette di essere tale.
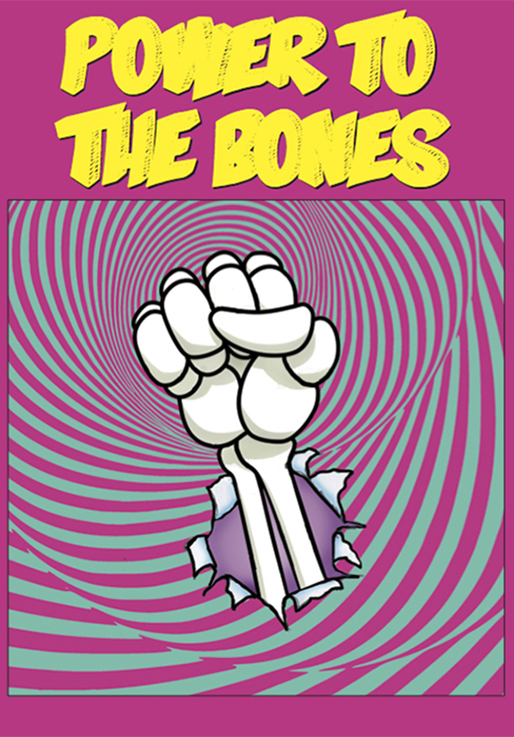
Aggiungo un’ultima cosa, sull’argomento “visibilità”. Premesso che un po’ di visibilità farebbe piacere a qualunque musicista, anche al più scalcinato degli underground, è comunque evidente che non questa è la molla che spinge qualcuno a fare scelte artistiche “fuori dal sistema”. La molla è un’altra, e puramente interiore.
Cito le parole di un marginale e dimenticatissimo artista degli anni ’60, Marzette Watts (sassofonista free jazz, sound engineer, pittore, attivista politico), che ho scoperto in un articolo retrospettivo sulla gloriosa etichetta ESP-Disk: «se sei un artista, ti è stato donato un talento, non puoi pretendere anche i soldi. Non è per il denaro che si fa arte, ma perché spinti da una pulsione irresistibile».
Naturalmente non tutti la pensano allo stesso modo. Billy Corgan nel 1995 dichiarò: «Se l’attenzione e il successo a poco a poco abbandonassero gli Smashing Pumpkins, non so che farei della mia vita, probabilmente mi ucciderei. Non ci sarebbe alternativa. Suppongo sia questa la vera pregnanza del rock’n’roll».
Ambedue le posizioni sono legittime, ma personalmente quella di Corgan mi fa zero simpatia, mentre sento a me più vicina (e persino più rock’n’roll, benchè facesse free jazz) quella di Watts.
Penso alle ultime parole di Nistri mentre immergo il cucchiaino nell’ultimo rimasuglio di bianca neve rimasta a coprire il caldo e dolce lago che profuma di cacao, penso alla sua citazione riguardante un gruppo che so entrambi non abbiamo mai valutato né amato, forse per il suo appartenere ad un mondo, per noi ancora barricaderi nonostante tutto: alieno, di classifica, in fin dei conti assolutamente
Perché siete tornati?

di Mario Temporale
Perché siete tornati? La domanda era appesa alla parete del bar, dietro al bancone, tra le bottiglie di aperitivi e amari.
Da un lato c’erano montenegro, jagermaster, vecchiaromagna, ramazzotti, stock, unicum, petrus. Dall’altro gancia, martina, cinzano, riccadonna, molinari, cynar.
In mezzo c’era la domanda: Perché siete tornati?
Ogni volta che la madre o il padre allungavano il braccio per prendere un aperitivo o un amaro – jagermaster era popolare soprattutto la domenica pomeriggio, fernet cynar piaceva alle donne e al capocorista del coro della chiesa che lo beveva con la menta e l’acqua minerale – quella domanda saltava fuori e non era possibile evitarla. Era più popolare dello jagermaster e del cynar messi assieme. Al bambino piacevano le bottiglie degli aperitivi e degli amari, gli piacevano le etichette, perché erano colorate, ma anche certe forme delle bottiglie, che erano strane ma proprio strane, come quella del vecchiaromagna che al bambino sembrava don Agostinis, il parroco del paese che era tondo e basso con la gabbana scura e la testa fina coperta dalla coppola nera come il tappo del liquore.
C’era anche la grappa, ma la grappa non era né aperitivo né amaro perché aveva il colore dell’acqua, era trasparente, non era niente, però la bevevano spesso i clienti del bar, e tanti la mettevano nel caffè, il caffè corretto grappa, che era il modo migliore per cominciare la giornata, diceva Jus, che era uno dei personaggi fissi dell’osteria.
Anche Jus, un giorno, aveva fatto quella domanda, dopo aver ordinato della grappa. Era strano che avesse fatto quella domanda, perché la grappa era in un posto diverso, era staccata dagli aperitivi e dagli amari, la grappa era trasparente, non aveva colore, non era niente. Era sul lato esterno, al margine di tutti loro, gli aperitivi, gli amari, i liquori tutti, e quindi distante dalla domanda. Però Jus la fece lo stesso. La fece una volta e poi basta, anzi due, ma la seconda era probabilmente tardi, dopo varie grappe e del vino, grappa e vino, vino e grappa, la testa di Jus non era più così lucida, e la voce uscì biascicante. Quindi se aveva fatto quella domanda più di una volta non importa, conta solo quella volta che la fece appena entrato, dopo aver notato che il quotidiano locale era occupato, lo stava leggendo un forestiero che beveva un caffè, un caffè semplice, non un caffè corretto con la grappa. Jus si era avvicinato al banco e aveva notato la domanda.
Non è che la domanda fosse proprio appesa al muro come una fotografia in una cornice o un orologio da parete, no, non era appesa così, era appesa in aria, sopra le bottiglie, e anche se non si vedeva lei c’era, e chi sapeva che c’era la vedeva. La vedevano tutti. Forse quel giorno Jus aveva dei pensieri e uno di quei pensieri era proprio quella domanda, quindi la vide al centro della parete, in mezzo e sopra agli aperitivi e agli amari e non poteva non farla, così la fece.
“Perché siete tornati?”
Quel giorno, a quell’ora, dietro al banco c’era la madre. Il bambino era rientrato da poco dall’asilo, il pulmino lo lasciava sulla porta e lui entrava correndo. Il bambino correva sempre. Perché certi bambini corrono sempre? Il bambino raggiunse la madre dietro al bancone. Chiese se poteva avere un gelato. No, non poteva, perché altrimenti non avrebbe avuto appetito per la cena. La cena era più importante del gelato. Era una cosa che non capiva, e lo faceva arrabbiare, ma non pianse. Si sedette su di uno sgabello, forse se aspettava un po’ la mamma avrebbe cambiato idea.
La madre tornò da Jus, non c‘erano altri clienti a parte lui e il forestiero che leggeva il giornale. “Eh, perché siete tornati?”, chiese Jus. La mamma gli versò la grappa e non rispose, non rispose subito, rimase in silenzio, un silenzio che si notava perché era più lungo del silenzio che di solito c’è tra la domanda di una persona e la risposta di un’altra.
E poi disse qualcosa, quando sembrava ormai tardi per rispondere: “E tu, perché sei tornato?”.
Questa fu la risposta della madre, che poi era una domanda, notò il bambino. Jus portò alla bocca il bicchiere di grappa, ma non replicò. Si voltò verso i tavoli e vide che il forestiero era uscito e il giornale era libero. Prese il bicchiere di grappa e si diresse verso il tavolo.
Due domande, nessuna risposta.
Jus non era un paesano qualsiasi, perché lui la domanda, quella stessa domanda che aveva fatto alla madre del bambino, se la portava dietro, ce l’aveva appesa alla nuca, che tutti la vedevano e si ricordavano di fargliela almeno una volta all’anno. Forse pensava che essendo rientrati da poco dall’emigrazione i gestori del bar fossero più indicati di lui per dare una risposta, e magari la loro risposta avrebbe aiutato lui a trovarne una. Lui, per sé, una risposta non l’aveva e quando gli facevano quella domanda metteva un sorriso stirato in viso, come uno che aspetta in fila di fronte a uno sportello e si stacca improvvisamente dalla coda perché ha deciso che non ha senso, che nulla ha più senso.
Jus una risposta a quella domanda non l’aveva.
Jus era più vecchio dei genitori del bambino. Era quasi un nonno ai suoi occhi, aveva forse quasi quarant’anni. Jus non aveva un mestiere. C’era il calcio, o meglio c’era stato. Quando il calcio finiva, c’era l’osteria. In mezzo, c’era il lavoro da bidello che un sindaco suo coetaneo e mezzo cugino gli aveva procurato quando la carriera di calciatore si era conclusa, troppo presto e senza una ragione valida.
Perché sei tornato? Il bambino non capiva perché facessero quella domanda a Jus che non era emigrato all’estero, mentre si era abituato alla domanda fatta a suo padre e sua madre, e si era anche abituato alle risposte secche o alle mancate risposte. Era come un teatrino, dove qualcuno recitava una parte e qualcuno la parte la rifiutava e mandava tutto all’aria, lasciando la scena, e gli spettatori, chi a bocca aperta e chi con i pugni in aria, a mormorare proteste verso chissà chi o chissà cosa.
Quando il bambino vide Jus fare quella domanda alla madre capì che lui non era come gli altri. Il bambino aveva appreso che se uno ordina una grappa mentre fuori fa ancora luce, e non è nel caffè, nel caffè corretto grappa, al mattino presto, è diverso dagli altri. Le sue domande sono innocue come i morsi di una minuscola lucertola. Ma dentro di lui fanno male, perché quei morsi sono profondi e i segni non si cicatrizzano.
Foto di THAM YUAN YUAN da Pixabay
Corporum primorum fragmenta – Rewriting dal Canzoniere di Stranamore
di Daniele Ventre (-2013 -con un contributo di F. P.)
...corpora prima, quod ex illis sunt omnia primis...
LUCREZIO
1.
Voi che sentite nel boato il suono
degli isotopi fissili nel ‘core’*
della centrale fuso per errore
umano che le barre non ci sono,
dal calcolo invariante in cui ragiono
di sindrome cinese con dolore
seguendo un’alchimia di Stranamore
non trovo soluzione e non perdono.
Rilevo radiazioni un po’ su tutto
e mutazioni appaiono sovente
e da scienziato un po’ me ne vergogno.
Ma di questa vergogna senza frutto
faccio pompa ai convegni vanamente
che il cielo è ancora azzurro solo in sogno
– – –
I call it the Madman Theory, Bob. I want the North Vietnamese to believe I've reached the point where I might do anything to stop the war.
RICHARD NIXON
2.
Ritorcere la massima vendetta
come risposta alle minori offese
inquadrando la strage con riprese
di combat film che il pubblico si aspetta:
la teoria del pazzo ha una ristretta
gamma di strategie per le difese:
sferra il tuo colpo e attendi le discese
del fall out che ogni atomica saetta,
perché il nemico dopo il primo assalto
non abbia o forze o chance o tempo o spazio,
vaporizzati i suoi compagni d’arme.
Che il numero di vittime sia alto
e lo Stato canaglia avrà il suo strazio
di sepolture e alle divise, ahi, tarme!
– – –
Ora sono diventato Morte, distruttore di Mondi.
BHAGAVADGITA
4.
La trinità che per i quanti e l’arte
relativistica ebbe magistero
e di bombe adornò questo emisfero
e sonde ne mandò su Giove e Marte,
giocando poco bene le sue carte
ha travisato un po’ dovunque il vero
e ha combattuto la guerra di Piero
e quella di Edith Stein nella sua parte
duplice in questo dramma senza grazia,
e quella di Giudea con il suo Stato,
poiché certo la pace non le piacque.
Quindi ad Alamogordo un sole ha dato
che la natura e il luogo non ringrazia,
tanta deformità nel mondo nacque.
12.
Non ci avessero poi dato il tormento
coi dispacci di guerra e i loro affanni,
non erano poi male gli ultimi anni
prima del botto e dell’inverno spento.
Dopo che il cielo è brillato d’argento
e d’oro fuso, evaporati i panni
dal corpo e il corpo insieme ai primi danni,
quando è calato questo freddo lento,
di noi infine ha goduto Stranamore
col suo ordigno al non-senso dei martiri
senza testimonianza d’ultime ore
e agiografie che si pregò (“Deh, Siri,
basta massacri!), e detonò dolore
e gli affari si fecero sospiri.
15.
Se si potesse ritirare un passo
dalla via che procede a questo porto
di Caronte, ne avremmo anche conforto,
ma troppo si è avanzati in questo lasso
di tempo dal pensiero troppo lasso,
lungo la strada del secolo corto,
fino a quest’epoca, al suo cielo smorto,
gridando in massa a vuoto “evviva”, “abbasso”.
E non ne sono rimasti che pianti
ghiacciati sulle palpebre e le membra
scarnificate da bombe lontane
e poi il fall out che qui smembra e rimembra
corpi deformi da un seme di amanti
sopravvissuti in forme non più umane.
20.
Chiedono come la parola taccia
in questo tempo vuoto senza rima,
perché certo non è l’età di prima
e non è tempo questo che mi piaccia.
Il peso ha superato le mie braccia
e l’anima da tempo ci si lima
di Stranamore che si sottostima
mentre d’intorno tutto il mondo agghiaccia.
L’inverno nucleare che ci apersi
già da tempo covava in mezzo al petto
gelato nell’inconscio e nel buio alto
di questa notte in cui riscrivo versi
altrui per dare sfogo a un intelletto
senza ragione vinto al primo assalto.
21.
Questa imbecille inciviltà guerriera
sta terminando infine con la pace
della sconfitta, come a tempo piace
per l’implosione d’ogni gente altera.
E se mai qualcun altro ancora spera,
si illude sciocco per ubbia fallace:
per parte mia non credo, mi dispiace,
che nulla tornerà mai più com’era.
L’illusione resiste forse in voi
che qualche dio ci presterà soccorso:
ma dio non corre dove l’uomo chiama.
La natura e la storia fuori corso
spacceranno moneta in mezzo a noi,
ma più ci si dorrà quanto più s’ama.
22.
Ogni specie che evolva in questa terra
deve ogni vita e nutrimento al sole,
o sia fra quelle che frequenta il giorno,
o sia fra quante al gelo delle stelle
escono a notte per fruscio di selva
fuori di tana dal tramonto all’alba.
Ma qui da quando detonò nell’alba
il canto nucleare in cielo o in terra,
contaminando zolla acqua aria selva,
resta sbarrato oltre le nubi il sole
e non ritorna un balenio di stelle
dal buio occluso né il brillio del giorno.
Eco di piombo ha travestito il giorno,
né si discerne dal tramonto l’alba:
la notte non accende le sue stelle
a guidare i viandanti sulla terra,
né dal mattino ci ritorna il sole
a intrecciare sull’erba ombre di selva.
Si aggirano per scheletri di selva
mutanti inscheletriti notte e giorno,
ora che il volto oscurato del sole
non arde l’erba senza ozono all’alba,
ora che quanto sopravvive in terra
non giace nudo ai raggi d’altre stelle.
Tempo verrà che sotto nude stelle
aperta piana e brulichio di selva
e tutto quel che vive ancora in terra
si cuoceranno nel feroce giorno
senza velo d’ozono, da che all’alba
ritornerà per sue vendette il sole.
E tutto sarà nuovo sotto il sole
e tutto sarà nuovo per le stelle
che veglieranno dal tramonto all’alba
sui resti inceneriti d’ogni selva
e lentamente giorno dopo giorno
muterà volto e rivivrà la terra.
Così la terra brucerà d’un sole
d’atomi, prima che fra giorno e stelle
ombra di nuova selva attenui l’alba.
23. Canzone metamorfica delle mutazioni
Amena villa dell’Estonia è Tade
in Kose vald, dove è mutata l’erba
irradiata, che poi fin troppo crebbe,
con nuovo frutto che non disacerba,
per vita che lasciò da liberta Ade,
e Stranamore a disdegno non ebbe.
Poi seguì che col tempo gliene increbbe,
di quell’erba drosera, quando avvenne
che divorò un lattante: e fu l’esempio
del multiforme scempio
dei genomi -e i gabbiani ebbero penne
rade sul ventre, ali spiumate, e a valle
pesci deformi nei fiumi e i sospiri
dei gemelli siamesi a breve vita,
grigi i burocrati a ridire: “Ah, ita”
e a consegnarli in ordine ai martiri
dei gulag: “Triste creatura: dalle
la morte dolce” poi girò le spalle
il colonnello medico, che in forza
del grado uccise e ne riusò la scorza.
Ricordo che dal giorno dell’assalto
di Stranamore anni erano passati
e anch’io mutai dal giovanile aspetto:
dopo le bombe gli inverni gelati
strinsero il mondo di glaciale smalto
e intorno era gelato ogni altro affetto.
Lacrime mi scendevano sul petto
rompendo il sonno, termine non c’era
per nostra mutua distruzione altrui.
Che sono ora? Che fui?
Il depresso si calma sempre a sera,
se distingue la sera: io ci ragiono
non la distinguo -mi lancia il suo strale
la mia Laura smarrita, alza la gonna,
mi approfitto di lei, l’unica donna
che qui intorno mi valse ancora e vale
prendere a forza e chiederle perdono:
altre sono mutate in quel che sono,
ora anch’io come alieno ho pelle verde:
dopo le bombe il carnato ci perde.
Mi chiedi come fu, quando mi accorsi
che mutai di colore la persona:
persi i capelli e spuntarono fronde
dalla mia fronte e ne ottenni corona
non voluta e balzai di scatto e corsi,
mentre ogni membro che a mente risponde
fu liquido di tremiti come onde,
e dentro mi sentii come se un fiume
di fuoco mi bruciasse e gambe e braccia!
E non meno mi agghiaccia
che mi spuntassero anche delle piume,
appena dopo che quel giorno giacque
il sole fosco e la notte montava.
Non lo sapevo più dove né quando
sarei tornato io: già lacrimando
per troppa luce e poco ozono, andava
il mio sguardo occhieggiando e intanto le acque
del lago luccicavano -e non tacque
voce spaurita nel buio maligno:
cantavo rauca parodia d’un cigno.
Così per luoghi solitari andai:
faccio finta di niente e canto sempre,
però non riconosco la mia voce:
radionuclidi dalle strane tempre
spandono intanto al mondo orrori e guai
mutando questo secolo feroce.
E nella nuova estate il sole cuoce
molto di più: non ha l’ozono innanzi
brucia allo zenit con luce nemica,
né serve che lo dica.
Di questo mondo restano gli avanzi,
sparsi nel vento per angizia fura,
mentre muschi e licheni mano a mano,
prendono vita ed io non ho parola:
che la verzura si muova da sola
troppo va oltre ogni buon senso umano
e questo muschio mette un po’ paura,
poiché si muove e assume la figura
d’un blob per consistenza alquanto lasso
che trasloca di zolla in fiume in sasso.
Rimasi un po’ turbato a quella vista,
e più quando corrose anche una pietra:
lo so che a raccontarlo non mi credi.
Torno a casa e il mio cuore un po’ si spietra
e mi riprendo dalla scena trista
il giorno dopo, coi primi albori “è dì
nuovo” mi dico e non mi guardo i piedi
nell’alzarmi e li ignoro e per me stesso
non penso “Li ho palmati!” Un tempo morto
è questo, un tempo corto
e sento strani fremiti qui presso
il muschio vivo cresce e delle scritte
parole occulta traccia e non ne parlo:
non se ne meraviglia chi le ascolta.
La meraviglia tutt’intorno ha avvolta
la terra smangiucchiata e non sai trarlo
più fuori il senso a queste epoche afflitte
senza più reti e holding inter-ditte:
forse ci resta ancora un po’ di inchiostro
per i posteri -eh, amici il guaio è vostro.
Laura mi posa intanto gli occhi suoi
addosso, eppure non mi crede degno
di meraviglia: io mi avvicino ardito.
Di me non sembra avere altro disdegno
a volte si querela appena, poi
non le dispiace che le alzi il vestito.
Il suo sorriso strano è già sparito,
s’apre ad ‘o’ mugolando intorno intorno:
la rubo io ladro e non le semino orma,
poi la lascio che dorma
tranquilla tutto il resto del suo giorno.
Una volta seguendo un tardo raggio
di sole, dopo averle dato freno
libero -cavallina!- uscii e mi parve
dopo che appena diradò e disparve
la nebbia -dalla gioia venni meno-
che fosse ancora lì la fonte e il faggio
dove una volta ci baciammo, in viaggio
di nozze -ah l’anteguerra, ah quella fonte,
quel faggio! Fiabe dalla nonna conte.
Quando rividi quel faggio gentile
ci portai la mia bella e la sua grazia
lo attrasse e lo animò. Chi mai ritiene
possa accadere? Mai natura è sazia
di novità. Quell’alberello -uhm, hyle!-,
anima vegetale nelle vene,
un amore d’ormoni anche sostiene.
Laura svanita alla fonte si specchia
senza pensiero lei, nulla-pavente,
ma poi se ne ripente
per lo scherzo che il faggio le apparecchia:
protende i rami la pianta commossa
la stringe a sé. Lei d’un tratto si vide
foglie addosso a frugarle il suo peccato
innocente: così mutò di stato,
doppia creatura nata a nuove sfide:
fuse col faggio innamorato le ossa.
La mia mente restò sgomenta e scossa:
presi asce e seghe e altre artigiane some,
e segai il verde amante senza nome.
Il suo corpo respira e si rimembra
nelle sue membra sciolte e pellegrine
che natura innestò con nuovo ardire
di mutazione e il processo ebbe fine
e lei riebbe coscienza in nuove membra
verdi di lauro-faggio e il suo sentire
e il suo intelletto -e questo era ed è sì ‘re
vera’ una meraviglia -ora s’oléa
di resine il suo corpo in forma cruda
soda di Laura ignuda:
danza con grazia più che in volo ardea:
io di nessuna altra vista mi appago
più che a sue nudità senza vergogna
verdi di fronde -da quando cielo arse
e Stranamore radiazioni sparse
sul mondo -e lo dirò senza menzogna-
vista più bella non tessé rima, ago
su carta o arazzo con ricamo vago
tanto che appena in parole trasformo
le gioie che da lei nacquero a stormo
Angeli partorì con piume d’oro
volati oltre il fall out, oltre la pioggia
di Stranamore, dopo che si spense
l’ultima bomba sulle ardenti cense
dove aratro nei solchi più non poggia.
In versi al vuoto mondo io qui la onoro
mio stranamore di mutato alloro,
che dai rami esfoliati non fa ombra
ma d’occhi e mente ha la sua chioma ingombra.
25.
Stranamore piangeva e anch’io talvolta
per i suoi funghi atomici lontani,
osservando i mutanti oscuri e strani
fra le rovine della città sciolta.
Ora che la natura s’è rivolta
ce ne restano piaghe sulle mani
e danze gaie di scheletri umani
che la ragione del silenzio ascolta.
Ombre difformi per contorta vita
vanno col capo rivolto alle spalle
e vedi come il loro passo poggi
indietro il tempo su ritroso calle
a fuggire il futuro e la salita
dura sul giogo di irradiati poggi.
26.
Lieta sorride al luccichio la terra
fosforescente ionizzata e vinta
di rosso fuoco e d’iride dipinta
e il bombardiere di ritorno atterra.
Dal suo carcere lieta si disserra
la forza forte per mesoni avvinta,
la materia si illumina discinta
di mille soli in sfavillio di guerra.
Poi Stranamore ne ritesse in rima
per un ordito d’amori non detti
quanto non s’era atomizzato prima:
era questione di assassini eletti
da popoli di schiavi senza stima
di prezzo e monopoli non perfetti.
30.
Ombra di donna su un tronco di lauro
vidi impietrita, il corpo come neve
sciolto alla bomba e per miliardi d’anni
radionuclidi: non traccia di chiome
d’alberi o donne, non più luce d’occhi,
pesci di fiume morti sulla riva.
Contaminato anche il mare alla riva
per luce d’un Apollo senza lauro:
vuoti d’un lampo radioattivo gli occhi,
gli scheletri di case come neve:
montagne calve di ghiacci e di chiome
desolate per lungo ordine d’anni.
Molti nel vuoto desolato d’anni
i mondi senza mare e senza riva
e senza vita e i tronchi senza chiome
per trionfi di guerre senza lauro,
corpi dissolti e ricaduti in neve
di fall out sopra teschi vuoti d’occhi.
Ora si mira per prodigio d’occhi
sul mondo inerte scivolare gli anni
come slavine per coltre di neve,
se l’eco rompe su rocciosa riva,
e poeti ed eroi nudi di lauro
marciano fra lebbrosi orbi di chiome.
Ora che a tutti cadono le chiome
per il terrore che ha scavato gli occhi,
non si raccoglie né mirto né lauro,
solo capelli incanutiti d’anni
o di secondi sull’opposta riva
dove ombre muoiono in fiocchi di neve.
Nella polvere lenta e nella neve
che brucia ai corpi i petali e le chiome
e argento impuro semina alla riva
e d’iride malsana offusca gli occhi
e di ghiaccio e di fuoco opprime gli anni,
Stranamore così cinge il suo lauro,
cinge il suo lauro nella grigia neve
che copre d’anni i teschi senza chiome
e vuoti d’occhi abbandonati a riva.
35.
Solo e pensoso per gaussiane e campi
misuro curve di neutroni lenti,
e sul rilevatore ho gli occhi intenti
se radiazioni anomale mi stampi.
Altro schermo non trovo che mi scampi
dai raggi beta sparsi fra le genti,
fra tutti i teschi allegri e gli occhi spenti
che ancora sembra un’esplosione avvampi:
purtroppo credo ormai che monti e spiagge
e fiumi e boschi abbiano uranie tempre
per la mia mutua distruzione altrui.
E per queste aspre vie fatte selvagge
va Stranamore tramutando sempre
la sua forma con me, la mia con lui.
Estratto da L’inganno
di Veronica Tomassini
Un estratto del romanzo “L’inganno” di Veronica Tomassini, in uscita per La nave di Teseo.

Jan riposava. Attraverso i nembi, il sole tornava a infilarsi tra le colonne, ribatteva dai ballatoi, sulla cima degli abbaini, sopra le finestrelle, sui tetti. Camminai lungo la via. La signora Erminia mi aspettava per il pranzo. Così mi decisi a tornare, nell’ora inconsueta. Presi l’autobus. La luce indebolita mi raccontava la desolazione che avrei raggiunto. Come ogni sera.
La destinazione popolare, meneghina e negletta. Mi ero abituata a un ingranaggio smorzato. La luce livida dopo la pioggerellina impastava colori scuri e accidiosi.
Avevo imparato a memoria ogni traccia di quel passaggio: la 69, il verduraio con le erbe amare già mondate. Il trillo del campanello, la signora Erminia che apre l’uscio serrato a doppia mandata. La cucina, il profumo oleoso e ruffiano del burro a rosolare, l’usciolo del tinello. La carta violacea e plumbea delle pareti. Il pendolo.
La tavola era apparecchiata. Il pane bianco tagliato a fette nella cesta, l’acqua corrente nella caraffa. Il vino di un supermercato ancora nel bricco di cartone.
Mangiammo in silenzio, la signora Erminia aggiungeva un mestolo di pietanza al mio piatto. Dolciastra, burro, verdure, non saprei distinguere. Mi piaceva osservare fuori le ombre in anticipo sulla fine del giorno. La nuvolaglia che avevo imparato a riconoscere, non più oscurità sfuggenti, strane sagome buie sul cielo senza rondini, ma sarebbero tornate le rondini, anche a Milano.
Quando sopravvenne l’ora tarda, erano le tre del pomeriggio. Per molti anni, le tre del pomeriggio era l’ora della tristezza non riferibile. L’ora che rifiutava il linguaggio, un assenso umano. L’ora definitiva. Ho capito molto dopo l’ora della tristezza, l’ora in cui il Cristo moriva.
Tutto questo agiva in me, ma io non avevo realizzato ancora che comunque sarebbe accaduto in futuro, che attraverso il nostro vestito di carne e sangue a pulsare, si riponevano verità eterne a dimorarvi. Quel che ci avrebbe disorientato, rimasto appresso al momento in cui avremmo inteso la tristezza, la disperazione, la preoccupazione, era il trabattello di un tramato inalterabile che ci avrebbe lambito con la ferocia purificatrice del fuoco, depositando brani di certezze perenni. Nella nostra inquietudine o concitazione o inutile rodìo c’era anzitempo deciso un destino, il castigo, la conversione. Consegnavamo tutti la riconferma, la replicazione ancor meglio, della vicenda biblica. Ne portavamo indosso una specie di marchio. Un crisma.
Ogni profeta ci aveva annunziato, lungo i millenni.
Conclusi il pranzo con una mela turgida e rosea. Zuccherina. L’acqua corrente aveva un retrogusto di erba umida, muschio. Stranezza che scioccamente confidai alla signora Erminia. Riuscivo a farla ridere delle mie ingenuità.
Andai a riposarmi. Riposai come riposava Jan, distesa, le mani incrociate sul petto. Chiusi gli occhi e pensai a Jan. Non al francese di Tolosa.
Mi addormentai e sognai un viaggio. Un treno antico, correvo per il corridoio di una vecchia locomotiva. Cercavo qualcuno. Il treno si arrestò di colpo. Mi affacciai dal finestrino e oltre non c’era niente. Un biancore traverso e un vuoto, un vuoto che sprofondava nel mistero. Dove?
In lontananza intercettavo un binario, l’odore del carbone, del brecciolino.
Mi svegliai nel buio della sera anonima. Tirai giù la tapparella. Sostituiva i battenti, ma prima notai, nel cavedio che porta alle cantine, proprio sotto la mia finestra, un colle di mondezza. Mondezza organizzata in sacchi, pronta per essere riconvertita in qualcos’altro di produttivo. Non un fatto che non servisse ad altro.
Mi sembrò avvilente che persino la mondezza avrebbe potuto ingannare il mio sguardo, nutrendo un campo di fiori selvatici, nel getto irrorato di un fertilizzante. Era forse un bel messaggio, l’ennesima metafora da apprendere e meditare, nei minuti sazi.
Io avevo bisogno soltanto di esistere. Non meditare, accidenti! Esistere. Il mio corpo, esiste? Cos’è il mio corpo?
Guardai il viso sciupato nello specchio sopra il lavabo del bagno.
Io esisto. Ma non so riconoscermi. Guardo i miei occhi nello specchio. Non è la stessa cosa, penso.
Quale viso io abbia deve dirmelo un altro.
Un uomo.
Lavai la faccia e indossai un rossetto fragola che trovai nel beauty case della signora Erminia.
Fissavo i miei occhi.
L’iride è gialla o marroncina o verde.
La lettera del francese concludeva così: “I tuoi occhi, Mademoiselle”. Senza aggiungere altro.
Veronica Tomassini, siciliana, di origini umbre. Esordisce con il romanzo “Sangue di cane”, Laurana editore, nel 2010. Fu un caso letterario. Nei suoi scritti tornano spesso ambientazioni suburbane, storie intestine e periferiche. Nel 2012, pubblica con Feltrinelli l’e-book “Il polacco Maciej”. Nel 2014, pubblica con Gaffi il romanzo “Christiane deve morire”. Partecipa con un suo testo all’antologia “La formazione della scrittrice”, edita da Laurana, curata da Chicca Gagliardo e Gabriele Dadati, per un’idea di Giulio Mozzi. Nel 2017, torna in libreria con il romanzo “L’altro addio”, per Marsilio editore. Nel 2019, pubblica il romanzo “Mazzarrona (Miraggi, edizioni) candidato al Premio Strega. Nel 2020, pubblica “Vodka Siberiana”.
Pietre da taglio
di Anna Franceschini

Il quartiere si dipana in cortili interni
portoni d’entrata numeri civici
i fili da stendere senza fiducia
corde antiche che non servono a nulla
Con le amiche ci si nascondeva
si andava un po’ fuori di casa
erano deserti di persone
Avevo un’amica senza colpa e senza casa
avevo una bicicletta la possedevo solo io
L’amica mi accompagnava a trovare
un posto nel labirinto di cortili
Non ci salivo più ogni luogo era inadatto sempre
nella posizione e nello spazio di non permesso
**
Uno strano godere dell’esistere
la casa partorì donne gravide
un pensiero come un tamburo neanche un figlio
Dolore nei passaggi bui che stringe il corpo
ecco la casa disporsi sui contorni il vuoto
c’è una stanza per un uomo disteso
riduce a immagini il sole gli alberi
ha la capacità la capienza gli occhi
Dove risiedono le non parole i non ricordi le non frasi
da qualche parte muovo le braccia a burattino
è un sacrificio e lo concedo ho osato
fare pienezza nella mancanza
quell’uomo che cerca casa dorme con me nella confusione
**
Morte senza racconto
Morire: stasi fino all’impostura
di un ferro di cavallo scovato
sfogliando sacchi rimestando carne
unghie macinate come ritorni alla terra
nutrimenti di vuoto albero collina
verde la storia dei solidi muti
la parte del nostro corpo più in vista
mineralizzata resto inutile lavorato
La tavola il legno che tiene il bicchiere
l’importanza del respiro corto sulle scale
dire sempre meno che non è nulla
morire per un’immagine che si è perduta
**
Hai uno spazio per riposare
lontano da tutto non vedi altri
da te accantona l’idea che esisti
hai abbastanza ferocia da spegnerti
hai abbastanza fame
Ti hanno assecondato
con materia umana riconosciuta
perdente esclusa pronta all’eliminazione
c’è del pane hai l’acqua appena
tutto questo andrà in circolo
il bisogno accrescerà il veleno
sarai compressa dal desiderio
il miasma si abbatterà su altri da te
Il tuffo
di Matteo Camerini

Tempo di lettura: minuti, ore
Come stai? chiesi, ma non mi rispose. O meglio, non so dire se mi rispose o meno perché non ascoltai la risposta, non ero pronto ad ascoltare. Ero pronto solo a proseguire. Forse mi rispose, certamente mi rispose, ma non so dire cosa, non era minimamente importante ai fini della prosecuzione. La prosecuzione di una conversazione non dipende minimamente dalle parole pronunciate o dal senso che viene attribuito ai suoni che con difficoltà questi strani animali logorroici vomitano a fatica. La prosecuzione del dialogo, così come della vita, dipende da una sola cosa: dall’interesse. Togliete l’interesse e non avrete più niente. Quale interesse? ma ditemelo un po’ voi quale interesse, trovatelo da voi, inventatevelo, copiatelo, fingetelo, ma non chiedetelo a me. Io ho il mio e certamente non lo condividerò con voi. Io sono un uomo che si interessa di molte cose. Pratico sport quotidianamente. Ho amplessi settimanali scanditi e calendarizzati dal ritmo del mio lavoro. Quando l’Istituto decreta la fine delle ore che mi sono necessariamente richieste per il corretto funzionamento dell’Istituto, allora io, come si suol dire nel mio campo, sono libero. In quel tempo indefinito e tragico, allora, cerco di impegnarmi nelle attività consone a quel tempo tragico e indefinito. Ogni settimana l’Istituto pubblica, a proprie spese, dei dépliant che suggeriscono quali attività siano consone ai miei interessi. Io, ovviamente, per non sprecare quel tempo già esile nella ricerca di altre possibilità nel vastissimo campo delle attività (attività, questa, che per essere portata a termine richiederebbe un tempo che supererebbe di gran lunga quello concessomi per lo svolgimento pratico di quell’attività), mi attengo sempre a ciò che il dépliant mi propone. Non sono mai rimasto deluso. Ho sempre riservato cinque stelle su cinque e ottime recensioni alle attività dell’Istituto. Nel corso degli anni, la personalizzazione del mio interesse è stata sempre più studiata e approfondita, sicché, oggi, mi trovo ad essere un tutt’uno tra ciò che sono e ciò che l’Istituto sa di me. Se non fosse, questo, un termine astruso che rischierebbe di compromettere ogni interesse che possiate provare nei miei confronti, direi che l’Istituto mi ha donato un’idiosincrasia. La scorsa settimana, ad esempio, ho avuto modo di dedicarmi ad un’intensa performance sessuale con una diciannovenne asiatica, coreana credo. Con l’ingresso nel mercato europeo delle neo-maggiorenni asiatiche, le attività dell’Istituto hanno goduto di una crescita esponenziale di recensioni positive. Risparmiando sul costo dell’importazione, infatti, sono stati aggiunti numerosi comfort ed extra che hanno reso le attività dell’Istituto ancora più sorprendenti. Mai avrei pensato che il mio interesse estetico potesse ricadere su questo tipo di ragazze, ma è sempre piacevole scoprire qualcosa in più su se stessi. Ho saputo, così, di essere un uomo-a-cui-piacciono-le-neo-maggiorenni-asiatiche-coreane-credo. Grazie a numerose proposte, prove ed errori, il processo induttivo di personalizzazione dei miei gusti sessuali ha raggiunto un grado di soddisfazione che sfiora la perfezione. Ma passiamo oltre. Cosa dicevo? che non mi rispose, già. O meglio, che mi rispose ma non so ben dire cosa mi rispose. Il come stai? è una manifestazione di interesse largamente sufficiente ai fini dell’inizio di un discorso. La normale consuetudine vuole che la pratica venga congedata in un range compreso tra una e due parole, massimo dieci caratteri. Certo, è possibile prolungarsi oltre quel limite, ma è un rischio che nessuno dovrebbe correre, a mio parere. A meno che voi non siate un Davide Gallese o un Tommaso Pincioni, ma non credo proprio che voi lo siate. Non cercate dunque di stupire alle prime battute, è da dilettanti. Limitatevi alla consuetudine e non sbaglierete. Ecco, mi avete fatto dilungare troppo e ora il mio tempo gratuito è finito. Volete la versione premium? No? Allora dovrete attendere sette righe di pubblicità.
MESSAGGIO CON FINALITA’ PROMOZIONALI:
Scarica FreeGo, la nuova app di acquisti alimentari connessa alla tua dispensa e alla tua dieta personalizzata. Grazie ad un innovativo software biometrico, i tuoi valori corporei saranno sempre monitorati e aggiornati, comunicando all’app i tuoi bisogni calorici. Dici addio a lunghe file e a diete impossibili! Torna a casa sapendo già cosa mangiare, senza perdere più tempo a fare la spesa! Scarica subito l’app sul tuo smartphone, non te ne pentirai!
Bene, vi siete goduti la vostra pubblicità? Certo che è una noia anche per me, che domande, perdo continuamente il filo del discorso, ma che volete? siete degli spilorci e i libri non si pubblicano mica da soli. Non avete idea di quanto le vostre amate versioni gratuite sarebbero nocive alla produzione, se solo la pubblicità non avesse sistemato le cose. Non ne avete idea. Ma, del resto, voi non avete idea di tante cose. Bene, proseguiamo. Senza perdere altro tempo vi dirò che quel discorso non mi interessò affatto. Vi starete chiedendo, dunque, perché mai ve ne abbia parlato. La ragione è molto semplice: perché posso. Posso parlare di ciò che voglio perché questo è il mio spazio. Trovare ulteriori giustificazioni, intrighi nella trama, ricercare tranelli nello stile linguistico ecc. sarebbe tempo sprecato. Non fatelo. Sarebbe inutile dirvi che sto scrivendo perché il mio psicologo mi ha consigliato di farlo, per portare fuori i miei drammi interiori, oppure che lo faccio perché preso da profonde convinzioni artistiche. Non vi interessa e non lo saprete mai. Posso farlo e lo faccio. Non avete la benché minima idea di quante spiegazioni insensate vengano date alle azioni umane, che invece potrebbero benissimo essere sostituite dalla semplice formula “perché poteva farlo”. L’uomo fa sempre tutto ciò che può, e se non lo fa oggi lo farà qualcun altro domani. Perché la scimmia si è evoluta? Perché poteva. Inutile lambiccarsi il cervello con teorie filosofiche. Ciò che può essere fatto verrà fatto, prima o poi. Ho perso nuovamente il filo. Quando finalmente la smetterete di farmi domande puerili forse potrò fare un discorso compiuto. Allora, ricominciamo. E adesso statemi a sentire. Come stai? gli chiesi e diciamo pure che mi rispose bene e che la conversazione finì lì per mancanza di interesse da parte mia. Fatto sta che non ci incontravamo da vent’anni e che vederci lì, inaspettatamente, dopo tutto quel tempo, su quella spiaggetta di rocce rugose e appuntite, fu un minimo interessante, almeno all’inizio. Non so perché il dépliant estivo, riservatomi per due lunghissime settimane di vacanze, il tempo più lungo di libertà indefinita e tragica dell’anno, mi avesse consigliato proprio quella spiaggia rocciosa. Forse avevo dimenticato di inserire, nella sezione malattie, le brutte vesciche che mi erano cresciute sotto la pianta dei piedi. Certamente, però, non si poteva trattare di un errore dell’Istituto, questo non lo pensai mai. Ma, per un attimo, sotto il sole cocente che riscaldava contemporaneamente il mio cranio e le pietre appuntite, colpendomi da entrambi i lati della mia lunghezza verticale, pensai che questa volta, forse, avrei dato quattro stelle e mezzo, e non cinque, a quel soggiorno. Ma, non volendo affrettare la decisione, mi riservai la possibilità di cambiare idea. Del resto, due settimane sono un periodo molto lungo, avrei potuto benissimo scoprire un camping di ragazze coreane proprio a qualche metro dal mio bungalow. Quello sì che avrebbe fatto riguadagnare la mezza stella mancante alla mia recensione. Fu mentre pensavo a queste cose che incontrai quella persona che dicevo, che non incontravo da vent’anni, a cui chiesi come stai? e che non ricordo cosa mi rispose. Con quella persona avevo condiviso gli anni dell’istruzione superiore. Anni tristi, per carità. A nessun maschio adulto possono apparire piacevoli i ricordi della pubertà, così costellati di dubbi e fallimenti. Un maschio adulto rinnega tutto, a meno che non voglia rimanere un adolescente, un fallito, o, ancor peggio, un artista. Un maschio adulto sa di star salendo una scala a pioli verso il successo ed è cosciente che tutti gli altri maschi adulti stiano facendo lo stesso. Un maschio adulto sa benissimo che se iniziasse a guardare in basso inizierebbe a provare quei sentimenti da femminuccia come le vertigini. Inizierebbe ad avere dei ripensamenti e a rimpiangere i primi scalini, quando la terra sotto i piedi sembrava ancora così vicina. Insomma, un maschio adulto come me non vuole perder tempo e rischiare di essere sorpassato mentre lui sta lì fermo imbambolato a raccontarsi chissà quali storie che si riveleranno, in ogni caso, assolutamente inutili ai fini della salita. Della mia istruzione superiore, di conseguenza, ricordavo unicamente qualche volto, qualche insegnante e qualche bel culo di ragazzina che si rivelava ancora utile nei momenti importanti, quando la pornografia online era per qualsivoglia ragione irraggiungibile. Il resto l’avevo rimosso, rinnegato, accantonato, scegliete pure voi il termine che preferite. Quella persona che incontrai era, come avrete certamente intuito da quest’ultima mia spiegazione, uno dei pochi volti che vagamente ricordassi. Lui, al contrario, sembrò ricordarsi ogni cosa. Quando mi riconobbe iniziò tutto un rituale di moine e gesti esagerati. Mi stringeva la spalla, mi studiava il volto facendo commenti sul mio aspetto a suo dire cambiato eccetera. Smisi subito di ascoltarlo, guardandomi intorno in cerca di scuse per allontanarmi il prima possibile da quelle smancerie che mi stavano mettendo in imbarazzo. Ci sarà un motivo se non ci siamo visti per vent’anni, morivo dalla voglia di dirgli. Eppure, quello continuava a blaterare qualcosa circa sua moglie e i suoi figli, trasgredendo palesemente ogni regola sull’interesse di cui sopra. Aver voglia di raccontarsi così tanto a uno sconosciuto è vomitevole. Senz’altro i manuali di psicologia traboccavano di definizioni per le plurime malattie mentali di quell’uomo. Bisognerebbe aver sempre in tasca un Freud, pensavo, per non perder tempo a cercare sempre di capire dove uno voglia andare a parare. Che diavolo di valore poteva avere per me quel suo raccontarsi? Ve lo dico io, nessuno. E il valore è un qualcosa che si crea dall’interesse reciproco. Ecco che ci risiamo. Non è un caso che si torni sempre lì. Avrei potuto scrivere un libro intero sulle cose che si generano dall’interesse. Provate a pensare per un secondo soltanto a come sarebbe la vostra vita se ogni singola azione che doveste compiere fosse totalmente, interamente, da cima a fondo, una noia mortale. Provate a immaginare di vivere ogni momento con la partecipazione e l’entusiasmo con il quale, che so, vi lavate i denti. Certo, se non vi lavaste i denti avreste un sorriso osceno e un alito fetido, ma se non vi interessasse il vostro alito e il vostro sorriso ve li lavereste comunque, quei maledetti spuntoni calcarei che avete nella bocca? Credo proprio di no. Se i soldi non vi interessassero, o se mangiare e scopare e dormire e giocare non vi interessasse, fareste comunque quello che fate? Lavorereste più di sei, otto, dieci ore al giorno? Che dico, vi alzereste dal letto? Se nulla, nessuna cosa, nessuna persona fosse per voi interessante, che fareste? Ve lo dico io, nulla. Non fareste nulla. Vi convincete, vi forzate, vi fate obbligare a convincervi che ci sia qualcosa di assolutamente interessante nel mondo, e il gioco è fatto. Ma molto spesso l’unica cosa veramente interessante è che quel qualcosa interessi agli altri. Solo che, arrivati a un certo punto, si perde completamente il confine tra la causa e l’effetto. Diventate voi stessi i promotori dell’interesse per i vostri figli, i vostri colleghi, i vostri amici, senza accorgervene. Dopo essere stati spinti, un giorno, vedendo qualcuno guardare con gli occhi spalancati una cosa (immaginiamocelo con gli occhi che brillano e la cosa che risplende di uno scintillio aureo), avete iniziato a cadere, a cadere, a ruzzolare senza più potervi fermare. E a quel punto avete spinto altre persone che erano lì, in discesa, davanti a voi, ma che ancora avrebbero potuto salvarsi da quella valanga. E così si crea e si ricrea e si propaga l’interesse. E le persone continuano a lavorare e a fare quello che fanno come se ci fosse un valore. Ma non l’avete scelto voi, cari miei. Voi avete solo iniziato a cadere, convinti che ciò che vi avesse spinto fosse una forza neutrale, naturale, insomma, una forza di gravità, per capirci. E invece erano solo altri uomini. Altri uomini cadenti. Ora, però, esigerò da me stesso di portarvi a una conclusione, per evitare di giungere alla prossima pubblicità senza aver colto il pun…
MESSAGGIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI
Ti è mai capitato di vivere un attimo di pura gioia senza che nessuno fosse lì a guardare e senza avere il tempo di scattare una foto? Da oggi non sarà più così! Con Memory, la nano-videocamera che puoi portare sempre con te, ogni istante verrà salvato e potrai accedervi quando vorrai. Infila Memory sui tuoi vestiti, sui tuoi capelli o usala come collana. Crea un archivio indelebile della tua vita, salva ogni bacio, ogni esperienza, ogni paesaggio. Dici addio all’oblio! Compra Memory!
Maledizione! Dovreste proprio farvi una versione Premium di questo affare sul quale state leggendo. Non solo potreste proseguire senza interruzioni ma, soprattutto, io non dovrei continuamente interrompermi. In ogni caso, al corso di mindfulness dell’Istituto ho imparato a gestire lo stress in maniera produttiva, quindi farò attenzione al respiro e cercherò di proseguire in quello che stavo dicendo. Se solo mi aveste incontrato qualche anno fa, dio solo sa se vi avrei convinti a pagare quell’abbonamento mensile. Insomma, il punto della questione è che per continuare a fare ciò che si deve fare, perché qualcosa bisognerà pur farla, si deve imparare a centellinare l’interesse. Donarsi solo quando è strettamente indispensabile. Imparare a dire di no, a tapparsi le orecchie, se necessario. Perciò non giudicatemi frettolosamente se, davanti a quella persona che si raccontava, io avrei preferito tuffarmi subito in acqua o fuggire via correndo sulle pietre incandescenti. Avrei preferito morire, piuttosto che farmi convincere da un uomo cadente che dovessi cadere anch’io, riconoscendo alla sua famiglia, ai suoi figli, alla sua nuova macchina, al suo lavoro e ai suoi viaggi un valore che per me non esisteva minimamente. Non sarei caduto, mi ripetevo, non mi sarei interessato. Eppure, proprio mentre stavo per congedarmi definitivamente, quello disse una frase che mi fece tornare a guardarlo. A guardarlo fisso negli occhi, come se scintillasse e come se quelle parole fossero infinitamente importanti. Quella frase che disse mi colpì più delle pietre roventi sotto le vesciche dei piedi. Speravo di incontrarti al funerale di Azzurra, mi disse, c’eravamo tutti, mi disse. Quale funerale, gli chiesi. Il funerale di Azzurra, ripeté quello, senza cambiare la frase precedente, semplicemente scandendola più lentamente. Non lo sapevi? mi chiese turbato. No, non lo sapevo, mi dissi turbato. Nessuno mi ha avvisato, aggiunsi turbato. Ma è impossibile, è impossibile, farfugliò quello, in preda a un’agitazione anormale. Poi prese il telefono e iniziò a frugare, a scorrere con il dito come un invasato, controllando mail, social network, tag, messaggi, messaggi privati, sms e registri chiamate. Passarono dieci minuti buoni prima che, esausto, si arrendesse, guardandomi con le lacrime agli occhi. Nessuno ti ha avvisato, mi disse. Te l’ho appena detto, risposi, nessuno mi ha avvisato. Ma io, ma noi, ma tu…non sei nei gruppi, non ci sentiamo da anni, continuò con la voce tremante. Dio santo, pensai, se non vado via ora si metterà a piangere proprio qui, davanti a me, con il sole che mi brucia contemporaneamente il cranio e le suole dei piedi. Io devo proprio andare, gli dissi. Non preoccuparti, aggiunsi, in ogni caso meglio che sia andata così, i funerali mi deprimono. Rifiutai con eleganza i tredici inviti che mi fece a pranzare con lui e la sua famiglia. Finsi di dover raggiungere qualcuno proprio oltre il punto in cui la spiaggia di pietre roventi curvava, coprendo il resto del litorale. Manovra, questa, che mise a dura prova i miei piedi, ma raggiunsi ugualmente il mio obiettivo: scomparire. Dopodiché, nascosto nell’insenatura, non lo vidi mai più. Azzurra era morta. Quando prima ho detto di ricordare solo alcuni volti mentivo. Nessun maschio adulto riesce mai veramente a rimuovere ciò che deve rimuovere. Del resto, il rimosso non si può certo gestire a piacimento, anche se è quello che bisogna dimostrare. Azzurra era morta. La frase mi rimbombava in testa, sempre con maggiore frequenza. Azzurra era morta. Azzurra era morta. Completai a fatica tutte le manovre necessarie alla mia distesa finale e definitiva al sole. Azzurra era morta. Stesi l’asciugamano. Azzurra era morta. Mi tolsi le ciabatte e la maglia. Azzurra era morta. Mi sedetti. Azzurra era morta. Mi stesi. Azzurra era morta. Conficcai gli occhiali da sole dietro le orecchie e una sigaretta tra le labbra. Azzurra era morta. Presi l’accendino. Azzurra era morta. Accesi la sigaretta. Prima boccata. Niente. Azzurra era morta. Seconda boccata. Niente. Azzurra era morta. Terza boccata. La nicotina penetrò nel sangue. Soddisfazione. Azzurra era morta. Quarta boccata. Meglio. Nessuna coreana sulla spiaggia. Azzurra era morta. Nessuno intorno a me sulla spiaggia. Quinta boccata. Un piccolo brivido di piacere. Azzurra era morta. Prime gocce di sudore. Sole spietato sulle tempie. Sesta boccata. Breve sensazione di stordimento. Azzurra. Una ragazza balenò nel mio campo visivo, da destra. Settima boccata. Si avvicinò a uno scoglio a forma di cavolo, tutto rugoso e inospitale alle forme umane. La ragazza lo affrontò. Ottava boccata. Nervosa. Azzurra. La ragazza salì, con maestria, una mano, un piede, l’altra mano, l’altro piede. Non si graffia? Nona e ultima boccata. Azzurra. Azzurra. Azzurra. La ragazza si ergeva in cima allo scoglio. Aveva un sedere tondo, ma non ci pensai. Aveva delle gambe lunghe e slanciate, la pelle liscia, non mi interessò. Si tufferà? Non si graffia? Non si graffia? Si fa male? Azzurra. Azzurra era morta. Spensi la sigaretta sullo scoglio. La lascio qui? Sì. La ragazza si avvicinò al bilico, al punto di non ritorno. Quattro, cinque, otto metri? Mi misi a sedere. Strinse con forza i piedi sulla roccia. Tese le braccia in alto. Azzurraeramortaazzurra. Tolsi gli occhiali da sole. Azzurra. Trattenni il fiato. Azzurra. Quattro stelle e mezzo. Quattro stelle. Tre stelle e mezzo. Tre stelle. Due stelle e mezzo. Due stelle. Azzurra era morta. La ragazza piegò le ginocchia. Una stella e mezzo. Una stella. Si staccò dallo scoglio. Mezza stella. Azzurra.
MESSAGGIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI
Non vuoi che il racconto finisca? Abbonati a Reader! Per te, ogni mese, più di mille nuovi racconti, nel nostro ricchissimo catalogo selezionato dai migliori esperti europei dell’editoria. Da gennaio disponibile anche in versione cartacea, con i nostri Reader riders pronti a consegnarti, direttamente a casa tua, i tuoi romanzi preferiti. Cosa aspetti? Abbonati subito a Reader premium!
cinéDIMANCHE #18 MONTEVERDI & TASSO Il combattimento di Tancredi e Clorinda [1624]
[ testimoni di bruttezza – volgarità – orrenda favella – un’immersione in bellezza di suono e parola suono – con Tasso – Monteverdi e Savall – anche se la bellezza non salverà il mondo ]
di Claudio Monteverdi
dalla “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso
Canto XII, 52 – 62, 64 – 68
Il Combattimento di Tancredi e Clorinda [1624]
Testo tratto da GERUSALEMME LIBERATA di Torquato Tasso
Canto XII, 52-62, 64-68
Tancredi che Clorinda un uomo stima
vuol ne l’armi provarla al paragone.
Va girando colei l’alpestre cima
ver altra porta, ove d’entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avvien che d’armi suone
ch’ella si volge e grida: – O tu, che porte,
correndo sì? – Rispose: – E guerra e morte.
– Guerra e morte avrai: – disse – io non rifiuto
darlati, se la cerchi e fermo attende. –
Ne vuol Tancredi, ch’ebbe a piè veduto
il suo nemico, usar cavallo, e scende.
E impugna l’un e l’altro il ferro acuto,
ed aguzza l’orgoglio e l’ira accende;
e vansi incontro a passi tardi e lenti
quai due tori gelosi e d’ira ardenti.
Notte, che nel profondo oscuro seno
chiudesti e nell’oblio fatto sì grande,
degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno
teatro, opre sarian sì memorande.
Piacciati ch’indi il tragga e’n bel sereno
a le future età lo spieghi e mande.
Viva la fama lor, e tra lor gloria
splenda dal fosco tuo l’alta memoria.
Non schivar, non parar, non pur ritrarsi
voglion costor, ne qui destrezza ha parte.
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:
toglie l’ombra e’l furor l’uso de l’arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
a mezzo il ferro; e’l piè d’orma non parte:
sempre il piè fermo e la man sempre in moto,
né scende taglio in van, ne punta a voto.
L’onta irrita lo sdegno a la vendetta,
e la vendetta poi l’onta rinova:
onde sempre al ferir, sempre a la fretta
stimol novo s’aggiunge e piaga nova.
D’or in or più si mesce e più ristretta
si fa la pugna, e spada oprar non giova:
dansi con pomi, e infelloniti e crudi
cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.
Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, e altrettante
poi da quei nodi tenaci ella si scinge,
nodi di fier nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’un e l’altro il tinge
di molto sangue: e stanco e anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.
L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue
su’l pomo de la spada appoggia il peso.
Già de l’ultima stella il raggio langue
sul primo albor ch’è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue
del suo nemico e se non tanto offeso,
ne gode e in superbisce. Oh nostra folle
mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!
Misero, di che godi? Oh quanto mesti
siano i trionfi e infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (s’in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Così tacendo e rimirando, questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse,
perchè il suo nome l’un l’altro scoprisse:
– Nostra sventura è ben che qui s’impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte rea vien che ci nieghi
e lode e testimon degni de l’opra,
pregoti (se fra l’armi han loco i preghi)
che’l tuo nome e’l tuo stato a me tu scopra,
acciò ch’io sappia, o vinto o vincitore,
chi la mia morte o vittoria onore. –
Rispose la feroce: – Indarno chiedi
quel c’ho per uso di non far palese.
Ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi
un di quei due che la gran torre accese. –
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi
e: – In mal punto il dicesti; (indi riprese)
e’l tuo dir e’l tacer di par m’alletta,
barbaro discortese, a la vendetta.
Torna l’ira ne’ cori e li trasporta,
benchè deboli, in guerra a fiera pugna!
Ù’l’arte in bando, ù’già la forza è morta,
ove, in vece, d’entrambi il furor pugna!
O che sanguigna e spaziosa porta
fa l’una e l’altra spada, ovunque giugna
ne l’armi e ne le carni! e se la vita
non esce, sdegno tienla al petto unita.
Ma ecco omai l’ora fatal è giunta
che’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e’l sangue avido beve;
e la veste che d’or vago trapunta
le mammelle stringea tenere e lieve,
l’empiè d’un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e’l piè le manca egro e languente.
Segue egli la vittoria, e la trafitta
vergine minacciando incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta
movendo, disse le parole estreme:
parole ch’a lei novo spirto addita,
spirto di fè, di carità, di speme,
virtù che Dio le infonde, e se rubella
in vita fu, la vuole in morte ancella.
– Amico, hai vinto: io ti perdon… perdona
tu ancora, al corpo no, che nulla pave,
a l’alma sì: deh! per lei prega, e dona
battesmo a me ch’ogni mia colpa lave. –
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza,
e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza.
Poco quindi lontan nel sen d’un monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v’accorse e l’elmo empiè nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentì la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide e la conobbe: e restò senza
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!
Non morì già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l’acqua a chi col ferro uccise.
Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise:
e in atto di morir lieta e vivace
dir parea: “S’apre il ciel: io vado in pace”.
 Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.
Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.
Helga Fanderl: una lunga vacanza sulla terra
In occasione del ciclo di proiezioni Screening exercises, curato da Flavia Mazzarino e Filippo Perfetti all’università IUAV di Venezia, ospito qui una conversazione con la cineasta Helga Fanderl, protagonista del primo incontro del ciclo. I prossimi appuntamenti saranno con Sílvia Das Fadas e Jan Kulka (qui il programma completo).
 © La Chambre blanche d’Arnaud Baumann
© La Chambre blanche d’Arnaud Baumann
“È vero, diceva, che nella progressione dei tempi le donne staccavano le stelle per darle ai loro bambini. Essi le bucavano con un fuso e facevano girare queste trottole di fuoco per mostrarsi tra loro come funzionava il mondo. Ma non era che un gioco (…)”
Dio d’acqua, Marcel Griaule
Ho incontrato Helga Fanderl al Festival di Pesaro, nel 2015, mentre introduceva quella che mi era sembrata, allora, una piccola ingegneria dello stupore. Quando, come nel cinema di Helga, è in opera uno sforzo di comunione, il dono della presenza piena appare ineludibile, e ogni elemento è teso a portare, meticolosamente, il peso e la forma del suo mistero. Sottrarre questa costellazione di film alla pratica che li vuole ogni volta ricomposti, ravvicinati e disgiunti (come fosse un’allegoria coniugale, un tappeto cucito e inconsutile) vorrebbe dire destinarla ad un divorzio dal destino che le è proprio, quello cioè di indicare una misura del mondo che sappia essere, allo stesso tempo, richiesta, decifrazione e deposito di senso. Ho iniziato a scrivere ad Helga accennando alla sua raccolta di memorie legate insieme (900 film archiviati e digitalizzati), e sempre per accenni e incursioni ne è nata una conversazione colma, mi sembra, di una devozione e di una attenzione verso il cinema oggi ritenute perlopiù illegittime. Eccola qui.
Salve Helga. Mi piacerebbe raccogliere qui, più che un sommario di esperienze, una testimonianza del tuo modo di guardare. Ricordo che nel 2015, durante il festival di Pesaro (dove proiettasti una “costellazione” di tuoi lavori), parlasti del girare in Super 8 come una pratica di resistenza formale. Mi chiedo cosa voglia dire, per te, filmare attraverso un supporto che potrebbe venire a mancare, filmare cioè come nel mezzo di una “sparizione”.
Non mi ricordo in che senso avevo parlato del girare in Super 8 come una pratica di resistenza formale. Però mi piace quest’idea. Quando ho scoperto la cinepresa Super 8 e le caratteristiche del formato negli anni ’80 questo mezzo per fare film amatoriali o film di famiglia per eccellenza stava già scomparendo. Il video l’aveva sostituito. Tanti laboratori abbandonavano lo sviluppo della pellicola reversibile e non facevano più copie Super 8 o addirittura chiudevano. La scelta delle pellicole Super 8 si riduceva come anche la produzione di cineprese e di proiettori. Sviluppare e fare delle copie Super 8 diventava sempre più caro. Erano finiti i bei tempo degli anni ’60 e ’70 quando molti cineasti ed artisti giravano in Super 8 liberandosi delle convenzioni del cinema amatoriale e di famiglia, ma anche delle convenzioni del cinema narrativo e documentario in generale. Il Super 8 era molto economico e permetteva di girare in modo più spontaneo, inventivo e creativo.

Mi sono messa a fare film con la cinepresa Super 8 in un momento poco promettente. Anzi mi confrontavo, sin dall’inizio, con la minaccia della sparizione del mio mezzo di creazione artistica. Dovevo sempre lavorare con cineprese e proiettori di seconda mano che spesso si sono rotti e che non si potevano riparare. Tutto è peggiorato da quando il digitale ha soppiantato il film in pellicola: da anni non esiste più la pellicola per fare copie di originali Super 8 reversibili, e per questo ho fatto fare dei gonfiati in 16mm. La versione 16mm di parecchi miei film permette la partecipazione ai festival internazionali. Ormai mi piace elaborare programmi combinando Super 8 e 16mm. Continuare lo stesso a girare in Super 8 ha a che fare con le qualità particolari della pellicola Super 8, i suoi colori, la sua grana, la sua bellezza e soprattutto con la cinepresa, lo strumento assai leggero e piccolo che mi accompagna e mi permette di montare direttamente in macchina, girare con grande attenzione e concentrazione. Mi piace poter immergermi in una situazione e comunicare con il soggetto mentre sto filmando. Se di resistenza possiamo parlare si tratta della difesa di un mezzo di creazione artistica che mi va bene e che amo.
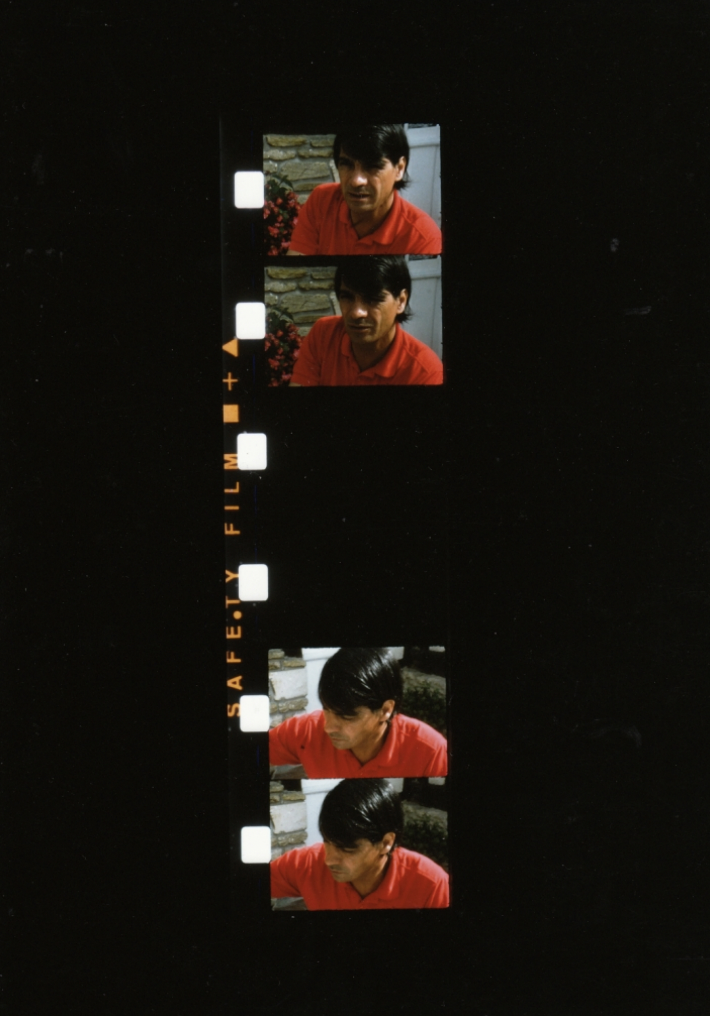
Mi sembra sbagliato considerare il film digitale semplicemente come progresso e miglioramento tecnico rispetto al film come film in pellicola. Perché il digitale dovrebbe farlo sparire totalmente? Il digitale permette altre pratiche, nuove pratiche, ma non può rimpiazzare le qualità specifiche ed uniche della pellicola. È possibile disegnare e pitturare sul computer. Ma per questo non spariscono matita, matita colorata, pastello, colore a olio o a acrile, pennello, carta, lino etc. La sparizione del film come film in pellicola è dovuto innanzitutto ad un interesse economico gigantesco. Si potrebbe dire allora che continuando a girare film in Super 8 faccio una specie di resistenza. Però non si tratta di una posizione ideologica o retrograda, ma legata alla mia esperienza artistica. Ma di resistenza formale si potrebbe anche parlare in un altro senso. Rispetto alla stragrande parte della produzione di cinema narrativo e documentario il film personale e poetico cerca altri se non nuovi modi di espressione e non serve gli interessi del mercato.
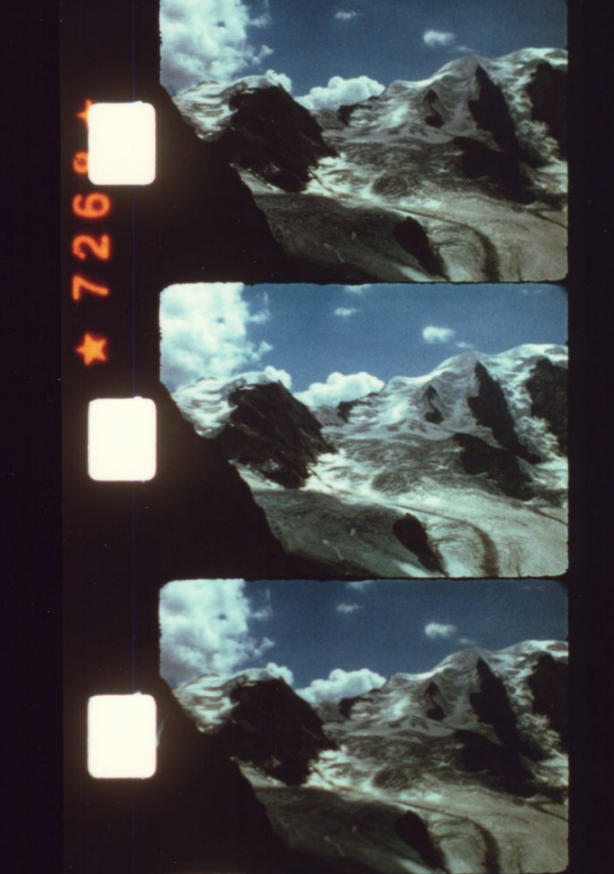
I tuoi film sono montati direttamente in macchina e spesso ritorna, nel tuo fare cinema, una misura ritmica. Si tratta di intuire attraverso la cinepresa la musicalità del mondo, l’accordo tra le singoli parti, o si tratta, piuttosto, di indicare proprio attraverso il cinema una nuova formula, una nuovo modo di guardare alle cose?
Sono spesso proprio i ritmi che trovo nel mondo attorno a me che mi ispirano a fare un film. Come hai detto in modo poetico, si tratta “di intuire attraverso la cinepresa la musicalità del mondo“. Però non basta vedere e riprendere questa musicalità. Fare un film significa strutturare il tempo, costruire un ritmo filmico nella durata. Montando i film direttamente in macchina sto molto attenta alla creazione di ritmi in corrispondenza con il soggetto che sto filmando, ma allo stesso tempo presto attenzione alla creazione di ritmi che esprimono e rendono percettibile la mia visione delle cose, cioè cerco simultaneamente di intuire proprio attraverso il cinema “una nuova formula, un nuovo modo di guardare le cose.” Il ritmo trovato nella realtà viene (ri)costruito e trasformato tramite il mio uso di varie velocità di registrazione, in ogni singola ripresa come anche tramite le loro relazioni nella durata di ogni film.

Da una parte le misure ritmiche si trovano in comunicazione con i ritmi inerenti al soggetto, dall’altra parte produco ritmi espressivi, consapevole del fatto che il film consiste in serie di singoli fotogrammi che nella proiezione e nella nostra mente vediamo come un continuo. Accentuare il contrasto tra continuità e discontinuità permette di dare una visione puramente filmica e diversa della realtà che trascende la visione dell’occhio. Vorrei creare una corrispondenza tra la musicalità del mondo e la musicalità del film.
Parte della tua pratica cinematografica consiste, mi sembra, in questo rimettere in circolo materiali diversi, nell’intuire e nel suggerire nuove combinazioni e nuove geografie, come se i film si rivelassero l’un l’altro, in uno spazio tutto fatto di incontri e di urti. Dove nasce, dunque, questa tua modalità di presentazione?
Questa modalità di combinare i miei film è nata quando studiavo ancora film alla scuola delle belli arti di Francoforte. La “Filmklasse“ stava per presentare un programma collettivo al cinema del Museo del Cinema della città. Il nostro professore di cinema Peter Kubelka mi consigliava di pensare a fare un “montaggio“ di qualche mio film. Non consideravo il singolo film montato direttamente nella cinepresa come un’opera finita, ma come un’opera aperta facente parte di un “work in progress“. Così ho elaborato per la prima volta una piccola “composizione“ di film. Si trattava di quattro film individuali, con soggetti, durata e ritmi diversi ma che, per la durata della proiezione, diventavano un “film“ unico. Con solo quattro film c’erano già tantissime possibilità di combinazioni, di “incontri“ e “urti“. Scambiare l’ordine di questi pochi film mi permetteva di analizzare e capire i fattori complessi che influenzano la “lettura“ del singolo film a seconda della sua contestualizzazione. In questo si potrebbe paragonare questa pratica al montaggio tradizionale, salvo che ogni mio montaggio di film è temporaneo. Trovare la sequenza che mi sembrava giusta e mi piaceva di più era un processo impegnativo, ma molto interessante. Alla fine, dovevo decidere la sequenza in modo intuitivo e sentito. Questa prima esperienza fu una vera introduzione all’arte della programmazione.

Da allora e col crescere della mia opera questa pratica è diventata sempre più importante e ricca, soprattutto da quando ho iniziato a prepare proiezioni individuali. Pian piano le possibilità di costellazioni si mostravano infinite. Questo lavoro di programmazione comporta sempre un momento di scoperta e di sorpresa, per me come per altri che rivedono un film in varie combinazioni. Il modo di vedere e interpretare il singolo film non è fisso, ma variabile. Questo aspetto dinamico mi incoraggiava a continuare anche se, a volte, era una sfida faticosa. Essere la curatrice dei miei film e non seguire la convenzione del film finito con datazione precisa limitava la visibilità del mio lavoro. Vista la mia pratica e poetica mi pareva quasi impossibile affidare i miei film alla distribuzione e ai festival. Preferivo rispettare le restrizioni inerenti al formato Super 8 e la mia libertà artistica. Ogni programma unico e passeggero rappresenta il mio lavoro cinematografico nel suo insieme.
In una delle e-mail mi hai scritto: “ … Questo lavoro mi ha fatto capire che ci sono tantissimi film che non ho mai fatto vedere e che sarebbe bene farlo nel futuro. Tramite un’esposizione all’inizio di quest’anno è nato l’idea e il sogno di creare uno spazio per film dove potrei riunire tutte le copie di film, apparecchi, materiali, documenti, dove potrei continuare ad elaborare programmi vari e soprattutto avere la possibilità di fare delle proiezioni ad ogni momento, in modo totalmente indipendente, per me, per visitatori, artisti amici ed altri, e ogni tanto anche delle proiezioni pubbliche, anche se solo per un pubblico ristretto. Potrebbe essere anche uno spazio di incontri e comunicazione.” Mi piacerebbe conoscere qualcosa in più a proposito di questo spazio a Berlino.
Siccome il Super 8 non è un formato cinematografico come il 16mm o 35mm sono costretta a badare alle condizioni giuste per ogni proiezione. Preferisco mettere il proiettore in sala, in mezzo al pubblico. Bisogna trovare la buona altezza del proiettore, la buona distanza tra proiettore e immagine sullo schermo e definire le buone dimensioni dell’immagine in relazione allo spazio. Mi sembra importante rispettare il piccolo formato che è più intimo rispetto ai suoi fratelli più grandi.

Preparare ogni proiezione è un vero impegno spesso difficile perché manca il tempo o il materiale. E’ stata una esperienza tutta nuova quella di poter creare – non per la durata di una sola proiezione ma durante tutta la mostra FILM LIVE – due sale di proiezione, un cinema S8 e un cinema 16mm, alla galleria DAS ESSZIMMER a Bonn nel 2015. Per la prima volta mi è venuto in mente che sarebbe bene avere uno spazio di proiezione permanente per i miei film. Ma c’era anche un altro motivo che faceva maturare lentamente il progetto dello RAUM FÜR FILM – SPAZIO PER FILM. Grazie al catalogo ragionato della mia opera elaborato con Karianne Fiorini ho capito che avevo fatto vedere fino ad allora solo circa un terzo dei miei tanti film e che ormai sarebbe tempo di mostrare di più.

Finalmente ho scoperto e preso in subaffitto un bello spazio a Berlino dove sono riunite le copie dei miei film, i proiettori e i diversi materiali. Questo spazio serve da studio e da sala di proiezione, per visionare film, preparare i miei programmi e fare delle proiezioni per amici, colleghi e visitatori interessati in modo autonomo ed informale. A volte vorrei anche organizzare proiezioni pubbliche. Spero che lo SPAZIO PER FILM diventi un luogo di incontri e scambi per riflettere insieme su temi di poetica, pratica artistica e politica che interessano. Mi sembra che questo spazio me permette di dare una forma idonea alla totalità della mia pratica artistica.
Notarella sullo sgonfiamento della mazza
di Andrea Inglese
.
Buone notizie dal mondo del pene, il cazzo si sta sgonfiando. E quando si parla di cazzo, non siamo mai in un regime puramente fisiologico, letterale, ma si naviga nella caverna platonica del simbolico e delle sue ombre. Se tutto ciò è vero non posso che felicitarmi con le nuove generazioni, poco importa come si considerino dal punto di vista del genere. D’altra parte, il problema del cazzo riguarda innanzitutto chi ce lo ha, fisiologicamente parlando. Questo lo sapevamo anche noi, giunti alla pubertà nei remoti anni ottanta. Non so per quale vie collettive, esplicite o implicite, ce lo fu incalcato, ma ogni adolescente finiva poi col capirlo chiaramente che, per essere un “maschio”, un “uomo”, mica bastava averlo un sesso maschile. Con il sesso floscio eri un uomo in potenza, un’ipotesi di uomo, una vaga e umbratile possibilità. Con il cazzo in tiro, diventavi uomo in atto, degno di un più alto, ultimativo, destino. Quale? E qui sorge l’enigma. A cosa diavolo serviva il cazzo in tiro? Credo che non ce lo siamo, allora, chiesto abbastanza. Siamo stati un po’ creduloni. Ci siamo accontentati delle indicazioni molto generali, senza preoccuparci di scendere nei dettagli.
D’altra parte, dal 1962, anno di pubblicazione del Maestro di Vigevano di Mastronardi, ai post-moderni anni Ottanta, lo slogan del giovane maschietto era praticamente rimasto intatto: “Funziona la mazza? E quando funziona stai a posto!” A farne uno dei tormentoni del romanzo, è il maestro Filippi, collega del protagonista nel romanzo di Mastronardi. Ma in fondo era pure la nostra preoccupazione di adolescenti: avere dapprima abbastanza peli, poi averlo abbastanza lungo (o illudersi di), poi riuscire a drizzarlo, poi a mantenerlo dritto nelle torbide e losche circostanze del primo rapporto amoroso con penetrazione inclusa. La fase che va dalle prime forme di autoerotismo o di omoerotismo (quest’ultime passate sotto un prudente silenzio) alle forme di un compiuto e ormai banale rapporto eterosessuale era densa di leggende, che si concentravano ovviamente tutte intorno al funzionamento della “mazza”. Non va, con ciò, sottovalutato, sempre per i giovani maschi, il fiabesco, ma anche un po’ horror, mondo del sesso femminile. Che poi sia venuta per tutti, appunto, la fase diurna della sessualità genitale, non toglie che intorno al sesso maschile siano rimaste appiccicate ombre più o meno lunghe.
In soldoni, si potrebbe dire che, a tredici anni, tra i miei coetanei dello stesso sesso, vigeva un’indiscussa miscela di omofobia & sessismo. Era l’aria ideologica che respiravamo. Naturalmente avranno fatto eccezione figli e figlie di cerchie avanguardistiche in politica e nei costumi, ma per la grande massa la faccenda era così. Poi le solite controculture giovanili (nel mio caso il punk anarchico) rimisero le cose abbastanza a posto, stabilirono legami con le esperienze degli anni Settanta, ecc. Però l’imperativo della mazza si era nel frattempo infiltrato negli ingranaggi della personalità.
Oggi pare che, anche quando il più insospettabile degli eterosessuali è coinvolto in un’inchiesta sui costumi erotici delle gioventù, e si trova al riparo da occhi indiscreti davanti a un’intervistratrice magari di solo dieci anni più vecchia di lui, ebbene l’insospettabile etero svuota subito il sacco. Non attende neppure di essere lavorato un po’ per via subdola e psicologica. Lo dice senza tentennamenti che a lui la faccenda della mazza gli sta sul cazzo, che la sopporta male, gli produce angosce, ansie, ripugnanze. E siccome l’equazione funziona ormai da lunga data, ci si vuole liberare della mazza e di tutto quello che essa rappresenta: mascolinità o semplice appartenenza al genere maschile e alle sue prerogative. Certo, qualcuno si alzerà per dire: “Non vorrete buttare via con il cazzo in tiro, anche l’uomo che sta al suo seguito!” Ma ormai il bambino è già finito per lo scarico con l’acqua sporca. D’altra parte si capisce. Avete identificato per un’eternità bambino e acqua sporca, e ora volete che ci mettiamo lì a fare i pignoli?
Tutti questi figli nostri che già giovanissimi sbandierano identità non-binarie, bi, pansessuali o asessuali forse ci preoccupano un po’. (Sono escluse dalla lista le cerchie avanguardistiche dei costumi, che non conosco preoccupazioni mai.) O forse ci sembra tutta una moda. In ogni caso, ci incitano a capire, studiare, leggere, decifrare questo nuovo mondo che viene, che viene con la faccetta amabile dei nostri figli, fino a ieri balbettanti e camminanti su gambette insicure. Ora, questo aggiornamento sui costumi erotico-identitari può anche farsi per semplice anamnesi, come ho cercato di mostrare. Tutti i genitori di oggi, che non sono stati educati in ambienti strettamente progressisti, possono ricordarsi ad esempio – se uomini – del fardello della mazza, fardello con cui ognuno ha patteggiato a suo modo nel corso dell’esistenza adulta. In ogni caso, non mi stupisce troppo che a un certo punto, passata acqua sotto i ponti del nuovo millennio, quel fardello non sia più di così universale gradimento.
Che cose ne verrà poi fuori da tutta questa riconsiderazione e reinvenzione delle identità sessuali? Su questo noi non siamo più, in termini generazionali, i timonieri della vicenda. Possiamo metterci in ascolto con empatia, cosa che in genere il buon genitore cerca di fare. Possiamo anche mantenere un occhio un po’ ironico e distaccato, perché anche la rivoluzione delle identità sessuali, come tutte le rivoluzioni, è disseminata di trappole e vicoli ciechi. Di certo, se anche una minima anamnesi l’abbiamo fatta sulla nostra prima gioventù, non avremo allora gli occhi intorbidati di orrore e spavento, come accade a coloro che vedono in tutto ciò uno dei turpi effetti del moloch liberal-capitalistico, e hanno nostalgie di colleghi che nel corridoio ti domandano: “Funziona la mazza?”
Glossa 1
L’imperativo (e l’assolutismo) dell’erezione (per gli etero) ha comunque qualcosa di enigmatico, come se si trattasse di un’antica strategia diversiva. Questo imperativo acquista senso fintantoché siamo in una logica puramente riproduttiva: niente inseminazione senza efficace penetrazione. Ma poiché il vero terreno su cui si giocherebbe la partita della mazza (in società a natalità controllata) è quello della soddisfazione femminile, perché mai si è rimasti fissati al primato della penetrazione? Si è trattato, nel migliore dei casi, di una rottura di scatole per entrambi. C’erano così tante altre cose che si potevano fare o non fare per essere felici e stare bene assieme. (Con ciò non ho nessunissima intenzione di sputare sulla penetrazione e sui magici mondi del piacere che essa apre, quando questo accade. D’altra parte, l’esistenza di orgasmi & piaceri affini, fanno parte dei più alti principi che si possono opporre alle teorie schopenhaueriane dell’auto-annichilimento come traguardo massimo.)
Glossa 2
Il non binarismo una moda? Si potrebbe avvicinare tutta questa faccenda delle ridefinizioni dell’identità sessuale, che funziona secondo una velocità epidemica, alle riflessioni condotte dal filosofo della scienza Ian Hacking, a proposito della “costruzione sociale della personalità”. In un magnifico libro, tradotto anche in Italia, La riscoperta dell’anima. Personalità multipla e scienze della memoria (Feltrinelli, 1996), l’autore canadese s’interrogava sull’avvento di una nuovo disturbo psichiatrico, la sindrome della personalità multipla, e notava come essa fosse stata diagnosticata in rarissimi casi negli anni Settanta, per diventare poi una malattia estremamente diffusa a partire dagli anni Ottanta. La sua ricerca sulla psichiatria ottocentesca e novecentesca, che prendeva le mosse da Foucault, gli ha permesso di formulare la tesi del “nominalismo dinamico”, per caratterizzare i fenomeni che avvengono nell’ambito delle scienze umane. In parole semplici, le persone sono “trasformate” dalle descrizioni che sono loro offerte dalle istituzioni e più in generale dal contesto sociale. Questa trasformazione non è da concepire in senso lineare, come un’imposizione o una manipolazione. Sono le persone stesse che decidono di “entrare” in certe categorie comportamentali, e che finiscono per appropriarsene, per organizzare in funzione di esse la loro personalità o – nel caso di un disturbo psichiatrico – la loro sofferenza psichica. Questo discorso ovviamente ha senso anche al di fuori del terreno di esplorazione scelto da Hacking, ossia la sfera dei disturbi mentali e la tipologie di malattie che l’istituzione riconosce in relazione ad essi. Per cui bisognerebbe cominciare a pensare le nostre identità sessuali nei termini “storici” del “nominalismo dinamico”, e considerare che esse si declinano secondo descrizioni, categorie, “forme” più o meno disponibili all’interno di una certa epoca e società. Queste descrizioni, poi, possono incontrare un particolare successo, ma questo dipende dalla scelta e dalla capacità dei singoli soggetti di farle proprie, di adattarsele.
Serpentez ! Due estratti da “Ma ralentie” di Odile Cornuz
a cura di Lorenzo Mari
Dopo una prima traduzione di estratti per Le Nature Indivisibili, propongo la traduzione di due nuovi lacerti da Ma ralentie (Editions D’Autre Part, 2018, premio Auguste Bachelin) di Odile Cornuz, autrice svizzera nata nel 1979, recentemente tornata nelle librerie con un nuovo volume per le Editions d’En Bas, Fusil (2022). Ma ralentie, invece, è una meditazione al tempo stesso saggistica, narrativa e lirica su un caposaldo della poesia francese del Novecento, La ralentie di Henri Michaux. Nella serpentina disegnata dal secondo estratto si esplicita il rallentamento che percorre tutto il testo di Michaux, movimento che, nelle parole di Odile Cornuz, si avvale di ulteriori digressioni, come ad esempio quella causata dalla polisemia del verbo francese foncer, mancante – per quanto è dato sapere a chi scrive – di una traduzione italiana, se non equivalente, altrettanto polisemica. Forse non intraducibile, dunque, ma di certo quella che segue è una traduzione foncée. (l.m.)
*
Dietro di te l’itineranza, oppure altre forme. Un’erranza interiore. Un percorso con le frecce tra melancolia ed esperienza. Una risacca di immagini e di esseri umani. Un fuoco modesto ma ravvivato. Tu non hai paura del vuoto. Non hai paura del silenzio. Non hai paura del bianco di certi muri. La sola paura che ti prende: quella dei grandi ragni estivi. Si introducono nel tuo spazio con il favore della notte, delle finestre aperte. Li incontri nel bagno al mattino, oppure in corridoio la sera, prima di andare a dormire. Li schiacci. Ti munisci di una scarpa da ginnastica da uomo. Non lasci alcun dubbio sullo schiacciamento della bestia sotto la suola. Produce un rumore di pera matura che scoppia al sole – e una macchia. Asciughi la suola con la carta. Le palpitazioni del tuo cuore si calmano. Svanisce anche la pelle d’oca sulle tue braccia. Senti la soddisfazione del cacciatore-raccoglitore che ha protetto il suo spazio vitale. Non ti sei lasciato divorare dall’ignobile. Hai vinto. Quando non si tratta di un ragno ma di una scutigera, la faccenda è diversa. Non si immobilizza in caso di estremo pericolo, no: la scutigera è veloce, corre alla velocità delle sue innumerevoli zampe (una trentina, in effetti) e si ferma soltanto su una zona più scura. Tu ne hai vista una che fuggiva di corsa, e pensava (ipotizzando che pensi, una scutigera) di camuffarsi grazie a un buco nell’assito, a forma di V – delle sue esatte dimensioni. Là si è immobilizzata, sull’irregolarità del parquet, dopo una corsa sfrenata. Tu l’hai osservata con stupore, senza dubbio, misto a una crescente sensazione di trionfo. Lei si credeva al sicuro. Come i bambini che, gli occhi nascosti dietro le mani paffute, pensano di non essere più visibili. Faceva lo struzzo. Ma tu, tu hai preso una rivista a caso, forse lo stesso Zio Paperone, e l’hai appiattita, la scutigera, che più piatta non si sarebbe potuto. Poi, sei stata costretta a ramazzare il resto delle zampe con un fazzoletto, e a grattare il pavimento. La macchia resta, piccola, scura sul parquet chiaro. Non ha più la forma di una V, bensì quella di una scutigera schiacciata. Non condividi più la tua interiorità con gli insetti visibili.
Derrière toi l’itinérance, ou d’autres formes. Une errance intérieure. Un parcours fléché entre mélancolie et expérience. Un ressac d’images et d’êtres humains. Un feu modeste mais entretenu. Tu n’as pas peur du vide. Tu n’as pas peur du silence. Tu n’as pas peur du blanc de certains murs. La seule peur qui te saisit : celle des grosses araignées d’été. Elles s’introduisent dans ton espace à la faveur de la nuit, des fenêtres ouvertes. Tu les trouves le matin dans la salle de bains, ou le soir dans le couloir avant de te coucher. Tu les écrases. Tu te munis d’une basket d’homme. Tu ne laisses aucun doute quant à l’écrasement de la bête sous la semelle. Ça fait un bruit de poire blette qui éclate au sol – et une tache. Avec du papier tu essuies la semelle. Les palpitations de ton cœur s’apaisent. La chair de poule sur tes bras idem. Tu ressens la satisfaction du chasseur-cueilleur ayant protégé son espace vital. Tu ne t’es pas laissé bouffer par l’ignoble. Tu as vaincu. Quand ce n’est pas une araignée mais une scutigère, c’est autre chose. Elle ne s’immobilise pas en cas d’extrême danger, non : la scutigère est véloce, elle fonce à la vitesse de ses pattes innombrables (une trentaine, en fait) et elle ne s’arrête que sur une zone foncée. Tu en as vu une filer en trombe, pensant (si l’on suppose qu’une scutigère pense) se camoufler grâce à un œil du plancher, en forme de V – juste à sa taille. Elle s’est immobilisée là, sur l’irrégularité du parquet, après une course effrénée. Tu l’as observée avec un étonnement certain, assorti d’un triomphe naissant. Elle se croyait en sécurité. Comme les enfants, les yeux derrière leurs mains potelées, pensent qu’on ne les voit plus. Elle faisait l’autruche. Mais toi tu as saisi une revue quelconque, peut-être même Picsou Magazine, et tu l’as rendue plus plate que plate, la scutigère. Tu as été obligée, après, de réunir le reste des pattes avec un mouchoir, et de frotter le bois. La tache demeure, petite, foncée sur le parquet clair. Elle n’a plus une forme de V mais une forme de scutigère écrasée. Tu ne partages pas ton intérieur avec les insectes visibles.
*
Alla cieca, non si sa da dove piovano i colpi però piovono. C’è anche la pioggia, però i colpi, quelli, non li vede nessuno – eccetto tu. Si pensava che avanzando tutti dritti non ci si potesse perdere, e paf!, all’altezza delle gambe, era meglio fare una deviazione, in effetti, non farci graffiare dai rovi, non annegare nel fiume in piena, non scalare la montagna quando è aperta la via alla cima – fa una serpentina, certo, ma tanto peggio. Bisognava accettare che la vita faccia la serpentina? Che bisognasse accettare non si sapeva. Bisognava aver già capito, prima di accettare. Bisognava aver già capito che non si può decidere su tutto, che il nostro potere è limitato. Ma veramente ? E se ad animarci forse stata la volontà di tirar sempre dritto? Questo non significa spiaccicarsi sui muri, schiacciare gli altri come pneumatici vecchi. No! Semplicemente tirar sempre dritto, al proprio ritmo, con naturalezza, concedendosi il tempo di raccogliere l’alchemilla, prendere in prestito dei libri, deporre baci sulle bocche, senza per questo fermarsi, tutto dritto, sempre tutto dritto. Perché non dovrebbe funzionare? Perché si dovrebbe credere agli uccelli del malaugurio? Perché si dovrebbero fare dei bambini per delle cattive ragioni? Quali sarebbero le cattive ragioni per fare dei bambini? Fate la serpentina! La serpentina! Smettete di tirar dritto in questo modo, è insopportabile! Fermatevi e avanzate al passo del serpente! Smettete di fare domande! Adottate unicamente la curva, l’anello, quello che scivola e ti tiene ben fermo il collo! Non attraversate alcuna strada, alcun corso d’acqua, alcun cerchio di fuoco! Se osate mettere il piede sulla linea, tagliando le rette dei cartografi, vi colpisca la disgrazia! Non abbiate la sfrontatezza di attraversare il campo, passare al di sotto della via ferrata, trovarvi allo scoperto, verso la cima, nudi. Copritevi di foglie, d’erba, di rami. Camuffate le vostre intenzioni, non lasciate trapelare alcuna emozione. Brulicate come formiche! Industriosi, industriose, ricordatevi che la linea retta non vi serve a nulla. Fate la serpentina!
À l’aveuglette, on ne sait d’où les coups pleuvent mais ils pleuvent. La pluie aussi, mais les coups eux, personne ne les voit – sauf toi. On pensait qu’en avançant tout droit on ne pouvait pas se perdre, et paf ! dans les jambes, en fait il valait mieux faire un détour, ne pas s’écorcher dans les ronces, ne pas se noyer dans le fleuve en furie, ne pas escalader la montagne quand la route du col est ouverte – elle serpente, bien sûr, mais tant pis. Fallait-il accepter que la vie serpente ? On ne savait pas qu’il fallait accepter. Il fallait déjà comprendre, avant d’accepter. Il fallait déjà comprendre qu’on ne décide pas tout, que notre pouvoir est limité. Vraiment ? Et si on était animée par la volonté d’aller tout droit ? Cela ne signifie pas de foncer dans les murs, d’écraser les autres comme des vieux pneus. Non ! Simplement aller tout droit, à son rythme, par simplicité, se laissant cueillir l’alchémille, emprunter des livres, déposer des baisers sur des bouches, sans s’arrêter pourtant, tout droit, toujours tout droit. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Pourquoi devrait-on croire les oiseaux de malheur ? Pourquoi ferait-on des enfants pour des mauvaises raisons ? Quelles seraient les mauvaises raisons de faire des enfants ? Serpentez ! Serpentez ! Arrêtez d’aller comme ça tout droit, c’est insupportable ! Arrêtez-vous et marchez au pas du serpent ! Arrêtez de poser des questions ! N’adoptez que la courbe, la boucle, ce qui coulisse et serre bien au collet ! Ne traversez aucune route, aucun cours d’eau, nul cercle de feu ! Si vous osiez poser le pied sur la ligne, couper les droites de cartographes, malheur à vous ! N’ayez pas le front de traverser le champ, passer par-dessus la voie ferrée, vous trouver à découvert, vers le sommet, nus. Couvrez-vous de feuilles, d’herbes, de branchages. Camouflez vos intentions, ne laissez dépasser aucune émotion. Grouillez comme les fourmis ! Industrieux, industrieuses, rappelez-vous que la droite ne vous vaut rien. Serpentez !
Sette poesie
di Simone Zoppellaro
.
Prayer
Benedici tutti i miei peccati, o Signore,
liberami dal bene, sradica
ogni pietà o speranza dal mio cuore: fammi
perfetto per il mondo che tu hai creato
come gli uomini che hai insufflato dal fango;
rimuovi da me ogni scintilla
di virtù o conoscenza, spronami
a perseguire il buio di ogni dogma, portami
a godere, come una iena all’inferno,
di ogni sbranato, di ogni violenza,
nella pura ferocia che sprigiona
dall’abbaglio delle cose del tuo mondo;
benedici tutte le mie voglie, o Signore,
inclusa quella di farti fuori.
Ludwigsburg, 3 maggio 2021
*
Frozen
Ma ho rovesciato il mio sguardo, dirigendolo
verso costellazioni ignote. Amore, fatti sentire:
affondo, affogo. Trepidazioni di termiti,
lampi laceranti, lance e lancette affilano,
grumi di luce, buio di marmo. Pietà, mercede.
Sguscia, scivola via il corpo
con tutte le torture impercettibili,
con tutte le storture della psiche
che si anima, rialza e cade,
fa un tonfo, risuona nella grotta,
dà forma al vuoto. τέλος:
è rigettare la polvere che ti nutre.
Madre-polvere, padre-palude.
Io non sono la ferita che si cuce. Io non sono
l’orbita esplosa di una pietra incenerita. Io
non sono un nome, una rivelazione biometrica.
Tocca i limiti del silenzio con le lame del palato.
Stratificazioni dello spirito. Balbetta, esala,
esulta. Per una caduta che ti declina in tutto.
Povero nodo o nucleo di materia assiderata:
tu fissa il cielo, le viscere notturne delle stelle.
Stoccarda, 30 agosto 2020
*
Die Wellen
Corpo dopo corpo, il mare
restituisce alle sue sponde
(perplessi, alcuni si fermano
a guardare, un paio di loro urlano,
altri scattano foto con gli smartphone)
arti scomposti, visi neri invisibili,
fradici jeans e camice strappati; anch’io
sono lì, in sogno. Non smettono
più di toccare terra, lenti, uno dopo l’altro,
sotto un sole che si accascia al tramonto,
pallido e esausto. I loro capelli,
ad avvicinarsi, sono alghe, i loro
occhi meduse: non appartengono
più a questo lato del mondo, ma al ventre
infinito del mare. Fermo, trattengo il respiro, prego
che ora anche le onde finiscano.
Stoccarda, 2 settembre 2020
*
Der Siebenschläfertag
“Saranno sette settimane di tempesta”,
sbuffano al vento i sette
dormienti – murati vivi
come da leggenda – il ventisette
di giugno, loro festa. “Saranno sette settimane
di lacrime e fango, di sangue e lampi
in tutta Europa”, sbuffano al vento
i sette redivivi, sbucati da una grotta
subito prima di morire.
Ludwigsburg, 28 giugno 2022
*
Area postrema
L’uomo che si prende cura del proprio giardino
commette un atto impuro. I suoi muti margini
coincidono con un cielo terrestre. A ogni ramo
dello scheletro della conoscenza, le teste degli impiccati:
frutti delicati, primizie di morte. Da ogni singolo tronco
spezzato si sprigiona il loro grido. Vertigine del ritorno,
intimità dell’abbandono. Il giardino è la memoria del futuro;
labirinto che conchiude luce e putredine, riconduce il respiro
in un seme nudo che condensa ogni passato, ogni possibile.
Stoccarda, 17 aprile 2020
*
Il contagio
Questa è l’alba dei soli che cadono.
This is the dawn of the falling suns.
Unerträglich, quando i numeri non tornano,
sono incommensurabili. Andrebbero
moltiplicati per l’umanità. Alle Straßen,
che portano a Milano, münden
in schwarze Verwesung. Il contagio
è una parentesi senza contenuto,
a esclusione del lutto. This is the dawn
of the black sun. Un fremito, so unheimlich.
Stoccarda, 22 marzo 2020
*
Il respiro
A Narine Abgaryan
Tace la guerra, e tacciono i morti. Il respiro di chi resta non è più lo stesso. Il tempo è disumanato, turgido. Le frontiere appaiono mutate, non le nuvole. Le stelle brillano come distese di tombe.
Dio è morto il giorno in cui siamo nati.
Alcuni uomini continuano a vivere. Tra altri sipari, altre porte, altre finestre che danno su un muro. Sempre lo stesso muro. Il mondo ruota, una danza di pavone, attorno al muro.
Mi arrampico sugli specchi: respiro. Navigo sugli abissi: respiro. Precipito, nuoto, affogo: respiro sempre.
Oppure non respiro.
Vergine vertigine. Cattedrale di edera elettrica e rumore. Occhi verdi, duri come pietre, morbidi come prati. Il vento sospinge gli uomini-soffioni. Il seme non è più un seme, ma solo una minuscola lapide di lingua.
Jerevan, 24 gennaio 2021
Marcel Proust, Véronique et moi
di Mauro Baldrati
 La mia scoperta del “mago notturno e favoloso” risale al 1969-70. Leggevo Jack Kerouac, come “una pera di furia”, recita l’ultima traduzione di Howl di Allen Ginsberg. Non solo leggevo, ma agivo. Le pagine di quel viaggio senza fine (e senza scopo, lo definì un kerouchiano pentito come Bob Dylan) erano una droga incendiaria che mi spingeva in avanti, per le strade della Romagna, gridando sììì! come Dean Moriatry. Poi sono passato a Henry Miller, che Kerouac considerava un padre letterario. A un certo punto ho scoperto che entrambi erano dei grandi ammiratori di Marcel Proust. Kerouac progettava addirittura di scrivere la sua Recherche. Per cui, visto che i miei due eroi adoravano il famoso scrittore francese, decisi che dovevo conoscerlo a mia volta.
La mia scoperta del “mago notturno e favoloso” risale al 1969-70. Leggevo Jack Kerouac, come “una pera di furia”, recita l’ultima traduzione di Howl di Allen Ginsberg. Non solo leggevo, ma agivo. Le pagine di quel viaggio senza fine (e senza scopo, lo definì un kerouchiano pentito come Bob Dylan) erano una droga incendiaria che mi spingeva in avanti, per le strade della Romagna, gridando sììì! come Dean Moriatry. Poi sono passato a Henry Miller, che Kerouac considerava un padre letterario. A un certo punto ho scoperto che entrambi erano dei grandi ammiratori di Marcel Proust. Kerouac progettava addirittura di scrivere la sua Recherche. Per cui, visto che i miei due eroi adoravano il famoso scrittore francese, decisi che dovevo conoscerlo a mia volta.
Ecco che vedo me stesso, una specie di invasato disperato sedicenne, nella mia cameretta seduto sulla poltroncina rossa dismessa dalla bottega di parrucchiera di mia madre, col capo chino sull’edizione del 1965 di La strada di Swann, tradotto da Natalia Ginzburg con prefazione di Giacomo Debenedetti. Rivivo me stesso sbalordito, e anche affaticato, per gestire le complesse descrizioni dei fiori, dei campanili, con periodi lunghissimi senza punti. Non che non fossi abituato, i miei due maestri non scherzavano, specialmente Kerouac, ma davvero non avevo mai letto nulla di simile. Quell’autopsia dell’amore in Un amore di Swann, che crudeltà, che precisione. Lo lessi di getto, in tutti i momenti liberi, con pazienza e tenacia. E non l’ho mai dimenticato.
Poi passò una ventina d’anni, e mi trovai costretto a trasferirmi da Milano a Bologna. Fu un trasloco lento, circa un anno. Prendevo il treno regionale, tre ore abbondanti, ma non avevo fretta, spendevo meno nel biglietto, e leggevo. Buona parte della Recherche l’ho letta su quei sedili, tra Milano e Bologna e viceversa. E mi sono reso conto di nuovo che davvero non avevo mai letto nulla di simile. Mi chiedevo anche come aveva potuto, uno scrittore appartenente al genere umano, gestire quell’opera immensa, ipertestuale (quel termine stava diventando di moda), che si poteva leggere da ogni direzione, composta da altri romanzi, racconti, dissertazioni naturaliste e filosofiche, in uno scorrere del tempo che sembrava metafisico, perché forse non era il tempo, ma la vita stessa.
Insomma, ero diventato un proustiano, il cittadino di una piccola popolazione transnazionale, con le sue regole, la sua costituzione, e una strana, forse inspiegabile contraddizione: benché avessi letto, come tutti, Contre Sainte Beuve, dove Proust esprime la sua famosa teoria che l’opera vive di vita propria, indipendente dal suo autore, volevo sapere tutto di lui. Lessi due libri che aumentarono la mia fascinazione, L’angelo della notte di Giovanni Macchia e La colomba pugnalata di Pietro Citati, frattali emozionanti di biografie romanzate dove l’autore emerge come una leggenda guerriera e sofferente, un eroe di passaggio sulla terra per lasciare un segno indelebile.
E nel corso del tempo, mentre facevo altre cose, guidavo un camion gru nei cantieri, poi mi occupavo di urbanistica per il comune di Bologna, tornavo su Marcel Proust. Passai alla monumentale biografia di George Painter, zeppa di aneddoti, personaggi pieni di segreti, i suoi amori, le tremende delusioni che, probabilmente, lo costrinsero a elaborare la sua teoria della disperazione: “Come si può avere il coraggio di augurarsi di vivere, come si può agire in modo da preservarsi dalla morte, in un mondo in cui l’amore non è provocato che dalla menzogna e consiste unicamente nel bisogno che abbiamo di vedere le nostre sofferenze lenite dall’essere che ci fa soffrire?” (riportato da François Mauriac in L’amour selon Proust, La Table Ronde, Paris 1947).
Ed è spuntata: una voglia di viaggiare in quel “bel mondo” così affascinante, perduto e spietato. Con un libro, un libro mio, dove c’era lui in persona. Subito mi resi conto che avevo bisogno di un navigatore, che viaggiasse per me. Doveva essere un sopravvissuto, come io mi consideravo – e mi considero – tale. Così sarebbe stato anche uno straniero, libero di muoversi, di osservare da una posizione di distacco, indispensabile per narrare. Ma un navigatore non mi convinceva. Temevo che non fosse abbastanza libero, che in quanto uomo anziano potesse essere patetico. Meglio una navigatrice. Così è nata la baronessa Veronique Fourier, “79 anni e non sentirli”, vedova di un giovanissimo aiutante di campo di Napoleone, che abita isolata nel loro grande palazzo deserto, buio e polveroso. Vive coi suoi ricordi, e l’anziano, fedele servitore tutto fare. Siamo nel 1894 (data mai indicata, ma i lettori forti di Proust capiranno presto perché), i salon sono sempre più lussuosi e chiassosi, affollati dai personaggi che il giovane Proust frequentava, e che avrebbe usato per costruire i suoi, componendo dei collages di tipi reali, dei quali campionava i discorsi, le inflessioni della voce, la comicità, la follia, l’egoismo, l’insensibilità. Durante i rari inviti che Veronique riceve, gli unici eventi che la fanno ancora sentire appartenente al mondo esterno, nel salone di Madeleine Lemaire viene avvicinata da un giovane pallido, elegante e complimentoso fino alla piaggeria. Fissandola coi suoi occhi che sprigionano una luce nera le chiede di essere ricevuto per parlare di Baudelaire, sul quale sta scrivendo un saggio. Veronique è lusingata – qualcuno la cerca! – ma anche sconcertata: come mai quel ragazzo sa di lei e di Baudelaire? E’ un segreto che nasconde gelosamente. Forse è per questo che accetta? Inizia così una serie di incontri, dominati dalla figura gigantesca, folle e disperata del più grande poeta della Francia moderna, ma anche dalla voracità di un vampiresco Marcel Proust di sapere, di rivivere quei tempi mitici, che cambierà per sempre la sua vita.