di Viviana Fiorentino

“(…) è il momento della mia vita agricola, indosso sempre, ormai, i miei vestiti da giardinaggio … Theo [Dorgan], il mio compagno, ha costruito una mini serra alta fino alla vita, ha un design stravagante, lì curo i semi germinanti …” risponde così a un giornalista di una testata irlandese la poetessa Paula Meehan dalla sua casa vicino al centro di Dublino; è la fine del mese di Aprile 2020 e l’Irlanda è in lockdown.
Radicale e indipendente, Paula Meehan scrive poesie che entrano nelle case della gente comune dei sobborghi dublinesi, così come nel mondo dei sogni e dell’immaginazione.
Nata nel 1955, primogenita di sei figli, è stata allevata dai nonni mentre i suoi genitori cercavano lavoro in Inghilterra. Ha trascorso i suoi primi anni di vita nelle vecchie case popolari di Dublino, all’angolo tra Sean McDermott Street e Gardiner Street. La sua storia familiare e i legami con il quartiere Monto, dove la sua bisnonna era Madame nel quartiere a luci rosse di Dublino, un tempo il più grande d’Europa, sono tra gli argomenti che attraversano la poesia di Meehan, come nell’ultimo libro, As If By Magic: Selected Poems (Dedalus Press, 2020), che raccoglie i lavori pubblicati tra il 1991 e il 2016. Venticinque anni di poesia e di impegno con le politiche di genere e di classe, di amore per l’ambiente. Una poesia guidata da un impulso olistico e visionario di un mondo verso il quale la Meehan si sente grata. Ireland Chair of Poetry al Trinity College di Dublino (fino al 2016), Meehan ha ricevuto molti premi e pubblicato otto raccolte di poesie, tra le ultime Geomantic (Dedalus Press, 2016) e il già citato As If By Magic: Selected Poems (Dedalus Press, 2020). La sua scrittura per il teatro comprende le commedie Mrs Sweeney (1997), Cell (1999), come anche i testi per bambini Kirkle (1995), The Voyage (1997) e The Wolf of Winter (2003/2004). Una raccolta delle sue opere radiofoniche, Music for Dogs, è stata pubblicata da Dedalus Press nel 2008. La poesia di Meehan è stata musicata da artisti diversi, tra i quali il compositore d’avanguardia John Wolf Brennan e la cantante folk Christy Moore. Nel 2015, è stata inclusa nella Hennessy Hall of Fame ed è nella giuria del Griffin Poetry Prize.
Nella poesia di Meehan apriamo sfere e scopriamo che, dentro ognuna, ce ne sono altre: comunità, famiglia, individualità, memorie. Painting Rain (Carcanet, 2009) è la continuazione di un progetto poetico che cerca di esprimere una voce pubblica eco-consapevole attraverso la poesia, “un impulso a esprimere la memoria collettiva”. Uno dei suoi critici più prolifici, Jody Allen Randolph, colloca la sua voce “a un incrocio tra idee contro-culturali e tradizione lirica irlandese” e sottolinea l’importanza del “suo attivismo ecologico”, ma anche l’influenza della poetessa Eavan Boland (della quale si è parlato su Nazione Indiana già qui) nell’impegno femminista.
Boland e Meehan condividono il desiderio di raccontare storie di donne, di ridefinire cosa significhi poesia politica: come scrisse Boland nella poesia “The Singers”, una voce in cui trovarono una visione.
Meehan amplia la gamma di figure femminili, nella forma di una preghiera offerta a una donna sconosciuta che torna a casa da sola in “Night Walk” o come omaggio all’ex presidente irlandese Mary Robinson in “She-Who-Walks-Among-the-People.” Le donne sono spesso raffigurate come guerriere, sia che si parli de “la gentile signora / che divenne una grande guerriera nei tempi antichi” (sempre in “She-Who-Walks-Among-the-People”) o di figure familiari, come in “The Standing Army”: “Ora porto la lancia di mia madre / indosso l’anello d’oro di mia sorella all’orecchio / cammino nel futuro, orgogliosa / di essere nella casta dei guerrieri” (Pillow Talk, Gallery Book 1994).
Eppure, Meehan resiste ad apparire come femminista, non ricade negli stereotipi e presenta il suo lavoro come cross-gender. Infatti, come poetessa proveniente dalla classe operaia, l’attivismo poetico di Meehan si concentra sulle ingiustizie storiche e restituisce i temi di classe sociale, genere e sfruttamento ambientale come intimamente connessi. “La poesia agisce come un parafulmine per mettere a terra le energie dello Zeitgeist che stai vivendo”, Painting Rain fa proprio questo: trasmette un senso collettivo di perdita e di dislocazione portato dalla recessione della tigre celtica nel 2008, durante la crisi finanziaria globale. “Non credo che una poesia che parli di un governo sia più politica di una poesia sul cambio del pannolino di un bambino.” (E. O’Halloran & K. Maloy, An Interview with Paula Meehan. Contemporary Literature, Vol. 43 (1), Spring, 2002)
La prima poesia della raccolta Death of a Field, è una dichiarazione per un’estetica economica ed eco-femminista che poi percorrerà tutta la raccolta. Il tema è una delle questioni ambientali ed economiche più urgenti in Irlanda: l’eccessivo sviluppo abitativo che ha portato a un paesaggio anonimo, frammentato e sfregiato da “proprietà fantasma”; complessi residenziali nei quali molte case in costruzione furono lasciate abbandonate.
Il campo, the field, assume valore nella sua qualità di inconoscibile. Questa qualità proviene dal linguaggio della terra come corpo, un “irriducibilmente altro” con il carico del suo mistero. Meehan rifiuta la scissione binaria tra natura e cultura, mentre “rappresenta l’umano e il non umano in una relazione intima, sostenuta da una tensione tra il conosciuto e l’inconoscibile”.
Ma i temi politici ed economici non vengono affrontati mai direttamente: “(…) Lo stato comincia nelle nostre cucine. Le persone mi chiedono, scriverai una poesia sul Nord Irlanda, i Troubles, o la Bosnia? Ho molte difficoltà a sedermi e scrivere coscientemente riguardo a una situazione politica. Ma riesco, invece, a riconoscere tutte quelle situazioni nella mia vita di ogni giorno. Allora, più probabilmente, scriverò di problematiche globali, della storia di altri popoli, guardando al mio contesto immediato. La situazione del Nord Irlanda, i Troubles, sono cose attorno a noi. Altrimenti è come non riuscire a vedere gli altri come esseri umani, o identificare gli altri come nemici”.
Memoria e continuità sono gli altri due temi ricorrenti nel lavoro di Meehan. Le storie locali, gli antenati, rispondono al suo desiderio di contrastare le cancellazioni della modernità, in particolare la singolarità e la specificità storica della sua comunità operaia. In Return and No Blame (Beaver Row Press, 1984), la voce poetica dice: “Sono perseguitata da voci che echeggiano, / Voci senza corpi, / Fantasmi della mia infanzia che sognano”. Queste ombre fantasma sono presenti in tutta la poesia di Meehan, ma acquisiscono un ruolo predominante nella raccolta Painting Rain. Meehan ricorda gli eventi tragici della sua infanzia, come lo sfratto che lei e la sua famiglia hanno subito (“How I Discovered Rhyme”) o il tentato suicidio della madre (“This is Not a Confessional Poem”).
La raccolta successiva, compie il salto di una riconciliazione, apparentemente impossibile, tra il territorio della vita comune e quello mistico e dei sogni. Il titolo della raccolta “Geomantic” (Dedalus Press, 2016) deriva dal greco e significa “divinazione della terra”, un tipo di divinazione che interpreta certi pattern sul terreno creati gettando su di esso terra o pietre. Geomantic è la divinazione di quei pattern dell’esistenza che ci sembrano casuali, così apparentemente impercettibili e che nello scorrere del tempo perdiamo del tutto. La poesia tenta di resistere alla perdita e al disfacimento dell’impercettibile e dell’invisibile, creando ordine dal caos.
Il pattern del nove si ripete attraverso tutta la raccolta: 81 poesie, ciascuna con nove versi composti da nove sillabe. Ancora una volta, i temi ambientali, sociali e familiari sono intrecciati con regni del passato, sconosciuti o familiari, ma rivolti sempre verso a un futuro. Nella raccolta, The Commemoration Takes Our Minds Off the Now è una poesia ispirata alle commemorazioni del 1916 avvenute nel 2016. “Quanta parte del paese è stata frustata come un vecchio ronzino”. La “ruota karmica” ci mette in guardia contro l’influenza di causa ed effetto: quei cicli ripetitivi della vita e di coloro che sono in povertà, “che girano e girano intorno”. Le righe finali della poesia sono, allora, una domanda retorica: “Quanto devi essere folle per dare/ un senso allo stato di questo Stato nel quale ci troviamo?”
Come uno sciamano, Geomantic ci porta ai picchi delle vittorie quotidiane e giù ai minimi delle perdite personali e collettive. E mentre leggiamo, sappiamo che tutti stiamo cercando di imparare il passato, di essere nel presente e tentare di navigare nel futuro. Riferimenti mistici e mitici ritornano nell’intera raccolta, offrendoci una visione unica della vita, delle esistenze singole e delle nostre storie condivise. Le parole di Meehan sono intricate, intrise di allusioni, eppure, allo stesso tempo, deliziosamente schiette sulle verità osservate.
Nello stesso periodo in cui Meehan lavorava al carcere di Mountjoy a dei workshop di scrittura e teatro, era anche impegnata come scrittrice residente al Trinity College di Dublino. “Lavoravo in due istituzioni contemporaneamente”, sottolinea, usando la stessa parola, istituzioni, per riferirsi a questi due luoghi: “Facevo lo stesso tipo di lavoro con entrambi i gruppi di persone, anche se provenivano da contesti sociali molto diversi.”
Questa esperienza confluirà nel lavoro teatrale Cell (cella): tre donne di età diverse, provenienti dal centro di Dublino, vengono incarcerate nella stessa cella per reati di droga. Nello spazio che le rinchiude, hanno creato una specie di mondo a sé, con proprie regole e convenzioni, spesso estreme. Ma il loro mondo, all’interno di un mondo, crolla quando una donna apparentemente ingenua, riconosciuta colpevole di omicidio, dovrà condividere con loro lo stesso spazio. Chi legge non può che scorgere nella sfera chiusa della cella, le stesse regole atroci che regolano il nostro mondo civile e sociale.
“Ho smesso di lavorare lì a metà degli anni 90”, spiega Meehan. “Mi sentivo così esausta e impotente. Avevo un enorme senso di rabbia e frustrazione perché molte delle donne con le quali lavoravo non ce la facevano. Avevo il cuore spezzato; mi sarei di certo ammalata se non mi fossi fermata.”
Quando Meehan afferma che le donne non ce la facevano, lo intende nel senso più letterale del termine. Delle 12 giovani donne che hanno partecipato al suo primo laboratorio a metà degli anni 80, solo una è ancora viva. Tutte le altre sono morte: overdose, malattie legate all’AIDS, suicidio.
“Scrivere Cell è stato un modo per risolvere quell’esperienza. Non è un documentario sulla vita a Mountjoy in quanto tale; le storie raccontate sono storie composte, di più donne.”
Dei quattro personaggi di Cell, Delo (42 anni) è dentro per spaccio di eroina; Alice (49 anni) per omicidio; Martha (26 anni) per taccheggio; e Lila (19 anni) per possesso di eroina. E poi la voce disincarnata e dal suono robotico (Lisa Tierney Keogh), che controlla l’accesso alla porta della cella, dando (o meno) il permesso di visitare medici, lavanderia, palestra, assistenti sociali e avvocati.
“Ho lo stesso background sociale di molte di queste donne. Sono cresciuta con le loro madri. Per me non sono persone invisibili. Ciò che accade loro in prigione è solo una versione più estrema di ciò che sta accadendo a molte altre nella loro comunità di provenienza. (…) Chi mi conosce bene direbbe che sto elaborando parti della mia storia, nei personaggi di Cell”.
Cell parla di abuso di potere, e della mancanza di esso: Delo controlla Martha e Lila, entrambe asservite a soddisfare il suo bisogno di droga. Delo governa i letti e il loro uso, come anche la latrina. Una dittatura minacciata dall’arrivo di Alice, outsider per diversi motivi: a differenza delle altre è di campagna (dalla contea di Leitrim), non conosce la droga ed è un’assassina. Poi, nel contesto più ampio, il sistema carcerario controlla tutte e quattro le donne.
Lotte di potere, rabbia, paura, tristezza e compassione. Dove e come ci liberiamo?
“Alcune delle più grandi poesie del mondo” scrive Meehan “sono state scritte in stati estremi di prigionia e isolamento, dai poeti russi che hanno scritto all’ombra del terrore di Stalin, alle poesie di Yannis Ritsos dai campi di internamento del regime”. L’Irish Times dice di Cell: “probabilmente sarebbe inguardabile se non fosse così potente”, alludendo agli abusi di potere e la perdita di ogni intimità corporale ritratti nel dramma.
“Sono stata cresciuta ed educata da persone che avevano ancora una mentalità coloniale, con tutte le fratture identitarie che ne derivano. Per me e per i miei colleghi “operatori culturali”, molto del lavoro consiste nel disintossicare, disintossicare la cultura dal passato coloniale e trovare dei modi per cercare di spingerla verso le libertà. Penso che la parola più importante per la mia generazione, sia per questioni politiche che legate al genere, sia stata liberazione. Ma dopo che sei stato decolonizzato da un potere, sei ricolonizzato da un altro.”
Forse, la scrittura della Meehan si potrebbe provare a racchiudere nella parola unravel e nel suo doppio significato di disfare e svelare, come ci dice nei versi della poesia In Memory, Joanne Breen (Painting Rain, Carcanet, 2009):
I see, spun into the yarn, fibres of blue
& yellow & purple, occasionally orange.
I am undoing the magic of the spindle,
Unravelling
Vedo, tessute nel filato, fibre blu
e gialle e viola,
ogni tanto arancioni.
Disfo la magia del fuso,
Dipano
Di seguito delle traduzioni di alcune poesie di Paula Meehan (da Geomantic, Dedalus Press 2016; a eccezione della poesia “Hannah, Grandmother”).
Hannah, Grandmother
Coldest day yet of November
her voice close in my ear —
tell them priests nothing.
Was I twelve? Thirteen?
Filthy minded.
Keep your sins to yourself.
Don’t be giving them a thrill.
Dirty oul feckers.
As close as she came to the birds and the bees
on her knees in front of the Madonna,
Our Lady of the Facts of Life
beside the confessional —
oak door closing like a coffin lid
neatly carpentered
waxed and buffed.
In the well made box of this poem
her voice dies.
She closes her eyes
and lowers her brow to her joined hands.
Prays hard:
woman to woman.
(Lettura di Meehan disponibile su Youtube qui)
Hannah, Nonna
Il giorno più freddo ancora Novembre
la sua voce nel mio orecchio —
Non dirgli ai preti niente.
Avevo dodici, tredici anni?
Luride menti.
Tieniti i peccati per te.
Non dargli soddisfazione.
Vecchi sporchi bastardi.
Per quanto potesse parlare di passere e cicogne
in ginocchio di fronte alla Madonna,
Nostra Signora dei Fatti della Vita
accanto al confessionale –
una porta di quercia chiusa come il coperchio di una bara
ben lavorato
cerato e lucidato.
Nella bella scatola di questa poesia
muore la sua voce.
Chiude gli occhi
e congiunge la fronte alle mani giunte.
Prega intensamente:
donna a donna.
The Luck
I don’t do the past, said my father,
into my oldfashioned microphone.
The rain, the eternal Irish rain,
beats and beats and beats at the window
and the fattening geese are dreaming
of the north. I knew that he’d be dead
by Samhain when the geese returned again.
We bet online and watched the horses,
all going round the bend together.
La sorte
Non rifaccio il passato, disse mio padre,
nel mio microfono fuorimoda.
Pioggia, eterna pioggia irlandese,
batte e batte e batte sulla finestra
e le oche da ingrasso sognano
il nord. Sapevo che sarebbe morto
per Samhain* quando le oche tornano di nuovo.
Scommettemmo online e guardammo i cavalli,
girare tutti insieme attorno alla curva.
* antica festa celtico-pagana, celebrata tra il 31 ottobre e il primo novembre
The Commemorations Take Our Minds
Off the Now
A boon to the Government; they rule
in the knowledge that none can keep track
of just how much of the country has
been flogged like an old nag to within
an inch of its life. The karmic wheel
goes round and round. I commemorate
the poor going round and round the bend.
How mad do you have to be to make
sense of the state of the State we’re in?
Le Commemorazioni Distolgono le Nostre Menti
Dal Presente
Un vantaggio per il governo; dettano legge
sapendo che nessuno ne può tenere traccia
quanta parte del paese è stata
frustata come un ronzino vecchio chiuso dentro
il centimetro della sua esistenza. La ruota karmica
gira e gira. Commemoro io
i poveri loro girano e rigirano intorno alla curva.
Quanto devi essere folle per dare
un senso allo stato di questo Stato nel quale ci troviamo?
The may Altar, 58 Collins Avenue, Killester
You dressed it with lilac and privet,
the good crystal vase on white linen,
wax candles, bright medals, hymn singing
to Stella Maris, Star of the Sea.
You prayed to Our Lady to mind you.
You believed in angels and mercy.
As if heaven wept at your going
it rained the whole day you left Dublin,
rained on the girl you were, setting out.
L’altare di maggio, 58 Collins Avenue, Killester
L’hai vestita di lillà e ligustro,
il vaso buono di cristallo su lino bianco,
le cere, le decorazioni luccicanti, gli inni cantati
alla Stella Maris, Stella del mare.
Hai pregato alla Nostra Signora di proteggerti.
Hai creduto negli angeli e nella misericordia.
Come se il cielo piangesse alla tua partenza
ha piovuto tutto il giorno che hai lasciato Dublino,
piovuto sulla ragazza che eri, andando via.
The Web
i giorni della merla
I spun those nights to Van Morrison
On Fitzroy Avenue in a dream
part Victoriana, part nightmare.
Elsewhere, at my web’s frayed selvage,
you were dying, less yourself each day
in a white cancer ward in Dublin.
I scanned your memory for this meme:
that time you talked me down, pulled me clear
of my fevered visions, my blank page.
La tela
i giorni della merla
Misi su quelle notti Van Morrison
in Fitzroy Avenue come in un sogno
parte vittoriano, parte un incubo.
Altrove, sulla cimosa sfilacciata di una mia tela,
morivi, meno te stesso ogni giorno
a Dublino in un qualche reparto bianco per il carcinoma.
Ho scansionato la tua memoria per questo meme:
quella volta tu mi avevi convinto, mi avevi liberata
dalle mie visioni febbrili, la mia pagina bianca.
The Hexagram
Before starting, find the lines – broken
and whole – arranged as a hexagram;
the crescent moon waxing, a token
in the night sky of beginnings. Palms
open to the grace of what might fall
like snow to the snow-white page. How calm
I am, and cool, when I hear the call.
She has found me out, in my silence,
come with rumours of heaven, of hell.
L’Esagramma
Prima di iniziare, cerca le linee –spezzate
e intere – organizzate come un esagramma;
la falce di luna crescente, un segno
nel cielo notturno degli inizi. Palme aperte
alla grazia per quello che potrebbe scendere
come neve sulla neve della pagina bianca. Ora calma
sono, e fredda, quando sento il richiamo.
Mi ha colto, nel mio silenzio,
viene con dicerie di cielo, d’inferno.
The New Regime
After love we sleep curled together.
I am dreaming her old dreams; she dreams
pines freighted with snow, ice storm weather.
Her mouth’s rimed with my milk, her hair streams
In curls and rivulets down her back.
She is spelling out the new regime:
its ins, its outs, my place in the pack;
where she keeps the names of the lost things;
how to bear the pain, the sweats, the rack.
Il Nuovo Regime
Dormiamo dopo l’amore insieme rannicchiati.
Sogno i vecchi sogni di lei; lei sogna
pini carichi di neve, in un tempo da tempesta di ghiaccio.
La sua bocca è brinata dal mio latte, fiumi i capelli
scivolano in riccioli e poi rivoli giù lungo la sua schiena.
Lei scandisce il nuovo regime:
i dettagli, il mio posto nel branco;
dove conserva i nomi delle cose perdute;
come poter sopportare il dolore, le fatiche, lo spasmo.
The Ghost Song
‘The singers and workers that never handled the air”
Gwendolyn Brooks
From a dream of summer, of absinthe,
I woke to winter. Carol singers
Decked the halls of some long-lost homeland.
Late-night shoppers and drowsy workers
Headed for the train.
So the night that
you died was two-faced, June light never
far from mind though snow fell. I handled
grief like molten sunshine, learned to breathe
your high lithe ghost song from thinnest air.
Canzone Fantasma
‘The singers and workers that never handled the air”
Gwendolyn Brooks
Da un sogno d’estate, d’assenzio,
mi svegliai nell’inverno. I cori di Natale
colmavano le sale di una casa persa da tempo.
Acquirenti notturni e lavoratori assonnati
andavano al treno.
Così anche la notte
Che sei morto aveva due facce, la luce di giugno sempre
Presente alla mente mentre cadeva la neve. Tra le mani
il dolore come sole che scioglie, ho imparato a respirare
la tua alta e agile canzone fantasma nell’aria più sottile.
The Handful of Earth
Under scrutiny it tells us all
we need to know about our futures,
it being composted of our past lives,
the nine years in this house by the sea.
Under the paths stars make, wild birds call.
I fancy I could read it like leaves
Of tea, yarrow stalks thrown down, tarot,
its minutest narratives of grief,
its aboriginal patternings.
Una Manciata di Terra
A un attento scrutinio dice tutto
ciò che dobbiamo sapere dei nostri futuri,
compost delle nostre vite passate,
nove anni in questa casa al mare.
Sotto i sentieri disegnati dalle stelle, chiamano gli uccelli selvatici.
Mi piacerebbe saperla leggere come se fosse foglie
di tè, o gambi di achillea buttati giù, tarocchi,
sue minuscole narrazioni di dolore,
i suoi disegni e ripetizioni aborigeni.
The Sea Cave
It is as close as I’ll get to her
In this life: to swim into the dark
Deep in the cave where the hot springs are,
to float in her amniotic dream
of children, of a husband, of home.
Flickers of light there where minnows teem
Like memories pulsing through my veins,
that lull me, that shrive me, uncertain
whether I hear her heartbeat or mine.
La Grotta Marina
Il più vicino che posso a lei
in questa vita: nuotare nel buio
profondo nella grotta lì dove sono le sorgenti calde,
e galleggiare nel suo sogno amniotico
di bambini, di un marito, di una casa.
Baluginare di luce lì dove pullulano pesciolini
come ricordi che mi pulsano nelle vene
che mi cullano, mi assolvono, incerta
di sentire il battito del suo o del mio cuore.





 Dalla dimora del tempo sospeso
Dalla dimora del tempo sospeso 


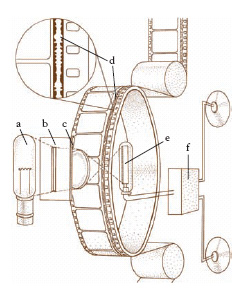 di
di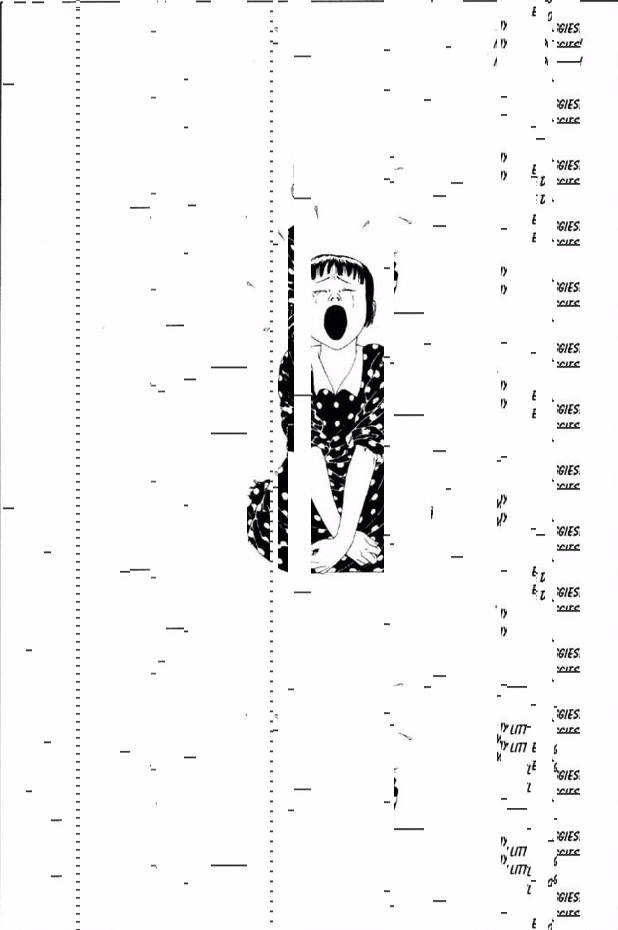
 di Giulia Felderer
di Giulia Felderer


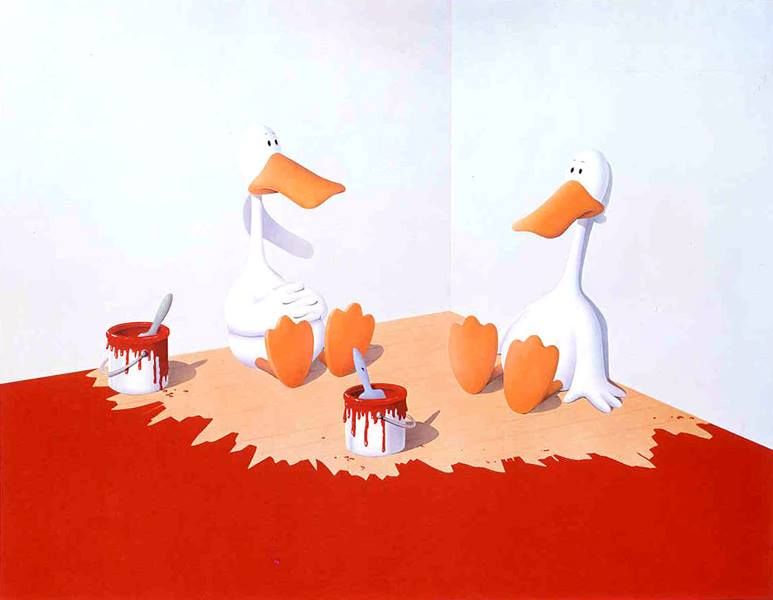


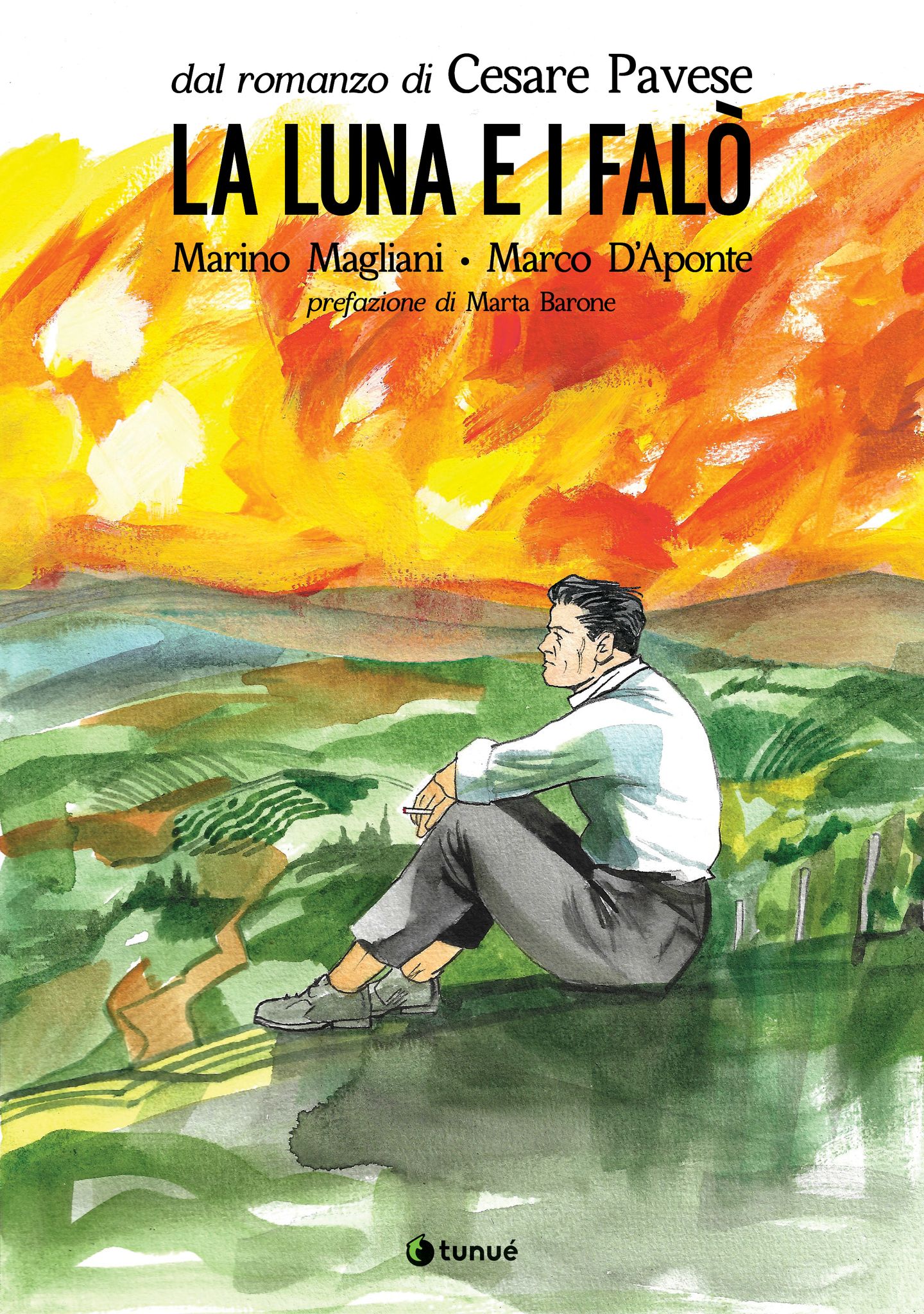
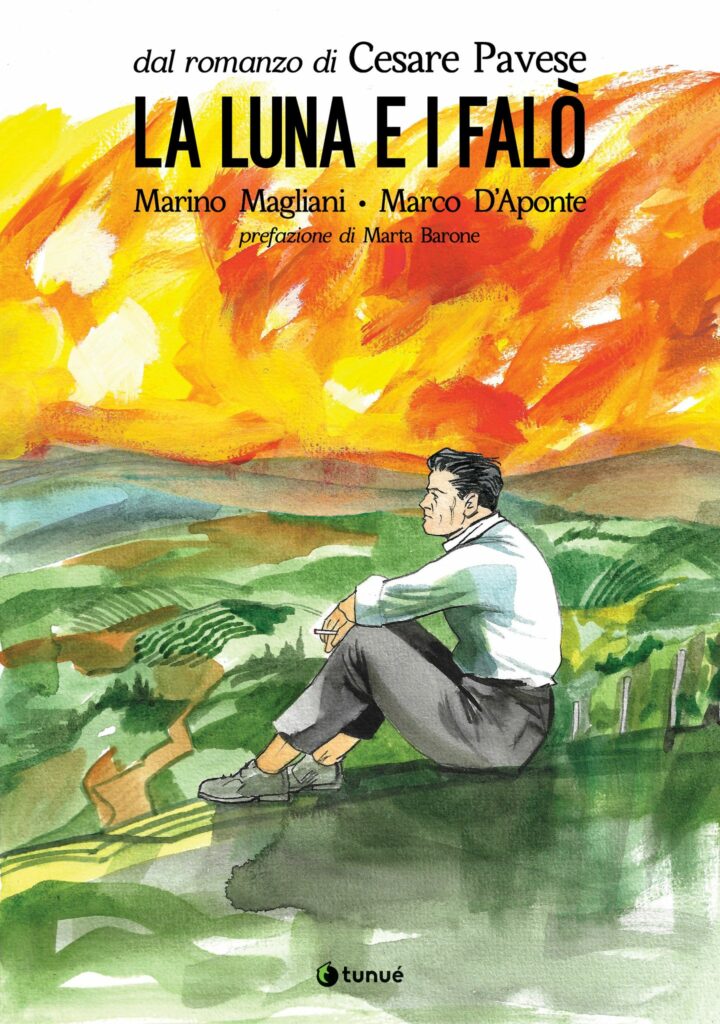

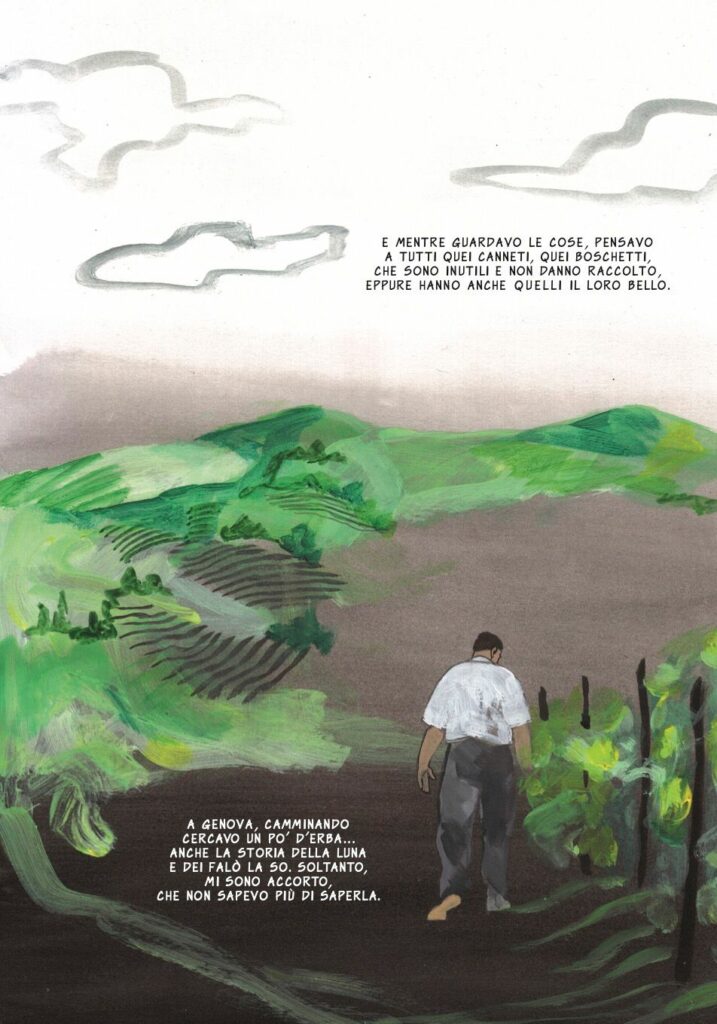
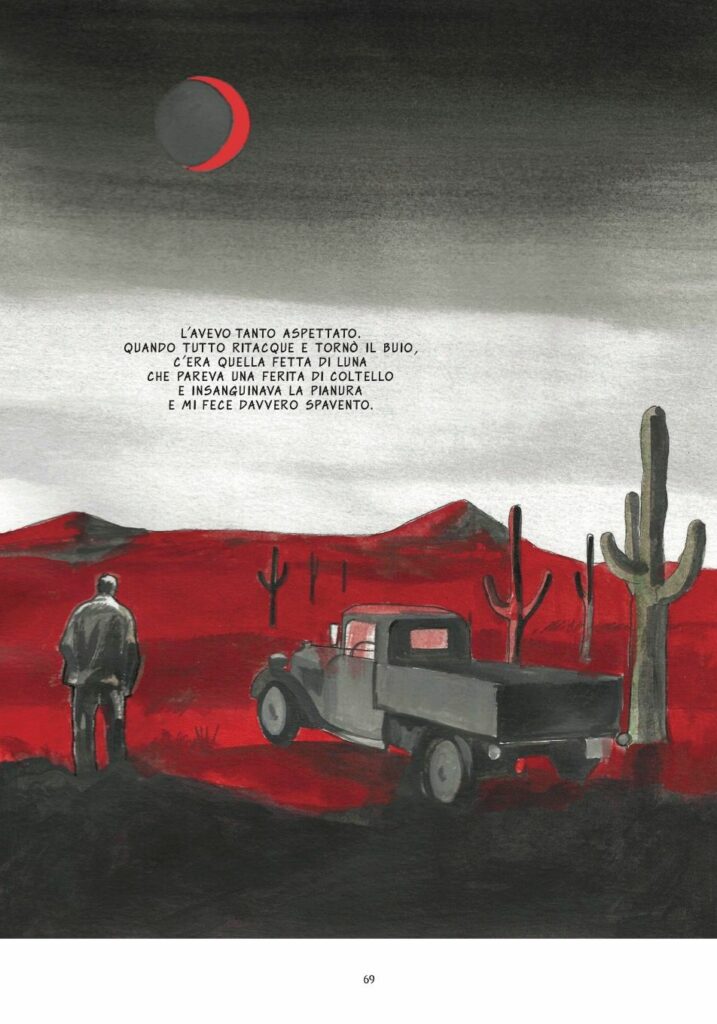
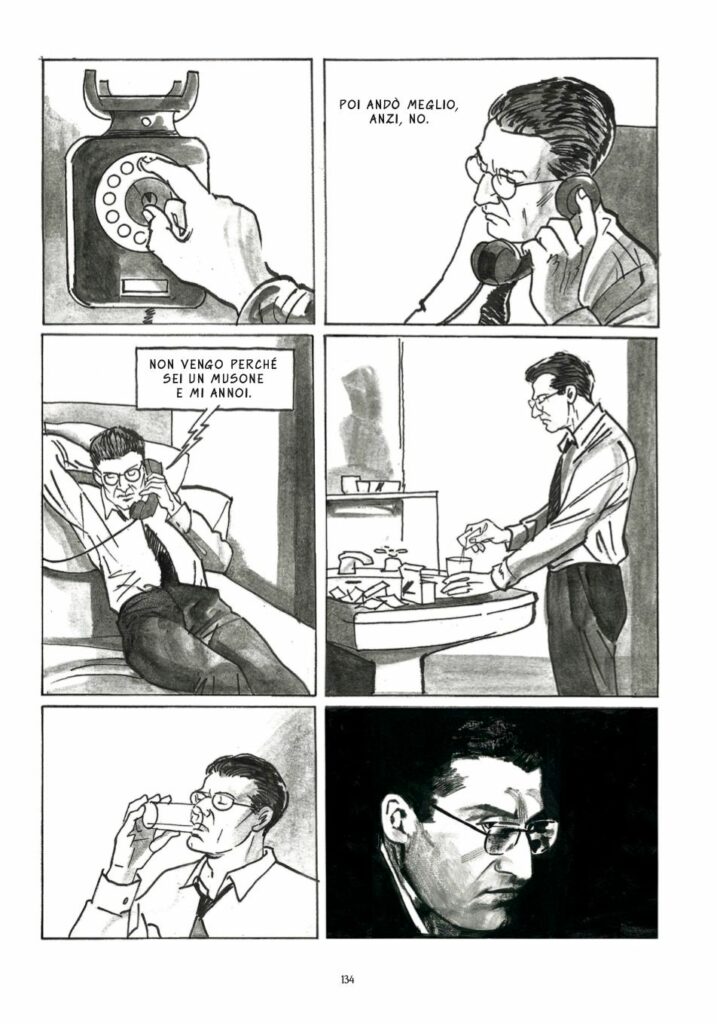
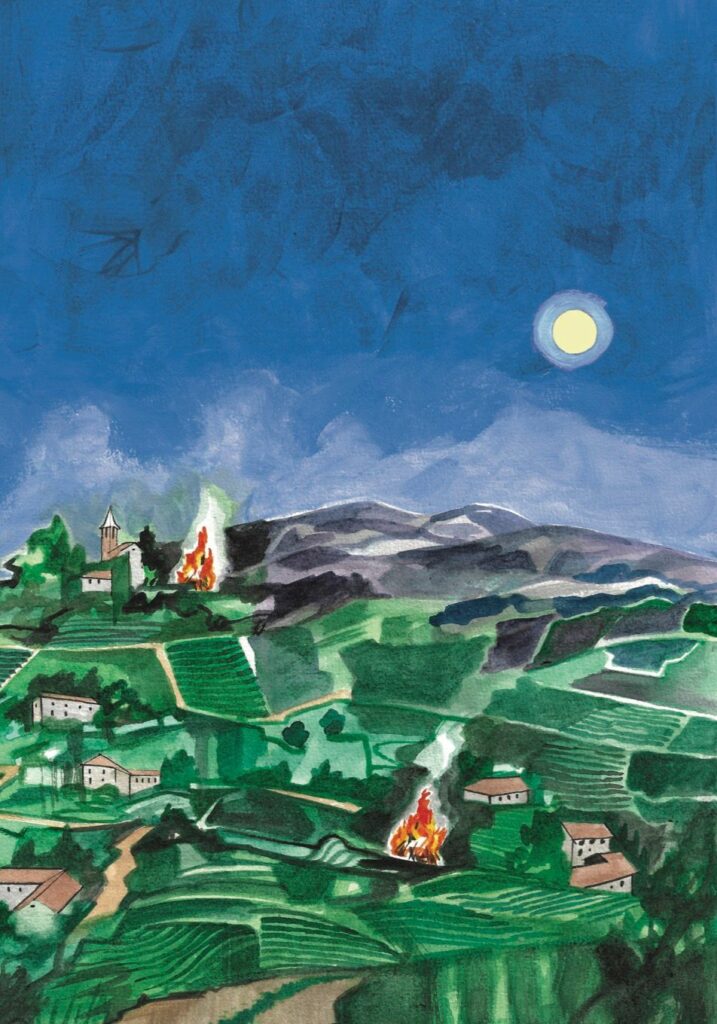


 di Elisabetta Costanzo
di Elisabetta Costanzo




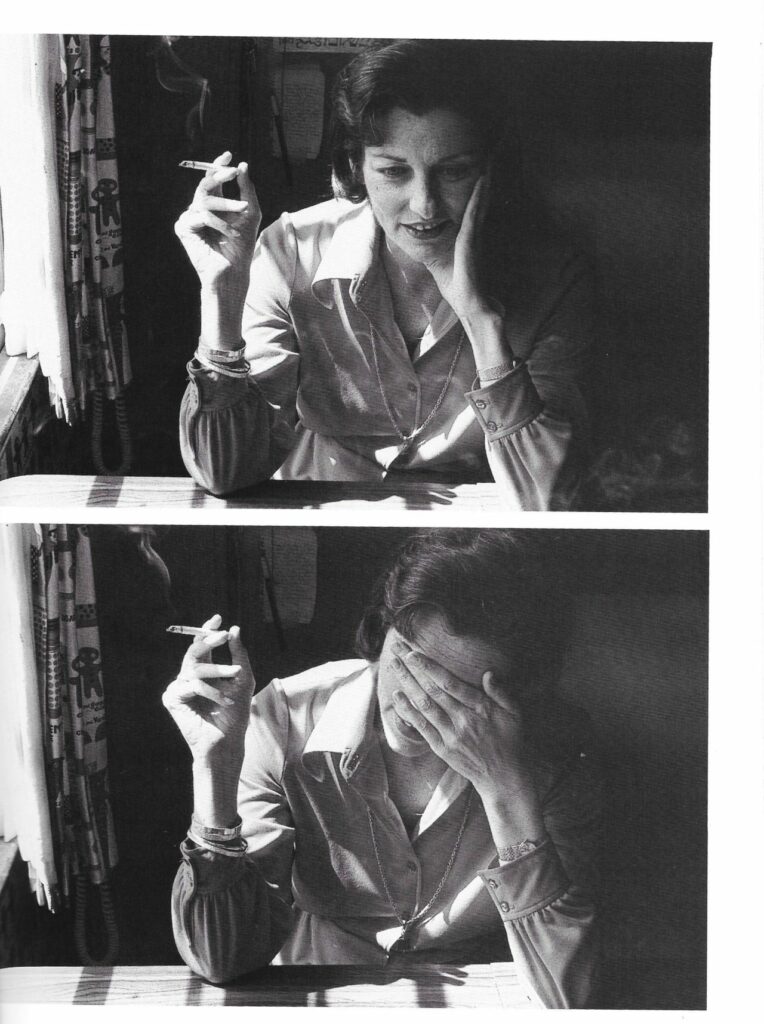 di Anne Sexton
di Anne Sexton