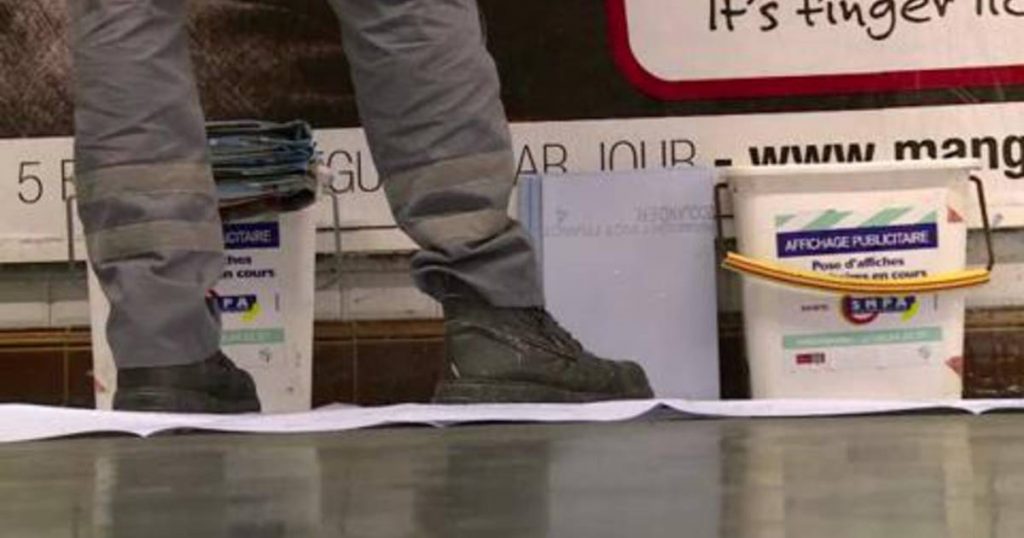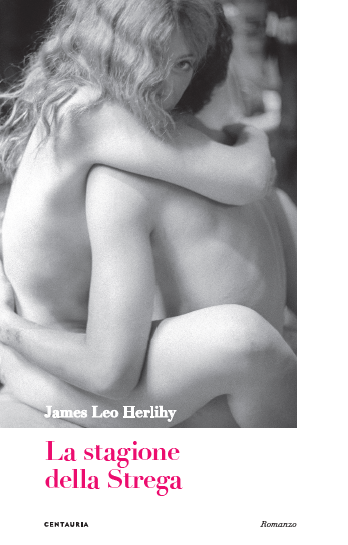[Petizione lanciata dalla SIES – Società degli italianisti dell’insegnamento superiore, Francia, che ha già ottenuto numerose adesioni, in Francia e in Italia, e che vi invito a firmare e diffondere]
https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-faut-il-retirer-la-joconde-des-collections-du-louvre
Ritirare la Gioconda dalle collezioni del Louvre ?
Leonardo da Vinci è morto in Francia, a Amboise, 500 anni fa, il 2 maggio del 1519. La storia della Francia e quella dell’Italia sono strettamente legate da moltissimo tempo, e l’amicizia franco-italiana è il risultato non solo dei fecondi scambi economici tra i due paesi, ma anche della loro storia culturale. Se l’Italia continua ad essere il secondo partner commerciale della Francia, l’insegnamento dell’italiano in Francia è però colpito molto severamente dalla nuova riforma del liceo, che scombussola l’insegnamento di una terza lingua vivente. Inoltre, il numero dei posti messi a concorso conosce da un paio d’anni una caduta senza precedenti: negli ultimi due anni, all’agrégation esterna questo numero è stato dimezzato (con soli 5 posti nel 2019), e quello del Capes esterno è passato da 28 a 16. I posti erano ancora 35 nel 2016, 2015, 2014, e 64 nel 2013. Nessun’altra lingua vivente, nello stesso periodo, ha subito amputazioni tanto violente, che mettono in pericolo l’esistenza stessa di una rete disciplinare fin là destinata a soddisfare una domanda che non sta invece diminuendo. Questo crollo del numero di posti non corrisponde dunque a nessuna disaffezione dei giovani francesi per la lingua italiana; questa politica vessatoria non riflette in nulla la situazione sul terreno, ma anticipa forse la programmazione della fine dell’insegnamento di una terza lingua, che costituisce il vivaio dell’italiano in Francia.
Noi, firmatari di questo testo, donne e uomini affezionati più che mai all’amicizia franco-italiana, convinti che essa deve essere sostenuta politicamente poiché essa è cruciale per il destino dell’Europa, esigiamo un gesto forte da parte del Ministero dell’Éducation Nationale, cioè il ristabilimento di un numero di posti tale da consolidare l’insegnamento dell’italiano (almeno 12 all’agrégation esterna, 35 al Capes esterno), e un progetto di accompagnamento della riforma in favore dell’italiano come lingua di specialità. Chiediamo anche che si metta fine alla politica di eccessiva concentrazione geografica dell’insegnamento dell’italiano e che esso sia proposto nelle scuole pubbliche di ogni dipartimento francese: il numero degli studenti che vogliono cominciare l’italiano all’università è in fortissima crescita, poiché questi studenti non hanno avuto la possibilità di studiare alla scuola media o al liceo la lingua che avrebbero voluto scegliere.
Lasciar morire l’insegnamento dell’italiano in Francia è tanto insensato quanto ritirare la Gioconda dalle collezioni del Louvre, o espungere Dante, Machiavelli, Galileo, Verdi o Eco dal nostro patrimonio culturale. Distruggere l’insegnamento dell’italiano in Francia significa cancellare una parte della storia e della ricchezza della Francia, spezzare i legami preziosi che uniscono da sempre i due paesi: l’amicizia tra Francia e Italia è una necessità vitale, e la cultura ne è il cuore pulsante.
Primi firmatari
Corrado AUGIAS, Jeanne BALIBAR, Julie BERTUCCELLI, Gianni BIONDILLO, Françoise BRUN, Graziella BONANSEA, Lucia CALAMARO, Andrea CAMILLERI, Luciano CANFORA, Ascanio CELESTINI, Annie CHAZAL, Françoise CIMAZ, François CIVIL, Emma DANTE, René DE CECCATTY, Jacques DALARUN, Gérard DARMON, Daria DEFLORIAN, Thomas DUTRONC, Mathias ENARD, Davide ENIA, Paolo FABBRI, Jean-Pierre FERRINI, Roberto FERRUCCI, Elvira FROSINI et Daniele TIMPANO, Julie GAYET, Carlo GINZBURG, Lisa GINZBURG, Eugène GREEN, Stéphane GUILLON, Claude HAGEGE, Giorgio INAUDI, Luigi LA ROSA, Dacia MARAINI, Jean-Yves MASSON, Pierre MICHON, Andrea MOLESINI, Antonio MORESCO, Hilaire MULTON, Florence NOIVILLE, Michel ORCEL, Jean-Baptiste PARA, Michel PASTOUREAU, Ernest PIGNON ERNEST, Daniel PERSONNAZ, Hélène PERSONNAZ, Micheline PERSONNAZ, Renaud PERSONNAZ, Jérôme PRIEUR, Lina PROSA, Francesco RANDAZZO, Vincent RAYNAUD, Ryoko SEKIGUCHI, Raffaele SIMONE, Antonio TAGLIARINI, Valerio VARESI, Catherine VIRLOUVET…
Johannes BARTUSCHAT (Univ. de Zurich), Michele CANONICA (Président de la Dante/Paris), Barbara CARNEVALI (Ehess), Enrico CASTALDI, Lynda DEMATTEO (Ehess), Alain GRAS (Ancien Directeur de l’École Française de Rome), Niel HARRIS (Univ. d’Udine), Jean-Marc de LA SABLIERE (Ambassadeur de France), Yves HERSANT (Ehess), Marielle MACE (Ehess), C. MARAZZINI (Président de l’Académie de la Crusca), Paolo MODUGNO (Sciences Po.), Ivano PACCAGNELLA (Univ. de Padoue), Giuseppe PATOTA (Univ. de Sienne), Giandomenico PILUSO (Univ. de Sienne), Aniello PLACIDO, Roland RECHT (Collège de France), Stéphane SALVETAT (Président du Syndicat des Transitaires de Marseille Fos et sa région), Dominique VALERIAN (Président de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public)…
I delegati della SIES : J.-L. NARDONE (Université Toulouse II Jean Jaurès), S. AMRANI (Université Paris 3), L. BAGINI (Université de Poitiers), D. BISCONTI (Université Clermont auvergne), I. CHIONNE (Université de Nantes), S. CIMINARI (Université Montpellier 3 Paul Valéry), T. COLLANI (Université de Mulhouse), C. COLLOMP (Aix-Marseille Université), R. DESCENDRE (ENS Lyon), V. D’ORLANDO (Université Caen Normandie), L. FOURNIER (Université Paris 8), M. JORBA (INU Champollion Albi), F. LANDRON (Université de Corse Pasquale Paoli), C. LASTRAIOLI (CESR Tours), C. LE LAY (Université Lyon « ), M. LUCARELLI (Université de Savoie Mont Blanc), B. MEAZZI (Université Côte d’Azur), Ch. MILESCHI (Université Paris Nanterre), E. MONTEL (Université de Lorraine), M. NOTA (Université de Bourgogne), C. PANZERA (Université Bordeaux III Montaigne), M. PAOLI (Université de Picardie Jules Verne), A. ROBIN, (Université de Lille), E. SANTALENA (Université Grenoble Alpes), F. SPAGNOLI (Université de Franche-Comté), S. TROUSSELARD (Université Lumière-Lyon 2), I. VIOLANTE (Université Paris I Panthéon Sorbonne), C. ZUDINI (Université de Rennes 2).

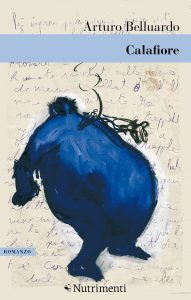
 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese

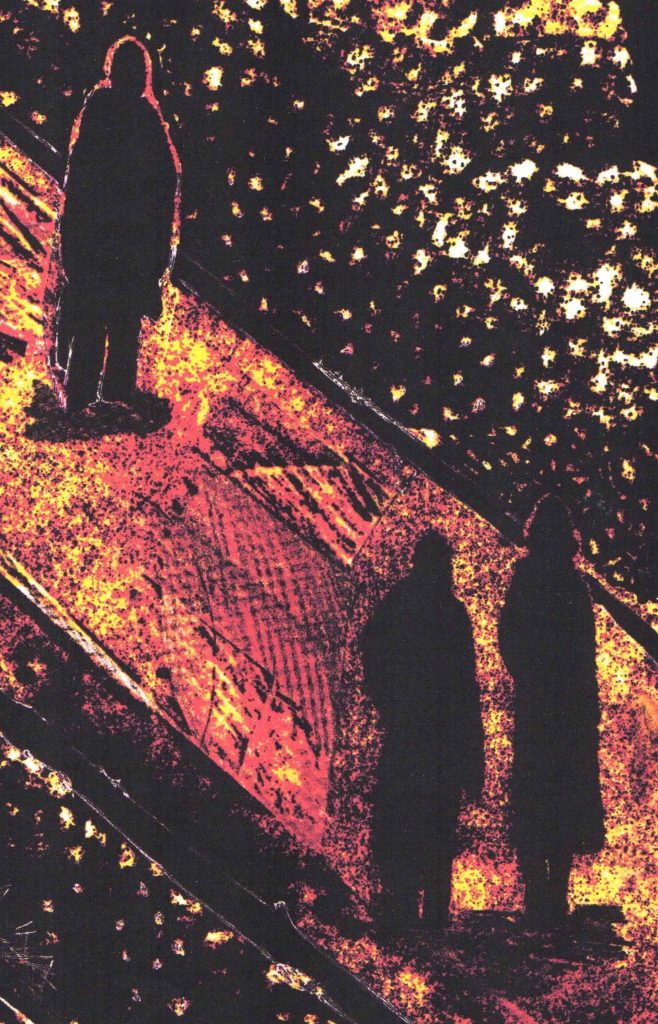
 di Giuseppe A. Samonà
di Giuseppe A. Samonà


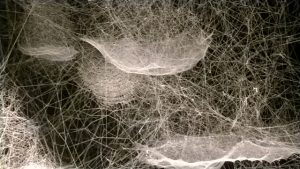




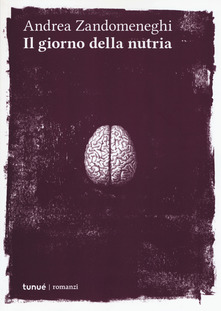



 Nota
Nota



 I
I