La descrizione del progetto L’Anno del Fuoco Segreto, si può leggere QUI.

di Edoardo Rialti
Bisogna pure cominciare da qualche parte, tanto vale farlo dalla Pawa.
Ce n’erano almeno tre migliori, in zona. Alla Runner ci stava pure la spa, a Skoda e Azzurra giravano le ragazzine, con tutti quei corsi coi nomi inglesi, la Pawa invece non cambiava pesi e macchinari da dieci anni, persino la musica pareva più vecchia. Un po’ come certe palestre delle città di mare, che in qualche modo sembrano ferme sempre agli anni ’90. Un’unica sala grande, più altra mezza ricavata da un garage, luci al neon per gli zompi di qualche vecchia la mattina e la boxe alla sera. Il proprietario adesso era un filippino che non spicciava parola, e pareva infastidito a ogni nuova iscrizione. Roba per chi non vuol spendere, barbe bianche in canotta col ventre gonfio e tony, altri filippini, ragazzi che in posti così si sentono più cazzuti ancora. Il Bomba li aveva conosciuti lì, Massimo a tirare di sacco pure lui e quell’altro, Lele, sempre in sala, invece. Massimo si attaccava con un braccio solo alla sbarra, raccoglieva le gambe al petto e guardava Lele alle trazioni. Perché non fa boxe pure lui, gli aveva chiesto il Bomba mentre correvano in cerchio, sembra fatto apposta, quanto cazzo sta sollevando laggiù, cento-centoventi? Quanto è alto, due metri? Che massello porcodio. L’altro, secco e olivastro che pareva uno zingaro, aveva sbuffato un sorriso e scosso indietro i capelli neri, lunghi e sottili pure loro, tastandosi il lobo e accorgendosi che non s’era tolto l’orecchino di brillante. Non ne ha bisogno.
Il sole è già alto ma la nebbia fuma ancora dall’acqua dei canali, lo vela e ne fa una macchia bianca, pulsante. Presto la luce si farà strada, squarcerà ogni velo e i colori diventeranno accesi e belli. Il rosso dei castagni nel boschetto del palazzo sotto di me. Il verde e il giallo dei templi e delle case. Il blu chiazzato di scuro dell’acqua sporca. Chiudo gli occhi sul balcone, inspiro a fondo. Sono nudo, eccetto la corona e i gioielli. Il pettorale di smeraldo è freddo sulla curva piena del petto, lo copre fino ai capezzoli. Ancora ieri sera, al banchetto, gli ospiti lo sfioravano e lodavano, lucido d’olio rosso alla luce delle fiaccole. Ancora ieri notte, le tre dee lo strizzavano e percorrevano con la bocca. Nonostante fosse l’ultima notte, non me n’è venuta alcuna tristezza. Dormono ancora, sul grande letto bianco. Da qui posso vedere le gambe snelle, intrecciate. Ho dato il seme a ciascuna, e adesso il mio pene e i testicoli riposano al tepore della pietra della balaustra, che si scalda. Come tutto è giusto e bello. Sopra di me, Nanauatl stende le braccia in cielo, diffonde il suo calore su tutta la terra. Sotto di me, Tonantzin respira piano sotto e dentro la pietra, adorna di case alberi acque che le gocciolano tra i seni e nelle pieghe del ventre immenso, smagliato da innumerevoli parti. Maishi mi soffia gentile su schiena e natiche. Xochipilli e Xochiquetzal stanno alla mia destra e alla mia sinistra, adorni di fiori bianchi e neri, mi tengono per mano prima di lasciarmi per sempre. Il mio corpo è un libro, le parole frusciano e fremono su cosce e braccia, su fianchi e collo, sulle mie palpebre chiuse.
Per un po’ li si vide spesso insieme, il Bomba e Massimo e Lele, si davano appuntamento alla Pawa e poi uscivano tutti e tre. Di sicuro il Bomba e Massimo, che chiacchieravano entrambi a manetta, Lele non lo si sentiva parlare quasi mai. Il Bomba era magro pure lui, più basso di Massimo, trentacinque anni, napoletano, capelli corti che già mostravano la pelata, tratti minuti che lo facevano sembrare più giovane, occhi tondi. Poi il Bomba non lo si vide per qualche settimana, e quando tornò lo fece a orari diversi, e qualche tempo dopo Massimo e Lele non vennero proprio più. Gli si chiese che facevano. Lui disse che non lo sapeva, non li sentiva. Sembrava volesse cambiare argomento. Si mise pure a parlare con quella coppia di finocchi, uno giovane e l’altro che pareva il babbo. E dire che di solito non se li sarebbe filati di striscio. Lo spogliatoio puzzava di vernice e legno umido. Meglio così, fece chi aveva domandato, con quella pertica d’omo in sala la panca te la scordavi. Oh non si schiodava.
Il Bomba lo chiamavano così perché le sparava sempre altissime e poi faceva Boom agitando il pugno chiuso. Anche l’ultima volta ch’erano usciti insieme, per incontrare una di cui gli aveva scritto Massimo, entrando in macchina aveva appena detto ciao che era già partito. Oh, stasera cazzi durissimi. Boom. Era novembre, faceva freddo, le luci gialle del viale tra gli edifici grigi erano fasci sformati nella nebbia.
Il mio corpo è un libro, strumento di profezia, proclama le imprese di vento e luce del futuro. Il sole adesso brilla in cielo, la foschia sfavilla, l’esercito degli spettri è imperlato di rugiada. Allungano le braccia al cielo, benedicono e si fanno benedire. Le stelle sono gocce di sangue. Non le vedo più, ma premono sulla pelle come spilli, oltre il velo azzurro. Anche loro sono un libro. C’è una canzone, dentro la mia nuca, che si lamenta piano, lontana. Avanza su un corridoio lunghissimo. Presto mi arriverà alla bocca, prenderò a scandirla senza suono, come i bambini che imparano a parlare. Per tutta la settimana ho fatto piovere sulla città, tranne ieri che è stato limpido e fresco. I preti dicono che è una buona cosa, come la pausa per il balzo del guerriero e del leone di montagna, come Mextli che flette le braccia prima di lanciare il giavellotto. Un atto commendevole e gradito a tutti. Sono stato un buon dio, mi dicono. È strano fare qualcosa, e non sapere come. Faccio piovere, sostengo il sole, massaggio le giunture legnose di Omechiuathl, eppure non so ancora come. È legge comune, mi dicono i preti, per bestie uomini e dei. Nessuno controlla davvero il respiro, o il fluire del sangue, le combustioni interne e il sudore sotto le ascelle. Adesso non so come eppure lo faccio. Presto lo saprò, confronterò libro con libro, alto come l’inimitabile falco e continuerò a farlo.
Ohi, spero questa sia troia per davvero, l’altra volta mi son fatto leccare solo le palle mentre ve la giravate, manco in culo se l’è fatto mettere. Il Bomba si accese una sigaretta. Dietro Massimo succhiò l’aria, chiese a Lele se avesse del deodorante nel borsone, perché puzzava. Forse, guarda un po’, disse Lele. Teneva spesso gli occhi socchiusi, come fissasse il sole.
C’era stato anche un altro, qualche mese prima, che chiacchierava meno ma sapeva comunque far da sponda alle cazzate di Massimo, l’alfabeto minimo dei porno guardati da entrambi, tipo darsi il cinque e sogghignare con tutta la lingua di fuori mentre si spartivano bocca e figa. Ma dopo che si erano visti con due tipe e tornavano in macchina e quello sorrideva ancora beato, s’era improvvisamente fatto serio, la fronte appoggiata al finestrino, e aveva cominciato a raccontare che aveva cambiato lavoro da poco perché al negozio di scarpe di prima ci stava ancora la sua ex, e che quella lui non riusciva a schiodarsela e faceva troppo male. Quello nuovo era un posto di merda, il capo stronzo, ma vallo a spiegare a sua mamma che ogni settimana gli scassava i coglioni perché lo stipendio era da meno. Eh eh. Massimo tendeva il gomito del chiodo sotto la luce dei lampioni. Lele prese l’uscita al cavalcavia che portava verso una piazzetta con una chiesa abbandonata, le case basse a ricordare che trent’anni prima qui era ancora mezza campagna. La chiesa aveva una facciata bianca con un affresco sbiadito e arrossato sulla parte inferiore, le figure ridotte a una fila di gambe e sottane. Scendi, disse al tipo, poi gli mise una mano sulla nuca e gli sbatte la faccia a terra, una due tre volte.
Cinque ore dopo il Bomba tornò a casa che aveva la febbre. Non accese neppure una luce, si buttò a letto a faccia in giù, senza dormire senza pisciare, senza mai girare la faccia per paura di guardare la luna. Passò gran parte del giorno dopo seduto sul divano, con le mani sulle ginocchia e la testa in avanti, come se dovesse alzarsi da un secondo all’altro per il suono di un fischio invisibile. Aveva finito le sigarette.
Quando avevano portato l’americana al casolare per una spaghettata di mezzanotte, lei era già sbronza persa. Ridacchiava. Avrà avuto sui trentacinque, ma il bere la appesantiva parecchio. Orecchini pesanti, quasi un anello per dito. Parlava poco l’italiano. Era venuta a trovare una cugina più giovane che studiava a Milano, e aveva fatto sosta a Firenze perché era appassionata di cucina e seconda guerra mondiale. Il Bomba aveva in camera dei bussolotti ritrovati col nonno in Appennino, dove passava la Gotica. Comunque gli ebrei stavano dietro a tutte le guerre, eh. Forse era l’unico che la ascoltava davvero, anche solo per le tette. Massimo annuiva al ritmo della cagate lounge che rifilavano, e intanto buttava occhiate intorno, valutava le altre, si rigirava l’anello all’indice. Il barista aveva il viso arancione per la camicia a quadri e il riflesso del bancone. Lele guardava l’americana. Non sei brava a dire le bugie, lui sorrise appena. Lei si rimise una ciocca bionda dietro l’orecchio in modo così banale da risultare improvvisamente più piccola e vecchia.
La mia nave è carica di fiori, li getteremo sul fiume man mano che procediamo, assieme alle mie vesti e alla corona di piume, mentre dondolo e lamento che il tempo ci spoglia come un’amante impaziente. Ho le narici bagnate di resina, mi aiuta a piangere. Ho le braccia spalancate, sento tendersi tutta le ossa del mondo. Ecco, i miei amici son tutti spariti, e qualcuno sa dirmi dove sono andati? Se lo chiedi al grano, quello scuote al capo, se alzi la testa al cielo, tace.
Vabbè è una figa all’olio di palma, il Bomba mormorava in italiano, guardando avanti, ma quella non avrebbe capito comunque. E che ti frega? Massimo stava sul sedile posteriore che le toccava le tette, mentre con l’altra mano la massaggiava tra le cosce. Tranquillo, il pisello non c’è più. Il casolare era stato dei suoi nonni, ma adesso lo si sistemava solo d’estate per affittarlo. Agli americani, appunto. Sborsavano qualcosa al vicino perché ogni tanto girasse a controllare le staccionate buttate giù dai cinghiali, poca roba. Il viale che scendeva dal cancello era fiancheggiato da pioppi e castagni. Era piovuto parecchio, come sempre a novembre, ma adesso faceva così freddo che pareva quasi di sentire sulla pelle le vibrazioni emanate da una neve che non era neppure caduta. La città era a venti minuti, dal cancello bastava svoltare un angolo e si vedevano le luci di Rifredi. Massimo era passato la mattina per il riscaldamento. Quando furono tutti dentro e la porta si chiuse, l’americana incrociò le gambe, oscillando un po’, le mani dietro la schiena per appoggiarsi al bordo del tavolo. Me lo potete mettere dove vi pare, disse, non si sa bene per rassicurare chi. Lele si tolse la maglietta. A differenza di Massimo che aveva tatuaggi su petto e braccia, era così bianco e liscio che pareva luccicare.
Quando si menava il cazzo alla mattina, poi Massimo se ne restava rannicchiato sul fianco intorno alla chiazza di sborra sulle lenzuola, come un ferito accanto a una pozza di sangue che si allarga. Conosceva musica troppo comune per avere un nome per il basso ronzio di archi che gli si prolungava nella testa. Poi si alzava e faceva colazione. Se sua madre era venuta il giorno prima pulirgli casa, trovava nel posacenere le Marlboro succhiate fino al filtro. Fermati prima, che ti fa male, le diceva sempre, ma lei sorrideva e tirava apposta facendogli l’occhiolino. Oh cazzi tua, nana.
Tutta la terra è un’urna e ogni cosa corre al proprio funerale. Però non temete, ho preso tutto il vostro dolore con me, con me. Il legno della barca è caldo sotto i piedi. L’aria odora di umidità e dolci delle feste. Adesso abbiamo gettato via anche i tappeti. Sulle rive uomini donne bambini mi tendono le dita come tanti occhi. Il mio sorriso è una falce bianca a incontrare le lacrime sulla faccia. Va bene così. Guardate, ciò che avete dato me lo premo sul petto, ogni mano tesa è il mio cuore, con me. Porto il sole sotto l’ascella. Adesso piangete, ma poi riderete, e nessuno potrà rubarvi la vostra gioia.
Nessuno parlava da un po’. L’americana biasciava e premeva la fronte sulla spalla del Bomba sotto di lei, che ogni tanto le prendeva la faccia tra le dita e le faceva Che c’è, eh, eh? e la scopava. Massimo la inculava da dietro, a colpi secchi e affannosi, alzando bene le chiappe, la bocca storta come per una battuta che continuasse a farlo sorridere. Poi si sfilò e fece entrare Lele, che si mise a spingere più piano e a fondo. La tizia rabbrividì. Ah ah. Occhio che mi stritoli, fece il Bomba. Poi sentì che Lele premeva con l’indice accanto al suo cazzo, appena fuori della fica. Te ne apro un’altra, disse Lele. L’americana sbavava sulla spalla del Bomba, ma quando Lele continuò a scavare col dito mormorò I dont like it e guardò il Bomba, stringendolo. Basta, squittì lei. Il Bomba sentì qualcosa di caldo colargli sulle palle e senza guardare capì che era sangue. Lele non diceva nulla, neppure respirava più veloce. Li schiacciava entrambi. L’americana si agitava e urlava. Ma che cazzo, il Bomba la guardava con tanto d’occhi, il pisello smoscio di colpo. Lele adesso le mordeva l’orecchio e lei sanguinava pure da lì. Lei aveva la bocca spalancata e strillava così forte che quasi non si sentiva. Massimo stava in piedi sul letto e si segava, sbuffando quasi fosse incredulo. Quando lui schizzò e Lele finì in culo, si scostarono entrambi e lasciarono la tipa a singhiozzare addosso al Bomba immobile. Lele fumava una sigaretta al tavolo. Massimo riscaldava il caffè. Poi lei si pulì come una bambina che l’abbia fatta grossa, obbedendo senza fiatare, lucida. Ma la fecero bere ancora, e il ritorno se le fece tutto piangendo. Il Bomba pensava che da un momento all’altro le avrebbero detto di stare zitta, ma non lo fecero. La fecero scendere quando furono al Warner Village. Appena fuori della macchina, lei si mise a urlare e sembrò raccogliere qualcosa che voleva tiragli addosso. Loro si allontanarono. I travelli fan sempre casino, disse Massimo, guardando verso lo specchietto di lato. Adesso sedeva lui accanto a Lele. Portarono il Bomba a casa. Quando ripartirono, lui rimase lì, quasi dondolando sulle punte, e una parte del cervello che fischiava si mise a contare le macchine che passarono in quei cinque minuti alle quattro circa di mattina. Comunque trentasette.
Questa non è morte, è più sicura e più calda. È un abbraccio che mi culla, un panno fresco sulla fronte, un ventaglio che tiene lontani uccelli e mosche.
Ne uccisero due, un’altra ancora sbagliò coi denti mentre succhiava in ginocchio e Massimo cacciò un urlo e si scostò come per un dito schiacciato mollandole un ceffone secco dall’alto. Guardò Lele seduto sul divano a giocare alla play, che però non si mosse. La lasciarono andare. Una la strozzarono con una cintura. Era una filippina bassa e lucida, che si era fatta combinare di tutto, incassando i pugni su costole e coccige storcendo appena la mascella sudata. Guaiva banalità. Daddy, daddy, qualunque cosa le facessero. Però ogni tanto, quando non vedeva uno di loro, i suoi occhi guizzavano, come per cercarlo ed ecco, come un messaggero subito scomparso, la paura. Mentre Massimo le stava addosso da dietro e la teneva per i fianchi, fissandosi il cazzo bagnato che entrava e usciva dalla fica, Lele le passò la cintura intorno al collo, e si mise a stringere mentre l’altro le schiacciava la testa sul cuscino. Quando lei finì di sussultare, Massimò prese a spingere più forte ancora, gridando come spaventato che le spinte andassero avanti per conto loro. Poi si buttò di lato e alzò le braccia verso il soffitto, soffiando forte, girando appena i pugni come fosse al volante. Suo nonno lo faceva sempre quando si sdraiava per la pennica. Era morto due anni prima. Aprirono le finestre per rinfrescare, tanto c’erano le zanzariere. Gli alberi frusciavano, a luci spente la luna sarebbe stata un faro.
Lele lavorava all’Ikea di Campi. Tecnicamente era caporeparto ma di fatto agiva perlopiù da libero battitore, gestendo quasi da solo alcuni settori. Nessuno gli stava troppo intorno, e comunque il suo lo faceva. Alle donne piaceva proprio perché sentivano che non gliene importava niente di loro, ogni scambio o battuta una concessione che confondeva e faceva vergognare, come se il flusso costante di una cascata nella sua indifferenza improvvisamente scandisse il tuo nome, e resti sempre il dubbio che sia stato tu a sentircelo. La tabaccaia vicino al magazzino si sorprese una volta ad addentarsi appena una mano e appoggiare la fronte sul bancone, dopo che lui sorrise e fu uscito.
Aveva lineamenti piccoli nel viso grande, che però non lo facevano apparire brutto. Capelli biondi a punte minute, magliette e tony bianchi e grigi, cosce e braccia enormi, dita tozze. A fine turno andava direttamente in palestra per un paio d’ore, e poi a casa. Era un bilocale in una palazzina piuttosto grande. Le stanze bianche e vuote, un paio di mobili degli inquilini precedenti, un grosso schermo per la tv e i videogiochi, le uniche confezioni a riempire gli scaffali subito sotto. Aveva solo ingrandito la doccia a vetri, e quando ne usciva a volte si buttava sul divano e guardava le strisce di luce sulla parete bianca che, percorse dal calore che usciva dal riscaldamento sotto la finestra, sembravano dei rivoli d’acqua. Guarda i documentari di storia, le famiglie mafiose, catastrofi naturali, gli animali. È aggiornato sui tentativi di costruire una città su Marte. Gioca a Rainbow Six, Ace Combat. Nessuna giostra di foto e ricordi a girargli intorno, niente sguardi diretti, e i vicini ignoravano che un simile sole si aggirasse sotto o accanto a loro, a irradiare la sua pigra luce pallida.
Questa non è morte, è più sicura e più calda. È un abbraccio che mi culla, una mano che spiega le grinze del rotolo. Tra indice e pollice reggo un fiore nero di vaniglia, gentile e fermo come le fauci del leopardo sul collo spezzato della capra. Lo vedo riflesso nell’acqua, come il mio braccio e il mio volto. Tra poco mi specchierò nel cielo, come un grande lago rovesciato sulla testa, rintraccerò lo stesso fiore che mi viene offerto con dita di nuvole bianche e carnose.
Un paio non salirono neppure in macchina, inventarono qualche scusa. Una andò in bagno e non tornò più. La seconda, forse la più bella, sicuramente la più giovane, gambe lunghe, davanzale che ci potevi appoggiare un bicchiere, aveva trent’anni. Rossa, con un tatuaggio a farfalla sul collo e un gran sorriso che non arrivava agli occhi grigi. Troppo fard a ringiovanire la faccia. Era arrivata al chiosco già ubriaca. Doveva essersi appena sfilata da un appuntamento deludente, o qualcosa di più triste ancora. Leggings neri, felpa bianca con un negativo di Rigoberta Menchù che nessuno dei due conosceva. Non c’entrava niente con quel posto. Gli si gettò praticamente addosso. Li fece ridere quando chiese alla barista brasiliana come avesse trovato lavoro lì, e quella strinse le spalle e disse che il proprietario voleva scoparsela ma lei non gliela aveva mai data. A non dargliela, scandì lei alzando il gin tonic. Chiacchierava di libri e film a manetta. Son tutta sudata, odio sudare, è colpa di sto piumino. Più tardi le tagliarono la faccia mentre la tenevano premuta contro il tavolo di cucina. Massimo voleva farle la svastica come in quel film di Tarantino, ma non si ricordava da che verso fosse. Lele stava appoggiato con la guancia sul piano accanto a lei, e la guardava fisso. L’ultima cosa che disse, mentre soffiava una bolla di sangue, fu una sequenza di numeri.
Ogni gradino della piramide è di un colore diverso. Grigio mare, rosso pomodoro, giallo senape. Una ghirlanda stesa ai miei piedi, il ponte dell’arcobaleno. A ogni gradino piango, rido. Serro la faccia come una tomba, la schiudo nella promessa della primavera. Giglio, corolla, danza, morte, stella. A ogni passo mi offrono i bambini, le sterili sporgono i ventri secchi. Com’è bello, com’è bello, lamentano le vergini. Non piangete per me, rispondo loro. Ogni tre gradini suono il flauto. In alto il sole pulsa calmo dietro le nubi che passeggiano lente come capre.
Le seppellirono tutte sul fianco d’una collina troppo ripida e smossa e che non si poteva mettere a coltura, poco sopra il ruscello. Confinava con un vicino piantaiolo che vendeva pure statuette da giardino e usava la sua parte di pendio per ammassare copie o pezzi rotti, ma ci veniva solo d’estate. Se avesse avuto più senso dell’umorismo, Massimo avrebbe potuto agitare una mano verso quei nani e cani e Veneri sporchi e silenziosi.
Massimo aveva lavorato al bancone di un forno vicino casa, ma una volta aveva litigato col ragazzo che faceva pratica di notte e il tipo gli aveva dato uno spintone davanti a tutti. Adesso faceva i pomeriggi alla rosticceria dello zio, un ex-pugile coi capelli tinti color ruggine, e nei fine settimana pure ci veniva pure suo fratello, che stava finendo il Tecnico e giochicchiava a calcio. Aveva una smart per cui lo zio lo prendeva sempre per il culo. Quando faceva un passaggio lungo accompagnava la parabola strascicando un Belloooo. Ogni tanto pure Massimo tirava un po’ con lui, nel giardino vicino al negozio. A un canestro da basket giocavano un ragazzo e quella che pareva la sorella, molto più brava di lui. Massimo li guardava. Lei aveva la coda e due macchie di sudore sotto le ascelle della maglietta verde, con le maniche arrotolate. Lui quando faceva centro chinava la testa come per un applauso, e allargava le braccia quando scazzava. Oh, sei sempre tu, gli avrebbe voluto dire Massimo. Agli amici del fratello Massimo piaceva. Commentavano le tipe su tinder o instagram, sotto le macchie d’alberi intorno allo spiazzo giallastro delimitato da zaini e cappotti, gliele facevano vedere e lui succhiava la sigaretta elettrnoica, socchiudeva gli occhi e sentenziava figa, figa.
È possibile vivere senza danzare mai. È questo che disse lei allungandosi tra loro col braccio steso per prendere il whisky. Ci credereste? Era un po’ che non tornavano a questo pub, e quella sera era pieno. Fuori faceva freddo e c’era odore di cappotti umidi. Lei indossava una camicia rossa a scacchi, aveva un capellino bianco a visiera e i capelli lunghi e crespi, tinti di nero. Jeans e stivali. Culo e tette reggevano. Naso grosso, zigomi alti, pelle scura e rugosa di chi passa tutta l’estate ad abbronzarsi, labbro inferiore pieno e sporgente, forse rifatto. il khol sotto l’occhio sinistro e basta. Orecchini d’oro a cerchio ampio. Un anello a fiore nero che le copriva indice e medio. Cinquant’anni o giù di lì. Con la mano del bicchiere indicò verso il piano rialzato dove c’erano una decina di tipe con cappellini come il suo, sotto dei festoni. L’addio al celibato della grassona al centro. Una lì mi ha appena detto che non ha mai ballato in vita sua. Un po’ tardi per cominciare, fece Lele. Quel che dico anch’io, perciò ora mi finisco questo e taglio la corda. Perché hai truccato un occhio solo? Chiese Massimo. Perché, stella stellina, e lei si batté sul khol, con questo non ci vedo. Quindi è il mio lato artistico, guarda carino. E sì scostò i capelli dall’orecchio sinistro, e in cima alla mascella c’era quella che pareva una B tatuata. Che tu sei, una che dipinge? Lei fece una mezza linguaccia e rovesciò gli occhi. Scherzi? Sono agente immobiliare, però faccio anche un po’ di radio. Figo, allora una volta mi ci inviti. Massimo teneva gli occhi socchiusi come fosse nella nebbia, un sorriso blando che gli penzolava in faccia. S’era già fatto due canne. E sei sposata? Lele stava sullo sgabello col gomito poggiato sul bancone, la guardava a sua volta con un accenno di sorriso. Ho sposato la miseria, che vuoi che ti dica. Lei si passò un indice dal collo al seno, dove correva una cicatrice che proseguiva sotto. M’hanno tolto uno stronzo grosso come un pugno. Aperta dalla testa ai piedi, due volte. Ce l’ho uguale sul retro manco fosse una zip. Lele aggrottò appena la fronte bianca. Non sei di qui. Lei alzò il bicchiere e inclinò la testa, con un gesto che non voleva dire niente. Ho viaggiato. Tipo? Lisbona, Nairobi, Bangharth, parecchia Turchia, posti così. A ogni nome, Massimo annuiva come ci fosse stato. E voi chi siete, miei cari? Avete niente per salvarmi la serata? Qualcosa ci si inventa, Massimo la fissava occhi socchiusi, la mano sulla fronte. Lei sbuffò. Nella mia esperienza, quando mi si dice così è probabile non si cavi gran che, ma magari voi due qui, pupazzetti segnatempo, col sole in tasca mi fate cambiare idea. Ti va del fumo? C’ho della roba che in due tiri ti fa vedere Bob Marley. Non che Massimo l’avesse mai ascoltato, ma ripeteva quel che gli diceva il suo pusher, un peruviano che spostava le macchine dei calciatori. Ah, tesoro, se non mi fa sudare rugiada azzurra non è che mi interessi. Oh ma come parla questa? Massimo guardò Lele con un sorriso incredulo. Riempio i vuoti, stella stellina. A volte dietro il nulla c’è il nulla e basta. Anche tu lì, gigante biondo, pesca e nocciolo, non è che siccome stai zitto ci acquisti in fascino. Lele la fissò più attentamente. Ecco spiegato il trucco, proseguì lei, magari ti credi un oracolo, portavoce di chissà che dio. Però diamo un’occhiata a quello che nascondi sotto tutto quel gilet di carne. Massimo si ficcò le mani sotto le ascelle e arricciò le labbra per un lento fischio senza suono, eccitato e spaventato come un bambino cui insultino il babbo per strada.
Non sono mai stato su questa cima prima d’ora. Per un anno il tetto squadrato è stato coperto da panni bianchi che adesso sono arrotolati ai bordi come grossi tronchi umidi. L’altare di pietra è stato bagnato con acqua calda più volte, persino adesso. Fuma ancora. Intorno stanno i preti, così ridicoli e bravi coi loro mascheroni. Le zanne, le lingue penzoloni, gli occhi cavi dovrebbero farmi paura, invece ho un groppo in gola, come la madre che senta recitare il proprio bambino nel coro. Stendo una mano a benedirli, per l’ultima volta sento il calore sui polpastrelli. Poi sulla cima soffia il vento e anch’io sono freddo e vuoto. Raggrinzisco come un verme mentre mi spogliano, mi stendono sulla pietra, mi legano i piedi e le mani sopra la testa. È giusto che abbia paura, è amore anche questo.
Nel bagno degli uomini, i bordi dello specchio quadrato sono percorsi da citazioni scritte col bianchetto. Vasco Rossi, Irene Grandi, Negramaro, Muse e Green Day. Altri hanno aggiunto sticker e frasi a pennarello subito sotto. Dino cisi. Maria ha le gambe di iuta. Viva España. Un tizio piscia ingobbito nell’orinatoio mentre Massimo si lava le mani, sciacqua la faccia. La musica e il vocio fuori sono uno sciabordio come di risacca. Si guarda nello specchio, osserva la fossetta sul naso per la cicatrice della varicella. Pensa se farsi un secondo buco all’orecchio. Il vetro non si accartoccia in un grappolo scuro. Non c’è alcun messaggio tra le strofe e le iniziali, nessun accordo in minore nella pausa tra due respiri. Ci siamo così abituati che la terra sia tonda e ogni passo avanti ha il conforto di riportarci comunque indietro. Per un attimo semmai il fumo gli dà l’impressione che il tipo stia curvo e dondoli manco trattenesse una risata. Che appena fuori della porta l’intero pub lo aspetti in silenzio per vociargli sul muso. Si fissa con un sorriso immobile. Sbuffa. Madonna puttana. In strada la tipa e Lele lo aspettano davanti alla loro macchina. Lei fuma col gomito della destra poggiato sul dorso della sinistra, lo guarda col naso sollevato, gli occhi accesi d’una lucina divertita, come due ciliegie lucide. Lui tiene le mani tasca, la supera di tutta la testa.
Le paludi lontane rilucono come un mare. Le barche nei canali sono foglioline vizze. L’aria è percorsa da uccelli trasparenti, preghiere, fili tenui e invincibili. Li colgo con la coda dell’occhio, mentre cielo e terra si capovolgono e mi stendono come un panno teso. Ora tutto l’azzurro è un grande occhio spalancato a incontrare i miei. Sento delle mani a coppa sulla nuca. Questa non è morte, è più sicura e più calda, un fiume vasto, profondo.
In macchina lei puzzava di profumo troppo forte e sigarette. Chiese di sedere davanti, abbassò il finestrino e continuò a fumare fino alla villa. A quella distanza da Massimo e con Lele che guidava, lei faceva loro qualche domanda, parlava di scarpe, delle api che sparivano, un’estate passata in un theyyam, il Tibet che è come l’Abetone ma con le scimmie, guardava le luci gialle e arancioni, il cielo d’inchiostro, gonfio. Mi piace fumare insieme al vento, diceva, pare che te la succhi via pure lui.
Questa non è morte, è più sicura e più calda. È un abbraccio che mi culla, una mano che spiega le grinze del rotolo. Conosce tutte le mie ossa, le numera nel segreto. Già la stipa per il salto nel sole.
Quando furono nel vialetto e scesero di macchina, lei si mise a guardare il bosco e il pendio, le mani sui fianchi, pensosa. Faceva meno freddo, sarebbe potuto essere ottobre, aprile. Lele la osservava con un sorrisino incuriosito. allora, chiese, entriamo o ti riportiamo a casa? Massimo si arrestò sulla soglia e lo fissò incredulo. Lei si girò. Scherzi, dopo tutta questa strada? Si tolse le scarpe e immerse i piedi nel ghiaino. Sospirò come li stesse lavando nel bidè. Allargò le braccia, una scarpa per mano e si diresse verso la porta, un piede davanti all’altro quasi fosse una sfilata. Fai strada, nottolo.
Gli astri sono mosche, i pianeti sono ragni. Premono invisibili oltre la corte azzurra. Ripenso a quando bambino facevo torte di terra, vicino al fiume. Non sapevo allora che zanzare e tafani mi parlassero già di oggi e che il brivido per quel coccio nel piede e il sangue che arrossava il fiume freddo, mi sarebbero rimasti compagni silenziosi, sempre accanto, solo la prima lettera del discorso a venire, infinito, avanti e indietro lungo tutta la danza, gli occhi sbarrati come quelli dei cavalli, il calcagno che batte, le mani a intrecciare volute di fumo. Ho un singhiozzo per tutto ciò che non conosco e non avrò mai.
Quando furono in casa, lei tirò il fuori il cellulare per fargli sentire Andy Scott. Massimo le scoccò uno sguardo. Lascia stare, qui il telefono non prende. Lei lo appoggiò al tavolo e il pezzo partì. Un ronzio che faceva avanti e indietro, il beat in 4/4. Abracadabra, lei gli fece l’occhiolino. Lei diede loro le spalle e prese a girare piano per la stanza, ondeggiando spalle e culo, i gomiti stretti al fianco. Guardava le foto accanto al camino. La prima comunione d’una bambina, un matrimonio. Un pranzo con parecchia gente sotto un gazebo in estate, cocomeri, probabilmente ferragosto. Sapete che ai bambini si dilatano le costole quando si eccitano? Lei guardava le foto, sempre ondeggiando le anche. Ricordo una figlia di mia cugina, come se ne stava a cavalcioni del babbo e si strusciava contro la testa, aveva già afferrato il concetto. Lui ovviamente non aveva capito nulla, ma io sì. Puttanella, Massimo la fissava sorridendo a bocca schiusa, Me la presenti? Nah, non sei il tipo, troppo sbatti, colle bimbe ci vuole tatto. Pozzangherine delicate. Hai visto troppi porno scadenti, le faresti scappare a gambe levate. Oh ma che sei una sbirro? Massimo tornò a fissare il cellulare. Ora mi offendi. Massimo guardò Lele. Se lui ci aveva pensato, non pareva preoccupato. Lei adesso aveva proseguito lungo la stanza, esaminava il vecchio poster stinto della Forestale coi vari tipi di funghi. Mi piace fargli il solletico, ai bambini, improvvisamente siete da tutta un’altra parte, solo tu e loro. Porte che danno su altre porte. Massimo dondolava sul posto, quasi in punta di piedi, gli occhi guizzavano verso Lele. Lui aveva una sigaretta accesa in bocca, e aveva aperto il frigo e tirato fuori una birra. Non la guardava. Vi siete fatti proprio un bell’ambientino qui, sì sì. Invulnerabile, compiuto, diceva lei, studiando il tetto a travi, la cesta della legna. Bello pieno, bello sodo. Lele poggiò la lattina sul lavandino, spense la sigaretta. La gente segue il ritmo delle canzoni, proseguì lei, ma dovrebbe essere il contrario. Ne dici di stronzate. Lele le diede un calcio sulla schiena che la buttò a terra con uno sbuffo. Massimo sussultò. Lele continuava a prenderla a calci, facendola strisciare intorno al tavolo, le chiedeva piattamente Hai viaggiato, sì? E dove? E giù un altro calcio. Lei a ogni colpo singhiozzava un gemito. Una mano salì su per una gamba di legno, come fosse cieca. La tirò su senza sforzo e schiacciò sul tavolo. Lei respirava forte, l’occhio sano fissava l’incerata bianca con la frutta. Massimo si era calato i pantaloni e si toccava nei boxer. Lele le tirò giù jeans e mutande. Aveva un sedere grosso è un po’ sformato, abbronzato pure quello. Lele prese a sbatterla da dietro, e quando lei gli rivolse il lato cieco lui disse Che cazzo guardi? e le abbatté un pugno sulla faccia. Da allora lei tenne faccia sprofondata nel tavolo come bevesse da superficie d’acqua. Massimo s’era tolto la maglietta e le scarpe e si menava, tenendosi un po’ lontano. Aveva i piedi venosi come le mani. Non gli veniva particolarmente duro e continuava a sorridere scialbo, quasi imbarazzato. La musica andava avanti, Ulvo, Sombre Lux, roba così. Sotto pareva fischiasse un bollitore. Lele spingeva meccanicamente, la fronte lievemente corrugata, come fissasse un’equazione o un intaso nel traffico. Improvvisamente lei taceva, ma dopo un po’, sempre nascosta dai capelli, la voce di lei rimbalzò impastata su dal legno. Io sarò una pollastra vecchio stile, ma qua sotto comincio a far la lista della spesa. Chiudi quella roba, disse Lele a Massimo e come le due cose fossero collegate le diede un altro pugno sulla nuca. Ci fu un verso acquoso. Quando la tirò su lei aveva il nasso rosso e c’era una macchia scura sul tavolo. Massimo stava sul divano e Lele gliela buttò addosso. Lei soffiò una risatina. Pavana e rigodone, proprio, biascicò sulla sua spalla. In culo, fece Lele. Massimo armeggiò, eseguì e lei cacciò uno strillo che pareva quasi un nitrito allegro e raddoppiò quando Lele da dietro aggiunse pure il suo e le si buttò addosso. I due cazzi sfregavano a ritmi diseguali, la testa di Lele era una palla scura. C’era un odore acre, di sudore, un filo di merda. Semilasciateoradimenticotutto, urlò lei tutto di fila, a scossoni. Nonètroppotardipertornareindietro. Lele la strinse più forte e Massimo la tenne per i polsi. Lei espirò manco quella reazione l’avesse sollevata. Massimo ebbe un tremito, le fissava le tette sulla maglietta alzata, i capezzoli grossi e scuri come acini, come occhi di vacca. Premuta sulla pancia, sentiva la fica pulsare, come una boccuccia che scandisse muta qualcos’altro. Poi lei si raddrizzò di scatto tra loro e prese a ondeggiare con la testa e la faccia tutta rossa, le mani che sbattevano sui polsi, come una bambola pazza. Pure Lele si scostò un poco. Bello sodo, bello pieno! Urlò lei. Dio maiale, a Massimo faceva male l’uccello, la guardava tenendo indietro la testa. Cavale l’occhio, disse Lele. Eh? Massimo faticava a restare dentro. Il cazzo gli pizzicava, quello più tozzo e grosso di Lele gli premeva sotto il glande. Cavalo. Un po’ incerto Massimo alzò una mano in faccia a lei e spinse con l’indice. Lei urlò e provò a scuotere la testa, ma Lele le bloccava il collo col gomito. Lei si pisciò addosso. Urlava come le si schiudessero i polmoni dopo un’immersione. Il sangue le scorreva sulla faccia, gocciolava sui tatuaggi di Massimo. Lele le morse il collo e di riflesso Massimo il naso. Adesso lei respirava forte, con voce più bassa. Si sentì uno schiocco quando Lele le spezzò il collo. Un lampo bianco. Cazzo! In risposta schizzarono entrambi, o qualcosa di simile, perché Massimo urlò portandosi le mani in faccia e Lele si sfilò di scatto sbuffando come si fosse scottato. Dondolava la testa bassa, gli occhi chiusi. Per qualche istante nessuno dei due ci vide più. Ma porco dio. Massimo la rovesciò di lato sul divano e si alzò barcollando, tirandosi su i pantaloni. La stanza puzzava di zucchero e sangue. Senza neppure guardare Lele, trovò la porta quasi a tentoni e uscì.
L’altare è ruvido sulla mia schiena, il cielo in parte è schiarito. Stracci tenui lo percorrono come strascichi bianchi. Tutti gli odori spiccano, le pitture sui corpi e le maschere di legno, la pietra bagnata. Sento le voci più in basso, come un mormorio confuso, uno sciabordio di lodi e cordoglio. C’è una canzone, dentro la mia nuca, non mi sforzo più di contenerla, non posso. La mugolo senza parole, mentre mi tendono braccia e gambe. Sento delle nocche corrermi sulla coscia, l’inguine, il ventre, si ficcano sull’ombelico, risalgono, si staccano, una mano verde e avvizzita mi fa ombra sulla faccia, scorgo una maschera di drago piumato, un braccio verde e rattrappito e ho una scarica di panico, perché niente dovrebbe essere storto, qui, nessuno spazio per brutture e imperfezioni. Il sudore mi cola lungo le ascelle. Le costole sobbalzano. La mano ritorta mi struscia sulla guancia, fredda, e mi ci abbandono. È tutto giusto, anche la paura e l’orrore, come potremmo sennò saltare in alto senza questo vuoto nella pancia, questo sasso nella gola che si spacchi all’ultimo singhiozzo del cuore?
Fuori pioveva appena. Gocce grosse e rade. Il bosco oltre ghiaino e staccionata frusciava tutto nel buio azzurro. Massimo stava piegato con le mani sulle ginocchia, fisava la trama dei sassolini bianchi. In qualche momento doveva aver afferrato il chiodo, perché adesso lo indossava sul torso nudo. I rami si scostavano e poi si riunivano di nuovo, come quando uno è contento e fa così con le mani. Era tutto sudato. Gli girava la testa. Troia, troia, diceva. Sputò quello che aveva in bocca. Oplà, ehi. Alzò la testa verso la voce. Appena oltre la staccionata, dove il pendio scendeva verso una conca sotto gli alberi, suo nonno spuntava con la testa, e gli faceva cenno con la mano. Oh nonno, che tu ci fai lì? Massimo era infastidito. Shhh, shhh, vieni giù, shhh. Massimo barcollò fino alla staccionata, la scavalcò e scivolò accanto al nonno. Shh, ecco, stiamo qui, buoni. Il nonno gli spazzolava il chiodo. Aveva cappello e giacca chiara, tutta zuppa di foglie. Le ombre gli mangiavano il nasone, come avesse una pallina scura da pagliaccio. T’ho chiesto che ci fai qui. Stai giù, ti ho detto. Ce la tua mamma dall’altra parte che tira i sassi alle compagne. In effetti ogni tanto si udiva un tonfo. La pigliano per il culo a scuola, perché è nana. Se ne sta lì, mezza nella merda, e tira. Massimo provava a sbirciare oltre il bordo. Ma il problema tanto non è quello, disse il nonno. È che lo sanno. Sanno cosa? Cosa tu combini là dentro. Massimo si sentiva le gambe molli, aveva freddo alla pancia. Chi lo sa? Tutti. Tuo zio, il tuo fratello. Come lo sanno? Il perticone, quello lì, spiegava il nonno, si è messo d’accordo con la donna di plastica, là dentro. A casa non puoi tornare. Troia, disse Massimo e vide la camera del fratello, come fosse dall’angolo, in alto, i poster degli zombie, i rapper tatuati, Atzori, la foto con Pulgar sul Viale Fanti, e suo fratello nudo e con gli occhiali su una biondina tutta bianca, mentre le sfrega e picchiettava il cazzo sulla fica rasata. Non lo vedeva in faccia, solo la nuca e i capelli ricci e biondi pure loro, ma lei faceva la linguaccia sogghignando e Massimo sapeva che pure suo fratello aveva la bocca storta e la lingua fuori, e mentre lei tremava come per il solletico e gli appoggiava i piedi sul petto e lui le tirava le tette tutto soddisfatto, ridevano di lui. Si sentiva accartocciare la pelle della faccia. Tremava pure lui, incazzato e chissà che altro. Negli occhi del nonno c’era un luccichio divertito. Sai com’è, quando si inizia con la stregoneria non si sa dove si finisce, gli diceva quasi scusandosi. Eh? Fece Massimo. Guarda qui, guarda, e il nonno si apriva giacca e camicia e su tutto il petto bianco e floscio aveva una grossa bolla lucida coi bordi rosati, che oscillava come dentro ci si spostasse del liquido. Se la premeva coi pollici. Oh non si apre, via. Ma Massimo ora non lo guardava quasi più. Sapeva in qualche modo che Lele stava per tagliare la corda, lasciandolo qui nella merda, e una rabbia spaventata lo scuoteva tutto. Stronzo. A me bastava scoparmele, stronzo, ripeteva lamentoso. Teneva le dita ficcate nella terra scura e umida, prese a risalire. Sentiva le formiche zampettargli sul dorso. Scrollò le mani prima che gli si infilassero nelle maniche. Senti – gli disse il nonno alle spalle, mentre si appoggiava di traverso un indice sull’unghia dell’altro – giacché vai dentro, non è che puoi portarmi mezzo sigarino? Ma shh, eh.
Le luci nella casa brillavano alle finestre come un fuoco che non ha sfogo.
Questa non è morte, è più sicura e più calda. Oh la punta di selce che affonda è una luce bianca, oh la mano che scava è un’onda rossa sugli occhi. Oh io mi torco, mi sollevo e mi tormento. Oscillo sulla barca del mondo. Brucio. Il sole non mi acceca più. Oh. C’è sangue sulla mia bocca. Sangue nel naso e gli occhi. La luce se ne va, succhiata via. La luce ritorna, mi avvolge come un velo spesso. I mondi sono punti neri. Leoni e gazzelle si inseguono nella scia delle comete. Le mani mi tengono giù, le nocche storte mi strusciano sulle labbra, un’altra mano è dentro, mi fruga sotto le costole. La testa è una nuvola leggera, il corpo trema come le montagne e i mari, il culo trabocca limo fecondo. Mi sciolgo. Chi è che grida con tanto dolore. Io no di certo. Sbuffo e soffio, sì. Soffoco. Tutto si tinge di rosa. Sento le mie ossa. Guarisco. Capisco. Mi rannicchio intorno al cuore come la mano che lo stringe. Sbatto le palpebre come il colibrì. Gliela bacio a ogni battito. E il mio primo ordine è di tirarlo via.
Lele sedeva accanto al tavolo, la testa bassa, come chi si rannicchi e avanzi contro un vento forte. Assorbiva il fragore come di cascata lungo le pareti, il suolo instabile. Registrava con curiosità imparziale la sensazione che la sua macchina fuori fosse in fiamme, e pulsasse scarlatta attraverso il muro, il khol sotto l’occhio socchiuso della donna, adesso a destra, che si spostava a intervalli ora sotto il mento, ora sulla fronte, come delle lancette. Lei stava sul divano con la testa rovesciata, i capelli che ricadevano a terra, la bocca aperta che vomitava un arcobaleno che si stendeva sul pavimento come una nebbiolina. Sentiva scalpicciare al piano di sopra, armeggiare nel salottino accanto, quello col camino. Inalava cauto quella che pareva lacca, mentre il respiro si regolava. Una volta aveva preso della DPT e gli effetti erano stati più o meno questi. In quel caso la pioggia pareva risalire. Voleva alzarsi a prendere del latte in frigo, ma aspettò ancora un po’. Si annusò il collo che profumava come la tipa. Dovevano essere le tre, le quattro. Qualche uccello rovesciava delle scariche di versi, a metà tra una risata e un trapano. Si alzò. In piedi, quel velo colorato sul pavimento si notava meno, in compenso gli alberi fuori si muovevano senza suono e sui vetri delle finestre parevano scorrere come navi scure e fracassate. L’unica cosa a dargli veramente fastidio era il pensiero di essersi beccato qualcosa al cazzo. Guardava la donna sul divano a occhi socchiusi e un abbozzo di piega sulla bocca, il che era quasi un cenno di assenso, per lui. La porta si aprì di colpo e Massimo rimase sulla soglia, battendo col pugno sullo stipite. Merda lì, oh merda che sei. Lo fissava a occhi sbarrati, scalzo e nudo sotto il giubbotto, e batté ancora una volta come per dirgli di farsi sotto. Lele sbuffò una risata incredula. Massimò gli corse contro, agitando i pugni come una scimmia, urlava. Lele gli diede un pugno che lo buttò a terra. Si sarebbe fermato lì, forse, ma Massimo si agitava manco andasse a fuoco, scalciava che pareva lottasse ancora con lui, invisibile e addosso. Vomitava bestemmie una attaccata all’altra. Ti ammazzo ti inculo. Lele lo guardava con la testa un po’ inclinata. Alzò il piede e glielo calò sulla bocca. L’altro fece per prendergli la gamba, aveva l’orecchio tutto rosso. Lele liberò il piede e lo abbatté ancora, più volte. La testa di Massimo scattò all’indietro. Lele gli sfracellò una mano col tallone, e Massimo si chiuse a bozzolo, sbuffando a occhi strabuzzati, come fissasse qualcosa sotto la credenza. Gli sfuggì un singhiozzo. Lele riprese a colpirlo sulla faccia. L’altro si sgolava, quasi di sollievo, come inalasse aria buona. Tossì una risata. Cazzo. Rattrappiva nella nebbiolina arcobaleno, un vecchio verme bianco con la testa tutta rossa, i lunghi capelli zuppi, il sangue nero sui denti. I tonfi parevano spari che esplodessero di luce bianca nel silenzio. Lele colpì ancora, e l’altro si fermò e il corpo della donna scivolò giù dal divano.
Questa non è morte.
È in piedi su Massimo. La nebbia adesso è sparita. Gli odori risucchiati via. La sneaker sinistra è un pugno rosso di polpa. Un clacson lontano annuncia i camion diretti alla variante di valico. Sta per chinarsi a slacciarsi la scarpa per non gocciolare altrove e dover pulire di più. Non avrà problemi a reggerli entrambi, uno dopo l’altro, Massimo e la tipa, ma vuole comunque usare i divani di salotto e camera da letto. Sta per chinarsi quando nel silenzio, distinte, nella testa gli risuonano le parole miele di vipera. Si ferma mezzo curvo, in ascolto, come guardandole scritte davanti agli occhi. Le smonta e rigira tra le mani, perplesso. Alza la testa verso la donna morta e quella ha la fronte sul pavimento e la bocca storta, chiusa. Tutto tace, e lui sa che nessuno verrà, che li getterà entrambi in una buca vicino alle altre, e poi si guarderà entrare in macchina e partire. Non ci saranno problemi. Magari andasse solo così, non succedesse niente. Il silenzio e il vuoto e lui al centro come un muro bianco di calcina, al sole. Meglio se avessero fatto a cambio, lui e la tipa, e adesso fosse lui a guardarla seppellirlo in quel corpo rotto. La terra gli premerebbe sugli occhi e lui se ne resterebbe lì sotto, a pulsare piano. Meglio se il cadavere sorridesse con la bocca storta. Però ci sono quelle parole, e lui sa che uscire e partire è solo una delle cose che farà. Un’altra è restarsene lì, a succhiarsi le mani, vergognandosi di doversi nutrire di quella crema bianca e spumosa che gli cola fuori da ditoni sbucciati come banane scarlatte. Un’altra è girare per le stanze, e ritrovarsi vecchio e muto in una casa di cura col cazzo ritto che brucia sulla sedia a rotelle e un diospero mezzo mangiato, mentre le infermiere passano e arrovesciano gli occhi. Si guarda i pantaloni. I vetri delle finestre sono pannelli scuri. Vede i corridoi e le voci che si rincorrono, le porte non aperte, già tutte aperte, come un gioco al pc che si allarga e basta e non procede mai. Stanze su altre stanze. C’è un guaito, dentro la sua testa, e sa che talvolta monterà fino a stendergli un velo, rallentare le azioni, e sarà una bambina scopata con una stecca da golf, o una bottiglia, e il vecchio di prima a sputargli sugli occhi improvvisamente troppo duri. Bello pieno, bello sodo. Da qualche parte c’è l’ingresso per una scuola in cui farsi strada col fucile, svuotandolo sulle teste di ragazzi e insegnanti. Pow pow pow. Basterebbe varcala, sfondarla, cavalcare la marea, tutte le urla, i cani sfracellati e i barboni che si agitano bruciati vivi, farsi travolgere, la testa bassa come a incontrare un’onda, integro. Si aprirebbe un varco a testate silenziose. Stringerebbe le vite che strillano in ogni sigaretta che si accende e spegne tra le dita. Invece rivede certi sorrisi sghembi del lampredottaio che pareva nervoso e forse non lo era, una macchia sul soffitto delle docce di palestra, la zingara fuori dell’Ikea la domenica, la voglia pelosa sulla scapola di Massimo. Geometrie insignificanti, trappole, goccioline di sudore sul sorriso che si schiude in discoteca sotto le luci viola e arancio. Cosa credevi, che il sole e mare lavorino tanto per una merda come te? Si vede accennare dei passetti di danza. Bello vuoto, bello pieno. Magari si trovasse quella tintura scura sotto l’occhio, glielo sbarrasse come lo sguardo d’un uccello di pietra. Da qualche parte lui va dalla polizia ancora con la scarpa sporca di sangue, dichiara tutto e finisce in cella, a crogiolarsi sulla branda come fosse su un’amaca. Invece sa che si guarderà uscire e partire, uccidere oppure no, fare cose che detesta o non capisce o crede di capire, mentre il suo corpo si guasta e deperisce oppure no. Si umilierà davanti a dei coglioni, risulterà ridicolo. Tornerà dai suoi a Rovigo. Si beccherà apposta l’aids, lo passerà. Questa non è la morte. Dimagrirà. Sulla panca arriverà a duecento chili, non gliene fregherà nulla. Le donne gli diranno sì o no per un ticchettio che sente nella testa, una specie di secondo squillo nel telefono che non dovrebbe esserci e invece c’è. Avrà il vento gonfio come avesse inghiottito un pallone, pieno di tutte le urla. Le cagherà di corsa quando meno se lo aspetta, ridacchiando tra le lacrime. Finirà alle poste. Stiperà le torture a sciaguattare in secchio di plastica, per recapitarle obbediente dove devono essere posate. Compirà prodigi cui non aveva mai pensato, verrà riposto nel taschino con un buffetto. Perché lo scherzo è bello quando dura sempre.
**
Immagine di Francesco D’Isa.
Edoardo Rialti è editor de L’Indiscreto e scrive per Il Foglio e Minima e Moralia. Per Mondadori traduce J. Abercrombie, R. Morgan, GRR Martin.









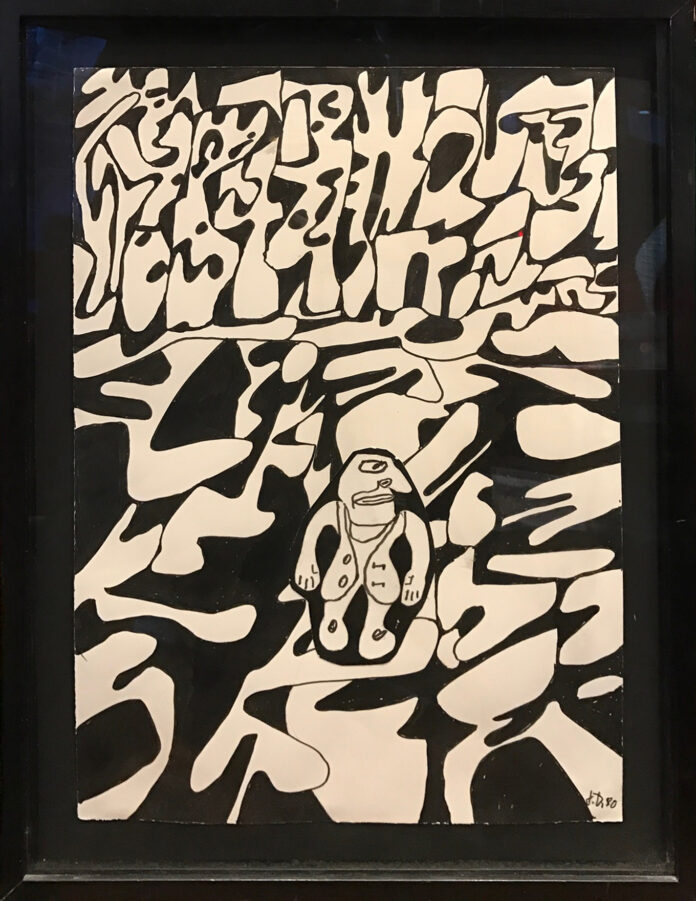

















 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi
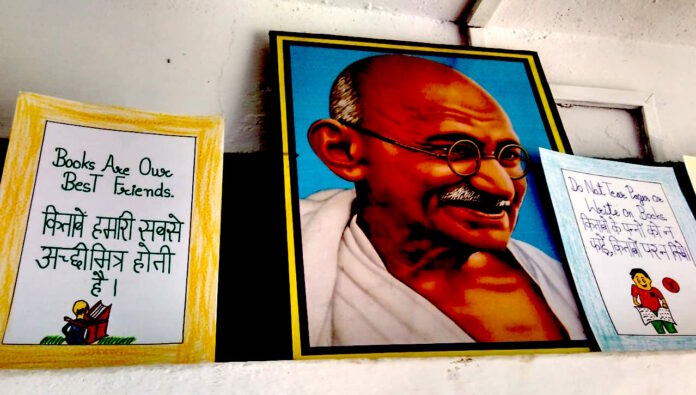
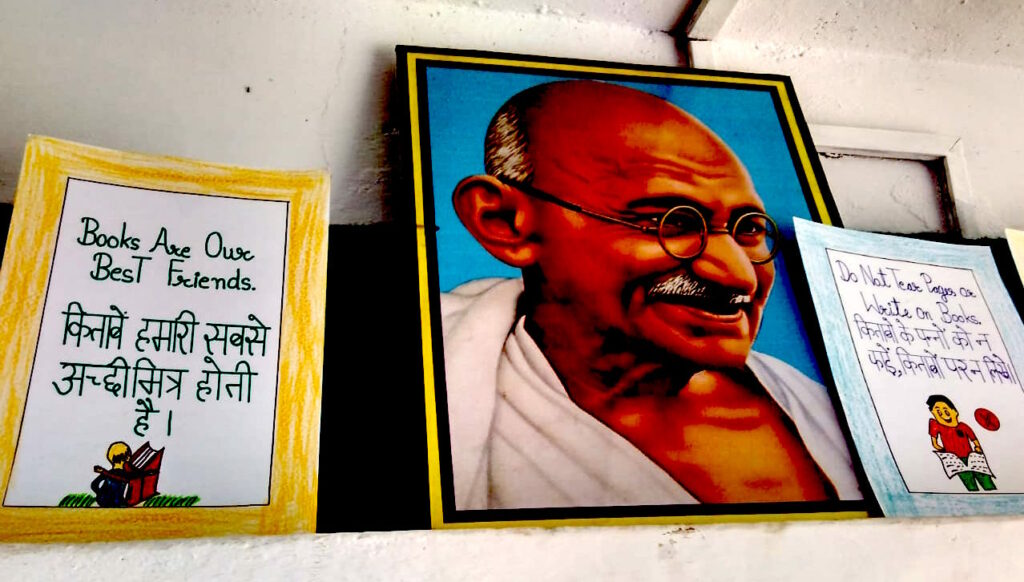 di R. Umamaheshwari
di R. Umamaheshwari 
