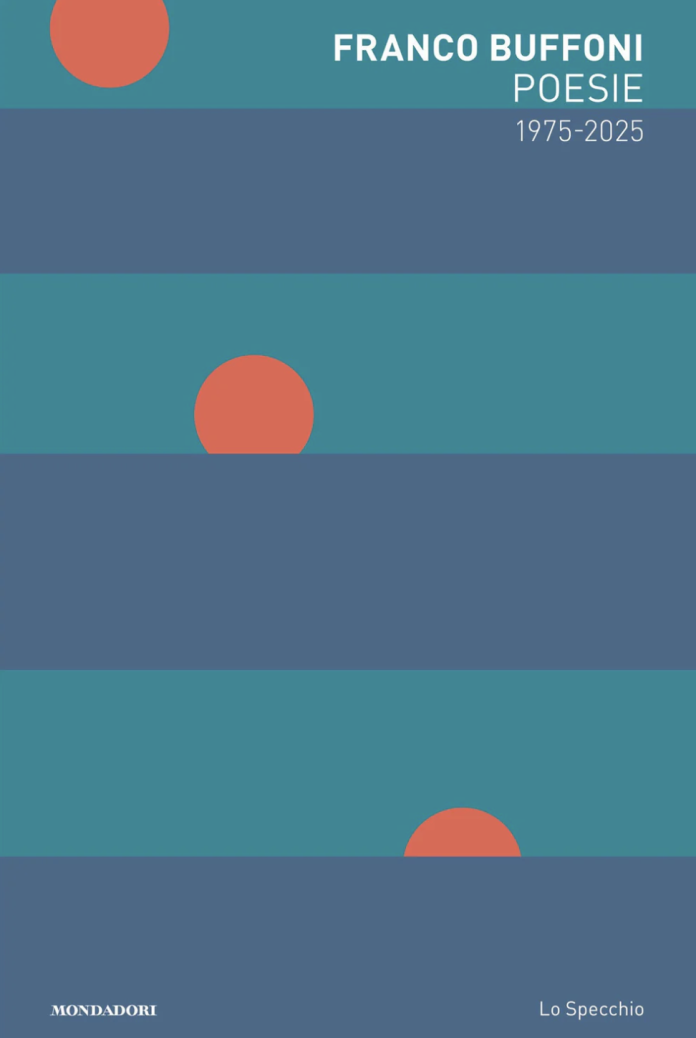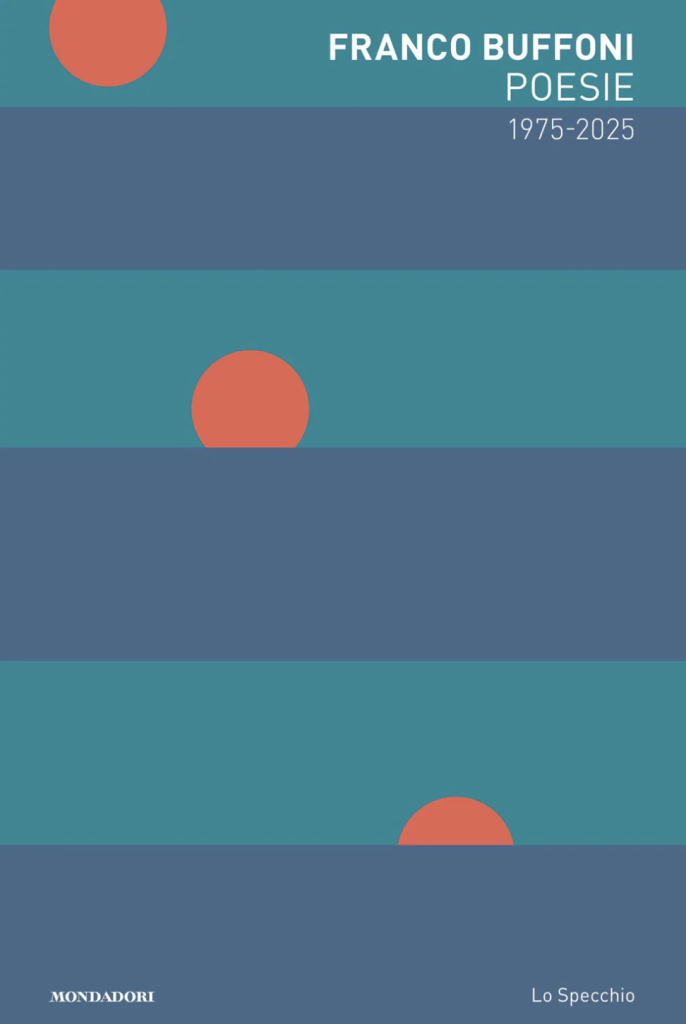[Pubblichiamo due estratti dal volume di Pierre Legendre La fabbrica dell’uomo occidentale seguito da L’uomo come assassino, a cura di Massimo Rizzante, Mimesis, 2025. Il primo estratto è parte del saggio introduttivo del curatore, e il secondo è tratto da L’uomo come assassino.]
Un ribelle conservatore
di Massimo Rizzante
Chi è stato Pierre Legendre?
La miglior definizione ce l’ha data lui stesso: “Un uomo del passato e del lontano avvenire”. Ergo: un uomo non troppo amato nel corso della sua vita. Un solitario con pochi amici, dispersi in vari continenti. Un uomo refrattario ai conformismi. Un intellettuale originale, versatile, polimorfo, un “animale parlante” difficile da classificare in quel parco umano di mode e spirito gregario che è il mondo universitario. E soprattutto uno studioso ai margini di tutti i movimenti composti da intellettuali in carriera, quasi sempre in vena di prediche.
Un ribelle, insomma, in aperto dissidio con il presente in virtù del suo sguardo profondo e ine- dito gettato su tutta la tradizione occidentale, da Atene a Roma, da Firenze a Parigi, allo scopo di conservarne i vincoli affettivi, morali e sociali contro la loro rapida dissoluzione – tanto dissennata quanto entusiasta – in nome di diritti, leggi, valori delle cui nozioni non si desidera più rintracciare né origini, né genealogie.
Ma un ribelle conservatore. Più che un para- dosso, una sfida, la sola possibile, nella nostra epoca dei “paradossi terminali” (Milan Kundera) in cui “l’animale che parla”, cioè l’animale diven- tato uomo attraverso la parola, sembra volersi congedare da ogni limite logico, semantico, istituzionale, per correre a briglie sciolte verso la libertà.
(…)
Mi chiedo: una volta aumentata artificialmente la nostra intelligenza, una volta privati di alcuni arti e organi e sostituiti da arti e organi biosintetici, una volta clonati, avremo ancora bisogno di una ragione per vivere? Avremo ancora bisogno del mistero? E di quel mistero chiamato alterità?
C’è una Urszene al centro dell’intera riflessione antropologica di Legendre: la scena dello Specchio:
Quando mi guardo allo specchio, si instaura una scena a tre: c’è un individuo che si guarda, il suo cor- po che si presenta; e poi, c’è l’immagine nello spec- chio, un’immagine che è la metafora dell’inaccessibi- le; e c’è il terzo termine, lo spazio insuperabile, che è la metafora del potere assoluto, lo Specchio.
L’universo umano è sempre diviso. L’uomo è “l’animale parlante” che coglie le cose attraverso il linguaggio. Mentre nomino una cosa, me ne separo e mi separo da me stesso. Il linguaggio è il nostro “sfregio”, come dice Legendre, il nostro marchio primordiale. Ciò significa che “l’animale parlante” intrattiene con il mondo un legame di identità e alterità e che ogni individuo intrattiene con sé stesso un legame della stessa natura.
Mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Mi guardo in una fotografia e mi chiedo chi sia quell’uomo con gli occhiali che mi osserva da lontano. Ascolto la mia voce registrata e non la riconosco. Chi è che sta parlando? Io sono la mia immagine (o la mia voce), ma anche un altro, uno sconosciuto. Chi tiene insieme questi due individui? Legendre afferma: un terzo termine, che però deve rimanere oscuro, inviolabile e che è “metafora del potere assoluto”, lo Specchio. Lo Specchio è il legame dogmatico e istituente che permette la relazione tra me e l’altro che sono e che non conosco. Ma, aggiunge, è anche il vinco- lo giuridico tra creditore e debitore che lega due individui e che fonda una civiltà. “La verità dello Specchio non si discute”.
Che cosa succede in una civiltà la cui ideologia individualista distrugge tale logica ternaria? Che cosa accade quando questa civiltà si mette a discutere l’autorità dello Specchio, facendosi portatrice del tutto è possibile, dell’assenza di ogni limite, dell’abolizione del mistero?
Capita quel che descriveva poeticamente il mito di Narciso: lo Specchio è in qualche modo dissolto, la struttura dell’identità è compromessa. L’esperienza istituzionale del XX secolo prova che uno Stato, come un individuo, può delirare […] sotto i nostri occhi l’ideologia individualista funziona come un narcisismo di massa che fa dell’individuo “un mini-Stato” (Wim Wenders), vale a dire un essere che è tutto per sé stesso, che è Dio affrancato dalla logica dello Specchio.
*
L’uomo come assassino
di Pierre Legendre
1
L’assassinio abita nello spirito dell’uomo. L’uomo pensa ad uccidere. Sogna di uccidere. Commemora i massacri.
Sin dall’inizio della storia dell’umanità e fino ai nostri giorni, l’assassinio fa parte delle abitudini sociali e delle grandi messe in scena religiose e politiche.
L’uomo lo sa, come sa che sorge il sole e che scende la notte.
Ma all’improvviso… Sì, all’improvviso! La terra interiore si mette a tremare. Ecco che l’individuo, un uomo come tutti gli altri, sente tintinnare i sonagli della follia: si suicida, uccide qualcuno, o uccide qualcuno e poi si suicida. E qui ha inizio, in tutte le civiltà, il mistero dell’assassinio.
Ricordo il mio stupore infantile. I gendarmi erano venuti nella mia scuola. Indagavano su un assassino, un ex alunno: che genere di bambino era? Quali erano i suoi voti? E le sue relazioni con i compagni? Un mondo, allora, mi si è aperto: il lato oscuro dei nostri atti – il marchio del sospetto, i segni premonitori del crimine, la vita del bambino criminale.
Mi domandavo: coloro che avevano crocefisso Gesù, avevano ricevuto bei voti? Erano bravi ragazzi? Le cose si confondevano nella mia mente di scolaro.
Qualcosa non quadrava. Presentivo vagamente che c’erano due specie di omicidi. C’è, infatti, omicidio e omicidio. Un omicidio che non è davvero tale: quello che esegue il boia, il soldato, il militante di una causa – un omicidio preventiva- mente giustificato, un lavoro, insomma, un gesto professionale. E c’è un altro omicidio, quello vero, commesso dall’assassino, che chiamiamo crimi- ne; c’è il gesto di uccidere, ma di uccidere per conto proprio.
Nella storia che racconterò – una storia tratta dalla cronaca – la frontiera tra l’omicidio che non è davvero tale e l’omicidio commesso da un assassino sembra venire meno.
Il giorno 8 maggio del 1984, un giovane caporale dell’esercito canadese faceva irruzione nel Parlamento del Québec con l’intenzione di ammazzare tutti i componenti del governo. Correndo attraverso i corridoi e sparando con un’arma automatica su tutti coloro che incrociava, Denis Lortie giunse ben presto nella Camera dei de- putati. Quel giorno, però, in Parlamento non si teneva nessuna sessione e la sala era vuota. Così andò a sedersi sulla poltrona del presidente. Ne seguì una trattativa per disarmarlo. Dopo la sua resa, si contavano tre morti e otto feriti.
Durante le prime ore, si parlò di attentato politico. L’attentato, per certi aspetti, risultava comprensibile; tanto più che, secondo un sondaggio realizzato da una radio locale, la maggioranza dei cittadini sembrava approvarlo.
Tuttavia, ci si dovette ricredere, arrendersi all’evidenza: il soldato-giustiziere non aveva agito per nessuna causa. Era appena salito alla ribalta commettendo un crimine assurdo. Armato fino ai denti, aveva ucciso in un contesto sontuoso e monumentale. Ma i morti e i feriti che giacevano a terra non erano attori. Esausto e ammanettato dai poliziotti a una sedia, Lortie non era altro che un relitto, un essere sollevato ma sconvolto, un ordinario assassino.
Era pazzo? Era sano di mente? L’affare Lortie aveva inizio. Un caso classico per la polizia e i giudici, un boccone prelibato per gli squali della cronaca, una vicenda oscura per tutti noi, perché racchiude la miseria del nostro tempo – la mise- ria dei senza legge del nostro tempo.
2
Quando ho cominciato a interessarmi al processo istruito contro Lortie, ho aperto i diari di Dostoevskij e ho letto: “È possibile attraversare un fiume su una trave, ma non su un truciolo di legno”.
Allora ho pensato: quel che mi affascina è proprio questo: la catastrofe, osservare la catastrofe. Ho guardato Lortie come si guarda un naufrago dopo che è annegato. Guardiamo con compassione un essere umano che non c’è più; ma anche con il timore e la furtiva soddisfazione di non essere lui, di appartenere ancora al mondo dei vivi. C’è lui e ci sono io; l’assassino e noi, gli innocenti, che attraversiamo la vita su una trave senza andare incontro alla catastrofe.
Mi domando: che cosa ci lega, che cosa mi lega a quell’uomo?
Perché l’intera società – la società degli innocenti – si applica con tanta passione a scrutare l’assassino e a soppesarne il crimine, a mettere in scena, in quel teatro che è la Giustizia, la catastrofe di qualcuno?
Perché, ad ogni crimine, ad ogni assassinio, siamo colpiti nel nostro intimo più profondo, più segreto, più oscuro: nello spazio di un istante ci rendiamo conto che potremmo essere quell’uomo, quel naufrago, quell’assassino. Ad ogni crimine, ad ogni omicidio commesso, bisogna apprendere di nuovo il divieto di uccidere.
Ecco perché le società organizzano delle messe in scena in cui si recita il duello tra l’assassino e tutti gli altri.
Recitare tale duello significa, nella cultura occidentale, istruire un processo che ricordi, a nome di tutti, la scena dell’omicidio compiuto, e fare in modo che l’omicida risponda del suo atto davanti a noi.
Siamo davvero consapevoli che un processo contro un assassino non è un regolamento di conti, ma un rituale di separazione dal crimine? Siamo sufficientemente civilizzati per riconoscerlo? Orrori senza nome, vendette di massa, umiliazioni, enormità abolizioniste e autocompiacimento di coloro che, in nome della scienza, pretendono di gestire la violenza, abomini sui crimini e sui criminali; tutto ciò avrà mai fine?
Per l’assassino, rispondere del suo gesto vuole dire separarsi dal suo atto di morte e, come diceva Dostoevskij, che conosceva bene la crudeltà del suo tempo, riconciliarsi, foss’anche in carcere, con gli uomini.
Il processo Lortie ci impartisce una lezione su cui meditare.
Dato che la strage si era svolta nelle aule del Parlamento del Québec, diverse telecamere ave- vano registrato una parte dell’attentato. Durante il processo la trasmissione coinvolse Lortie in un faccia a faccia pubblico con sé stesso: il colpevole Lortie guarda qualcun altro, guarda l’assassino Lortie mentre dialoga con un funzionario del Parlamento che cerca di disarmarlo.
Estratto dalle riprese del video di sorveglianza del Parlamento del Québec
Lortie è seduto sulla poltrona del presidente.
Lortie: Sono pronto. Non esiterò, cazzo!
Lortie spara alcuni colpi di arma da fuoco.
Al questore del Parlamento René Jalbert che sta entrando:
Lortie: Signore, trovi un riparo. Jalbert: Come va?
Lortie: Sono un po’ fuori, cazzo. Non le pare? Jalbert: Beh, sì…
Lortie: Ti sorprenderò, appartengo all’esercito. Jalbert: Anch’io sono un soldato.
Lortie: Ne è sicuro? Jalbert: Sì.
Lortie: Che pensa dell’esercito?
Jalbert: Ho passato trent’anni nell’esercito. Lortie: Il mondo ride del nostro mondo, cazzo.
Jalbert: Che cosa ci fa lì?
Lortie: Cosa succede qui? Ci sono merde di poliziotti come lui. 1, 2, 3, 4, 5 … 29.
Jalbert: Vuoi che andiamo a parlare fuori? Lortie: Di che cosa vuoi che parliamo?
Jalbert: Volevo sapere perché distruggi tutto? Lortie: Non distruggo, volevo uccidere. Ma non c’è nessuno…
Jalbert: Ah! Sei arrivato troppo presto. Lortie: Che cosa vuol dire troppo presto? Jalbert: Oggi non cominciano prima delle 14. Lortie: Mi avevano detto alle 10.
Jalbert: No, alle 10 cominciano domani.
Lortie: Ah è così! E adesso che faccio? Che ne pensa come soldato?
Jalbert: Beh, come soldato, se fossi in lei…
Dopo un po’, Lortie accetta di lasciar uscire le persone che erano ancora nell’aula.
Lortie: Uscite. Jalbert: Esca, signora.
Lortie: Escano quelli che si sono nascosti. Jalbert: Uscite tutti.
Un poliziotto interviene dal balcone.
Lortie: Vuoi parlare con me. Come mai? Che cosa ho fatto?
Policier: Perché lo hai fatto? Lortie: Questa è la politica! Policier: La politica?
Lortie: Se ne vada.
Dialogo a bassa voce tra Lortie e Jalbert. Jalbert: Dai, andiamo. Denis, Denis, il tuo ber- retto.
Lortie: Ah sì, il mio berretto. È l’esercito. Jalbert: Così sei un buon soldato.
Nel corso del processo ci fu un momento in cui si raggiunse il culmine del pathos: Lortie si allontanava dalla morte sotto lo sguardo di tutti.
Un giornalista riassume così il cambiamento dell’imputato: “Mentre cercava le parole per spiegare al suo avvocato il significato di certe espressioni presenti nel video, Lortie, che era parso calmo per tutta la proiezione (circa quaranta minuti), è crollato a causa dell’eccessiva pressione. In piedi, al banco dei testimoni, ha prima abbassato la testa per alcuni secondi e, senza dire una parola, ha lasciato l’aula delle udienze piangendo e disperandosi, per poi dirigersi verso l’anticamera degli imputati. I due agenti della sicurezza che lo controllavano lo hanno seguito e, a un certo punto, lo hanno sentito emettere nell’arco di pochi secondi un grido acuto e alcuni suoni incomprensibili. Si è appreso più tardi che Lortie era stato isolato in una stanza e che si era a poco a poco calmato. Dopo una sospensione di quarantacinque minuti, ha riguadagnato il banco dei testimoni, apparendo più disteso”.
Così si è spezzato il giogo della follia.
Lortie, davanti al giudice, affermerà: “Non posso dire ‘non sono io’. Sono io. Che cosa vuole che le dica di più? Mi ha fatto davvero male quando ho visto il video. Bisognava che lo vedessi. Bisognava che attraversassi questo momento”.
(…)


























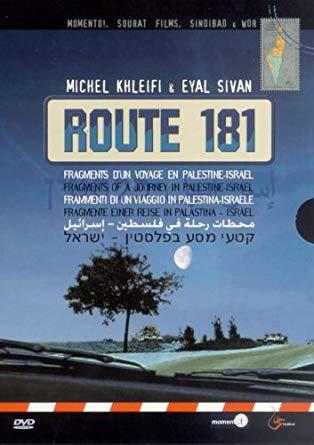
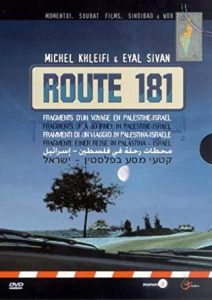




 “Se leggendo la Recherche la realtà mi balzava agli occhi e mi prendeva la gola, cosa era stata allora la mia vita, se non una finzione?”
“Se leggendo la Recherche la realtà mi balzava agli occhi e mi prendeva la gola, cosa era stata allora la mia vita, se non una finzione?”


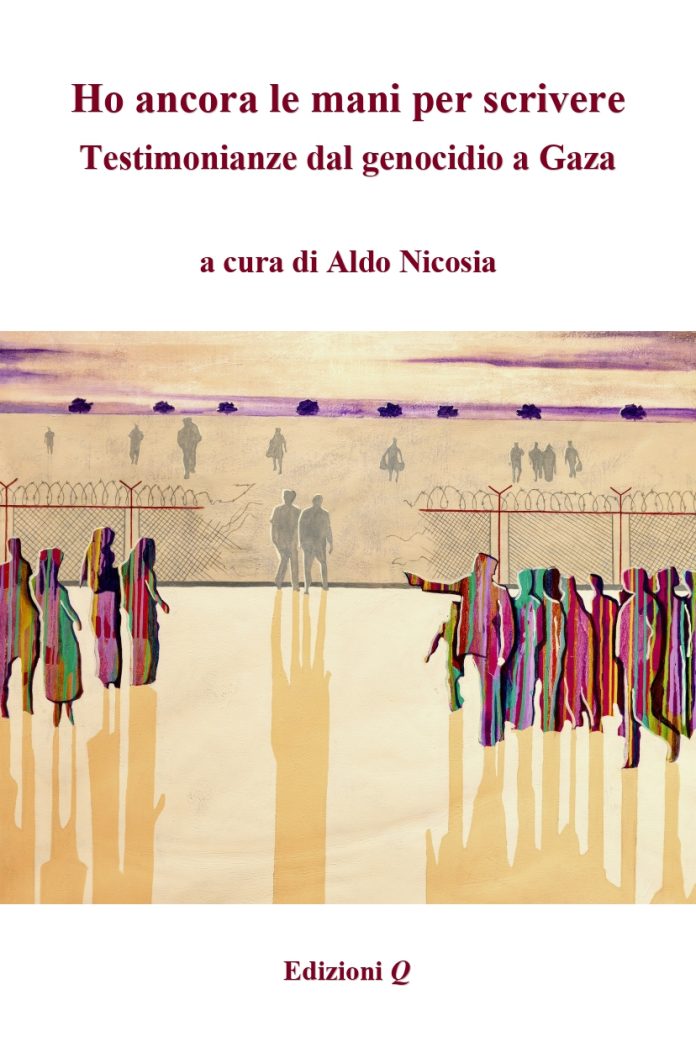
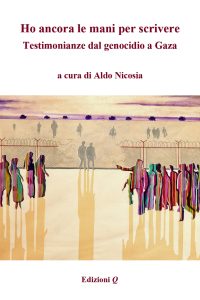

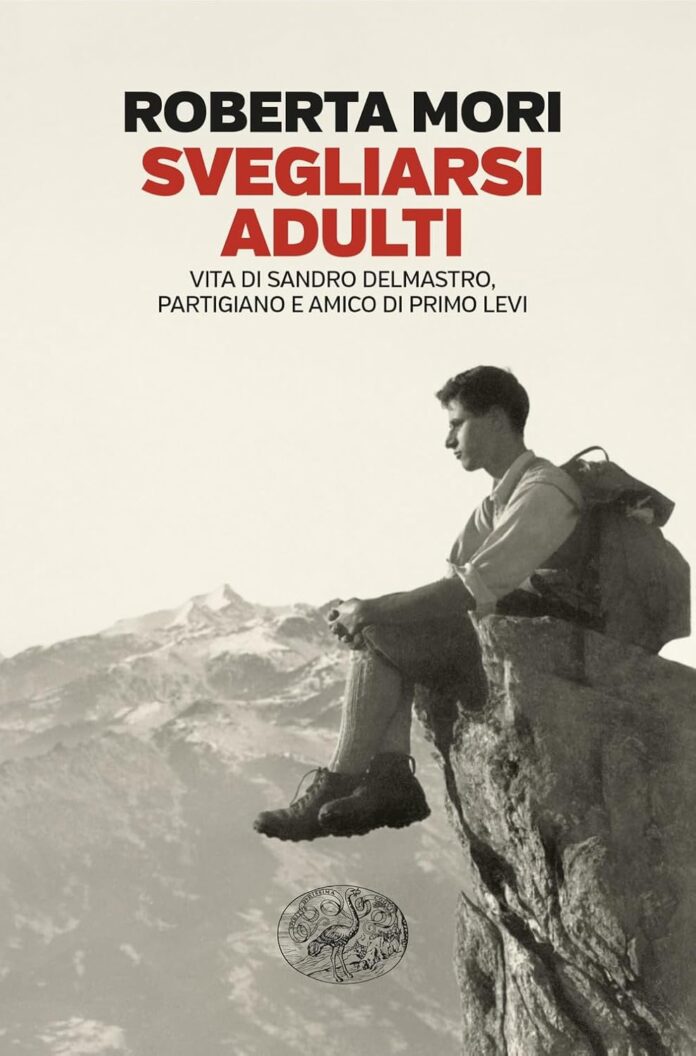
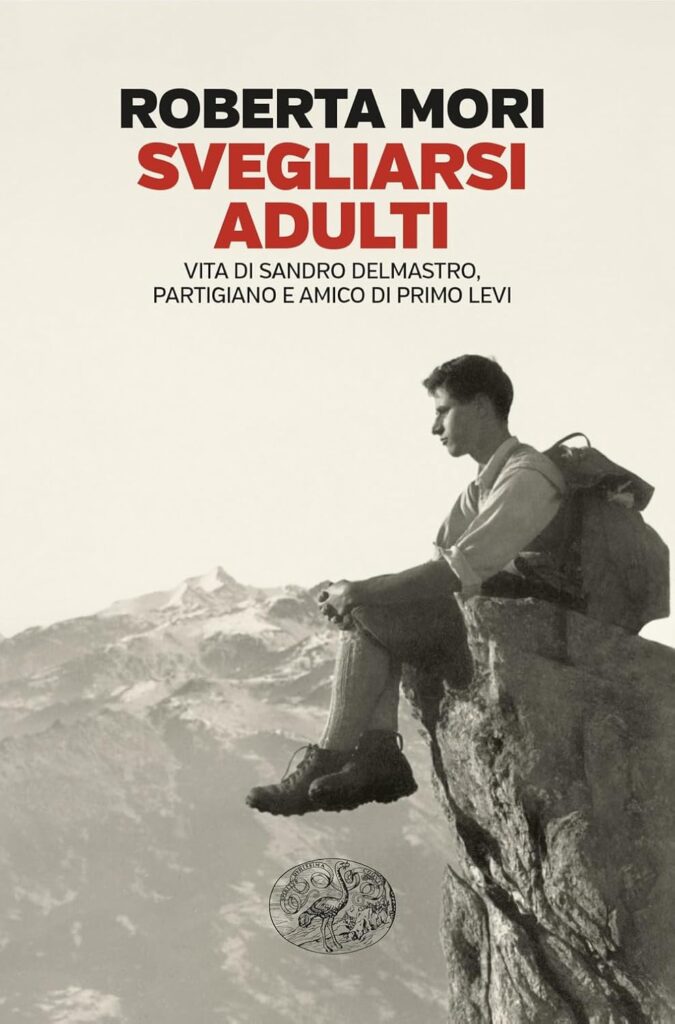 Chiamatelo Ferro. All’anagrafe è Alessandro Delmastro, nato a Torino il 7 settembre 1917. Chimico come Primo Levi, che a lui dedica il racconto Ferro de Il sistema periodico e La carne dell’orso, nel quale, però, porta il nome di Carlo. Amante della montagna e capo partigiano nelle formazioni di Giustizia e Libertà. Svegliarsi adulti. Vita di Sandro Delmastro, capo partigiano e amico di Primo Levi (Einaudi, 2025) è la biografia che Roberta Mori gli ha dedicato. Ricercatrice del Centro Studi Primo Levi, la Mori è riuscita a vascolarizzare la sua solida ricerca, tra documenti, corrispondenza e scritti inediti, con quella passione personale che può impegnare un’intera esistenza. Pertanto, questa biografia, in bilico tra personaggio letterario e drammatica testimonianza storica, irradia un luce aurorale generativa di nuovi sentieri di lettura e di studio. Non è solo la storia di Sandro, è la storia di un’intera generazione che ha arato e seminato il terreno della libertà.
Chiamatelo Ferro. All’anagrafe è Alessandro Delmastro, nato a Torino il 7 settembre 1917. Chimico come Primo Levi, che a lui dedica il racconto Ferro de Il sistema periodico e La carne dell’orso, nel quale, però, porta il nome di Carlo. Amante della montagna e capo partigiano nelle formazioni di Giustizia e Libertà. Svegliarsi adulti. Vita di Sandro Delmastro, capo partigiano e amico di Primo Levi (Einaudi, 2025) è la biografia che Roberta Mori gli ha dedicato. Ricercatrice del Centro Studi Primo Levi, la Mori è riuscita a vascolarizzare la sua solida ricerca, tra documenti, corrispondenza e scritti inediti, con quella passione personale che può impegnare un’intera esistenza. Pertanto, questa biografia, in bilico tra personaggio letterario e drammatica testimonianza storica, irradia un luce aurorale generativa di nuovi sentieri di lettura e di studio. Non è solo la storia di Sandro, è la storia di un’intera generazione che ha arato e seminato il terreno della libertà.