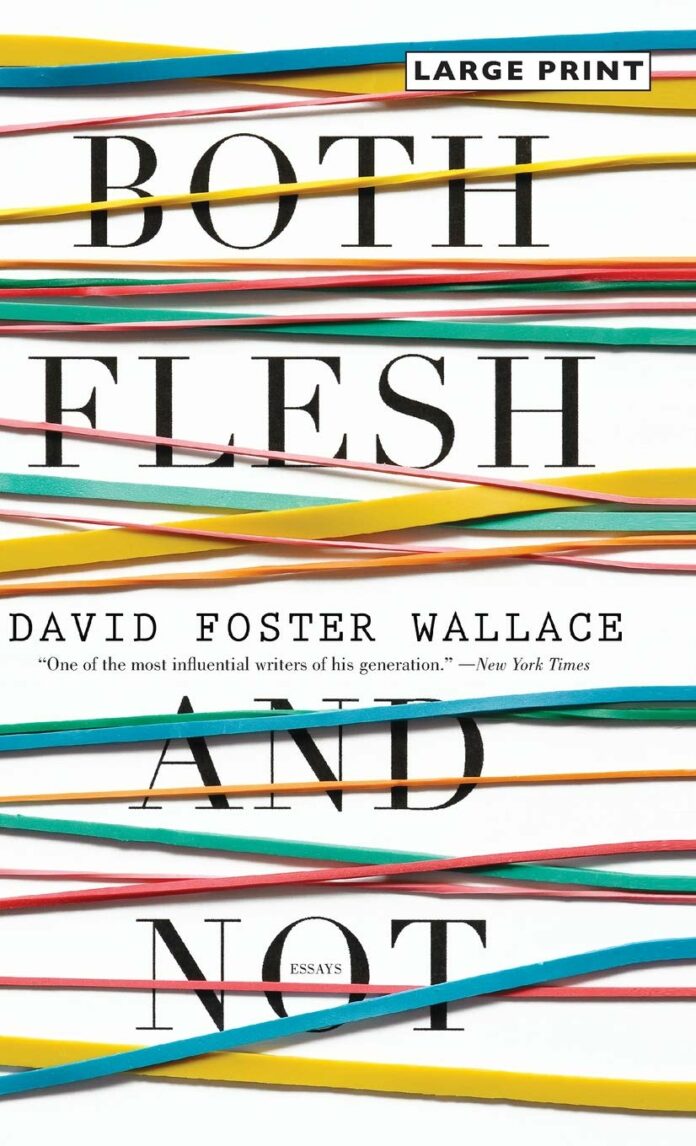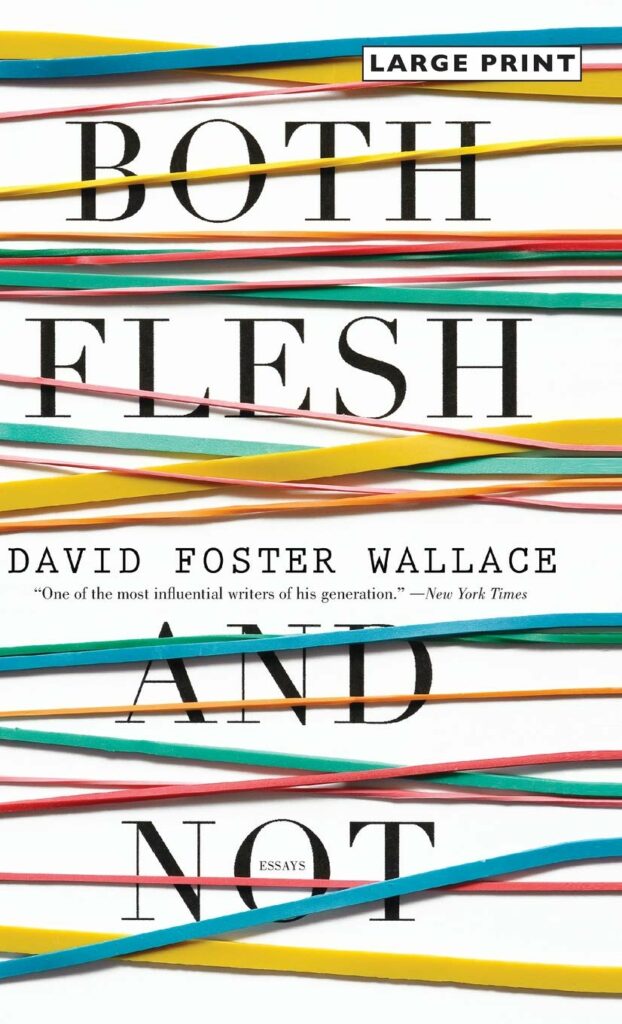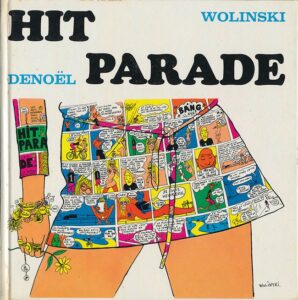 di
di
Claudio Loi
2021. 15 DISCHI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE
Anche quest’anno è arrivato il momento dei bilanci, di partecipare allo stupido giochino delle playlist che come al solito non serve a niente ma proprio per questo ci piace e ci diverte. E un po’ ci angustia e ci turba perché scegliere in un’infinita massa di produzioni discografiche è sempre un gran casino e poi dispiace togliere scegliere persino dimenticare. Ma queste sono le regole e questa è la cruda realtà della vita. Ecco quindi 15 bei dischetti in rigoroso ordine alfabetico che mi sembrano degni della massima considerazione e se vi avanza del tempo potete anche divertirvi a fare la vostra selezione della specie. Che dire? Buon ascolto, buona selezione e buon 2022 e se posso aggiungere un dischetto di ottimo new jazz (che clamorosamente quest’anno manca nella mia lista) acchiappate l’ultimo dei Sons of Kemet che è bellissimo è ha un titolo ancor più bello: Black to the Future!
 Paolo Angeli. Jar’a (PA Records)
Paolo Angeli. Jar’a (PA Records)
Dopo anni trascorsi a scrutare diversi orizzonti e a capire in che direzione andare Paolo Angeli è tornato al centro della sua isola dove ha ritrovato emozioni e sorprese. Si sa, la Sardegna è un mondo che nasconde tante emozioni che vanno riesumate con la certosina applicazione dell’esploratore impenitente. E Paolo Angeli questa attitudine ce l’ha ben radicata. Tutta la sua storia è un continuo avvicendarsi di scoperte e nuove ipotesi di creazione: dal suo strumento in continua evoluzione alla disperata voglia di riappropriarsi di una tradizione che talvolta sfugge, si nasconde, depista anche i più attenti studiosi della materia. Jar’a ci racconta proprio di questo periplo e di un ritorno a una terra che è storia di vicende millenarie ma anche evoluzione e superamento. Un disco gravido di emozioni, di sensazioni forti e tangibili e un manifesto di dialettica condivisione di umori, profumi, ricordi, animali e natura senza freni.
 Big Red Machine. How Long Do You Thinks It’s Gonna Last? (Jagujaguwar)
Big Red Machine. How Long Do You Thinks It’s Gonna Last? (Jagujaguwar)
Un progetto estemporaneo che nasce nella cantina di casa National grazie a uno dei due gemelli (Aaron Dessner) che ha trovato in Bon Iver un partner ideale. Già l’anno scorso Matt Berninger ci aveva stupito con un delizioso lavoro solista a significare che in quell’ensemble c’è gente molto seria. Il progetto Big Red Machine si sviluppa su un versante compositivo piuttosto classico: ballate di pop evoluto con grande risalto all’aspetto melodico ma con una prospettiva leggermente laterale. Diventano fondamentali in questo contesto le collaborazioni (Anaïs Mitchell, Fleet Foxes, Taylor Swift, Ilsey, Naeem, Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, My Brightest Diamond) che rendono questo lavoro più strutturato e complesso di quanto non si aspetti e le composizioni tutto sembrano tranne divertissement dell’ultima ora.
 Black Country, New Road. For The First Time (Ninja Tune)
Black Country, New Road. For The First Time (Ninja Tune)
Quando gli inglesi decidono di fare sul serio non c’è storia. Questo 2021 è stato un’esplosione di imberbi formazioni che hanno riportato alle cronache il vecchio e caro post-punk. Ora su questo termine ci sarebbe da disquisire a lungo. Il primo a usarlo mi pare sia stato Simon Reynolds e da allora viene ab/usato un po’ dappertutto, spesso senza ragioni valide. Quando Reynolds attaccò il post al punk per molti fu inteso in senso temporale ovvero quella ondata di creatività che segui alla deflagrazione del punk primigenio. In realtà – ma questo si è capito dopo – quel post andrebbe inteso come “oltre”, come superamento dialettico di uno stile, evoluzione di suoni e colori verso un nuovo sistema semantico che non si è ancora definito. E questi ragazzini sono la nuova svolta di questa piacevole rivoluzione. Tutti li aspettiamo per il secondo passo che ci confermerà quanto di buono traspare da queste canzoni.
 Black Midi. Cavalcade (Rough Trade)
Black Midi. Cavalcade (Rough Trade)
Anche questi giovanotti si divertono a riscrivere la trama del rock dei propri genitori con una strana, nervosa, instabile e frizzante proposta sonora. Pescano da diverse fonti: dal protopunk al metal passando persino nei territori infestati dal prog. Ci vuole coraggio e sangue freddo e anche una certa dose di perizia strumentale per affrontare questi viaggi ma li sostiene una sfrontatezza giovanile che nel rock è sempre stata carburante indispensabile. Anche in questo caso sarà il futuro a chiarirci meglio dove potranno arrivare ma questo presente è già abbastanza pieno di buone vibrazioni.
 Vasco Brondi. Paesaggio dopo la battaglia (Cara Catastrofe)
Vasco Brondi. Paesaggio dopo la battaglia (Cara Catastrofe)
Vasco Brondi ha trascorso molto tempo a Ferrara e si sa che da quelle parti le cose si fanno sempre molto seriamente. Pensate alla salama da sugo e tutto il tempo che ci vuole a prepararla e la cura nella scelta degli ingredienti e tutte le minuzie che vanno rispettate e così via. Anche il nostro caro Brondi ama fare le cose per bene e ci ragiona e ci rimugina, si prende i suoi tempi e solo quando il momento è propizio si fa sentire. Questa nuova operetta morale, pubblicata sotto forma di libretto con dischetto allegato, contiene 10 belle canzoni da ascoltare durante la lettura ma anche in perfetta solitudine o come preferite voi. Note a margine e macerie è il racconto di questa avventura musicale ma è anche il resoconto di una vita dedicata alla musica nella sua forma più sincera e passionale. “Dopo la battaglia c’è una pace incerta, piena di ferite e piena di sollievo. C’è qualcuno che chiama un nome tra le macerie, qualcuno che risponde”. E se le luci della centrale elettrica sembrano flebili fiammelle all’orizzonte ci consoliamo con il potere delle parole e della musica.
 Dry Cleaning. New Long Leg (4AD)
Dry Cleaning. New Long Leg (4AD)
La più bella sorpresa di questo 2021 è questo quartetto composto da solidi musicisti e da una voce che riesce a compattare le varie influenze dei singoli. Su una base elettrica e disfunzionale la voce di Florence Shaw si staglia lucida e impavida e racconta cose che tutti noi già sappiamo e proprio per questo diventano parametri di autorappresentazione universale. Uno spoken word che rimanda a tante altre cose, troppe per essere citate, tutte intrise di emozioni che arrivano da lontano. E in questo universo di citazioni e rimandi a piè di pagina ci si ritrova a sognare sempre lo stesso sogno in un loop emozionale che stordisce e lascia attoniti. Dal vivo la loro proposta è ancora più pregna di pathos e sembra quasi impossibile che tutto ciò sia possibile. Saranno il bastone della nostra vecchiaia? Quello a cui attaccarci quando sfiniti cercheremo riparo e supporto umano? Forse si forse no ma godiamoci questa meraviglia che nessuno si aspettava.
 Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra. Promises (Luaka Bop)
Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra. Promises (Luaka Bop)
Qualcuno tra i puristi ha storto il naso di fronte a questa improbabile commistione di storie, come se si trattasse di speculazione pseudo commerciale per racimolare qualche consenso. In realtà ci troviamo di fronte a una creazione che appare tanto sincera e coerente quando azzardata e coinvolgente. Pharoah Sanders è uno che ha scritto pagine gloriose di jazz contemporaneo, il suo sax ha attraversato le correnti più intransigenti della ricerca, ha flirtato con la tradizione, ha fatto i conti con i suoi fantasmi e con gli spiriti dell’inconscio. Non stupisce quindi trovarcelo in età avanzata a condividere la scena con uno dei più intelligenti sperimentatori della scena attuale e mettere a disposizione la sua esperienza in un progetto che spinge verso qualcosa di nuovo e inconsueto. La materica rappresentazione del jazz di Sanders trova cittadinanza nel caos della liquidità elettronica e qualcosa di magico si manifesta, qualcosa che solo le menti aperte riescono a concepire. E il supporto della London Symphony aggiunge un ulteriore chiave di lettura per un lavoro che rimarrà un punto di riferimento per chi ha bisogno di scrollarsi la polvere del tempo e sterili categorie merceologiche.
 Iosonouncane. IRA (Trovarobato)
Iosonouncane. IRA (Trovarobato)
Attenzione: contiene moltitudini. Jacopo Incani ha trovato il coraggio di scrivere la sua recherche e ci vorrà del tempo, tanto tempo per decifrare a pieno la massa incombente di suoni e umori contenuti in questo disco. La metafora più ricorrente nel cercare di esplicare i contenuti di Ira è stata quella geologica-mineraria. E ci sta! Lui che viene da Buggerru conosce bene il peso della terra e delle sedimentazioni storiche, del lento lavorìo della materia, di quel silente mutare delle forme. La sua musica è la logica rappresentazione di una complessità in continua mutazione, di una concezione del tempo che non trova spazio nelle logiche del presente e si posiziona fuori dalle divulgazioni didascaliche. Complessità quindi ma anche ricerca interiore, speculazione filosofica, metamorfosi e rinascita. La visione di Incani è stratigrafica e difficile da penetrare. Avremo bisogno di tempo e di pazienza per capire queste composizioni forse non ci basterà e forse non tutto verrà alla luce ma ne varrà la pena.
 Kings of Convenience. Peace Or Love (EMI)
Kings of Convenience. Peace Or Love (EMI)
Quando tanti anni fa si presentarono al mondo si capì subito che si trattava di qualcosa di speciale. Il loro sound venne identificato con l’inizio del New Acoustic Mouvement che riapriva scenari di quieta beatitudine e una predisposizione alla calma interiore e al relax senza peraltro finire nelle paludi dell’easy listening o delle musichette per tramonti in qualche isola inesistente. Poi si è capito che – a parte qualche sussulto estemporaneo – quella roba lì la sapevano fare solo loro nonostante sembrasse così facile da replicare e persino superare. Invece ci sono cose che non sono riproducibili e allora ogni loro disco diventa qualcosa di unico e prezioso. Loro se la prendono calma, non hanno l’assillo di essere sempre presenti, non sentono il fiato sul collo e neanche ansia di prestazione. Il loro suono rimane essenziale e limpido come un paesaggio nordico e allo stesso tempo caldo e intimo come il sole del sud. E come sempre si divertono a spiazzare tutti con geniali giochi di parole che hanno bisogno di un certo impegno per essere decodificati.
 Low. Hey What! (Sub Pop)
Low. Hey What! (Sub Pop)
Due anni fa sbaragliarono tutte le classifiche di fine anno con un lavoro che pareva destinato a rimanere il top di una carriera irripetibile. Poi arriva questo nuovo lavoro e lo stupore diventa enigma e viene da chiedersi come sia possibile restare sempre così lucidi e in tiro dopo tanti anni di onorata carriera. Hanno pure perso il bassista storico e sono rimasti in due Alan Sparhawk e Mimi Parker a spartirsi l’onere di continuare. Hanno persino il coraggio di deturpare le loro canzoni con violenti inserimenti elettronici, con arrangiamenti che spesso disturbano quando potrebbero semplicemente proporre le loro creazioni senza troppi patemi d’animo. Ma loro sono fatti così. Amano il rischio e amano demistificarsi. Sanno quanto sia facile ripetersi e vivere di rendita e godersi il giusto climax che chiunque si terrebbe stretto. Ma questi sono i Low: immensi, irripetibili (persino a se stessi), unici e necessari. Sarà l’aria di Duluth?
 Gianni Maroccolo / Antonio Aiazzi. Mephisto Ballad (Contempo)
Gianni Maroccolo / Antonio Aiazzi. Mephisto Ballad (Contempo)
Maroccolo è uno che non si è mai fermato. È sempre li che si guarda intorno per capire da che parte proseguire, dove stare, quali nuove prospettive scrutare, sembra un adolescente in cerca delle prime emozioni, uno che si lascia coinvolgere quando ci sono le giuste inclinazioni. Insomma una di quelle figure che danno un senso compiuto al fare musica ma anche al piacere di poter ascoltare e partecipare e farsi trascinare dai suoni e dalle idee. Una storia che arriva da lontano senza cadute di stile o falsi proclami sempre sottotraccia ma con la giusta dose di saggezza e partecipazione. Spesso lavora in solitudine (Alone) spesso è in mezzo alla gente e tra la gente. Le ultime profonde manifestazioni di gioia le ritroviamo nel disco inciso di recente con Edda (altro transfugo del nostro miglior rock) e in questa con Antonio Aiazzi storico batterista dei Litfiba e compagno di lungo corso (quant’erano bravi i Beau Geste…). Mephisto Ballad appare come una sorta di viaggio verso quello che è stato per ripercorrere 40 anni di vita comune e di passioni condivise e in particolare rimanda a un concerto del 1982 a Firenze con la mente che si intinge di ricordi, venature dark, miti più scuri dell’oscurità di quegli anni.
 Mogwai. As The Love Continues (RockAction)
Mogwai. As The Love Continues (RockAction)
Da sempre considerati come la migliore espressione del post-rock europeo (viviamo in un mondo sempre più post) eccoli al loro decimo album in studio con la forza di chi ha ancora tante cose da raccontare. Il loro sound è subito riconoscibile ma si sente che in tutti questi anni molte cose sono cambiate e questo disco è la perfetta manifestazione di un nuovo modo di fare musica e di interagire con se stessi e con tutti gli altri. E poi la pandemia che ha scombussolato tutto e ci ha obbligati a essere più smart più ubiqui più connessi ma anche più soli. Ma si continua si va avanti si incespica e il post-rock è ancora una bella medicina per lenire i patemi d’animo e le nostre piccole catastrofi quotidiane.
 Salmo. Flop (Sony)
Salmo. Flop (Sony)
Il potere dell’immagine, la forza dei suoni, la provocazione come opera d’arte e l’immedesimazione totale dell’artista con la sua arte. Niente di nuovo sia chiaro e la società dello spettacolo è lo scrigno ideale per avvallare queste ipotesi de/costruttive. Salmo conosce bene queste dinamiche e sa che la provocazione è uno stimolo e uno strumento utilissimo da sfruttare. Sta a noi, umili spettatori, governare il sottile discrimine che separa il nulla dall’infinito. Sta a noi verificare la qualità di una proposta artistica e svelare i facili illusionismi che gli scenari della contemporaneità mettono a disposizione. Ma Salmo è lucido assai nel verificare le sue gesta, rischia con fervida partecipazione e non trascura il valore del suo messaggio. In lui convivono la ricerca musicale e il suo apparire, la messa in scena e il substrato testuale, la teoria e la praxi. Flop è una contraddizione sin dal suo titolo e le contraddizioni sono le parti più nobili di ogni artista, soprattutto in Salmo che ne ha fatto scienza e incoscienza.
 Squid. Bright Green Field (Warp)
Squid. Bright Green Field (Warp)
Un altro esordio per una nuova band che per comodità abbiamo inserito in quel soffice contenitore chiamato post-punk ma che disvela più complessità di quanto questa terminologia lasci intendere. Si sente effettivamente la spinta della prima new wave anni Ottanta ma si respira altresì l’aria dei nostri tempi e la capacità ormai intrinseca di citare, mescolare, sintetizzare e globalizzare. Non stupisce quindi il richiamo a certe esperienze punk funk e alle migliori espressioni del math rock. Insomma ritmo, composizione e piacevoli scosse elettriche per dirla con parole più umili. Un lavoro che ci aiuta a capire i luoghi, gli spazi, gli eventi e le architetture di questa strana realtà che ci circonda. “We’re still dance, dance, dancing today to the global groove / We’re still tap, tap, tapping away to the global groove”.
 Vanishing Twin. Ookii Gekkou (Fire)
Vanishing Twin. Ookii Gekkou (Fire)
Il gemello scomparso è un omaggio a tutte quelle cose che non sono ma sarebbero potute essere, all’imprevedibile caos della vita. Questo progetto nasce dall’unione di tante anime differenti, quasi inconciliabili eppure pronte a fare fronte comune. Phil MFU, Susumu Mukai, Cathy Lucas e Valentina Magaletti (che nomino musicista dell’anno) hanno dato vita a un progetto multiforme, fluido, quasi impalpabile, un creatura che sopravvive alla selezione della specie: quel fantasma mai nato che finalmente trova spazio e forme. Ecco perché (anche grazie alla collaborazione con Malcom Catto degli Heliocentrics) in questi solchi ritroviamo l’energia del miglior afro-funk, il jazz più esoterico, le divagazioni spirituali di Alice Coltrane e persino l’ingaggio fuori tempo massimo di certe sperimentazioni esotiche del primo Holger Czukay. Ma si rincorrono persino echi di certa library music di provenienza italica e varie altre declinazioni di difficile catalogazione. Per Pitchfork “Una band che fluttua senza paura nello spazio nebbioso tra il mondo reale e quello immaginario, offuscando il confine tra calorosamente nostalgico e inquietantemente infestato”. Questo disco è un’epifania che ci riporta a quell’istante in cui siamo tutti solo idee, desiderio e immaginario mai realizzato. E comunque segnatevi il nome di Valentina Magaletti e di tutti i suoi progetti artistici per un futuro più policromo e instabile.

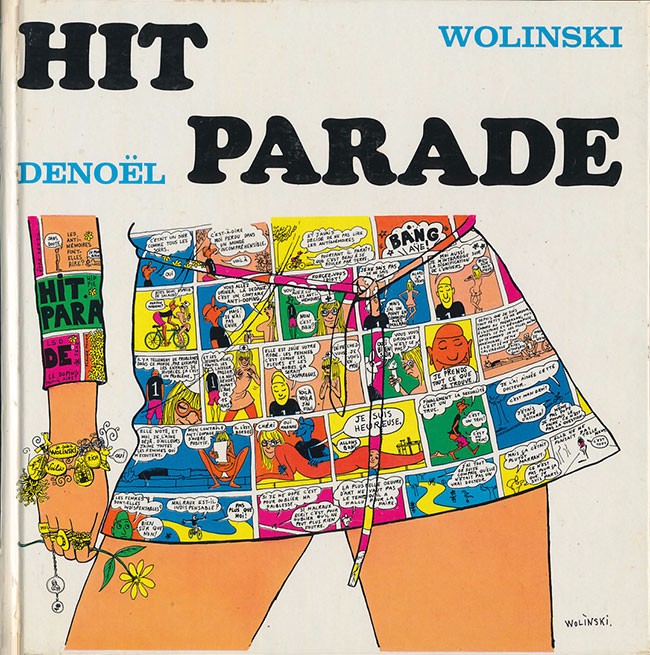
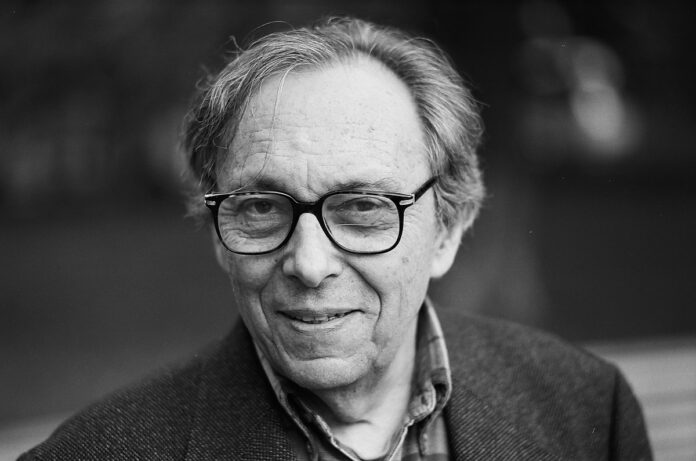
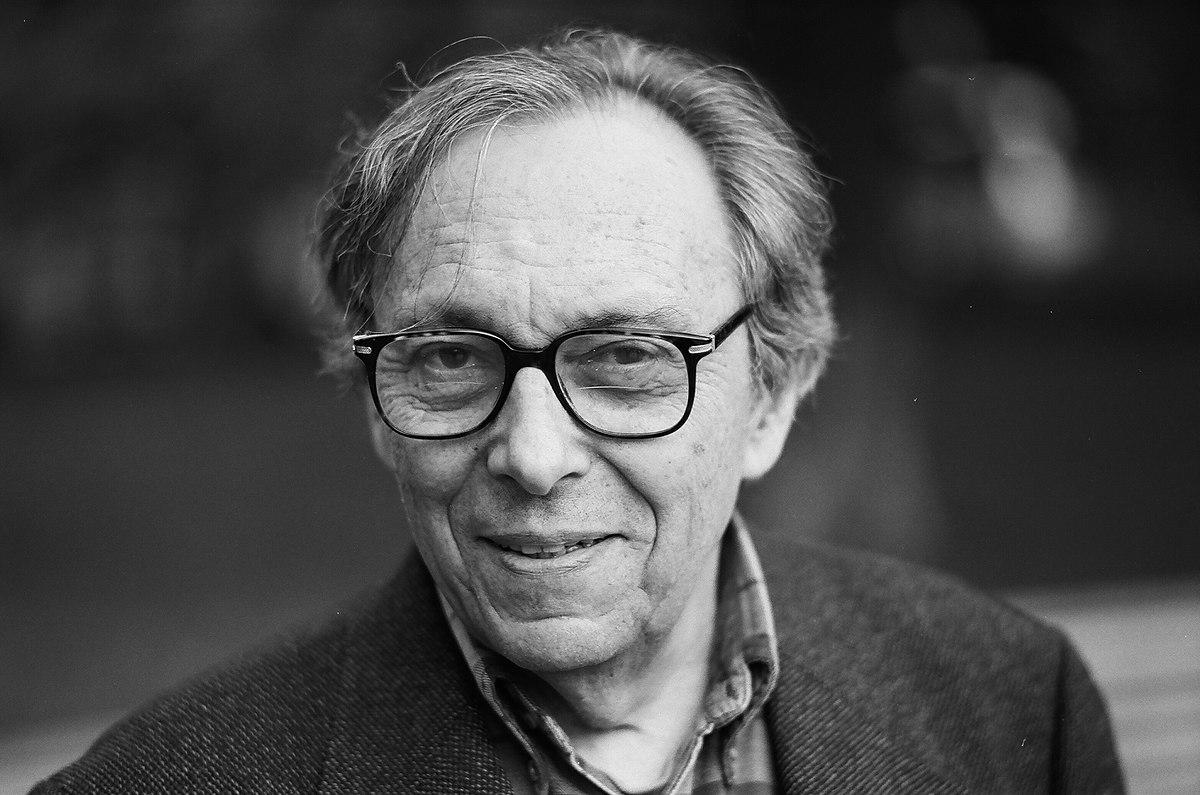


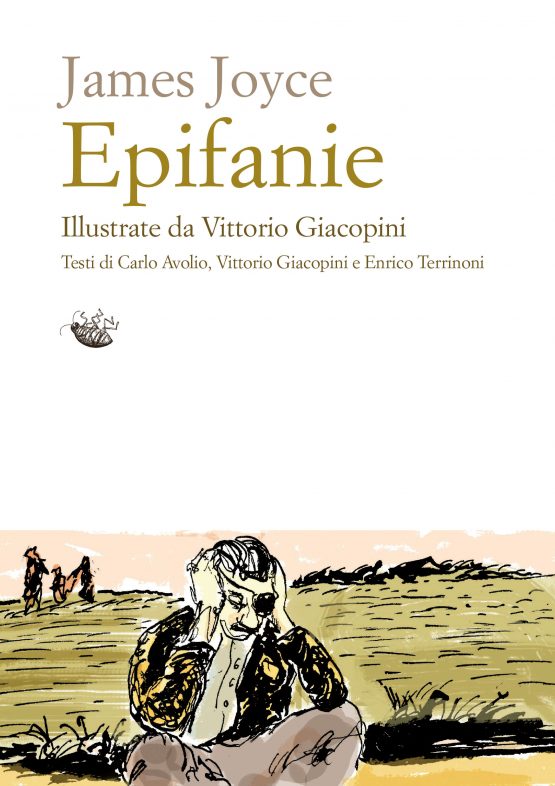








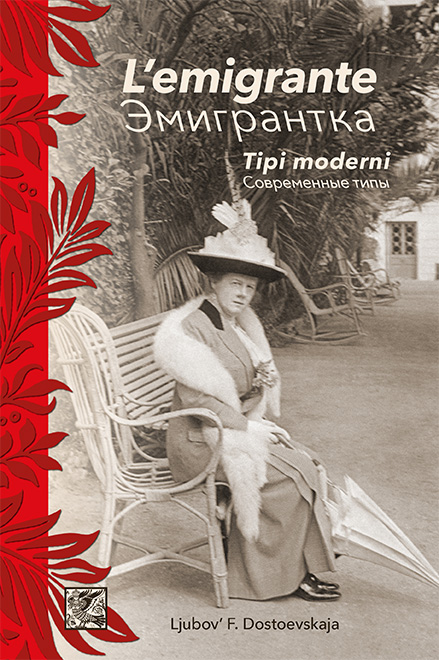








 di
di In una bellissima conversazione con Marta Federici, pubblicata su
In una bellissima conversazione con Marta Federici, pubblicata su 



 di Lisa Ginzburg
di Lisa Ginzburg