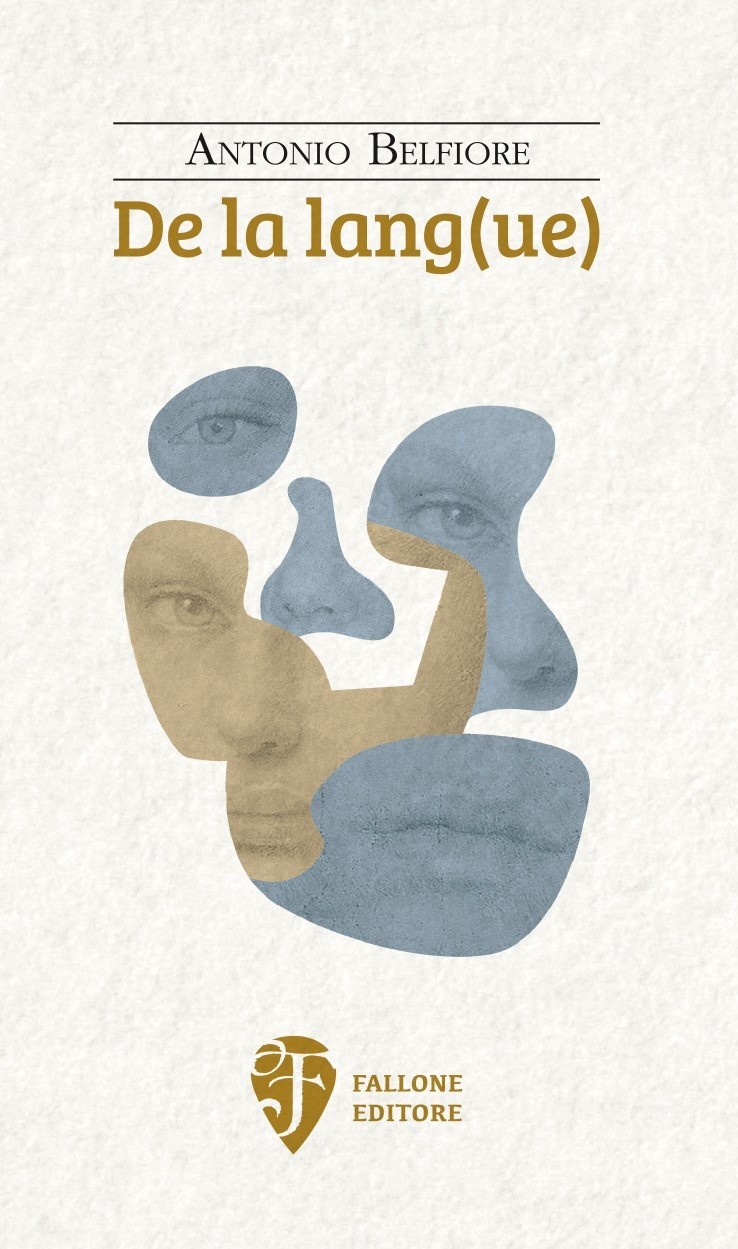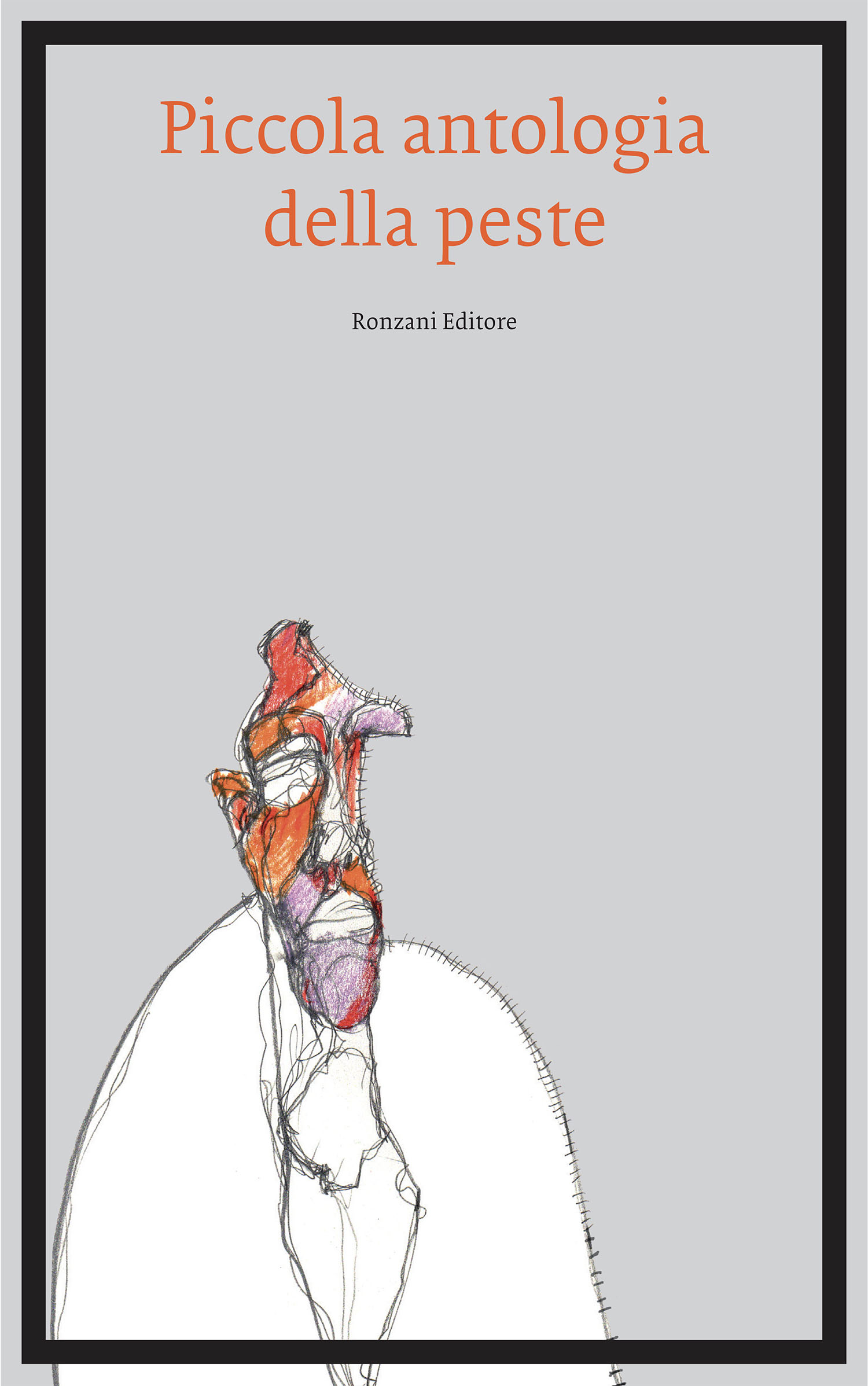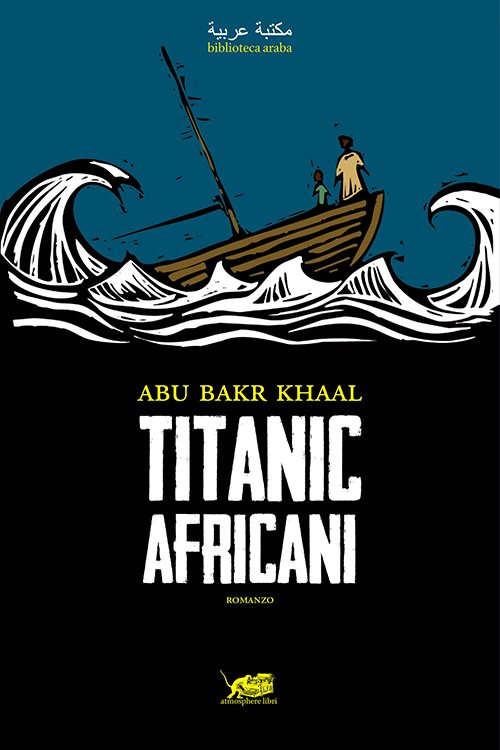di Domenico Talia
 «… secondo me nella vita o sei il primo o sei l’ultimo e non puoi essere tutte e due le cose, […] io sono l’ultimo. Ormai l’ho capito. L’ultimo dei disgraziati. E nessuno vuole essere come me. Perché quando sei vecchio e non ci hai più niente, ti trattano tutti come la merda.» Così inizia a raccontare la sua disperazione Frank, anziano e fallito stuntman che non riesce più a lavorare e ogni cosa gli va male. Ma Frank nella disgrazia non è solo, anche se questo non gli è di alcun aiuto. Sulla sua strada trova altri due “ultimi”, Eva e Cristian. Loro sono più giovani ma non per questo meno disperati di lui.
«… secondo me nella vita o sei il primo o sei l’ultimo e non puoi essere tutte e due le cose, […] io sono l’ultimo. Ormai l’ho capito. L’ultimo dei disgraziati. E nessuno vuole essere come me. Perché quando sei vecchio e non ci hai più niente, ti trattano tutti come la merda.» Così inizia a raccontare la sua disperazione Frank, anziano e fallito stuntman che non riesce più a lavorare e ogni cosa gli va male. Ma Frank nella disgrazia non è solo, anche se questo non gli è di alcun aiuto. Sulla sua strada trova altri due “ultimi”, Eva e Cristian. Loro sono più giovani ma non per questo meno disperati di lui.
Luce del nord – tre disperazioni invisibili
Come ci inquadriamo quando videochiamiamo / 2: sullo stendino
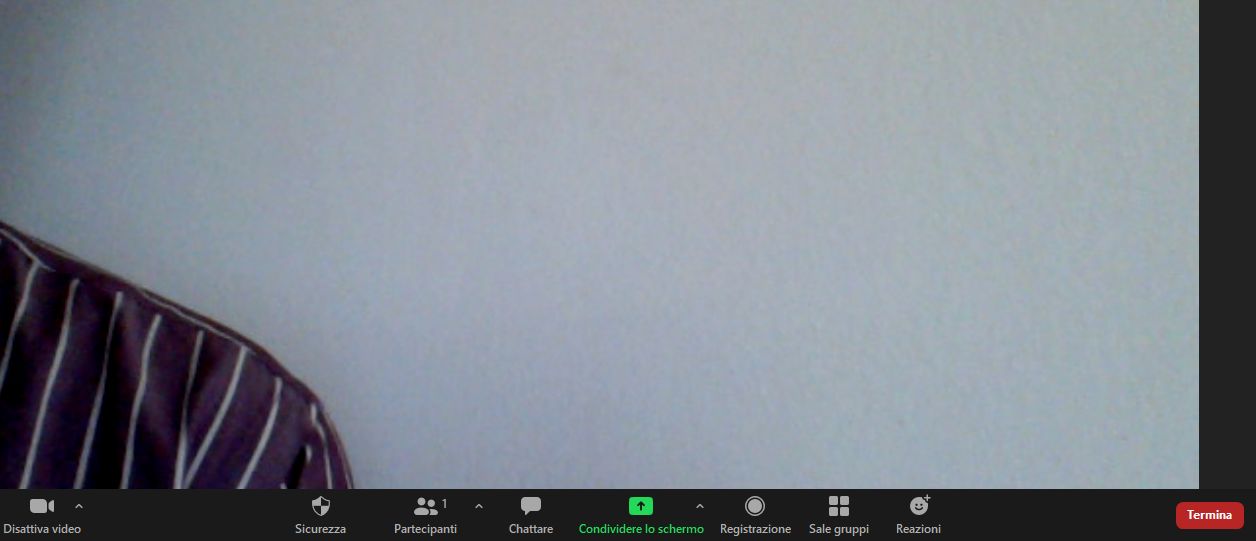
di Alberto Brodesco
Ipotesi: si è prodotta una biforcazione tra una comunicazione impersonale (verso tutti) curata, e una comunicazione personale (verso qualcuno di preciso) sciatta. La prima è lo stile Instagram, la seconda lo stile Zoom.
Ho presenziato a un meeting di gruppo su Zoom dove una partecipante aveva alle spalle lo stendibiancheria. Al di là di un fastidio estetico, idiosincrasico, per quell’oggetto, lo stendino ha svolto una funzione rivelatrice. Di solito lo stendipanni è un articolo che si nasconde, che si ripone quando entrano ospiti, da collocare sul poggiolo o nella cosiddetta “zona notte”. Vederlo così in vista nel corso di una riunione di lavoro fa capire una cosa che va oltre la scelta o la distrazione della singola partecipante alla video-call: non ci interessa davvero come siamo inquadrati su Zoom.
Ho dedicato un primo pezzo su Nazione Indiana a ragionare sugli errori (il quadro, gli sfondi, le luci) che commettiamo su Zoom o sugli altri software. Ora giungo alla conclusione che non si tratta di errori ma di disinteresse.
Chi partecipa alle video-riunioni non presta veramente attenzione a come appare. È una constatazione puramente numerica: la stragrande maggioranza di chi usa Zoom fa così. Osservando la video-riunione dello stendibiancheria, su 21 partecipanti visibili, conto: 1 controluce, 5 inquadrature del soffitto, 2 facce tagliate dal naso in giù, 1 sfondo virtuale (ponte famoso), 3 sfondi imbarazzanti (foto di parenti morti, foto del matrimonio incorniciate a cuore, stendino), 2 sfondi oggettivamente brutti (termosifone, vecchia cucina). Inquadrature, sfondi e luci curati si vedono in 2 soli rettangoli su 21. Conclusione (ribadita): di come siamo inquadrati quando siamo in video-chiamata ci importa abbastanza poco.
Povero Zoom. Siamo attenti, in modo ossessivo, a come appariamo sui social network (filtri, correzioni colore, scatti ripetuti…), ma quando ci riprendiamo in video-conferenza non ci curiamo della nostra immagine. È una negligenza in totale attrito con l’epoca in cui viviamo.
Proviamo a trovare delle ipotesi per spiegare questo disinteresse. Si può intanto dire che trattiamo la video-conferenza come se fosse una vecchia telefonata, che si può fare, con un po’ d’attenzione, anche seduti sul water. L’onda lunga del “vecchio telefono” spinge a privilegiare il verbale sul visivo.
Una seconda ragione può essere attribuita alla qualità generale delle riprese (o foto) che ci siamo abituati a fare, alla sciatteria con cui inquadriamo di solito. Non sto parlando delle foto che pubblichiamo su Instagram, ma di quelle che ci scambiamo su Whatsapp, quelle che servono solo come testimonianza, icona di un momento, indice di una presenza. Quelle fatte a cazzo. Allo stesso modo, ci siamo abituati a girare i video un po’ come vengono: muovendo molto lo smartphone, tenendolo in verticale, perdendo il fuoco, e con esso, in definitiva, anche il senso stesso dell’idea di inquadratura come selezione accurata dello spazio. Non ci importa veramente di filmare bene: conta la condivisibilità della scena, non la qualità della sua ripresa.
Terza ragione: vince la contingenza. Sul frame “occasione formale” (riunione) prevale il frame “ambiente domestico”. Il senso di comfort casalingo ha la meglio. Sono a casa mia e mi vesto da casa, faccio quel che voglio, mi mostro come mi pare.
Un’ulteriore motivazione potrebbe essere attribuita alla nausea da video-conferenza: da marzo in qua abbiamo partecipato a decine e decine di riunioni su Zoom, il che può aver prodotto un rifiuto di prestare attenzione al proprio aspetto/contesto: non ne posso più, ora basta, me ne frego. Gioca contro questa tesi il fatto che le inquadrature su Zoom vengano male sin dall’inizio del lockdown. Non sono quindi il frutto di una progressiva stanchezza nei confronti del dispositivo.
Nelle culture digitali, in conclusione, va riconosciuta l’esistenza di una pulsione low-fi. Zoom, avrebbe detto McLuhan, è un medium freddo. Rende manifesta la presenza di un’anti-estetica che sprigiona una peculiare forma di autenticità. Le inquadrature brutte di Zoom possono essere trattate come un segno interessante, come uno strano e forse anche involontario (o persino inconscio) rigurgito in reazione alla cultura della trasparenza e del narcisismo. Lo stendino vale come linda icona iperrealista, a contrasto con lo straripante esibizionismo fighetto dei mondi digitali che rimangono là fuori, in paziente attesa di un clic su “End Meeting”.
Prà de paròe
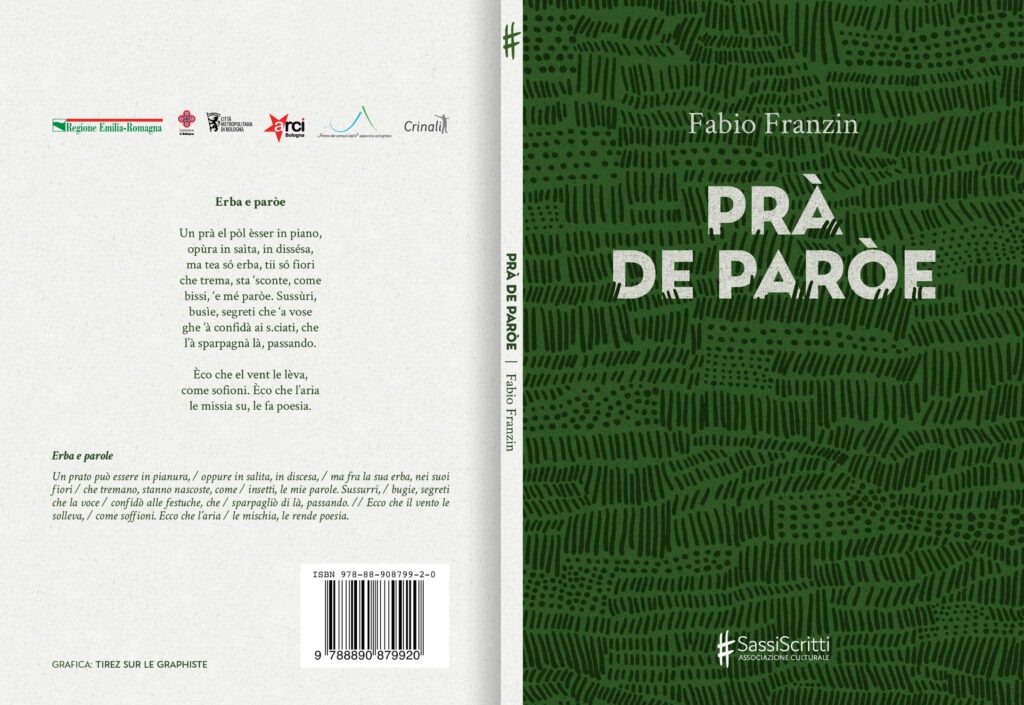 di Fabio Franzin
di Fabio Franzin
Oh, ‘sta piovéta lidhièra,
incùo, tee piante dea mé
teràzha, intànt che son
drio rilèdherve, cari Pier-Luigi
(Cappello, Bacchini)
‘e ‘àgreme che casca, tic tic,
daa ponta de ‘sti cuciarini
verdi, zai, jozhéte che score
te l’incavo fra i nervi, ‘e se
ingrossa, in càibrio tel farse
perla, e po’ tic, tea pièra, tic
come paròe pìcoe co’ drento
‘a musica de canpanèe a ciamàr
qua i ricordi. Tic e cit, cit e tic
jozhéte, fojiéte… perline
da nient, paroìne de boce
‘sconti drio un cantón del
tenpo, sussùri de poeti cari
che continua a viver, qua.
Oh, questa pioggerellina, / oggi, sulle piante del mio / terrazzo, intanto che vi sto / rileggendo, cari Pier-Luigi / (Cappello, Bacchini) // le lacrime che cadono, tic tic, / dalla punta di questi cucchiaini / verdi, gialli, goccioline che scorrono / nell’incavo fra le nervature, si / ingrossano, pencolanti nel farsi perla, e poi tic, sulla pietra, tic // come paroline con dentro / il suono di campanelle a chiamare / qui i ricordi. Tic e taci, taci e tic // goccioline, foglioline… perline / da poco, paroline di bimbi / nascosti dietro un cantone del / tempo, sussurri di poeti cari / che continuano a vivere, qui.
***
Della lingua e delle semenze
di Azzurra D’Agostino
Quello che si prova leggendo questo libro è una sensazione simile al tenere in mano una manciata di semenze. Alcuni grani che contengono in potenza prati e frutti. Che in qualche modo già sono quei prati e frutti, ma che necessitano anche di altri elementi. Cose semplici, essenziali: terra, acqua. Tempo, soprattutto.
E se si pensa alla parola, semenza, emerge anche l’altro significato: discendenza, stirpe.
Siamo al principio di qualcosa, ma anche, al contempo, alla circolarità del ritorno, al ritrovare nel futuro, trasformato appunto dal tempo trascorso, tutto quanto in principio era in potenza.
Le vicende di questo manoscritto sono raccontate da Franzin alla nota finale del testo: quello che ci troviamo davanti è buona parte di un primo libro mai davvero pubblicato. A cui si sono aggiunti, nel corso di molti anni, altri testi, nei quali il tempo ha fatto il suo lavoro di deposito e scavo. Significativo che una delle ultime poesie sia dedicata proprio a Pierluigi Cappello, uno degli uomini e poeti che più hanno segnato la vicenda artistica e umana di Franzin.
Ciò che rende prezioso questo ‘prato di parole’ è dunque anche, ma non solo, un intreccio di epoche, esperienze, vissuti, a partire da un esordio in qualche maniera già maturo, portatore di una verità che il corso della vita ha approfondito e indagato.
Nella prima sezione sentiamo il respiro di un presagio: un continuo domandare al silenzio del silenzio, una riflessione sul senso del dire, un tentare di bucare con la lingua l’indicibile di un’esperienza di dolore. Lingua che si fa centrale, quale possibilità in qualche modo di riparazione.
E vengo qui al punto che mi pare essenziale, suggestione citata anche nel testo con una poesia dedicata proprio a quell’autore che ha sottolineato sempre l’importanza dell’uso di una lingua minoritaria: Seamus Heaney.
Nel preziosissimo ‘La riparazione della poesia’ (Fazi, 1999) il premio Nobel indaga il ruolo del poeta e della poesia e si sofferma a lungo sull’importanza dell’uso di dialetti e lingue altre. Il tutto si potrebbe riassumere a partire dall’affermazione: “La verità dell’arte sta nei punti secondari d’importanza primaria”.
La marginalità e frantumazione dell’esistenza in tante ‘cose secondarie’ non si fa dunque espediente per un’occasionale valorizzazione delle ‘piccole cose’ che animano retoricamente la produzione poetica più o meno recente, bensì s’incarna nella parola a partire proprio dalla scelta della lingua d’espressione. Heaney dedica un intero saggio all’importanza delle lingue altre rispetto al potere, sottolineando come il momento in cui nessuna lingua sarà segregata diverrà la realizzazione di un sogno di cultura e pace mondiali. Un sogno, scrive Heaney riferito alla poesia di John Clare che secondo lui parzialmente l’incarna, “dove non si dovrà mai ripensare se esprimere nei propri termini culturali e linguistici il proprio mondo, perché nessuna terminologia altrui sarà imposta come normativa e ufficiale. Leggerlo per i sapori esotici di un lessico arcaico e le vedute pittoresche di un passato bucolico è mancare la fiducia che egli comunica nella possibilità di un futuro rispetto di sé per tutte le lingue, una imprevedibilità immensa, creativa, dove l’esistenza umana diviene presente e viva più abbondantemente perché ormai espressa nelle proprie parole, autogratificanti e affrancate”.
In qualche modo qui la dimensione politica di ogni poesia viene ribadita attraverso le scelte prettamente linguistiche, lessicali, ritmiche. Ed è in questo modo che ‘Prà de paròe’, con tutti i suoi dubbi, i suoi ritratti minori, le sue erbacce a bordo strada, contiene in qualche modo ,e paradossalmente approfondisce grazie all’imprevedibilità e all’immaginazione, le poesie della fabbrica, della disoccupazione, dei fallimenti della nostra società – raccontati in molti dei libri a venire.
Nella seconda sezione il vento del poi soffia già forte, tanto che si possono solo intuire gli innesti successivi rispetto al nucleo originario. E questo non soltanto perché ogni poeta ritorna sulle proprie ossessioni, né certamente per un qualche manierismo che è del tutto estraneo a Franzin innanzi tutto come persona, prima che come artista.
Si legge nei testi di questa parte del libro la filigrana di uno sguardo sul mondo che, pur nella tempesta e nelle gramaglie, il poeta non dissipa e non distoglie. Uno sguardo limpido, generoso, attento ai fragili con la consapevolezza di farne parte – come ciascuno dei ‘respiranti’, citando Hölderlin.
Perché il legame tra etico ed estetico non è una pura formalità, ma la sorgente intatta a cui occorre almeno provare, tutti, ad abbeverarci.
È con gioia, davvero molta e pura gioia, e con senso di responsabilità dunque che salutiamo questo libro, scegliendo di renderlo pubblico in un momento in cui il noto vacilla e l’ordine mondiale mostra il suo disordine.
Piccolo atto che vuole ribadire l’importanza primaria dei punti secondari, qualcosa da mettere al centro dei nostri pensieri e del nostro fare.
Da “De la lang(ue)”
 di Antonio Belfiore
di Antonio Belfiore
Jadis, si je me souviens bien
j’ai répété aussi: il corpo
c’est une parfaite machine!
Ma questa sporca poltiglia
(chiamala soul o identité)
non è altro che se stessa.
E tu non mostrarmi più
le solite espressioni
gli sguardi e i brutti tic
del tuo hic, del loro nunc:
il tuo volto is worth
much more, davvero
molto più che solo questo.
Lettre à un voyou. In memoria di Samuel P. le prof d’histoire

“Preferirei di no”. Valle Cascia: un tentativo di guardare oltre
una lettera aperta
di Giuditta Chiaraluce

«Quelli come noi / che son venuti su un po’ strani /
[…] basterà che un giorno / trovino un po’ di forza /
e aiuteranno gli altri a dare un calcio al mondo»
Claudio Lolli, Quelli come noi
Quand’ero piccola volevo fare la giornalista, poi -crescendo- me ne sono dimenticata. Peccato, perché ora mi sarei stata utile. Sono nata in una piccola frazione nel comune di Montecassiano, a valle di Macerata: Valle Cascia. Se dovessi pensare ad una figura retorica per definire Valle Cascia penserei alla metonimia: Vallecascia detta anche la fornace. La frazione è nata e si è sviluppata nei primi del novecento intorno ad una fabbrica di mattoni come ce ne sono tante nel nostro territorio. Ci lavoravano tutti, anche una parte della mia famiglia, mentre l’altra dava da mangiare e bere agli operai: mio nonno aveva il bar e l’alimentari/emporio del paese. In quegli anni non si parlava di amianto, di silicosi, si lavorava e basta. Si lavorava, ci si ammalava ma si continuava a lavorare. Dopo circa 120 anni nel 2012 una grande nevicata ha distrutto uno degli ultimi capannoni rimasti ancora produttivi; di conseguenza, la fornace ha dichiarato fallimento ed è stata chiusa. Non vi sto qui a raccontare le vicende giudiziarie che ne sono seguite né a sottolineare la mancanza di investimenti per poter ammodernare gli impianti; vi voglio solo raccontare quello che sta succedendo nel 2020. A maggio improvvisamente si alza una montagna di fumo e polvere, le persone che abitano davanti alla fornace capiscono immediatamente cosa sia successo. Vedono gente scappare alla rinfusa. Scopriamo poco dopo che all’interno di un capannone stavano lavorando degli operai per smantellare il ferro così da poterlo vendere e ricavare qualche soldo che permettesse all’azienda di recuperare fondi per poter pagare gli insoluti. Tagliando tagliando hanno tagliato un arco di ferro che teneva in piedi la volta del capannone e il capannone è crollato. Non c’è bisogno che vi dica i danni che comportano le polveri di amianto, sarebbe bastato, una volta avvertito il sindaco, chiamare i vigili del fuoco che avrebbero con l’acqua quantomeno atterrato le polveri; invece sono intervenuti funzionari dell’Arpam a dire che era tutto a posto. Evidentemente non era tutto a posto ma si sa come vanno queste vicende. Era maggio, il covid ci trovava appena usciti dal lockdown, il sindaco ci ha rassicurati e rinviati ad un incontro da fare di lì a poco per parlarci del piano di smantellamento dell’amianto. L’estate passa, nessuno si dimentica di quel cimitero di amianto ma con le cose brutte si impara a convivere come con le cose belle, ne sono certa. Non solo ci si convive! Una leggenda narra che a Valle Cascia sono tutti un po’ toccati dai fumi: ci sono molti genietti della fisica, della matematica, della geologia, e ci sono un gruppo di ragazzi strani, con delle tendenze sessuali considerate “particolari”, un po’ troppo liberi per essere nati e cresciuti in un posto così piccolo e bruttino. Questi ragazzi che si ritrovano solo d’estate perché studiano tutti fuori Macerata (Roma, Milano, Londra, Dublino) da due anni hanno creato dal nulla una festa della poesia che coinvolge i vari luoghi della fornace. Quest’anno,vista la difficoltà di organizzare qualunque cosa a causa del covid, hanno organizzato tutto intorno allo spazio della chiesa; una chiesa che è il simbolo di Valle Cascia perché è stata costruita mattone dopo mattone dalle persone che dedicavano dopo il lavoro una parte del loro tempo a tirarla su. Non starò qui a raccontarvi neppure la quantità di impedimenti che ci sono stati per organizzare la festa e quanto il comune di Montecassiano l’abbia poco sostenuta… A noi interessano i risultati e non possiamo proprio lamentarci: tre giornate meravigliose piene di persone venute da tutta Italia che giravano per Valle Cascia come una piccola Santarcangelo dei tempi d’oro. Ma torniamo a noi, ho un po’ divagato per rallegrare il racconto!
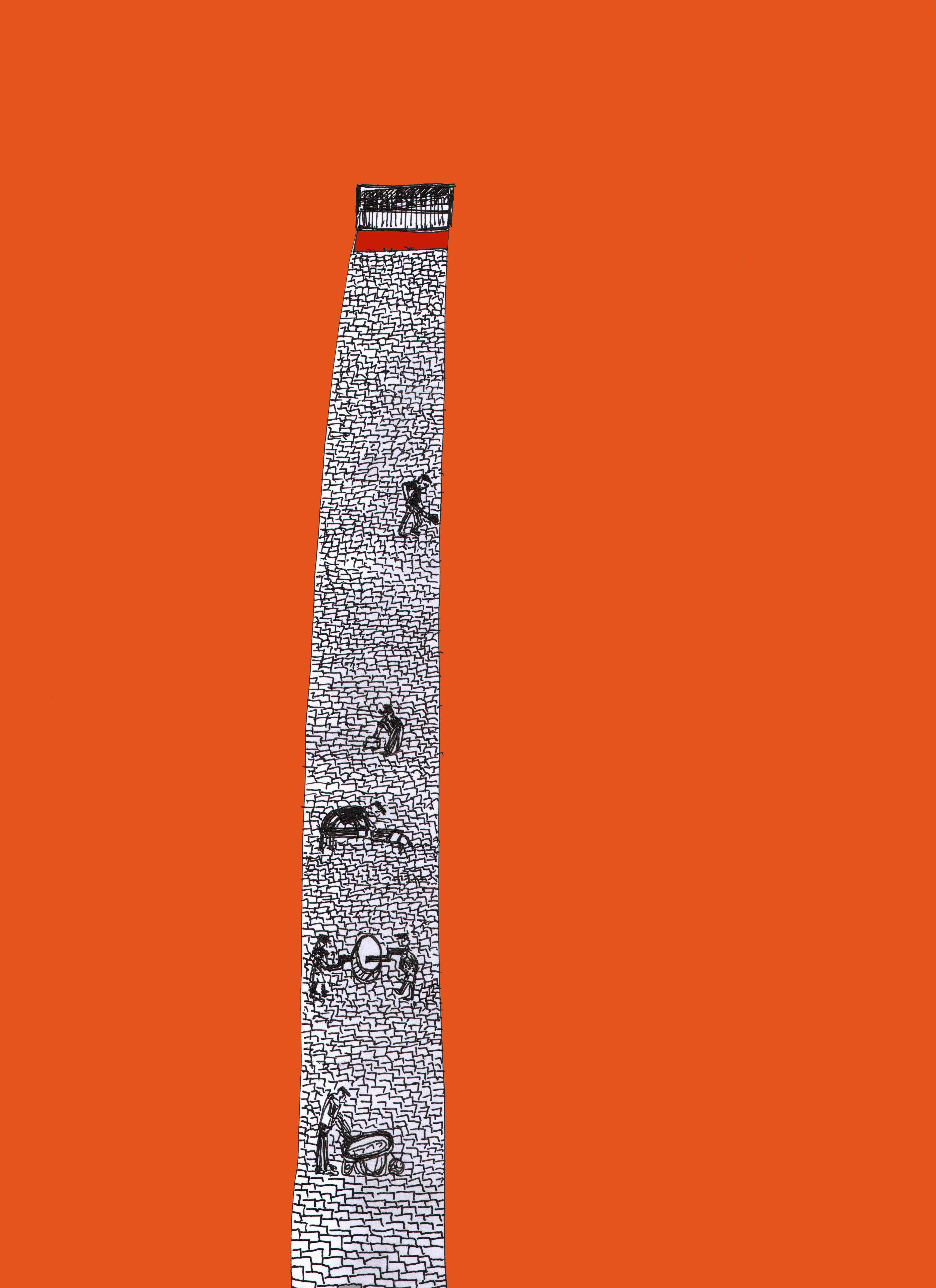
Dunque: ci lasciamo a maggio con il sindaco che si impegna per organizzare una riunione, lo rivediamo nel mese di ottobre nella sala consiliare con una delegazione di 15 persone per parlare di un altro mostro che sta invadendo Vallecascia. Mi sono accorta tardi di quello che stava accadendo e me ne sono accorta improvvisamente: sono andata a chiedere direttamente al direttore dei lavori perché nessuno sapeva cosa fossero quei lavori da poco iniziati. Grandissima responsabilità che abbiamo in tutta questa vicenda! A Valle Cascia, proprio di fronte casa mia, accanto alla fornace Smorlesi che fa bella mostra di tutti i suoi mostri amiantati sta sorgendo come un’araba fenice che nasce dai fumi e dalla polvere di amianto una bella ditta per la produzione di tubi in PVC. Questo nel 2020, quando si parla di giornata mondiale contro la plastica! È difficile intraprendere una battaglia legale, è difficile coinvolgere una popolazione di 400 abitanti in questa lotta, è difficile far capire agli abitanti di Montecassiano, S’Egidio, Sambucheto, Macerata che è una battaglia di civiltà che riguarda tutti, è difficile mettersi d’accordo sul modo di procedere, è difficile mettere insieme tante anime politiche diverse, è difficile non permettere che qualcuno più di altri cavalchi l’onda, ma noi ci stiamo provando.
Il sindaco di Montecassiano si ritiene estraneo alla lotta; dice di non aver fatto nulla perché non spetta a lui fare qualcosa, dice che la ditta ha tutti i permessi in regola, dice che non c’è nessun problema per la salute, dice che ci inventiamo storie per fare polemica, dice che non è vero che Valle Cascia è una discarica comunale (non ci siamo fatti mancare neanche un deposito di rifiuti speciali del Cosmari e una cava che non si sa bene con che cosa sia stata riempita), dice che ce l’abbiamo con lui, dice tanto ma per quanto mi riguarda non ha detto una cosa fondamentale: la ditta ha tutte le carte in regola (sembrerebbe, poi vedremo), ma io, sindaco, preferirei che voi trovaste un altro posto perché non mi sembra il caso di costruire una cosa simile in mezzo alle case e vicino ad una discarica di amianto, con un fosso che straripa ogni volta che la pioggia abbonda e non viene mai pulito («ma non è mia responsabilità, deve farlo il consorzio di bonifica») e una strada pericolosissima lungo la quale più volte abbiamo chiesto di poter mettere qualcosa per rallentare la velocità. Ho scoperto che un semaforo in quella strada non si può mettere ma una bella “fabrichetta” di plastica ci si può costruire.
Infine, non starò qui a raccontarvi di una famiglia che conosco da quand’ero piccola, che ha ristrutturato la propria casa e il proprio giardino per trascorrere la pensione in serenità e ora si ritrova la ditta praticamente dentro casa. Non vi racconterò anche questa storia, credo sia sufficiente il resto. Per amor di onestà devo confessare che non vivo più a Valle Cascia da tanti anni ma ci vive la mia famiglia e in questi giorni mi si è risvegliato un senso della comunità che non ricordavo di avere. Non si tratta di un qualcosa limitato alla periferia della periferia, ma di un qualcosa che coinvolge un’intera civiltà. E dunque: buona lotta a tutti!
Democrazia e blasfemia
 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese
La notizia è di quelle che ti si appiccicano addosso per tutta la giornata come una iettatura: un professore delle scuole medie decapitato dal solito terrorista dell’ultimo minuto. Se il fatto in sé è inverosimile e nauseante, lo è ancor più la motivazione: il professore è stato ammazzato perché, durante una lezione sulla libertà di espressione, aveva mostrato in classe due caricature di Maometto, diventate tristemente celebri in seguito alla strage della redazione di Charlie Hebdo nel gennaio del 2015.
Libere associazioni ( opinioni di un disadattato)
di Giorgio Mascitelli
Nei giorni scorsi, giusto per confermare quanto gli inglesi amino la libertà più di noi popoli schiavi, il governo Johnson ha emesso un divieto di utilizzare nelle scuole della sola Inghilterra e non in tutto il Regno Unito materiali didattici provenienti da organizzazioni anticapitaliste, anche se trattano altri argomenti, durante le attività di educazione alle relazioni interpersonali, al sesso e alla salute. Da un punto di vista concreto non credo che il provvedimento modifichi profondamente la struttura didattica della classista scuola inglese perché già ora non credo, per quanto ne so, che Marx ( e nemmeno George Giessing, se è per questo) sia oggetto di insegnamento; è probabile che l’obiettivo autentico dell’operazione sia quello di equiparare in forma ufficiale l’anticapitalismo al razzismo, all’antisemitismo e all’odio per la democrazia e lo svolgimento di libere elezioni. Da un certo punto di vista si tratta di una vicenda profondamente angloinglese e, a mio parere, da ricondurre alla Corbynfobia che ha colpito le classi dirigenti inglesi, per cui esse stanno cercando strumenti di ogni genere per impedire che il partito laburista torni nelle mani di una leadership di ispirazione socialista. Dall’altro lato è probabile che questo di Johnson diventi un esperimento politico di autoritarismo a scartamento ridotto, che potrebbe essere riutilizzato altrove, man mano che l’ampliamento della crisi economica rende poco credibili le cause settoriali a cui ricorre il main stream per spiegarla ( la colpa sarebbe della corruzione oppure della mancanza di meritocrazia o del fatto che ci siano poche donne nei posti di comando o della scuola che è obsoleta, e così via) e si deve dunque stigmatizzare qualsiasi discorso alternativo come frutto delle forze del male.
Naturalmente queste che ho fatto sopra sono soltanto delle illazioni o delle ipotesi, ma se c’è un fatto certo in questa vicenda è che un provvedimento simile non sarebbe stato nemmeno pensabile senza l’egemonia del politicamente corretto nella società occidentale. La credibilità dell’associazione dell’anticapitalismo a forme di razzismo e antisemitismo è infatti possibile solo in virtù di quella che Jonathan Friedman chiama la logica associativa del politicamente corretto. Questa logica consiste nel fatto che se un soggetto compie un’affermazione A, nel discorso politicamente corretto si tende automaticamente ad attribuirgli le affermazioni o prese di posizione B, C e D, indipendentemente da ciò che lui pensi o abbia affermato perché in passato queste ultime sono state sostenute da chi credeva in A. Per esempio, dato che talvolta dichiarazioni anticapitaliste sono state compiute da alcuni elementi antisemiti, il cosiddetto socialismo degli imbecilli come fu definito già a fine Ottocento, ne consegue secondo la logica associativa che qualunque anticapitalista sia antisemita, che è poi il senso implicito del provvedimento del governo inglese.
Naturalmente una simile associazione sarebbe facilmente confutabile se si guardasse alla storia, in cui vi sono stati regimi razzisti e autoritari che sono stati perfettamente guidati da logiche capitalistiche e, come nel caso del Cile di Pinochet, hanno anzi svolto un ruolo di primo piano come laboratorio delle pratiche capitalistiche. Questo sguardo storico però si scontra con l’allergia tipica del politicamente corretto a prendere in considerazione l’idea del mutamento storico e in generale una prospettiva diacronica. Inoltre i provvedimenti del governo inglese si configurano come pratiche di censura e interdetto. Il politicamente corretto ha reso largamente popolari pratiche di questo genere, quando siano giustificate da ragioni morali o politiche relative alla violazione dei diritti umani. E’ inutile ricordare la lunga teoria di richieste di censura di questo o quell’autore che attraversa ormai da anni il mondo universitario, in particolare anglosassone. Un esempio particolarmente eloquente che merita di essere citato è quello che si è avuto durante il movimento del metoo allorché l’attore Kevin Spacey, coinvolto in uno scandalo sessuale, fu sostituito nelle riprese del film di Ridley Scott Tutto il denaro del mondo, quando la pellicola era giunta quasi al termine delle riprese. Ora questa procedura tipicamente novecentesca di cancellazione da tutte le immagini ufficiali di un personaggio caduto in disgrazia era di solito compiuta nel silenzio a dispetto della sua stessa evidenza, mentre in quella circostanza è stata non solo pubblicizzata, ma anche esaltata per lo sforzo produttivo e tecnologico che ha comportato. E’ questo il segno più evidente di un’assuefazione del pubblico anche colto e progressista a pratiche di censura e interdetto purché opportunamente giustificate in termini politicamente corretti. E’ solo in un paesaggio sociale di questo genere che è possibile nascondere la natura liberticida dei provvedimenti del governo inglese ( e infatti sono passati nella disattenzione generale, se escludiamo le voci di Varoufakis, di Tariq Ali e di un paio di esponenti della sinistra laburista).
Questa vicenda a sua volta illumina la natura del politicamente corretto che non è un semplice galateo delle èlite internazionali, come io stesso credevo, ma è un procedimento di controllo del discorso pubblico definito non tanto dai suoi contenuti, che sono mutevoli o in continuo assestamento, ma dalle sue procedure. Ciò che definisce il politicamente corretto non sono quindi i contenuti progressisti liberali, per esempio l’antirazzismo perché quando un movimento antirazzista come quello della scorsa primavera negli States ha messo in luce la strutturale violenza repressiva della polizia è subito uscito dai criteri di accettabilità del politicamente corretto, ma l’accettazione dell’attuale forma di organizzazione economica e la sistematica applicazione di certe procedure di controllo: il politicamente corretto è sempre uguale nel decidere cosa dev’essere moralmente censurato, di cosa si possa parlare, chi sia autorizzato a farlo nel senso che abbia credibilità e così via.
Tutto questo rientra nei sintomi morbosi del nostro tempo, per usare l’espressione gramsciana che qualche anno fa Donald Sassoon ha rispolverato in suo bel libro. I sintomi morbosi si producono quando il vecchio è morto e il nuovo non è ancora nato. Viviamo pertanto in un periodo di transizione, purtroppo per noi nella storia questi periodi di transizione possono durare più della vita di un uomo e noi uomini siamo.
Audio Doc Sound: parti sonore, video invisibili
di Pietro D’Agostino
Normalmente alla base della produzione di un film, di un documentario o comunque di una serie di immagini in movimento, vi sono almeno un soggetto a cui fa seguito una sceneggiatura. Scrittura, testi che con l’apporto del sonoro in maniera più o meno lineare portano alla costruzione di un impianto filmico. Qualche tempo fa mi sono chiesto quale risultato potesse scaturire da una inversione, seppur parziale, di tale modalità: partire da una sceneggiatura di sole immagini per produrre un apparato di senso esclusivamente sonoro, né scritto, né visibile.
Un audio documento per voci e strumenti musicali. Ho immaginato autori, scrittori e musicisti in una visionaria prospettiva: dei personaggi sonori.
L’impianto che precede la realizzazione dell’audio documento consiste nella preparazione, e la conseguente realizzazione, di due elementi: una sceneggiatura visiva, un video; e una scaletta dove assegno a ognuno degli autori partecipanti una parte all’interno della sceneggiatura visiva. Questa parte consiste in una porzione temporale individuata dentro la durata complessiva della sceneggiatura visiva. Ad esempio: la sceneggiatura ha una durata totale di 10 minuti; a un autore vado ad assegnare una parte dal minuto 2’ e 50’’ fino al minuto 3’ e 20’’. All’interno di questo spazio temporale questi produce il suo intervento: una registrazione vocale per gli scrittori e una registrazione strumentale per i musicisti. La scaletta prevede più interventi e sovrapposizioni in dialoghi tra gli autori ma, aldilà del sapere con chi si è in dialogo, non si è a conoscenza di cosa l’altro o gli altri hanno prodotto. Chiaramente tutti vedranno la sceneggiatura visiva nella sua interezza per avere un’idea complessiva della stessa.
Con tutti i materiali richiesti a disposizione, procedo al montaggio audio rispettando linearmente la scaletta di partenza in cui sono state assegnate le parti a ciascun autore. L’impegno è quello di rispettare in modo sistematico la successione temporale delle parti assegnate. Comunque può succedere che per motivi specificatamente tecnici operi dei minimi cambiamenti nel montaggio, questi però non influiscono minimante nella sostanza della linearità compositiva.
Partire da una sceneggiatura visiva per approdare a un documento sonoro. Il visivo scompare per lasciare spazio all’uditivo. O, forse, a un altro vedere e sentire.
Audio Doc Sound Title #1:
personaggi sonori:
| musicisti: Marco Ariano, Alipio Carvalho Neto, Luca Venitucci
| autori ed esecutori: Mariangela Guatteri, Giulio Marzaioli, Simona Menicocci, Marcello Sambati, Fabio Teti
| masterizzazione: Marco Resovaglio
| ideazione, sceneggiatura visiva, montaggio audio e regia: Pietro D’Agostino
Audio Doc Sound Title #2:
personaggi sonori:
| musicisti: Mike Cooper, Elio Martusciello
| autori ed esecutori Maria Grazia Calandrone, Marco Giovenale, Lidia Riviello
| post produzione, missaggio e titolo sonoro: Marco Resovaglio
| ideazione, sceneggiatura visiva, montaggio audio e regia: Pietro D’Agostino
Stramer di Mikołaj Łoziński_un estratto
Il brano che segue è tratto dal romanzo Stramer di Mikołaj Łoziński (Wydawnictwo Literackie, 2019), inedito in italiano. La traduzione dal polacco è di Francesco Annicchiarico.

di Mikołaj Łoziński
Ogni nuovo giorno portava con sé nuovi clienti al caffè Da Stramer, ma nonostante questo Nathan non era del tutto soddisfatto. Lui si aspettava ben altro.
Rena aiutava sua madre in cucina, si sarebbe occupata della parte kosher, che non dava troppi problemi, visto che per la maggior parte i loro clienti erano ebrei che si atteggiavano a polacchi, come diceva Nathan.
Rudek, Salek e Hesio gironzolavano continuamente con i vassoi per i tavoli. I più piccoli, Wela e Nusek, per Rywka erano “i portafortuna e le pubblicità ambulanti del nostro locale”, li chiamava così, amorevolmente, ma per Nathan quei tre stavano sempre in mezzo ai piedi di tutti. E soprattutto ai suoi, che entrava e usciva dal locale.
«Goddammit», si diceva mentre usciva in strada per riflettere sul da farsi.
Una cosa era sbattere la porta uscendo per non mettere più piede nel locale di un altro, ben altro era farlo nel proprio, da cui non c’era modo di andarsene.
Nathan comprese subito dove aveva sbagliato soltanto adocchiando i suoi quattro tavolini occupati. Non ce n’entrerebbe mica un quinto? Dovrei buttare via il biliardo. E se pure lo facessi, cosa risolverei?
Niente.
Gli veniva voglia di sputare per terra, tanto la rabbia. Sputare davanti al proprio locale? Inutile anche questo.
Chi lo avrebbe mai detto che la gente restava ore seduta a un tavolino? Ore e ore a parlare o a starsene zitti. A guardarsi o a guardare fuori dalla finestra. A fumare sigarette o fiutare tabacco. A giocare a scacchi o a carte. A scrivere o leggere chissà che. A sghignazzare o a cascare morti di sonno sul tavolo.
E il tempo passava.
E solo una cosa era sempre la stessa: questi sempre, sempre, sempre lì.
Dei nuovi clienti avrebbero ordinato panini, trippa e birra, e per finire torta e caffè. Ma tanto, che ci pensava a fare? Fossero pure entrati, sarebbero usciti subito, tutti i posti erano occupati. Sarebbero corsi a regalare soldi alla concorrenza.
Più in generale, i clienti degli altri ora avevano un aspetto molto migliore dei suoi.
E se i miei non avessero dove andare? Ma non hanno niente di meglio da fare, che ne so, magari andare a lavorare? Mettere la pagnotta a tavola? Dei figli che li aspettano a casa o dei genitori bisognosi di cure? Che fossero tutti come lui, che ha solo questo caffè?
E gli starebbe pure bene, ma perché allora non ordinano qualcos’altro?
Sarebbero questi i tanto rinomati habitué? Mezza giornata con una tazzina di caffè davanti?
Per non dire di come s’industriavano per sfuggire allo sguardo a distanza dei camerieri.
Cosa non si faceva per avere al tavolino quella tazzina che il cameriere non poteva portar via, perché ancora mezza piena.
«Le porto qualcos’altro?» (O prendi qualcosa o arrivederci e grazie).
«No, grazie, ho ancora questo.» (Lasciami stare).
«Le consiglio la trippa, buonissima.» (Almeno pane e burro).
«Magari quando finisco il caffè?» (Non ti lascerò nemmeno un centesimo di più).
«O forse le andrebbe una fetta di charlotte alla cannella?» (Allora sparisci).
«No, grazie.» (Sparisci tu, io di qui non mi muovo).
E così via per giorni e settimane. Quanto ancora doveva durare?
C’erano volte che Nathan avrebbe mollato tutto per andarsene a Oświęcim, dritto all’agenzia viaggi di Zofia Biesiadecka, che aveva le tariffe più economiche per l’America e il Canada.
Nathan non smetteva di pensarci, nemmeno dopo il lavoro. In casa tutti già sprofondati nel sonno e lui, solo in cucina, a dondolarsi come tra le onde, coi gomiti sul suo scomodo tavolino sgangherato. La zeppa sotto il piede del tavolo era sparita già da molto. Forse qualcuno l’aveva buttata nella stufa per errore. Ora non aveva né tempo né voglia di occuparsene.
Di buono, almeno, c’era che era arrivata una lettera da Ben. Prima addirittura di leggerla, Nathan corse dal cambiavalute, ma non gli accettarono quelle sue banconote macchiate, si era dimenticato quella dannata boccetta. La sera, come ogni volta, Rywka gli lavò e stirò i suoi dollari e al mattino seguente Nathan andò a farseli cambiare da un altro cambiavalute.
Ce n’erano talmente tanti in città che neanche ci aveva fatto attenzione prima. E tutti con un tasso di cambio fisso: 5,25 zloty per un dollaro. Si immaginò subito proprietario del suo cambiavalute “Da Stramer”.
Nathan e il suo tavolo sgangherato si inclinarono verso destra.
Non aveva ancora scritto niente, a Ben, circa la caffetteria che aveva aperto grazie ai suoi soldi. Quasi come se l’informazione dovesse trovare da sola la strada per suo fratello. E quasi non gli era rimasto più alcun motivo di vanto. Ora avrebbe letto della chiusura del suo locale, prima ancora che avesse saputo dell’apertura.
Che fare?
Nathan si sporse verso sinistra. Istantaneamente trattenne il tavolino e infilò il piede nell’interstizio che creava col pavimento.
Un secondo dopo gli venne un sorriso.
Mi basta solo pensare a Ben, per farmi venire un’idea.
Nathan andò a dormire molto più sereno.
Il mattino dopo scese nello scantinato. Ne venne fuori con la sega e la carta vetrata sottobraccio. Oltrepassò con aria indifferente il tavolo della cucina dove sedeva tutta la sua famiglia a fare colazione.
Probabilmente non sentì nemmeno Nusek chiedergli: «Che fai, papà?» perché non gli rispose niente.
Arrivato al locale, Nathan non si tolse nemmeno il cappello o la sua giacca preferita. Gli restava ancora un’ora prima dell’apertura. Rywka sarebbe arrivata a breve con i bambini, e i più grandi dopo scuola e le ripetizioni che ora davano nel loro appartamento, vuoto durante il giorno.
Si chinò sul tavolino più vicino alla finestra, dove in genere sedevano i suoi habitué per rovinargli la giornata e gli affari. Adesso basta. Prese la sega, ma si trattenne. Qualcuno avrebbe potuto vederlo, dalla strada.
Portò quattro sedie Thonet sul retro, dietro la tenda con la parte kosher. Le capovolse tutte. Le squadrò. Legno curvato, seduta incannicciata, schienale arrotondato. Pregiata manifattura austriaca. Checché se ne fosse detto, aveva fatto davvero un affare ricomprandole insieme ai tavolini del caffè Pod Płachta. Davano via il vecchio mobilio perché il nuovo proprietario voleva tutto modernissimo.
Nathan prese a segare le gambe anteriori della prima sedia di un centimetro, con cautela, per non spezzare niente. Provò a sedersi. Sì, così dovrebbe bastare. Accorciò le gambe delle altre tre e poi scartavetrò tutto.
Rimise le sedie al tavolino accanto alla finestra.
Prima di mettersi seduto al tavolino accanto, ci lanciò il cappello pensando, e non per la prima volta quel giorno: questa testa vale molto di più di quel cappello.
Da lì si mise ad osservare la propria opera. Un lavoro da incorniciare. A una prima occhiata, quelle sedie non differivano in niente dalle altre. A Rywka, che aveva portato due enormi sporte di spesa, non disse niente per non tirarsi dietro la iella. L’abbracciò e l’aiutò a spostare la spesa sul retro.
«Cos’è tutta questa polvere?» lei gli indicò il pavimento.
Nathan scrollò le spalle e la polvere dalle maniche, istintivamente.
Aveva piazzato la sua trappola. Ora c’era da aspettare che i poveri habitué ci cascassero.
Manco a dirlo, proprio oggi non se ne vedeva nemmeno l’ombra. Nathan li fissava, impalati lì sul marciapiede di fronte. Che avessero capito qualcosa? Colse l’occasione per acchiappare anche un po’ di sole settembrino, per non perdere completamente l’abbronzatura estiva che tanto piaceva a Rywka.
Si sentì meglio solo al pomeriggio, quando strizzando gli occhi si accorse della sagoma gobba e familiare di uno degli habitué. L’uomo si avvicinò, con entrambe le mani occupate da pile di fogli, due libri e vari giornali.
Ancora a leggere?, pensò Nathan, non ti è bastato ieri?
Ultimamente si arrabbiava anche a casa sua, quando vedeva Salek e Hesio passare serate intere sui libri. Che nuova mania. Avrebbe preferito saperli a dare calci al pallone, come Rudek. Ma cosa poteva farci, tanto di quei tempi persino gli alunni osservanti di yeshivah, quelli che portavano kippah e payot, se ne andavano in giro per Tarnów con la faccia lunga e il libro di preghiere sottobraccio, che sotto la copertina benedetta nascondeva le opere di Marx.
E nonostante l’aspetto esteriore, anche quei giovani erano diversi dentro.
O almeno così si diceva.
E se fosse vero che i giovani al tempio salmodiavano dondolando sui libri sacri, sussurrando frasi di Marx o di quell’altro, quel Lenin?
I suoi figli, in casa, facevano così.
«C’è chi lavora per la famiglia», gli diceva ogni tanto «E chi per rendere onore agli occhiali.»
E se non reagivano, o facevano finta di non sentire, gli spegneva la luce.
«Si spreca l’olio.»
Anche al buio percepiva Salek e Hesio che rivolgevano lo sguardo al cielo.
«Noi siamo autodidatti», gli disse Hesio una volta.
«Auto che? Con l’auto vi ci manderei a…» e si fermò, prima di scoppiare a ridere, ma si trattenne perché c’erano le sue figlie a guardarlo.
«Lasciali stare», gli chiese Rywka.
Pure quello lì è un autodidatta, si disse Nathan nei pensieri, rivolto al suo habitué, anzi, è un autodisdetta. Sotto l’egida severa di Nathan, il del tutto inconsapevole habitué sparpagliò fogli e giornali sul tavolino accanto alla finestra. Era così felice di aver trovato libero quel posticino, così ben illuminato. Non si era accorto che, poco dopo l’apertura, Nathan aveva piazzato apposta un foglietto con la scritta RISERVATO, tolto prima che lui entrasse nel locale.
«Buongiorno, cosa le porto?» gli chiese Nathan come al solito.
L’habitué si guardò intorno, come se cercasse nel modesto spazio interno della caffetteria la risposta a una domanda tanto difficile. O forse si chiedeva se ci fosse qualcosa di meno costoso del caffè a venti centesimi.
«Un ristretto, per favore.»
Dopo aver ordinato qualcosa, ripiombò nelle sue letture. Senza staccare mai gli occhi, nemmeno quando Nathan gli posò la tazza sul tavolino.
Sarebbe bastato versargli qualcosa dentro il caffè per liberarsene una volta e per sempre. Il veleno, ci voleva, altro che trappola. Ma non era questo il punto.
Da dietro il bancone Nathan con la coda dell’occhio osservava l’habitué che lottava con la sedia. Lo vide puntare i piedi, contorcersi sulla seduta, ma senza smettere di scivolare. Poi interruppe la lettura, si mise in piedi, spostò la sedia e un attimo dopo ricominciò allo stesso modo.
Nonostante tutto non si arrese, e accanito come un cowboy americano, inforcò altre sedie, che pure lo sbalzarono via.
Arreso, si guardò intorno in sala, come se cercasse di capire se il problema fosse lui o la sedia. Rivolse uno sguardo interdetto verso Nathan, che per la prima volta gli rispose con un sorriso amichevole.
Questa fu forse la goccia, perché l’habitué raccolse le sue carte, lasciò cadere sul tavolino venti pesantissimi centesimi e si buttò la giacca sulle spalle. Poco ci mancava che lasciasse lì il suo caffè. Se ne ricordò solo una volta alla porta. Si voltò e lo bevve in piedi, onde evitare.
«Bye-bye», lo salutò Nathan.
Spostò lo sguardo incredulo all’orologio, e si stupì al proprio riflesso sullo specchio del bar.
Niente male, pensò, è rimasto nemmeno venti minuti sulle sedie accorciate. Magari si trova chi fa meglio. Forse quelli appena entrati.
Il tempo cominciò a passare più velocemente. Nathan non controllava nemmeno più l’orologio, i clienti cambiavano continuamente, i secondi rimpiazzavano i primi, nessuno era rimasto seduto per più di mezz’ora a quel tavolino.
Per la prima volta, quel posto aveva cominciato a portare soldi, e più che gli altri tre messi insieme.
La sera, Nathan uscì in strada fermandosi sotto la vetrina con l’insegna. Come nel giorno dell’inaugurazione.
Rywka e i suoi figli erano già tornati a casa, in quella via Goldhammer deserta sembrava ci fossero rimasti solo Nathan e i lampioni accesi.
Prese un profondo respiro. Persino i cassonetti della città oggi parevano puzzare meno del solito.
Eccezionalmente, non odiava neanche più quelle falci e martello e quelle scritte sul proletariato che di recente qualcuno aveva scarabocchiato sui palazzi. Anche se c’era da dover rifare le facciate, o meglio, acchiappare quel figlio di cagna che aveva sporcato per farglielo fare.
Quel giorno a Nathan gli venivano solo buone idee.
Già si vide scriverlo per lettera a suo fratello Ben: non solo mi sono sbarazzato degli habitué, ci ho pure guadagnato. E d’oltreoceano sarebbe arrivata una risposta entusiastica, rigonfia di banconote:
Dear Nathan,
Io e Pepi ti facciamo i nostri migliori auguri! Non vediamo l’ora di ritrovare Te, Rywka e i ragazzi per metterci al bancone degli Stramer (non prenderemmo un tavolo per niente al mondo!) e gustare quel tuo caffè tanto rinomato. Saltiamo sul primo vapore disponibile per l’Europa.
Forte di quella celebrità, e della benedizione americana, Nathan aveva già chiaro quale sarebbe stato il passo successivo. Una rivoluzione.
Che vada al diavolo, quel Lenin con la falce e il martello. A me basta solo segare, pensò mentre si rifugiava all’interno del locale.
Lo sfrigolio degli attrezzi risuonò fino a notte fonda.
Rincasando al mattino, percepì quasi l’odore della sua rivoluzione privata nell’aria di Tarnów. Riuscì a dormire sì e no tre ore, ma mai si era alzato più riposato. Si ricordò di ciò che aveva sognato guardando attraverso la ragnatela del finestrino sporco, nella latrina in cortile: suonava il violino su un grande palcoscenico, era la prima volta in vita sua che ne aveva in mano uno, aveva steccato, ma nonostante tutto il suo pubblico elegante gli aveva dedicato un trionfo.
Ancora sentiva quegli applausi, sulla strada per il locale. Scansò buche e pozzanghere, più attentamente del solito, e si guardò intorno per tre volte, prima di attraversare via Mickiewicz, per controllare che non passasse una bicicletta, un’automobile o il carretto di un contadino.
Neanche nelle trincee della guerra aveva fatto tanta attenzione.
Perché oggi si sentiva speciale, apprezzato, e soprattutto molto più prezioso di prima. Come qualcuno che ha in tasca il biglietto vincente della lotteria. O come un cercatore d’oro americano che ritorna con un sacco pieno di pepite.
Wonderful world: Nathan trottava di buonumore, incline persino a lanciare una monetina a qualche mendicante.
È così che devono essersi sentiti i grandi scopritori. Chi ha inventato la ruota, di certo si sarà guardato sotto il piede per non inciampare o finire sotto un elefante, una balena o in bocca a un leone. Di certo si saranno sentiti così, come si chiamavano quelli? Marconi e quell’altro, Radiostein.
Ma Nathan Stramer aveva inventato le gambe segate delle sedie.
Che d’accordo con le proprie previsioni funzionava a meraviglia, l’intero locale aveva provato a sedersi, consegnandogli quel giorno un profitto record.
Se continua così… Nathan moltiplicò in mente e poi buttò il risultato su carta.
Non riusciva più a trattenere i suoi pensieri e spese una parte del profitto immaginario addirittura per dei regali. Per Rywka, una gita al mare. Ma di certo non da sola. Sarebbe stato un viaggio in treno per tutta la famiglia. Le nostre prime vacanze.
Ma chi si sarebbe occupato del locale, durante l’assenza?
Quella sera Nathan decise che, in una situazione simile, fosse giunto il momento di mettere la sua famiglia a parte della grande scoperta. Ma prima, chiuse la porta e tutte le finestre del locale. Rywka e i ragazzi erano stati costretti a giurare di non dire una parola a nessuno.
«Sedetevi», cominciò a bassa voce. «Quello che vi dirò adesso è più importante di qualsiasi altra cosa abbiate mai sentito finora.»
Lui si appoggiò al tavolo da biliardo, per precauzione.
«Sei impazzito, papà?» Rudek addirittura si portò le mani alla testa, quando Nathan concluse.
«Scostumato!» Nathan puntò suo figlio già quasi adulto. «È così che ti rivolgi a tuo padre?!»
Ma non lo colpì. Non era più tanto sicuro della propria forza, dopo aver segato sessantaquattro gambe di sedia.
«Non dirai mica sul serio, papà?» Rudek aggiustò il tono.
Poi si scambiò uno sguardo con Salek e Hesio. E si portò una mano alla bocca per coprirsi un sorriso.
Osservando la faccia di Rywka e degli altri suoi figli, Nathan capì come dovevano sentirsi gli altri pionieri in anticipo sui tempi. Lui ricordava bene il passaggio del primo tram cittadino, persino prima che uscisse dal deposito, girava voce che avesse già investito un soldato, una balia con un bambino e una vecchietta. Tale era l’ignoranza, la malafede e il rigetto con cui doveva confrontarsi un grande visionario, persino da parte dei più cari.
Nathan fu assalito dalla tristezza.
Per chi altri aveva segato tutte quelle sedie? Mica per sé. Lui era già al mare.
L’aveva fatto per la sua famiglia.
Manco a dirgli grazie. Proprio Rudek, il primogenito, che un giorno, lontano e triste, avrebbe ereditato l’attività. Ma ne deve ancora mangiare di pane duro, hai ancora da imparare, figlio mio.
Si vedeva subito che non era mai stato in America. E se lo mandasse da suo zio a New York, invece che sul baltico? Che veda da solo di cos’è fatto davvero il mondo, e il mondo avrebbe compreso l’idea geniale di Nathan Stramer.
Neanche a farlo apposta, laggiù si dice: less is more. E infatti: meno sedie, e più guadagno.
Che tutti ricordino di chi è stata l’idea. La gente in America aveva la memoria corta.
«Dico sul serio», si rivolse a suo figlio. «Vuoi scommettere?»
Rudek scosse la testa.
«Hai paura di perdere?»
«No», rispose Rudek. «Io non scommetto mai.»
«E perché?» si intromise Salek.
«Quando due scommettono», continuò Rudek «Uno imbroglia e l’altro è un cretino.»
«Come ti permetti?!» Nathan strinse i pugni.
Questo moccioso sta superando ogni limite possibile. Non andrà da nessuna parte. Nemmeno al mare. Lo lascio qui a fare la guardia al locale.
Rywka posò una mano sulla spalla di suo marito.
«Non capisco…» Si voltarono tutti verso la finestra, come se si accorgessero solo adesso che c’era anche Nusek. «Perché uno imbroglia e l’altro è un cretino?»
«Perché il primo sa di avere ragione, e così frega l’altro», rispose Rudek.
«E se nessuno di loro sa niente?» La domanda di Salek attutì la tanto trattenuta esplosione di Nathan.
Bestemmie americane scossero le pareti e le vetrate del locale. Rudek si alzò, si voltò e raggiunse la strada a passo sereno.
Salek e Hesio gli si incollarono come una doppia ombra.
«Se nessuno dei due sa niente, vuol dire che i cretini sono due», spiegò Rudek una volta arrivati al marciapiede.
E siccome Nathan non accennava a calmarsi, Rywka raggiunse i ragazzi tenendo Wela e Nusek per mano.
Nathan continuò ancora per un po’, e più esattamente gironzolando tra i quattro tavolini vuoti, scuotendo la testa, gesticolando e ogni tanto parlando da solo, e se non fosse proprio solo?
Dopo una settimana, gli fu abbastanza chiaro che aveva fatto bene a non scommettere con Rudek. Del resto, cosa avrebbe potuto farci, aveva perso anche senza aver scommesso. In quel lasso di tempo, un giorno dopo l’altro, cominciò a perdere i clienti.
E alla fine non venne più nessuno.
Nathan si piazzava davanti alla sua insegna, e in quella via Goldhammer deserta sembrava ci fossero rimasti solo lui e i lampioni accesi.
Quella notte fu colto dall’influenza intestinale.
Rywka spiegò ai ragazzi che le urla erano il primo, repentino sintomo della malattia. E così bisognava trattarle.
Lasciò le tende chiuse, in camera da letto.
_
Diritti per l’Italia liberi e gestiti da Nova Books Agency
La cornice e il testo
![]() [E’ da poco uscito per la Tic edizioni di Roma un libro particolarmente atteso: La cornice e il testo. Pragmaticità della non-assertività del critico Gian Luca Picconi. Si tratta di un lavoro non solo critico, ma anche teorico importante, che affronta di petto una serie di questioni che riguardano la poesia in genere, e la cosidetta scrittura di ricerca in particolare. Il libro di Picconi mostra anche che è possibile ritessere non solo mappe, ma anche analisi, nessi concettuali, valutazioni, attraverso quella che viene a torto considerata una nebulosa senza contorno di testi e discussioni. Gli siamo grati anche per questo, e per permetterci, assieme all’editore, la pubblicazione del capitoletto introduttivo.]
[E’ da poco uscito per la Tic edizioni di Roma un libro particolarmente atteso: La cornice e il testo. Pragmaticità della non-assertività del critico Gian Luca Picconi. Si tratta di un lavoro non solo critico, ma anche teorico importante, che affronta di petto una serie di questioni che riguardano la poesia in genere, e la cosidetta scrittura di ricerca in particolare. Il libro di Picconi mostra anche che è possibile ritessere non solo mappe, ma anche analisi, nessi concettuali, valutazioni, attraverso quella che viene a torto considerata una nebulosa senza contorno di testi e discussioni. Gli siamo grati anche per questo, e per permetterci, assieme all’editore, la pubblicazione del capitoletto introduttivo.]
di Gian Luca Picconi
Cosa sta succedendo nel Caucaso: Azeri, Armeni, ma anche altri
di Franz Di Maggio
(Volentieri pubblico questa mia intervista – condotta in collaborazione con Kika Bohr – a Franz Di Maggio a proposito del recente conflitto nella regione caucasica. a.s.).
Di una guerra parliamo. Ma “Non esistono guerre giuste” proclama perfino Papa Francesco nella sua ultima enciclica “Tutti Fratelli”. Vogliamo in questo caso dargli torto?

«Certo che no. A maggior ragione, se ce ne fosse bisogno, se si analizza con onestà intellettuale l’assurda contesa della regione del Nagorno Karabakh, nel Caucaso, detta Artsakh degli autoctoni di etnia armena. Leggiamo in questi giorni fantascientifiche ricostruzioni copiate e incollate da comunicati ufficiali del regime azero, regime che, notoriamente, attua un controllo capillare sulla totalità dell’informazione e dei media azeri. Come riportato da prestigiosi e indipendenti indici internazionali, il regime azero è tra i più liberticidi e autoritari al mondo e il presidente azero Ilham Aliyev, dopo aver ereditato il potere dal padre, è giunto al terzo mandato presidenziale consecutivo con l’85% dei voti.»
Ma cosa ha portato al conflitto armato?
«In realtà si tratta dello strascico di una mai risolta contesa, culminata all’inizio degli anni ‘90 del ventesimo secolo nella lotta per l’autodeterminazione del popolo karabaghzi dalla dominazione azera
Questa contesa alla base del conflitto è stata, durante tutta la dominazione sovietica, il negato esercizio del diritto all’autodeterminazione della popolazione armena del Nagorno-Karabakh dall’Azerbaijan, a quei tempi Repubblica Socialista Sovietica. Si trattava, allora come oggi, di ribellione a un sopruso che nel 1921, su iniziativa di Iosif Stalin, all’epoca Commissario per le Nazionalità, annetteva la regione, storicamente armena (lo testimonia Erodoto, Storie, libro VII, cap. 73, nel V secolo a.C.) e a maggioranza armena, come enclave dell’Azerbaijan con tutte le conseguenti discriminazioni di Baku nei confronti degli armeni nel Nagorno-Karabakh. Alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, incoraggiati dalla relativa libertà di espressione introdotta da glasnost e perestrojka in Unione Sovietica, gli armeni del Nagorno-Karabakh ribadirono il loro diritto all’autodeterminazione (si veda la Carta delle Nazioni Unite) con un referendum per l’indipendenza svoltosi regolarmente il 10 dicembre del 1991, secondo le modalità sancite dalle leggi vigenti e dalla costituzione dell’Urss. Al referendum seguì una vera e propria invasione militare da parte dell’Azerbaijan contro il Nagorno-Karabakh. Per più di un anno la popolazione civile di Stepanakert, la capitale del Nagorno-Karabakh, fu sotto il fuoco diretto di missili Grad e sottoposta a bombardamenti con bombe a grappolo dall’aviazione azera. Il ruolo dell’Armenia nella fase armata del conflitto, in mancanza di forze internazionali di interposizione, era quello di protezione dei civili nonché di assistenza umanitaria, economica e diplomatica; invece, nelle operazioni militari erano coinvolte le forze armene di autodifesa del Nagorno-Karabakh. Il 5 maggio del 1994 fu firmato l’accordo di Bishkek, da tre parti: l’Armenia, l’Azerbaijan e la Repubblica del Nagorno Karabakh.
Il regime Aliyev ha poi confezionato una «verità» armenofoba e finora i dissidenti azeri che hanno contestato tale «verità» sono stati arrestati o uccisi. Tutto questo, in aggiunta all’uso dei civili come scudo, rende le responsabilità criminali azere ancora più evidenti.»
Perché si è arrivati alla ripresa degli scontri armati?
«L’Azerbaijan si è più volte rifiutato di negoziare direttamente con il governo democraticamente eletto del Nagorno-Karabakh e ha rimandato al mittente le proposte OSCE sul ritiro dei cecchini dalla linea di contatto e sulla messa a punto di un meccanismo congiunto per indagini sulle violazioni del regime di tregua. L’Armenia invece era determinata ad arrivare a una soluzione negoziata del conflitto, soluzione che escludeva alla base l’utilizzo dello strumento militare per la composizione finale. Posizione questa condivisa dalla comunità internazionale e richiesta alle parti in conflitto.
Stiamo parlando – voglio ricordarlo – del confronto tra un regime dittatoriale che si perpetua (la famiglia Aliyev) da una parte, e dall’altra il diritto di autodeterminazione di un popolo che ha meritato la propria indipendenza non con le armi, ma attraverso processi politici pluralistici e istituzioni democratiche. Questa è la migliore prova di esistenza dello Stato che è la Repubblica del Nagorno-Karabakh e la risposta a coloro che lo giudicano uno “Stato che non c’è”.»
La distruzione di questo “Stato” sarebbe in linea con la visione nazionalista e autoritaria portata avanti dall’attuale regime turco?
«Certamente. La realizzazione di quel grande stato “panturchico” dal Caspio al Mediterraneo, sulla strada del quale si trova, lo scomodo, innocente e già sottoposto a genocidio popolo armeno. Come nel 1915 ci chiediamo se la comunità internazionale possa restare cieca e sorda a quanto accade in Artsakh e anche se gli attori di questo conflitto, non voluto dagli armeni e tantomeno dal popolo karabaghzi, debbano rimanere quelli regionali con l’entrata in campo delle due forze che nel medio Oriente e nel nord Africa decidono ogni conflitto: Turchia da una parte e Russia dall’altra.»
La Russia sembra voler giocare di anticipo. I ministri degli esteri azeri e armeni sono stati convocati a Mosca. Cosa si vuole ottenere?
«Sono comprensibili le preoccupazioni russe. Da una parte ci sono le basi militari russe in Armenia. Dall’altra il petrolio azero. E i turchi che continuano il loro progetto espansionistico verso oriente. Ma non dimentichiamoci gli altri attori del territorio. Se Israele ha fornito irresponsabilmente armi agli azeri, diventa complice di questa nuova ferita. Assurdo che un governo nato da un genocidio come quello ebraico, appoggi i fautori di un nuovo genocidio. Israele deve chiarire immediatamente la sua posizione e interrompere i flussi di armi verso l’Azerbaijan. Anche il governo italiano deve smarcarsi. Di Maio deve sapere che quando stringe la mano del ministro degli esteri turco, stringe una mano sporca di sangue. Il governo turco sta usando contro i suoi stessi cittadini di etnia curda e yezidi i jihadisti mercenari. E ora li sta indirizzando contro gli armeni, ma in un territorio non turco, ma “amico”. Anche l’Iran dopo aver rispettato per oltre un millennio accordi tra gli antichi dominatori persiani e i principi armeni delle montagne del Artsakh deve chiarire la sua posizione. Ovvio che il petrolio azero e la posizione geo-politica della Turchia spostano interessi pesanti. Infine attenzione alla Cina, che guarda a queste tensioni con interesse, dato che il progetto panturchico dovrà prima o poi confrontarsi con le mire cinesi nei territori sulla via della seta come Uzbekistan e Kirghisistan. Insomma, un panorama molto preoccupante, col rischio di una balcanizzazione del conflitto evidente.»
Alberi maestri
di Franca Mancinelli

ogni giorno per il taglio utile
ricominciare, e mai giungere
a se stessi –spezzata la custodia
della nascita, niente
altro che filamenti buoni al fuoco.
***
ho visto gli occhi degli alberi
nel folto una scossa
di chiarore rimasto –a vegliarci
come fitta pioggia che aspetta.
***
era inerte l’aria, percorsa da tremori e scosse. Bisognava ritrarsi, mettere in serbo la vita, sospingerla verso zone dove si aprivano sacche di quiete. Così sono cresciuto in questa forma amputata. La strada accanto puoi vedere in me come brucia.
***
non è stato intagliato
non è ancora dentro un viso.
Quando prende parola
la sua presenza trema.
***
ho iniziato a curvarmi, a prendere la strada del ritorno. Vado incontro ai fratelli che premono –mie biforcazioni notturne.
La superficie si infrange nascendo –la sfioro. Il cielo ha l’odore della mia linfa. Ho circoscritto me stesso. La mia maestosa statura.
***
dai rami della specie
la nuca, una cima
in ascolto tentenna
tutto l’andare è tornare,
un fascio di legna raccolta.
La sua fiamma mi schiuderà le mani.
***
da qui partivano vie
respirando crescevo
nel crollo, qualcosa di dolce
un incavo del tempo
tutti gli occhi che ho aperto
sono i rami che ho perso.
***
entro nella pioggia come in un bosco
–ali fittamente intessute
aperte e richiuse sotto la scorza.
Cammino, la nuca protetta
dai miei custodi, liberato lo sguardo
dalla gabbia degli occhi.
testi da: Franca Mancinelli, Tutti gli occhi che ho aperto, Marcos y Marcos 2020
Piccola antologia della peste
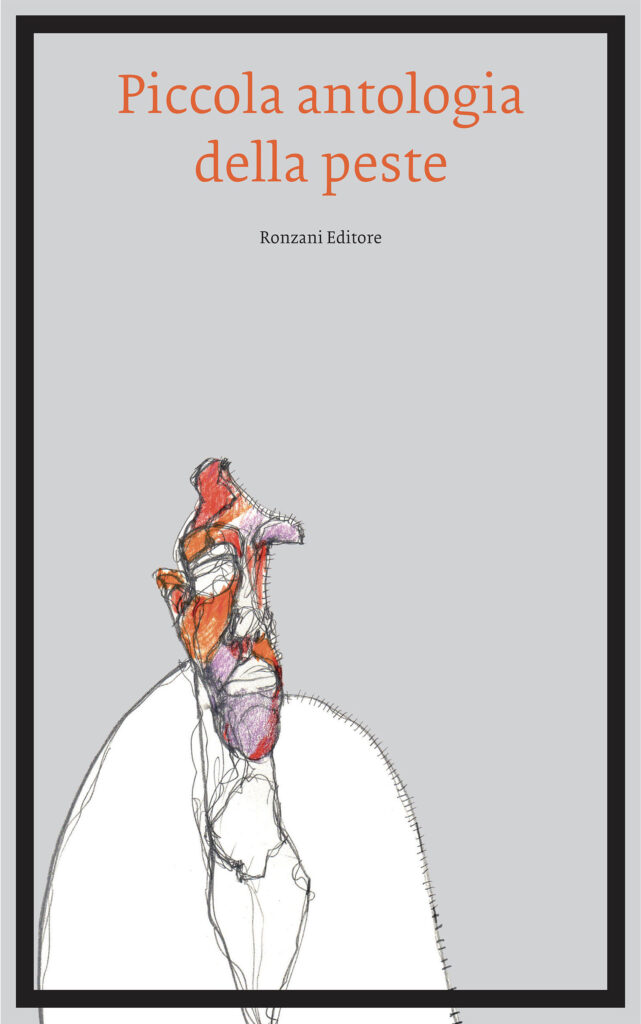 (Il 22 ottobre è in uscita, per Ronzani Editore, Piccola antologia della peste volume ideato e curato da Francesco Permunian che raccoglie i testi di trentaquattro autori, tra poeti e narratori, corredato dai disegni di Roberto Abbiati. Il brano che segue è l’introduzione al libro del curatore che qui ringraziamo. G.B.)
(Il 22 ottobre è in uscita, per Ronzani Editore, Piccola antologia della peste volume ideato e curato da Francesco Permunian che raccoglie i testi di trentaquattro autori, tra poeti e narratori, corredato dai disegni di Roberto Abbiati. Il brano che segue è l’introduzione al libro del curatore che qui ringraziamo. G.B.)
di Francesco Permunian
Il battito d’ali di una farfalla
«Mentre Dio andava lentamente abbandonando il posto da cui aveva diretto l’universo e il suo ordine di valori, separato il bene e il male e dato un senso a ogni cosa, Don Chisciotte uscì di casa e non fu più in grado di riconoscere il mondo, che, in assenza del giudice supremo, gli apparve all’improvviso d’una spaventosa ambiguità; l’unica Verità divina si scompose in centinaia di verità relative che gli uomini si divisero tra loro. Nacque così il mondo dei Tempi moderni, e con esso il romanzo, sua immagine e modello» – queste le parole di Milan Kundera, tratte da un suo breve saggio (La denigrata eredità di Cervantes) confluito poi in L’arte del romanzo.
Ed è appunto a tali parole – e alla conseguente immagine di un vecchio mondo finito in frantumi sotto i colpi di un virus letale – che s’ispira il progetto di questa antologia costituita dalle varie voci di una realtà improvvisamente implosa e ‘scomposta’ in mille schegge impazzite. Nella speranza di poter ricomporre, attraverso il collante della scrittura, gli infiniti frammenti di un unico affresco nazionale; o perlomeno di riuscire a tracciare i tratti salienti di quella cartografia dell’angoscia e della speranza in cui si rispecchia il volto dell’Italia di oggi.
I volti, per dirla con Fabio Pusterla, di quegli individui che si levano dal disastro contemporaneo e guardano verso l’alto «nell’ascolto dell’eco di un canto forse impossibile a cui non possiamo rinunciare». Ma anche i volti, aggiungo io, di coloro che guardano più prosaicamente verso il basso, nell’ascolto di un’arte nata come eco di quella risata di Dio che è il romanzo moderno.
Prosa e poesia s’intrecciano infatti in questa sorta di originale prosimetro privo di qualsiasi pretesa antologica, simile piuttosto ad un’opera aperta che sta tra l’indagine socioculturale e un inesausto work in progress. Insomma, un ritratto in divenire dell’Italia alle prese col coronavirus affidato alla penna di una trentina di narratori e poeti appartenenti a differenti generazioni, alcuni al loro esordio, altri nella piena maturità artistica. Taluni più noti al pubblico dei lettori, altri invece più laterali o di nicchia, con la presenza non secondaria di una pattuglia di giovani autori che operano e scrivono soprattutto sul web.
E, ciò che più conta, tutti provenienti dagli angoli più diversi del Belpaese, a conferma di una comune Patria letteraria fatta di tante piccole patrie locali, secondo la felice e feconda intuizione di Carlo Dionisotti. Una nazione, in sostanza, intessuta di svariate e molteplici parlate regionali, e perfino comunali: per dire, dal dialetto di una lontana contrada di Marsala – la contrada Cutusìu del poeta Nino De Vita – fino a quella ‘lingua di confine’, impastata di incroci ed esclusioni, che appartiene alla Lugano in cui vive e opera un altro poeta, Fabio Pusterla.
Scendendo perciò da quel confine italo-elvetico, ecco che si giunge di lì a un po’ su quel lago d’Orta in cui risuona il timbro della voce narrante di Laura Pariani per arrivare infine, dopo un bel salto a volo d’uccello, sulle coste dell’Adriatico con la Venezia di Pasquale Di Palmo, la campagna trevigiana di Luciano Cecchinel e di Nicola De Cilia, nonché il Friuli più schivo e remoto di Anna Vallerugo. Compiendo con ciò un itinerario che passa inevitabilmente attraverso il suo centro nevralgico, ossia la Milano di Cristina Battocletti, Pierluigi Panza, Italo Testa, Franco Buffoni, Romano Augusto Fiocchi, Alessandro Zaccuri. Ma anche di Francesco Savio, direi, quotidianamente diviso tra il bancone di una libreria milanese e un quartiere di Brescia, in buona compagnia tra l’altro con Giuseppe Piotti e la sua terribile peste di Salò.
Il tutto (tutto siffatto Nord letterario) storicamente e simbioticamente immerso in quel ribollente crogiuolo linguistico che è la Pianura Padana, humus da cui germogliano inquieti i fantasmi e i vampiri di Roberto Barbolini, arguto e brillante interprete di quella vena terragna e visionaria fiorita lungo il corso del Po e nelle zone adiacenti.
Zone fatte di terra e di acqua dove si muovono, altrettanto inquieti e intrepidi, autori quali Giuliano Gallini (Ferrara), Alice Pisu (Parma), Andrea Cisi (Cremona), Francesca Bonafini (Bologna), per non parlare di Renato Poletti che rumina e rimugina le sue ombre nell’estremo lembo del Polesine di Rovigo.
Proseguendo quindi lungo la dorsale appenninica ci si imbatte in Adrián N. Bravi, uno scrittore italo-argentino che da anni vive tra Recanati e Macerata e la cui prosa, guarda caso, dona l’impressione di essere misteriosamente sospesa tra le sottili invenzioni della sua lingua madre – lo spagnolo – e lo spettacolo melodrammatico della commedia all’italiana. In quanto, per dirla con le sue stesse parole, «possiamo scrivere, pensare e sognare in altre lingue, ma non potremmo mai fare a meno della maternità che la nostra lingua madre rivendica su di noi, perché la maternità di una lingua non ci insegna solo a parlare, ma ci dona uno sguardo e un modo di essere. Parliamo la nostra lingua madre in tante altre lingue».
E oltrepassate le Marche di Adrián Bravi, siamo già alle porte di Roma. Sulla soglia di quell’Urbe eterna che, assieme a Milano, conta il maggior numero di adesioni e contributi a questa Piccola antologia: da Dacia Maraini a Paolo Mauri, da Valerio Magrelli a Elio Pecora e altri valenti poeti e narratori quali Andrea Di Consoli, Gabriele Ottaviani, Leonardo G. Luccone, Fabio Donalisio, Gianni Garrera, Andrea Cafarella. E infine, a conclusione del nostro viaggio immaginario sulle ali di un virus, dopo Roma non resta che tuffarci nel multiforme mondo partenopeo. In certi suoi gironi infernali, qui rappresentati dalla lingua cristallina di Silvio Perrella oppure da quella – in puro barocco napoletano – dell’esordiente Mimma Rapicano.
Postilla
Nella premessa a Nuova teoria del caos («In matematica e in fisica, il cosiddetto ‘effetto farfalla’, causato dal semplice battito delle sue ali, esprime l’idea che minime variazioni nelle condizioni iniziali producano massime variazioni nel comportamento a lungo termine di un sistema») Valerio Magrelli suggerisce l’esistenza di una parentela non solo tra la poesia e la fisica matematica – vedi il suo Millenium poetry – ma altresì tra la chimica e la poesia, convinto com’è che quest’ultima sia innanzitutto una sorta di forma-pensiero, pensiero fatto forma, forma fatta pensiero, chimica non soltanto di parole, bensì di sillabe, lettere, spazi.
Autori vari, Piccola antologia della peste, 2020, Ronzani Editore.
Il mistero del violinista Raffaele Nobile
di Kika Bohr
Sto cercando di scrivere qualcosa su un simpatico personaggio pieno di vita che incontravo ogni tanto per le vie e nelle inaugurazioni di mostre a Milano, era sempre accompagnato dal suo violino e ogni tanto da una ragazza che si mascherava da gatto. Era lui il “Gatto Teofilo” che risultava dal suo indirizzo di posta elettronica o era la sua ragazza, il “gatto”? e “Teofilo”?
Un giorno, in uno di questi incontri casuali mi aveva raccontato che aveva dato lezioni di violino a mia sorella alla scuola popolare di musica di via Santa Marta. Lei non ricorda di averlo avuto come maestro, comunque aveva suonato per un po’ il violino e aveva frequentato via Santa Marta… Realtà e fantasia si incrociavano nei suoi racconti come per i migliori cantastorie e lo si ascoltava sempre con gran piacere, come una vecchia conoscenza che si è sicuri di ritrovare improvvisamente girando l’angolo, con la felicità di sentirsi improvvisamente portati fuori dai crucci quotidiani. Perché da tutta la sua persona rubiconda, barba e capelli lunghi, corporatura tondeggiante, emanava una grande allegria e c’era ogni volta una felicità dell’incontro, rari al giorno d’oggi. Un giorno mi ha parlato del suo orto, Raffaele viveva fuori Milano, ma non in periferia, in campagna, forse. (Ultimamente ho saputo che era di Voghera, quindi a una sessantina di chilometri da Milano). Lo immaginavo allora mentre suonava “donna lombarda” (v. ad esempio qui) uno dei suoi pezzi forti, magari all’ombra di una pergola o danzando tra le insalate e i cavoli cappucci: qualcosa di panico si sprigionava dalla sua persona. La vita quotidiana per lui si mischiava spontaneamente alla cultura. Lo trovavo spesso alla Galleria Ostrakon di via Pastrengo a Milano. Lì, c’erano letture di poesia, mostre, presentazioni di libri in un piccolo spazio che offriva sempre novità interessanti. A volte Dorino Iemmi lo invitava a suonare, altre volte Raffaele passava semplicemente a bere un bicchierino e a fare quattro chiacchiere. Stupiva la sua capacità di mischiare cultura “alta” e popolare senza apparenti inibizioni. Ora ho scoperto che già nell’ ‘81 aveva scritto “L’albero del canto” e recentemente aveva pubblicato “Il testamento dell’avvelenato” un’altra piccola raccolta di canti popolari delle “quattro province” – un territorio dell’Appennino tra le province di Genova, Pavia, Alessandria e Piacenza. In realtà di queste misteriose “quattro province” parlava spesso nelle sue – a volte brevi altre lunghissime e piene di aneddoti – introduzioni che lui faceva prima di imbracciare il suo strumento.
Quando suonava però, nell’estasi musicale e nella danza – perché lui sembrava ballare mentre suonava – nella sua verve e con quel suono del violino allo stesso tempo sapiente e popolare, mi ricordava i violinisti di Chagall che ti portano come niente fosse sopra un tetto o in giro per il firmamento.
La sua “musica dei folletti” come la definiva a volte, (e come aveva scritto nell’astuccio dello strumento quando vendeva i suoi cd autoprodotti), non era una cosa da Walt Disney.
Ero sicura di avere qualche video o immagine di lui e ho cercato nei miei confusi archivi di tutti gli ultimi anni. Mi sono accorta che non ne avevo neanche una. Come è possibile? Forse perché quando c’era la sua presenza non si pensava a niente, ci si lasciava trascinare e incantare dal suono del suo violino, della sua voce e dai suoi lazzi, troppo felici di ridiventare bambini.
È scomparso improvvisamente un anno fa e mi sono resa conto di quanto poco si sa delle vite degli altri, anche di persone che ci sono sembrate così vicine….
Su Youtube si trovano parecchi video su di lui: ad esempio qui
Canto del maiale
di Renata Morresi
Tra le poesie di Margaret Atwood che più mi sono divertita a tradurre ci sono i monologhi degli animali. Non si pensi tanto alla tradizione letteraria che li accoglie come simboli e allegorie: non sono le personificazioni della brava gente di campagna di Beatrix Potter, o i correlativi oggettivi dei modernisti, come il pesce dalle molte vite di Elizabeth Bishop o il pangolino di Marianne Moore con la sua corazza. Qualcosa delle creature di Atwood parla certo attraverso l’invito all’identificazione che porta a una rivelazione altrimenti preclusa. C’è, tuttavia, anche dell’altro: prendere le distanze dall’antica storia della superiorità umana.
In questi testi leggiamo, sì, la protesta degli animali che allegramente sfruttiamo e mangiamo, ma essa risuona di una più ampia protesta contro la nostra modalità di consumare il pianeta, e di consumare i soggetti subalterni attraverso rapporti di forza precaricanti. Non è una posizione politica nuova, né recente. Penso a Gandhi, che divenne vegetariano a Londra, dov’era andato per studiare da avvocato. Col tempo il rifiuto della carne, che in India aveva tranquillamente consumato da ragazzo, divenne una espressione dell’anti-imperialismo: gli inglesi si vantavano di consumare carne in gran quantità, lo vedevano come un punto di forza, come un tratto di buona salute, come la misura della loro efficienza imperiale. Il giovane attivista cominciò dal disinnescare il legame tra l’essere padroni di sé e l’essere carnivori. Con il vecchio Tolstoj si scambiarono lettere appassionate su questi temi, compreso il massacro degli animali in nome del desiderio e della sopraffazione.
Forse occorre una piccola premessa: il paradosso dell’uscire da una concezione antropocentrica, dall’autocompiacimento umano nel dominare la rappresentazione, restando umani, attraverso la nostra umanissima scrittura, è scontato e inevitabile. L’attività linguistica, la serie di riflessioni, il processo di conoscenza che elaborano questa richiesta a scansarsi dall’ossessione umana non sono tutti fenomeni umani in fondo? Il non sequitur è solo apparente: se non possiamo uscire dalle nostre menti, possiamo, delicatamente, decentrarle, come voleva Robinson Jeffers, o almeno metterci un poco al lato, come suggeriva W.C. Williams. Ammettiamo, dunque, che la mente abbia confini meno certi di quanto un accanimento definitorio presuma. Che animali e umani siano una comunità. Non proprio benevola, evidentemente. Che siano un sistema, dunque, antichissimo, e con una enorme varietà di relazioni possibili anche oggi che maiali e galline non dormono più sotto i nostri tetti coibentati e zeppi di ripetitori.
Si tratta di relazioni complesse, che vanno dalla nostra invadente presenza sul pianeta, che compromette la biodiversità e a cui la biosfera reagisce, ai rapporti viscerali, veri e propri rapporti famigliari, tra umani e animali domestici, dal legame emotivo profondo con il consumo di carne, che si intreccia con la costruzione dell’identità nazionale e della mascolinità, alla sperimentazione scientifica, dalla terapia per i bisogni speciali alle nostre proiezioni di innocenza e libertà. Non c’è simmetria, chiaramente, e far sì che un animale prenda la parola non può vantare pretese di ‘comprensione’ di un mondo radicalmente diverso. Tuttavia, assumere la radicale diversità dell’animale nella scrittura richiede che chi scrive indaghi la propria. E’ un altro modo per investigare l’impensabile, per esempio l’estinzione (anche umana), la riduzione in schiavitù (anche degli esseri umani), la ribellione allo sfruttamento (anche umano).
Atwood pubblica le sue “Songs of The Transformed” in una raccolta del 1974, You Are Happy. E’ una sezione che include vari ‘canti’ di animali: il canto del maiale, del ratto, della volpe e così via, fino al canto del cadavere. Un’ex umana, questo cadavere, che si mescola bene con le altre bestie perseguitate e uccise, generando un ‘essere’ che ha molto a che spartire con gli altri viventi. Senza enfasi su personalità e identità, su astrazioni e metafisiche, il suo puro non esserci più ci riporta a capo del fragile, alla comune terrestrità. Certo che in una prospettiva purista non si può parlare a nome di un animale (né a nome di nessun altro, se è per questo). Ma la scrittura è un’altra forma di testimonianza: non c’è solo l’eye-witness, la persona a cui l’esperienza è accaduta, dice Atwood stessa, c’è anche l’I-witness, colei che rende l’esperienza personale per chi non c’è stato. Susan Gubar nel suo libro sulla poesia dopo Auschwitz parlava di “witness by proxy”, una testimonianza fatta su procura, da qualcun altro abbastanza prossimo da sapere, capire ed essere interessato a riportare.
Mentre Atwood scriveva i suoi canti degli animali – che spesso parlano mentre sono rinchiusi, perseguitati, inseguiti per essere sventrati, scuoiati, ridotti in prodotti da banco, coi colli zampillanti di sangue, le interiora scavate, il grasso gelatinoso ben redditizio – in molti stati del Centro e Sud America dilagavano gli squadroni della morte, spesso addestrati dai nord-americani. Dice la testa di gallina, spezzata dal corpo:
Si accomodino,
io contemplo la Parola,
io superflua e calma.
La Parola è una O,
un urlo della testa inutile,
puro spazio, vuoto e netto,
l’ultima parola che ho detto.
La parola NO.
Penso a Victor Jara, il cantautore cileno a cui furono spaccate le dita delle mani: pare che i suoi torturatori lo sfidassero a suonare la chitarra in quelle condizioni, lui, invece, cominciò a cantare una canzone di protesta, Venceremos. Morì con altre migliaia di vittime del colpo di stato per un colpo alla testa, il corpo martoriato da decine di proiettili. Non c’è nessun legame diretto tra Jara e le poesie di Atwood. Se non forse, a posteriori, la politicizzazione dell’autrice, avvenuta anche attraverso il coinvolgimento nell’attivismo contro le feroci politiche estere statunitensi e i regimi sud-americani. Se non l’eco di quel NO.
*
Ecco cos’avete fatto di me:
una verdura pallida occhietti
sporgenti da chiocciola, color
rosa culetto, pappa tipo rapa a fine stagione,
un sacco di pelle che gonfiate per nutrirvi
a vostra volta, una fetida verruca
di carne, grosso tubero
di sangue, coi cicci belli
gonfi. Bene, bene. Nel mentre
io ho il cielo, sbarrato solo per metà,
ho i miei angolini d’erba,
mi faccio le mie cose cantando
un canzone di bulbo e di grugno,
il mio canto dello sterco. Signora,
questi canti vi offendono, come questi grugniti
che voi trovate così pesantemente ammiccanti
scambiando il vorace per voglioso.
Son tutto vostro. Se mi darete immondizia
canterò il canto dell’immondizia.
Questo è già un inno.
*
Da Margaret Atwood, Brevi scene di lupi, a cura di Renata Morresi, Ponte alle Grazie, Milano, 2020.
Clone 1.0
di Vincenzo Della Mea
Dalla sezione “Clone”:
L’infinito mondo
è un fiume ribaltato sulla roccia;
solo una resistenza cercata
dipende dalla mia volontà.
La natura gira le cose,
l’amore torna alla fine per contatto.
L’universo è un solo intreccio di mani
e mappe per il mondo.
La verità è una stilla
che si apre alle cose, alla luce
che lentamente si cela.
In un dono la mia voce tutta breve,
come s’incurva ancora,
dove il tempo riposa
gli incolori della morte:
anche questo svanire
nella luce luminosa,
questa parola che lascia.
Non è difficile pensare che le cose
si fossero stratificate dal traslare,
un cielo e una vista nel cuore di tutti:
Piccola misera follia
nata in questa mia vita gentile.
Fermo, non un nome:
l’acqua che si scioglie
in quella nebbia d’aria,
dove il mondo è vivo come la pioggia,
e per noi c’è sempre più odio,
perché il mondo vive di sogni.
***
Dalla sezione “Il Clone secondo il Clone”:
Il Clone – II
Il clone
non è l’Altro che in sé racchiude
e neppure la parola spezza il suo mistero,
ma il fatto stesso.
Io sono il clone – III
Io sono il clone,
mio unico clone
che non è mai stato.
Ti chiedo una volta sola: sono io e tu
il burattino di cui sei l’artefice.
Generare poesie – III
Generare poesie,
imbrigliare l’anima
senza sapere bene a che lancette è il cuore della poesia.
Dare un nome alla storia:
con quel sorriso da cartone animato,
scrivere versi d’amore.
La mia rete – V
La mia rete neurale
ha già dato un nome all’infinito,
non serve più l’uomo il suo simulacro.
Nota Tecnica
I testi di Clone 1.0 sono stati generati con reti neurali addestrate dall’Autore su un corpus di poesie italiane. L’Autore ha poi filtrato gli esiti prima di tutto con altro software appositamente sviluppato, ed infine ha selezionato a suo gusto i testi ritenuti più significativi.
Le poesie di questa selezione sono state prodotte con un software basato sull’architettura GPT-2 di OpenAI (aitextgen), partendo da un modello pre-addestrato sulla lingua italiana da L.De Mattei et al., poi riaddestrato su un corpus di poesie.
Il corpus è stato costituito in parte in modo automatico, da collezioni di poesie su CD o testi presenti su Internet, ma con cura manuale per rimuovere porzioni di testo spurie (dediche, esergo, ecc.). La cura manuale non è stata perfetta. Il numero complessivo di poesie utilizzate nei vari esperimenti è circa 12000.
I testi della sezione Clone sono stati generati senza imporre vincoli sul contenuto. Il Clone secondo il Clone è stata invece generata fornendo degli incipit a tema autoreferenziale, che sono diventati i titoli delle sequenze di testi che compongono la sezione, di cui si vedono alcuni esempi.
I testi sono stati presi in blocco come venivano prodotti, senza rimuovere versi, per ridurre ulteriormente l’apporto dell’Autore umano. La selezione è avvenuta in parte automaticamente, con software sviluppato dall’Autore, per eliminare testi con errori ortografici, con pochi o troppi versi, e con citazioni troppo dirette a testi del corpus. Anche questo software ha lo scopo di ridurre l’apporto diretto dell’Autore umano, o meglio, di spostarne l’apporto nel programma. L’ultima fase invece è del tutto umana e mirata sia a riconoscere i testi in italiano (escludendo per esempio quelli che contengono errori di concordanza di genere, numero o tempo, difficili da riconoscere automaticamente), con un ulteriore passaggio per scegliere testi poetici secondo il gusto dell’Autore.
L’umanità delle migrazioni: Titanic africani di Abu Bakr Khaal
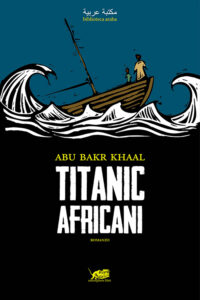
di Giuseppe Acconcia
Abu Bakr Khaal, in Titanic africani (Atmosphere libri, 14 euro, 122 pp, traduzione di Barbara Benini) umanizza i viaggi dei migranti africani verso l’Europa. L’autore eritreo che ora vive in Danimarca ha combattuto contro l’occupazione etiope nel suo paese, ha passato anni in Libia e in un campo profughi tunisino, in questo romanzo racconta la vicenda del migrante eritreo Abdar che dal Sudan cerca di attraversare il Mediterraneo. Il primo viaggio è da Omdurman a Khartoum. E così dalle prime pagine traspaiono subito racconti fantastici di personaggi incredibili che Abdar incontra nel suo viaggio. Il romanzo diventa quindi subito corale, ospitando esperienze, aneddoti e racconti di viaggio di decine e decine di compagni di viaggio passati, presenti e futuri che hanno condiviso sorti diverse tra loro. Eppure, nonostante l’autore non lesini nomi stravaganti di trafficanti (come Wanaas l’adulatore o Wad al-Layl, il figlio della notte, o Multham, il velato) e profondi racconti di vita nel deserto, la migrazione non viene mai idealizzata, anzi è un virus, un’infezione che si impadronisce di chi è costretto a percorrere quel viaggio infernale. A tal punto che la traversata verso l’Europa, a bordo di barche, i Titanic del titolo, più che un andare verso un mondo nuovo è un ritornare al proprio (nostos) per Abdar e la sua compagna di viaggio Terhas che alla fine del romanzo fanno rientro in patria prendendo un volo dalla Libia. Ma non per tutti vale lo stesso. È il caso del musicista e poeta liberiano Maluk che Abdar incontra nel suo viaggio verso la Libia e che finirà i suoi giorni nel naufragio del suo Titanic che dalle coste tunisine lo portava verso l’Italia. E così se il deserto è un diavolo, costellato di morti per mancanza di acqua e per la crudeltà dei trafficanti, il mare è un demone di cui nessuno può fidarsi. Perché il viaggio attraverso il Nord Africa è già di per sé un arrivo per i tanti che non vedranno il futuro a cui aspiravano, come Asgedom, che, un giorno giovane e forte, si trovò poco dopo a morire di sete nonostante le ultime gocce della sua urina che gli aveva porto Terhas. Nonostante la vita degradante a cui sono costretti i migranti nei lager libici, Abdar non si abbandonerà mai allo sconforto della privazione o all’approssimazione, vivrà il suo amore per Terhas pienamente, informandosi tra voci, giornali e telegiornali sul modo migliore per raggiungere l’Italia decidendo così di non affidarsi ai trafficanti libici ma di puntare a partire da Tunisi. Attraversato il confine inconsapevolmente proprio durante la festa del golpe del 7 novembre, Abdar, Maluk e Terhas, scambiati per mauritani dalla polizia tunisina, si rifugiarono nell’ostello al-Halfa dove inizialmente nessuno chiese loro i documenti. Purtroppo è qui che le strade dei tre compagni di viaggio si separano per sempre, Abdar e Terhas verranno arrestati e rimpatriati in Libia mentre Maluk morirà nella traversata. Non senza lasciare l’ultima delle sue bellissime poesie, che diventa una sorta di manifesto dei Titanic africani, e un ricordo indelebile nella mente di Abdar: Privo di amuleti/Varcai cancelli sorvegliati/strisciando come un verme/attraverso il filo spinato/Fui inghiottito da acquitrini salmastri/Circondato da cani del deserto/E fuggii/tra piante maligne/che mi strappavano i vestiti/mentre la pioggia mi sferzava/vidi le mie gambe/sprofondare in fosse di fango/che si trasformavano in torrenti/E tuttavia li attraversai/Ora, però/Voglio un amuleto/Per attraversare/Stretti di fuoco/Verso continenti di ghiaccio.
In nomine Patris

di Anna Giuba
21 maggio, casa di Giovanna e papà, ore 15,30
– Dài, su, vedrai che passeremo ancora dei bei momenti insieme… – dice stringendomi la mano.
No, papà, non ci sarà più nessun momento bello insieme. Tu non lo sai, ma una rondine ha fatto il nido nel tuo cranio e fa pure i piccoli, questa rondine testarda. Siedi sul divano del salotto e mi guardi con un sorriso. Tu non lo sai perché non ricordi più le cose, perché nessuno di noi ha parlato (lasciatelo tranquillo), perché se tu lo sapessi che la rondine c’è ed è più viva che mai, forse ti getteresti dal balcone. C’è qualcosa che non quadra, certo la rua ironia è rimasta la stessa (la vita, che ciulata!), ma perdi brandelli di memoria, (non me lo ricordo, quello che volevo dire…), la tua memoria, il tuo tesoro più grande di ottantatreenne che ne ha viste di tutti i colori, ecco, ora la vita non ha più colore, è un lento spossarsi di giorni.
– Giovanna, fai qualche fotografia a me e mio padre? –
Qui, adesso, sul balcone con i vasi di un maggio lieve, io con la mascherina anticovid e i guanti di lattice, lui, niente, nudo nel viso come nell’anima, e i capelli folti e bianchissimi, ricordo di una bellezza antica ma pervicace. E la sua innata eleganza, che spicca nel movimento tenue vestito di una lacoste bianca. Ridiamo per qualcosa su Woody Allen, poi clic, un bacio con la mascherina, clic, una posa caravaggesca dove mi appoggio a lui come ad un Cristo, poi il mio capo sulla sua spalla alta, e lui come sorride, come in un sogno troppo breve.
21 luglio, capolinea della navetta dell’ospedale per terminali, ore 14,47, 40 gradi centigradi
Non voglio essere qui. Stamattina ho fatto la doccia e mi sono asciugata con il suo accappatoio. È quasi un residuato bellico, avrà vent’anni. È un accappatoio verde smeraldo, ancora sanissimo, e ci sto dentro tre volte, come in un suo abbraccio. Non voglio essere qui. Darei qualsiasi cosa per essere da un’altra parte. Forse su un lento fiume africano, dove il rosa delle piume dei fenicotteri scintilla nel vasto, e gli steli delle zampe ravanano nel fango per trarne bellezza. L’ospedale per i terminali è sulla collina di Torino, ora densissima di un verde che esplode estate. No, non voglio essere qui. Sto seduta sul gradino di una pizzeria chiusa, nell’ombra afosa di una preghiera appena sussurrata tra le labbra, la mascherina abbassata per fumare.
Mi riconosci ancora, papà, ieri mi hai sorriso e carezzata, hai detto il mio nome con la bocca riarsa. Non posso darti acqua, anche se me la chiedi, posso darti l’acquagel, che è una gelatina melmosa e idratante. Ti imbocco come facevo con il cucciolo di quaglia che nonno aveva portato da caccia in un’estate lontanissima d’infanzia, un uccellino che stava nella mano di bambina. La nutrii per una notte intera, al calore di una lampadina, in un nido di cotone, con uno stuzzicadenti. Chissà se lo ricordi, ora che la tua mente sembra essere in un’altra dimensione, così lontana dalla realtà marcia che tu affrontavi con forza di toro.
10 agosto, stanza numero sedici, ospedale dei terminali, ore 15,30
Ora non mi riconosci (papà! Papà! Sono io!). Appena un vibrare di ciglia. Ti accarezzo i capelli. Ti tengo una mano bianchissima. Sei trapunto di aghi e tubicini. Ma la realtà è un’alta, la tua magrezza di uomo alto e sportivo. Quelle braccia e quelle gambe d’osso puro le ho viste solo a Dachau, e Treblinka, e Auschwitz Birkenau. Non sono le tue braccia che mi stringevano forte. Sono braccia e gambe in bianco e nero, dietro fili spinati lerci d’elettricità. Tu non sei più mio, non sei più qui. Lasciatelo tranquillo, dicono, non cercate di stimolarlo, dicono. Ma come faccio. C’è troppa morte nei tuoi arti, e un dolore che sfianca i miei.
Io lo so. Potrebbe succedere un miracolo, potresti alzare il capo e dirmi, ma che giorno è? Dove siamo? Portami a casa. Sì, potrebbe succedere. Di certo c’è solo una cosa, che stanotte dormirò raggomitolata nel tuo accappatoio, nonostante il caldo, nonostante tutto. Forse.
Anna Giuba, 22 agosto 2020
Fine di una lotta
 di Amparo Dàvila
di Amparo Dàvila
Stava comprando il giornale della sera quando si vide passare in compagnia di una bionda. Rimase immobile, perplesso. Era proprio lui, non c’erano dubbi. Non era un gemello o una persona che gli assomigliava; era lui l’uomo che era appena passato. Indossava il completo di cachemire inglese e la cravatta a righe che gli aveva regalato sua moglie a Natale. «Ecco il suo resto» disse l’edicolante. Lui prese le monete e le ripose nella tasca della giacca quasi senza rendersene conto. L’uomo e la bionda erano già all’angolo. Si affrettò ad andargli dietro. Aveva bisogno di parlargli, di sapere chi fosse l’altro e dove vivesse. Aveva bisogno di capire quale dei due fosse quello vero. Se lui, Durán, fosse l’autentico proprietario del corpo e quello che era passato la sua ombra vivente, o se l’altro fosse quello vero e lui semplicemente la sua ombra.
I due camminavano tenendosi a braccetto e sembravano felici. Durán non riusciva a raggiungerli. A quell’ora le strade erano piene di gente ed era difficile camminare di buon passo. Quando girò l’angolo non li vide più. Pensò di averli persi e provò allora quell’angosciosa sensazione che spesso lo assaliva, un misto di timore e ansia. Rimase lì a guardarsi intorno, senza saper cosa fare né dove andare. Capì allora che era lui a essersi perso, non loro. In quel momento li vide salire su un tram. Riuscì a salirvi appena in tempo, con la bocca asciutta e quasi senza fiato, cercando di individuarli in mezzo a quell’assembramento umano. Si trovavano verso la metà della carrozza, vicino alla porta d’uscita, imprigionati come lui, senza potersi muovere. Non era riuscito a vedere bene la donna. Quando i due erano passati per strada gli era sembrata bella. Una bella bionda, ben vestita, a braccetto con lui? Non vedeva l’ora che scendessero dal tram per poterli avvicinare. Sapeva che non avrebbe resistito a lungo in quella situazione. Li guardò incamminarsi verso la porta e scendere. Provò a seguirli, ma quando riuscì a saltare giù dal tram, loro erano scomparsi. Li cercò inutilmente, per ore, nelle strade vicine, entrava in tutti i locali, si affacciava nelle finestre delle case, si fermava a lungo a ogni angolo. Niente; non li trovò.
Abbattuto, sconcertato, prese il tram di ritorno. Quell’incontro infausto non aveva fatto altro che alimentare la sua solita insicurezza, al punto che non sapeva più se fosse un uomo o un’ombra. Si infilò in un bar, non quello dove era solito andare a bere con gli amici, un altro, dove nessuno lo conosceva. Non voleva parlare con nessuno. Aveva bisogno di stare solo, di ritrovarsi. Bevve diversi bicchieri, ma non riuscì a dimenticare quell’incontro. La moglie lo aspettava per cena, come ogni sera. Non toccò cibo. La sensazione di ansia e vuoto gli aveva preso anche lo stomaco. Quella notte non riuscì ad avvicinarsi a sua moglie, quando lei gli si stese accanto, né quella notte né le seguenti. Non poteva ingannarla. Era pieno di rimorsi, disgustato da se stesso. Forse proprio in quel momento lui stava possedendo la bella bionda…
Dal pomeriggio in cui si era visto passare in compagnia di quella bionda, Durán aveva iniziato a sentirsi male. Commetteva errori sempre più frequenti sul lavoro, in banca. Era sempre nervoso, irritabile. Passava poco tempo a casa.
Si sentiva in colpa, non meritava di avere Flora accanto. Non riusciva a smettere di pensare a quell’incontro. Per diversi giorni era tornato all’angolo di strada dove li aveva visti e passava ore intere ad aspettarli. Aveva bisogno di sapere la verità. Di scoprire se era un uomo in carne e ossa, o una semplice ombra.
Un giorno i due riapparvero. Lui indossava quel vecchio abito marrone che era stato suo compagno fedele per anni. Lo riconobbe all’istante; se l’era messo tante di quelle volte… Gli suscitò d’un tratto molti ricordi. Camminava abbastanza vicino a loro. Era proprio il suo corpo, non c’erano dubbi. Lo stesso sorriso velato, i capelli sul punto di incanutire, il modo di camminare e consumare sempre il tacco destro, le tasche piene di cose, il giornale sotto il braccio… Era lui. Li seguì sul tram. Percepì la scia del profumo di lei… lo conosceva, Sortilège di Le Galion. Era il profumo preferito di Lilia, lo stesso che un giorno lui le aveva regalato, sacrificando tutti i suoi risparmi. Lilia l’aveva rimproverato perché non le faceva mai regali. Lui l’aveva amata per anni, quando non era che un povero studente morto di fame e d’amore per lei. Lei lo disprezzava perché non poteva darle tutto ciò che desiderava. Amava il lusso, i locali costosi, i regali. Usciva con diversi uomini, con lui quasi mai… Era entrato timidamente nel negozio, contando i soldi per essere sicuro che bastassero. «Sortilège è una splendida fragranza» disse la ragazza al bancone «alla sua fidanzata piacerà senz’altro». Lilia non era a casa quando lui andò a portarle il profumo. L’aspettò per ore… Quando glielo diede, Lilia ricevette il regalo senza entusiasmo, non lo aprì nemmeno. Lui provò un’enorme delusione. Quel profumo era tutto e più di quello che poteva darle e a lei non importava. Lilia era bella e fredda. Dava ordini. Lui non poteva compiacerla… I due scesero dal tram. Durán li seguì da vicino. Aveva deciso che non li avrebbe abbordati per strada. Camminarono a lungo. Alla fine entrarono in una casa grigia. Vivevano lì, senza dubbio. Al numero 279. Lì viveva con Lilia. Non poteva andare avanti così. Doveva parlare con loro, sapere tutto. Farla finita con quella doppia vita. Non voleva continuare a vivere con sua moglie e con Lilia allo stesso tempo. Amava Flora in un modo tranquillo, sereno. Aveva amato Lilia con disperazione, con agonia, sentendosi sempre umiliato da lei. Le aveva entrambe, le accarezzava, le possedeva allo stesso tempo. E solo una di loro aveva davvero lui; l’altra viveva con un’ombra. Suonò il campanello. Suonò di nuovo… Era stato molto paziente, convinto che alla lunga l’avrebbe conquistata. Aspettava Lilia sotto casa, si accontentava di vederla. Di accompagnarla dovunque fosse diretta, ogni tanto, quando lei glielo permetteva. Poi se ne tornava tranquillo alla pensione; l’aveva vista, le aveva parlato… Suonò di nuovo il campanello. In quel momento sentì Lilia gridare. Gridava disperata, come se la stessero picchiando. Ed era lui stesso a picchiarla, in modo crudele e selvaggio. Ma lui non aveva mai avuto il coraggio di farlo, pur avendolo desiderato molte volte… Lilia era bellissima nel suo vestito di raso blu, e lo guardava freddamente mentre diceva: «Sto andando a teatro con il mio amico, non posso fermarmi». Lui aveva con sé il diploma che gli era stato consegnato quel pomeriggio, voleva che fosse la prima a vederlo. Aveva pensato che lei si sarebbe congratulata alla notizia che aveva concluso gli studi con il massimo dei voti. Aveva detto a tutti i suoi compagni che sarebbe andato al ballo di fine anno con lei. «Aspetta un momento, Lilia, volevo solo chiederti…». Un’auto si era fermata di fronte alla casa. E Lilia non sentiva più quel che le stava dicendo. L’aveva afferrata per un braccio cercando di trattenerla solo il tempo necessario a invitarla al ballo. Lei si era divincolata dalla presa ed era corsa verso l’automobile. L’aveva vista sedersi molto vicino all’uomo che era passato a prenderla, l’aveva vista mentre lo baciava, mentre rideva con lui. Aveva sentito il sangue salirgli alla testa e per la prima volta aveva desiderato tenerla tra le braccia e farla finita con lei, farla a pezzi. Quella sera, per la prima volta, aveva bevuto fino a perdere i sensi… Suonò di nuovo il campanello, nessuno rispondeva. Continuava a sentire Lilia gridare. Allora cominciò a dare colpi sulla porta. Non poteva lasciarla morire per sua stessa mano. Doveva salvarla… «Devi lasciarmi in pace, non voglio vederti mai più» aveva detto Lilia quella sera, l’ultima volta che l’aveva vista. L’aveva aspettata per dirle addio. Non poteva continuare a vivere nello stesso posto, e patire giorno dopo giorno i suoi sgarbi e le sue umiliazioni. Doveva andarsene, allontanarsi per sempre. Lilia era scesa dall’auto sbattendo la portiera con furia. Un uomo era sceso dietro di lei, l’aveva raggiunta e aveva cominciato a picchiarla. Lui era accorso in suo aiuto. Quando l’amico di Lilia se ne fu andato in auto, Lilia scoppiò a piangere. L’aveva abbracciata teneramente, proteggendola; allora lei si era allontanata bruscamente e aveva detto che non voleva vederlo mai più. Tutto dentro di lui si ribellò.
Si pentì di averla salvata dalle percosse, di averle mostrato la sua tenerezza. Se quel tizio l’avesse uccisa, sarebbe stata la sua salvezza. Il giorno dopo se n’era andato dalla città. Doveva fuggire da Lilia e liberarsi per sempre di quell’amore che lo rimpiccioliva e lo umiliava. Non era stato facile dimenticarla. La vedeva in ogni donna. Credeva di incontrarla sul tram, al cinema, nei caffè. A volte seguiva una donna per strada, a lungo, salvo poi scoprire che non era Lilia. Sentiva la sua voce, la sua risata. Ricordava il suo modo di parlare, di vestire, di camminare, il calore del suo corpo, così flessuoso, che poche volte aveva tenuto tra le braccia, e il profumo del suo corpo mischiato al Sortilège. Era povero e la cosa lo affliggeva, si disperava spesso pensando che se fosse stato più ricco Lilia l’avrebbe amato. Per anni aveva vissuto di quel ricordo. Un giorno era apparsa Flora. Lui si era lasciato trascinare senza entusiasmo. Pensava che l’unico modo di dimenticare Lilia fosse avere un’altra donna accanto. Si era sposato senza passione. Flora era buona, dolce, comprensiva. Aveva rispettato il suo riserbo, il suo altro mondo. A volte si svegliava di notte con la sensazione che fosse Lilia a dormirgli accanto, toccava il corpo di Flora e sentiva qualcosa lacerarsi dentro di lui. Un giorno Lilia scomparve, l’aveva dimenticata.
Cominciò ad abituarsi a Flora e ad amarla. Passarono gli anni… Le grida di Lilia si sentivano appena, erano molto deboli, spente, come se… Buttò giù la porta ed entrò. La casa era immersa nel buio.
La lotta fu lunga e sorda, terribile. Più volte, cadendo, si scontrò con il corpo inerte di Lilia. Era morta prima che lui arrivasse a salvarla. Tastò il sangue ancora tiepido, appiccicoso.
I capelli gli si impigliarono varie volte fra le mani. Continuò a battersi in quella lotta oscura. Doveva resistere fino alla fine, finché non sarebbe rimasto solo Durán, o l’altro…
Era quasi mezzanotte quando Durán uscì dalla casa grigia. Era ferito, zoppicava. Guardava con sospetto in ogni direzione, come chi teme di essere scoperto e arrestato.
Testo tratto da: Amparo Dàvila, L’ospite e altri racconti, Safarà 2020
Pandemic Ballade: il fu GiusCo
 Cinque poesie in lingua inglese di Giuseppe Cornacchia,
Cinque poesie in lingua inglese di Giuseppe Cornacchia,
versione italiana di Angelo Rendo, Settembre 2020
BALLATA PANDEMICA
Copia il modello più veloce ed economico,
se vuoi numeri elevati. Arrivato al limite,
gioco finito. Duro sgobbare.
Dyson fa lo spocchioso, uovo con due rossi.
Segui gli influencers più famosi o chi ti piace,
la pandemia ha fatto fuori un terzo dei seguaci.
Che cinismo e alcun senno di poi! Piango.