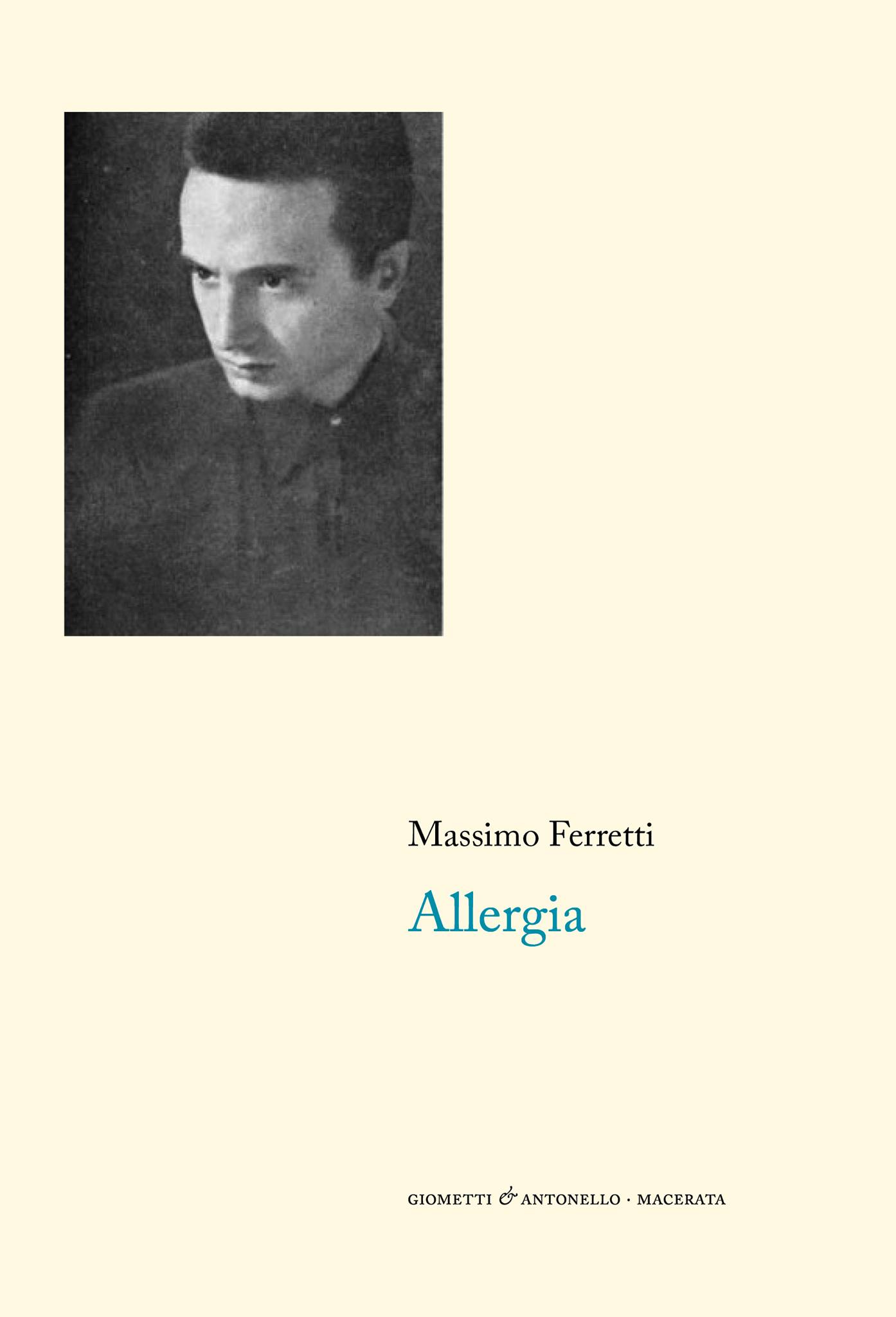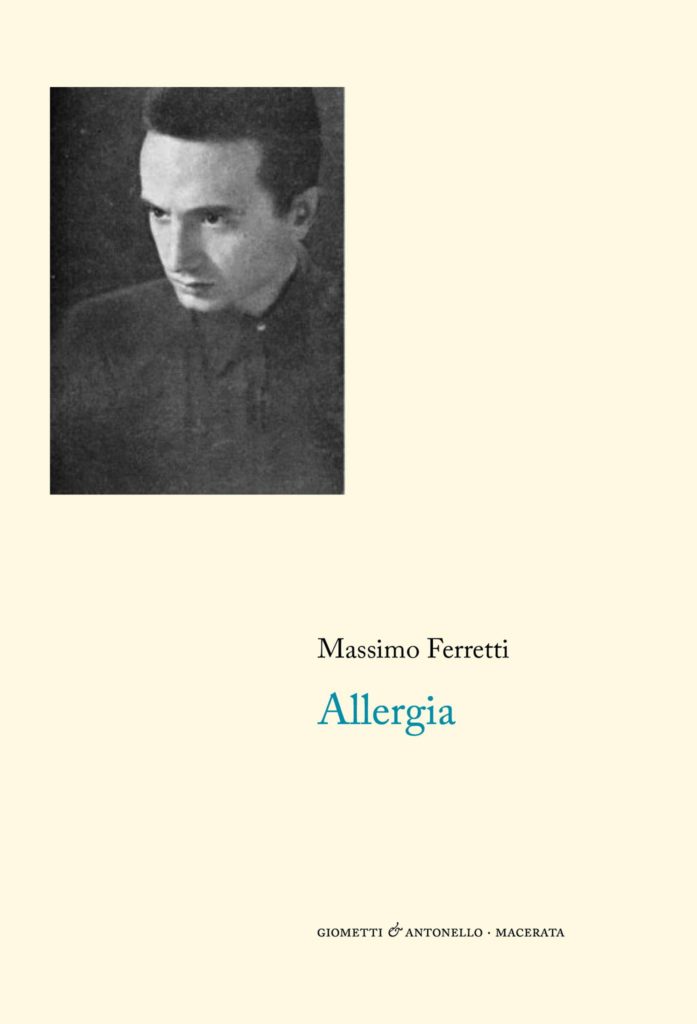di Florinda Fusco
 Vorrei iniziare questa conversazione su la bambina (il verri, 2018, collana diretta da Milli Graffi), ritratto autobiografico di un’infanzia vissuta tra due famiglie, quella d’origine e quella adottiva, negli anni Cinquanta, soffermandomi su quella che a me sembra una questione centrale: lo sviluppo dell’identità femminile. Sia la protagonista che gli altri personaggi in primo piano sono donne. In questo senso si può parlare di un’identità femminile fluida e multiforme che dalla protagonista fluisce verso gli altri personaggi?
Vorrei iniziare questa conversazione su la bambina (il verri, 2018, collana diretta da Milli Graffi), ritratto autobiografico di un’infanzia vissuta tra due famiglie, quella d’origine e quella adottiva, negli anni Cinquanta, soffermandomi su quella che a me sembra una questione centrale: lo sviluppo dell’identità femminile. Sia la protagonista che gli altri personaggi in primo piano sono donne. In questo senso si può parlare di un’identità femminile fluida e multiforme che dalla protagonista fluisce verso gli altri personaggi?
Oppure il contrario, identità femminili intorno alla bambina che confluiscono in lei… Nel mondo descritto in questo libro di fatto compaiono donne molto potenti, mentre i maschi stanno in secondo piano, presi da altri affari. La bambina non ha per nulla chiaro quale sia il suo genere: certo, è una bimba, ma… Bisogna pensare che alla fine degli anni Quaranta, quando la bambina nasce, quasi tutti i genitori sperano che il nuovo nato sia maschio: probabilmente, già prima di nascere, la bambina viene pensata e desiderata come maschio. E dunque lei che, come tutti i bambini, vuole essere amata e accettata, si sente anche maschio: questo glielo conferma la madre quando, con grande soddisfazione della bambina, la chiama Capitano; e di fatto, finché può, lei è il leader della banda dei fratellini, li espone a rischi e li trascina in avventure. Più avanti, dagli zii intorno ai dieci anni, la bambina addirittura pensa di poter essere un eunuco – dunque un maschio evirato. Il femminile (rosa, fiocchi, bambole) è perfettamente rappresentato, nella mente della bambina, dalla sorellina Paola, la “femminuccia”. Paradossale, perché la bambina, che è femmina, si trova a disprezzare, attraverso lo specchio della sorella, il proprio stesso genere. Tutto intorno, dicevo, gravita un vasto universo femminile: la madre, la zia, le domestiche, la nonna, le altre zie. Sono tutte donne in qualche modo potenti. Anche la mamma: è vero, è fragile, bipolare, ma è anche, lei e la sua malattia, il vero nucleo attorno a cui ruota l’intera famiglia, tra assenze e umorali ritorni. Lei è potente in questo modo infelice e infelicitante, disturbato e disturbante. La zia invece è potente in modo armonioso: una potenza mai esibita, ma vera, che poggia su un grosso senso di realtà. Si può dire che la madre con i suoi eccessi rappresenta una sorta di dionisiaco “domestico”, mentre la zia mostra il quieto splendore dell’apollineo. La zia è la Regina, così la chiamava lo zio (che invece non era re).
Vorrei che ora ci concentrassimo sul rapporto io bambina-io madre tra simbiosi e distanza.
In realtà, questo libro (me ne sono resa conto solo dopo averlo scritto) è centrato sull’assenza della madre. Che, anche in assenza, è tuttavia sempre presente come nostalgia di una simbiosi paradisiaca precocemente interrotta. Paradiso perduto. Nel profondo, la bambina è profondamente ancorata all’universo illusorio della madre. A livello consapevole la bambina disprezza la madre.
Nel libro racconti di quanto alla bambina piacesse guardare le riproduzioni dei quadri di Renoir, i suoi nudi, mentre lei stessa aspettava le trasformazioni adolescenziali del suo corpo. Mi interessa, in particolare, la crescita congiunta io-corpo femminile nel libro. Puoi parlarmene?
Lì, quando guarda Renoir, la bambina è molto piccola, e probabilmente quei morbidi nudi le evocano nostalgie materne. Nel caso della bambina (poi bambona) la crescita congiunta io-corpo femminile si è verificata in modo sotterraneo, complesso e in sostanza conflittuale. Nel momento in cui la bambina si avviava all’adolescenza, quando doveva spuntare con tutta la sua grazia la sembianza femminile, ha ricoperto il proprio corpo di una coltre di grasso, imbottendolo per parare i colpi, tenendolo nascosto agli altri (mai preda!) e persino a se stessa. Mi spiace, su questo tipo di integrazione non ho alcuna esperienza. Una plausibile immagine femminile (non si può ancora parlare di identità) l’ho assunta molto dopo, artificialmente. Intorno ai vent’anni, una domestica a casa della zia mi ha dato degli anoressizzanti: non avevo più fame, mangiavo poco e presto diventai molto carina. L’artificio dell’anfetamina ha probabilmente fatto sì che io considerassi l’immagine del mio corpo come qualcosa di totalmente esteriore, artificiale appunto.
Amelia Rosselli pensava che si potesse parlare di scrittura femminile che ha come origine non solo un dato culturale, ma anche biologico. Tu cosa pensi a tal riguardo?
Più o meno negli stessi anni in cui Rosselli pensava ad uno specifico femminile della scrittura, insieme ad un gruppo di compagne femministe, alla Maddalena, avevamo messo su un gruppo di scrittura proprio alla ricerca dello specifico femminile (una sorta di nostro graal). Era il ’77, e io mi ritrovai a inventare una (probabilmente un po’ ridicola) azione teatrale intitolata A mezza maschera, in cui le quattro donne in scena non riuscivano a parlare ed erano solo in grado di emettere grida e suoni inarticolati. Alla fine, alle domande del pubblico, le quattro donne rispondevano, non necessariamente a tono, recitando poesie. In quegli stessi anni avevo scritto un piccolo racconto che si intitolava Storia della ragazza muta che poi parla, il cui “lieto fine” vedeva la ragazza parlare con incomprensibili nonsense. Per dire che a me era ben chiara (in qualche modo forse era ancora vigente) quella sorta di proibizione alla parola (e dunque al pensiero) che per secoli e millenni aveva investito il genere femminile. Devo confessare che allora il nostro graal non riuscimmo a trovarlo. Cosa penso ora, a distanza di oltre quarant’anni? Dico subito che non ho alcuna evidenza di una scrittura femminile fondata su dati biologici. Sono agnostica: può essere, e può anche essere di no. Tendo a pensare alla scrittura come a un meraviglioso strumento neutro, estremamente duttile, capace di essere sia femmina che maschio. Ovviamente, è impensabile che i ruoli dati dalla nostra cultura al maschile e al femminile non condizionino la scrittura. Nei testi delle donne è certamente più presente il corpo, il tempo, la cura, il quotidiano: perché questa appunto è la secolare esperienza delle donne. Il fatto nuovo è che, dagli anni Settanta del secolo scorso, i ruoli sono stati anche messi in discussione, e questo ha prodotto un’importante presa di parola da parte delle donne. Tante scrittrici, quante al mondo non vi erano mai state…
In questo testo non c’è finzione dal punto di vista letterario, in tal senso non è un romanzo o in termini di teoria della letteratura non rientra nel genere epico nel senso di Jonathan Culler. Si può parlare di un diario traslato nel tempo, scritto a sessant’anni di distanza? E dove la distanza è anche fissata dall’uso della terza persona?
Certamente l’uso della terza persona mi ha aiutato a tenere la giusta distanza da una materia che tornava alla luce dopo moltissimi anni. Una materia oscura e vergognosa. Nel senso che tendenzialmente non ci ripensavo mai, l’infanzia era una sorta di nebulosa dai contorni sfumati: pensavo di non ricordare nulla. Ho cominciato a scrivere queste pagine per me, in un tentativo di mettere insieme, di ricordare. Scrivendo, è successo che un sacco di “pezzi” si sono affacciati alla coscienza: fatti, pensieri, sensazioni. Un puzzle con molti buchi, ma anche ben fornito di pezzi. Quanto ai diari, io non ne ho mai scritto uno, ne ho cominciati diversi, ma sono rimasti quale a tre giorni, quale a dieci, massimo quindici. Erano dei pessimi diari, pieni di elucubrazioni, intenerimenti su di me, autocompiacimenti, vittimismo, illusioni. In questo libro sono stata molto attenta (è stata forse la mia preoccupazione principale) a non indulgere in nessun modo a simpatia, a non tifare per me (come dico chiaramente nella poesia in esergo). L’altra grande attenzione è stata quella di essere il più fedele possibile alla voce reale della bambina e ai suoi veri pensieri. Mi sono potuta permettere un’operazione così spudorata solo dopo i miei sessantacinque anni, e dopo un incontro molto terapeutico con il cancro, che è stato un ineguagliabile incontro di realtà.
In che modo la bambina è stata influenzata dalle prose sperimentali apparse in Europa e negli Stati Uniti dalla seconda metà del Novecento ad oggi?
Ho sempre amato le avanguardie e le sperimentazioni nell’arte, nella poesia e nel romanzo, grande ammirazione per gli oulipiani. Le cose che ho scritto prima de la bambina sono tutte sbiecamente sperimentali e confinano col nonsense. Autore adorato Lewis Carroll, ma anche Edward Lear, Lawrence Sterne, Gertrude Stein, E. E. Cummings… la bambina potrebbe essere il meno sperimentale dei miei libri, dato che tutto sommato è una biografia. In realtà, anche questo testo può forse essere considerato sperimentale per l’uso di scritture diversificate: al presente in corpo grande, le cose che succedono alla bambina; al passato tra parentesi in corpo minore, le considerazioni ex post; tra parentesi in corsivo, le poesie; annegati nel testo a illustrare le cose che succedono, i disegni tratti dalle fotografie.
Nel testo vi è una sovrapposizione di parole e disegni: mi puoi parlare del rapporto arte-scrittura sia nel libro che nella tua vita?
Lo scrivo nel libro: la bambina, in un tema di prima media in cui viene chiesto cosa si vuole fare da grandi, scrive che lei lo sa cosa vuole fare: vuole scrivere e disegnare, perché solo quando scrive e quando disegna le sembra di “pensare le cose fino in fondo”, di essere davvero “installata” in se stessa. Credo che questa sia stata la mia fondamentale presa d’identità: essere una che scrive, che disegna, che dipinge, che fa cose con le mani. Intorno ai sette anni (questo non l’ho scritto nel libro) mi ero inventata un giornalino, in realtà un quaderno con mie leziose poesiole, con disegni, con l’angolo dei lettori e della moda, con la pagina dei viaggi. Era un giornalino totalmente illustrato. Tutti i libri da me pubblicati sono illustrati da piccoli disegni in bianco e nero. Nel caso de la bambina, le illustrazioni provengono quasi tutte dalle vecchie fotografie di famiglia e i disegni sono come un’altra scrittura a testimoniare ulteriormente della veridicità del racconto.
Conoscendo parte della tua arte visiva, ho constatato come alcuni dei tuoi oggetti d’arte sono indumenti femminili. Poi ricordo con grande interesse il tuo video che ha al centro una tua testa nuda multiforme. Mi parli del rapporto arte visiva-corpo femminile?
Molti degli oggetti d’arte che tu hai visto riflettono effettivamente sul vestito e sul vestire. Nella mia prima mostra personale (Milano 2000), il centro era costituito da undici giacche-quadro, o giacche-scultura, e non a caso la mostra si intitolava Sotto mentite spoglie. L’abito riveste il corpo, lo nasconde e modifica. Lo maschera, è finzione. L’ultima mostra, A testa nuda (Roma 2015), espone la mia testa completamente rasata dipinta in varie fogge, ripresa in foto e in video. Tra mentite spoglie e testa nuda, io percepisco un percorso che è sempre più orientato a svelare il vero. Di questo percorso fa parte anche la bambina.
Appare nel testo un episodio in cui tu immagini che i vicini di casa filmino scene reali della tua adolescenza, un documento che ti sarebbe servito per ristabilire giustizia. Come si sviluppa questa istanza nel testo?
La bambina subisce una serie di allontanamenti dalla casa dei suoi genitori senza che le venga mai detto esplicitamente perché. Sente di essere trattata ingiustamente e fa mille ipotesi sulle possibili ragioni di tale ingiustizia. Questo nucleo mai compreso è come una sorta di mistero che sottende e struttura tutta la storia. E insieme quasi in ogni pagina è presente una muta richiesta di giustizia. Aver scritto questo libro che ristabilisce la veridicità dei fatti mi ha permesso di rimettere le cose al loro posto secondo giustizia. E mi ha tolto ogni residuo di vergogna.

 La lingua della poesia è per Landolfi lo spazio musicale della confessione, dell’interrogazione di sé, dell’affabulazione interiore. Una sorta di palcoscenico dell’anima. Scandaglio nel segreto di un’intimità confrontata costantemente con l’azzardo del vivere, con la pena del vivere. Esplorazione di sé affidata al suono di una parola che conosce bene l’artificio e il gioco delle maschere, e tuttavia nel suo farsi verso e ritmo, cioè tempo e insieme visione, allestisce un teatro che è rito di difesa dal nulla incombente, dal nero orlo che circonda la parola stessa.
La lingua della poesia è per Landolfi lo spazio musicale della confessione, dell’interrogazione di sé, dell’affabulazione interiore. Una sorta di palcoscenico dell’anima. Scandaglio nel segreto di un’intimità confrontata costantemente con l’azzardo del vivere, con la pena del vivere. Esplorazione di sé affidata al suono di una parola che conosce bene l’artificio e il gioco delle maschere, e tuttavia nel suo farsi verso e ritmo, cioè tempo e insieme visione, allestisce un teatro che è rito di difesa dal nulla incombente, dal nero orlo che circonda la parola stessa. 



 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese

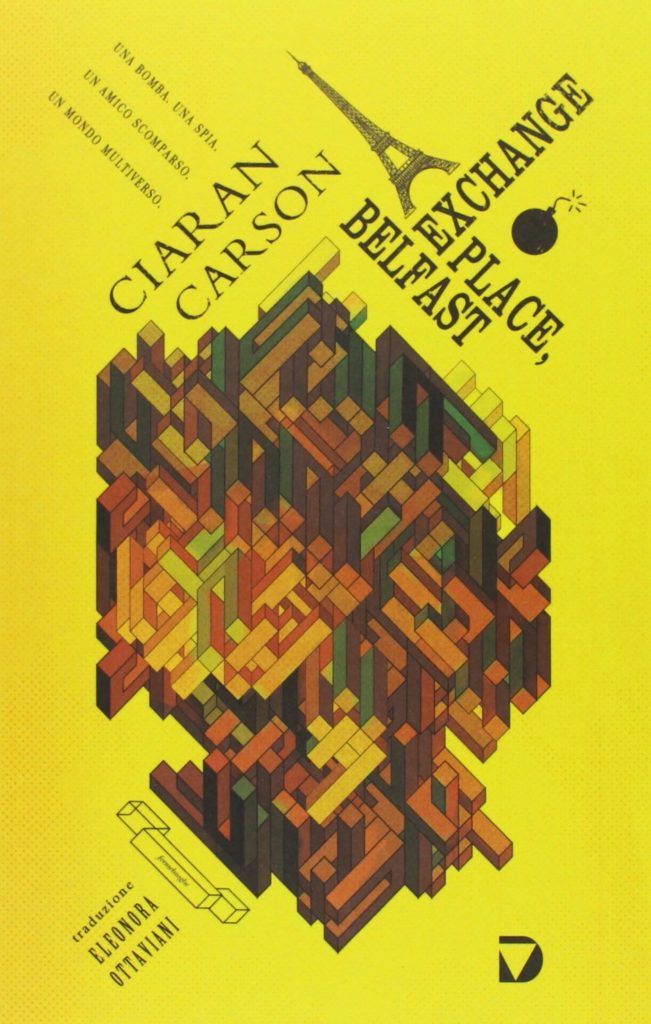

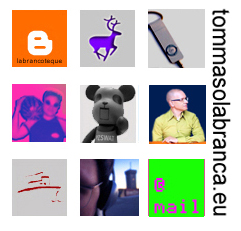 (
(