di Giacomo Sartori

Sull’utilità pragmatica del concetto di Antropocene, e sulla sua propensione, così come è nato e viene propalato, a nascondere l’origine dei singoli problemi e le responsabilità, e quindi anche a complicare l’individuazione di strategie non velleitarie per contenere le catastrofi, mi sembra che ci sia molto da discutere, moltissimo. Ma è innegabile che l’Antropocene, con i suoi sconquassi e minacce, sia ormai sotto gli occhi di tutti, ogni giorno di più. Meno noto, ma fondamentale, è che molti, tra gli altri Charles Fourier (Détérioration matérielle de la planète, 1820-21, pubblicato postumo nel 1847), l’hanno visto arrivare per tempo, e che quasi tutti i suoi passi più nefasti sono stati volontaristici e tutt’altro che consensuali, insomma politici. E quindi non era poi così ineluttabile come si da per scontato, sopravvalutando il peso della demografia, e l’umanità non è parimenti colpevole. Per quanto mi riguarda l’ho avvistato, nel mio piccolo, ben prima che il suo nome venisse coniato. E mi ha poi affiancato, come un compagno ormai inseparabile, nel lavoro che faccio.
Quando avevo sei anni la mia famiglia ha traslocato dall’appartamento che avevamo in affitto in città alla villa di mia nonna in collina. Erano solo una manciata di chilometri dalla città di distanza, ma era un altro mondo. Un complesso meccanismo dominato dalla vegetazione, addomesticata ma pur sempre fieramente autonoma, con la sua energia linfatica e i suoi cicli, e dove subordinatamente c’erano muri, viottoli, boschetti, piccole frazioni con case coloniche e qualche villa signorile. E dove si muovevano a loro agio animali di varia taglia e indole. E anche naturalmente, pure essi di casa, abitanti umani, con le loro abitudini e la loro lingua. Lì ero straniero. Sapevo intrufolarmi e farmi accettare, tessendo amicizie intrinsecamente asimmetriche, come ho poi fatto tutta la vita, ma ero un essere alieno.
Questa funzionale coabitazione di natura e essere viventi traeva la sua forza dalla continuità e dalla ripetizione, era radicata in un passato che si avvertiva molto antico. Era evidente che ogni più piccolo elemento affondava nel tempo, dal quale traeva una sua invincibile inerzia, ribadita dalla lingua e dai gesti. E proprio per questo le novità avevano dirompenza di meteore. Perché in realtà tutto stava cambiando. Un’estate è comparsa una falciatrice a motore, pilotata da un ragazzino appena più grande di me seduto come un motociclista, che con le sue due larghe chele di aragosta faceva in due ore il lavoro che richiedeva molte giornate di fatica con la falce. E l’anno dopo è comparso un trattore a cingoli Fiat, che avanzava minaccioso e ostinato con un frastuono di ferraglia, e con le sue unghie dure incideva le carreggiate e faceva tremare la nostra vecchia casa come ci fosse un terremoto. E subito sono scomparsi, subito non ci ho fatto caso che le due cose erano legate, i buoi, diventati ingombranti e desueti. D’improvviso basti, finimenti, fruste, aratri di legno, erano reperti impolverati e quasi curiosi.
La stradetta secolare cinta sui due lati da alti e bianchissimi muri a secco che saliva dal paese a valle, è stata trasformata in carreggiabile a doppia corsia, dove ci passava comodamente un autobus, delimitata da cemento. L’asfalto guadagnava terreno come una lingua ingorda, mangiandosi perfino il saliscendi finale per arrivare da noi, un tratto della via romana Claudia Augusta. Per decenni ha resistito solo la piazzetta del borgo, poi quando si è riempita di auto è stata sigillata anche quella. In pochi anni la plastica ha invaso case e aie, le spazzature sono proliferate come infestazioni micotiche, e la dieta è cambiata: la pasta ha sostituito la polenta di mais, la carne è diventata normale. Intere piane sono state invase da caseggiati di calcestruzzo e parcheggi. La vita era più facile e molto meno dura. Nessuno dei giovani faceva più il contadino a tempo pieno, semmai era un secondo lavoro, finiti i turni in fabbrica. Prima di bere l’acqua delle fontane bisogna però vedere se c’era scritto che era potabile. E anche la frutta non si poteva più mangiarla dall’albero. Le lucciole e le rondini si sono diradate, e poi sono scomparse per sempre. Le fumosità marroncine che tappavano ormai la valle hanno preso l’abitudine di salire verso di noi. A cose ormai concluse, sarebbe poi arrivata anche la nuvola micidiale di Chernobyl. Moltissime persone morivano di cancro, vai a sapere le cause precise.
Tutto stava cambiando, e mia nonna si stizziva, sentiva che lei non poteva stare con le mani in mano. Era già anziana, e ormai del grande patrimonio non restava quasi più niente, però doveva muoversi, se non voleva rimanere tagliata fuori. Si è sbagliata anche in quello. Ha comprato un cavallo magro e collerico, che non ha mai ubbidito a nessuno, e un carro troppo pesante, che non è mai uscito dalla rimessa. Non aveva capito che la rivoluzione era ben più radicale, e era basata – i lontani anni in America avrebbero dovuto metterla sulla via buona – sui motori. Del resto i suoi vigneti erano troppo pendenti, per portarci le macchine.
Senz’altro la mia scelta di studiare agronomia va ricondotta in qualche modo a quel groviglio di natura e tecniche umane che mi aveva tanto colpito. Mi sono iscritto a Firenze, facoltà rimasta inceppata nell’Ottocento, e per certi versi al Rinascimento. Tra gli allievi c’erano conti e marchesine bronzineschi, e erano completamente assenti i computer, la statistica, i modelli matematici. C’era però una rinomata scuola sui suoli, e io ho fatto una tesi in quel campo, e poi ho continuato per tutta la carriera a occuparmi solo di terra. Noi specialisti ci sgolavamo per dire che i terreni soffrivano, spesso morivano, erano spazzati via. Nessuno ci ascoltava, eravamo visti come patetici passatisti. Solo negli ultimi anni ci si è resi conto che le terre coltivabili sono limitate e fragili, e sono insostituibili. Spesso però è troppo tardi.
Studiavo soprattutto i suoli di montagna, che interessavano ancora meno. Un pomeriggio ho sorpreso il direttore della istituzione per la quale lavoravo che mi prendeva in giro per la mia attrezzatura e la mia strumentazione antiquate. Un professore di Zurigo è però venuto a cercarmi: quegli studi antiquati che avevo fatto, che legavamo i caratteri dei suoli all’altitudine, e insomma al clima, potevano essere utilizzati secondo lui per prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici. In Italia nessuno parlava di cambiamenti climatici, lì da loro li davano per scontati. Abbiamo lavorato per tanti anni assieme. Lui era il mago delle tecniche più innovative, io ero principalmente il braccio organizzativo, che conosceva come le sue tasche i terreni di montagna e le loro minime paturnie, però insomma respiravo anch’io quel fermento scientifico. Finché è arrivata la crisi, e fondi per quelli studi, e più in generale ambientali, nel nostro paese non ce ne sono più stati. Avevo comunque imparato che di molte questioni basilari, e men che meno degli intrichi di correlazioni che caratterizzano gli ambienti complessi, non ne sappiamo nulla, e che non si può modellizzare ciò che non si conosce. Di qui la mia diffidenza per i cosiddetti modelli climatici, e per la scienza stessa, che da sola – senza coinvolgere gli uomini e le loro strane passioni – non può dare risposte.
Negli anni successivi ho dovuto ripiegare sui terreni dei meleti e dei vigneti, dicendomi – certo ingenuamente – che conoscendoli beni si sarebbero potuti proteggere e risparmiare, limitando i danni al contorno. Anche lì quello che facevo e faccio non interessava quasi a nessuno, lasciando stare le parole. Gli istituti di ricerca parlano e spendono per l‘agricoltura di precisione, come se le conoscenze di base, che mancano, potessero essere surrogate dai gps e dai sensori dei droni, o dall’intelligenza artificiale. E si inebriano di ingegneria genetica, come se si potesse far quadrare il cerchio delle risorse energetiche e degli inquinamenti con quella. Quando ogni vero conoscitore dell’agricoltura del mondo, e non solo dei paesi ricchi, sa che sono le tecniche antiche che sfamano, e sfameranno, la maggior parte degli uomini, dando sollievo al pianeta. E che solo tornando a quelle, certo affinandole e migliorandole, potremo forse sopravvivere. Ma queste cose gli antropocenisti, inebriati dalle stesse tempeste tecnologiche delle quali vituperano gli effetti, e sviati da fantascientifici sogni di redenzione, non le sanno, e forse non le vogliono sentire.
NdA: queste consideraizioni mi sono venute riflettendo in vista del dibattito di oggi al Book Pride di Genova, moderato da Michele Vaccari, e con Laura Pugno, Matteo Meschiari e il sottoscritto: Dopo la grande cecità. Scrivere l’Antropocene.












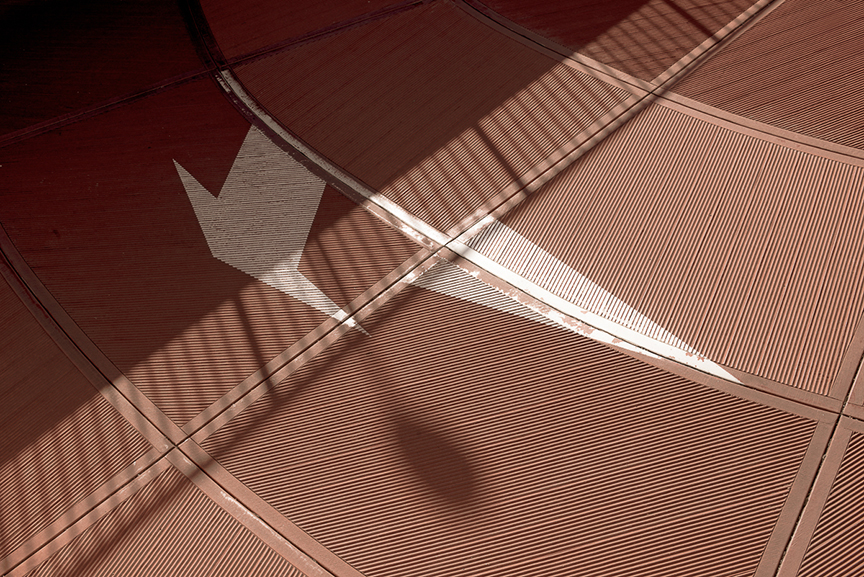

 di
di Dalla archeologia del pop sixty di Son Of a Lovin’ Man dei Buchanan Brothers alle rimasticature r&b di Mitch Ryder & The Detroit Wheels con Jenny Take A Ride. Siamo su un ottovolante sparato a tutta velocità nella musica anni Sessanta. La giostra è condotta dai parrucconi delle case discografiche impegnati ad estrarre i soldi dalle tasche della gioventù americana ancora lontana dalla ribellione, grazie a una musica-merce, senza velleità artistiche o sociali. Il gioco sui registri alto/basso della cultura ci fa salire altissimi con un Neil Diamond, che per rubare la battuta a uno dei personaggi del film, Sam Wanamaker/Nicholas Hammond: «cattura la zeitgeist dei tempi», e poi si scende in basso con una Hey Little Girl di Dee Clark che avrebbe giustificato una carneficina da parte del buon Bo Diddley. Come spiegare il guazzabuglio musicale messo in piedi dal Quentinone? Rileggiamo in chiave 45 giri il mito di Superman di Umberto Eco? Lo consideriamo solamente del pulp musicale? Non serve: stappiamoci una Old Chattanooga Beer sul divano con Cliff/Pitt, usando un citazionismo appropriato a Tarantino: «Da quel gran paraculo che è», come ha scritto Luca Giannelli su Intellettuale dissidente. La musica comunque gira. Dov’è che toppa il film, allora? Nel non avere utilizzato la stessa precisione per dipingere il quadro sociale.
Dalla archeologia del pop sixty di Son Of a Lovin’ Man dei Buchanan Brothers alle rimasticature r&b di Mitch Ryder & The Detroit Wheels con Jenny Take A Ride. Siamo su un ottovolante sparato a tutta velocità nella musica anni Sessanta. La giostra è condotta dai parrucconi delle case discografiche impegnati ad estrarre i soldi dalle tasche della gioventù americana ancora lontana dalla ribellione, grazie a una musica-merce, senza velleità artistiche o sociali. Il gioco sui registri alto/basso della cultura ci fa salire altissimi con un Neil Diamond, che per rubare la battuta a uno dei personaggi del film, Sam Wanamaker/Nicholas Hammond: «cattura la zeitgeist dei tempi», e poi si scende in basso con una Hey Little Girl di Dee Clark che avrebbe giustificato una carneficina da parte del buon Bo Diddley. Come spiegare il guazzabuglio musicale messo in piedi dal Quentinone? Rileggiamo in chiave 45 giri il mito di Superman di Umberto Eco? Lo consideriamo solamente del pulp musicale? Non serve: stappiamoci una Old Chattanooga Beer sul divano con Cliff/Pitt, usando un citazionismo appropriato a Tarantino: «Da quel gran paraculo che è», come ha scritto Luca Giannelli su Intellettuale dissidente. La musica comunque gira. Dov’è che toppa il film, allora? Nel non avere utilizzato la stessa precisione per dipingere il quadro sociale. Vorrei iniziare questa conversazione su la bambina (il verri, 2018, collana diretta da Milli Graffi), ritratto autobiografico di un’infanzia vissuta tra due famiglie, quella d’origine e quella adottiva, negli anni Cinquanta, soffermandomi su quella che a me sembra una questione centrale: lo sviluppo dell’identità femminile. Sia la protagonista che gli altri personaggi in primo piano sono donne. In questo senso si può parlare di un’identità femminile fluida e multiforme che dalla protagonista fluisce verso gli altri personaggi?
Vorrei iniziare questa conversazione su la bambina (il verri, 2018, collana diretta da Milli Graffi), ritratto autobiografico di un’infanzia vissuta tra due famiglie, quella d’origine e quella adottiva, negli anni Cinquanta, soffermandomi su quella che a me sembra una questione centrale: lo sviluppo dell’identità femminile. Sia la protagonista che gli altri personaggi in primo piano sono donne. In questo senso si può parlare di un’identità femminile fluida e multiforme che dalla protagonista fluisce verso gli altri personaggi? La lingua della poesia è per Landolfi lo spazio musicale della confessione, dell’interrogazione di sé, dell’affabulazione interiore. Una sorta di palcoscenico dell’anima. Scandaglio nel segreto di un’intimità confrontata costantemente con l’azzardo del vivere, con la pena del vivere. Esplorazione di sé affidata al suono di una parola che conosce bene l’artificio e il gioco delle maschere, e tuttavia nel suo farsi verso e ritmo, cioè tempo e insieme visione, allestisce un teatro che è rito di difesa dal nulla incombente, dal nero orlo che circonda la parola stessa.
La lingua della poesia è per Landolfi lo spazio musicale della confessione, dell’interrogazione di sé, dell’affabulazione interiore. Una sorta di palcoscenico dell’anima. Scandaglio nel segreto di un’intimità confrontata costantemente con l’azzardo del vivere, con la pena del vivere. Esplorazione di sé affidata al suono di una parola che conosce bene l’artificio e il gioco delle maschere, e tuttavia nel suo farsi verso e ritmo, cioè tempo e insieme visione, allestisce un teatro che è rito di difesa dal nulla incombente, dal nero orlo che circonda la parola stessa. 



 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese

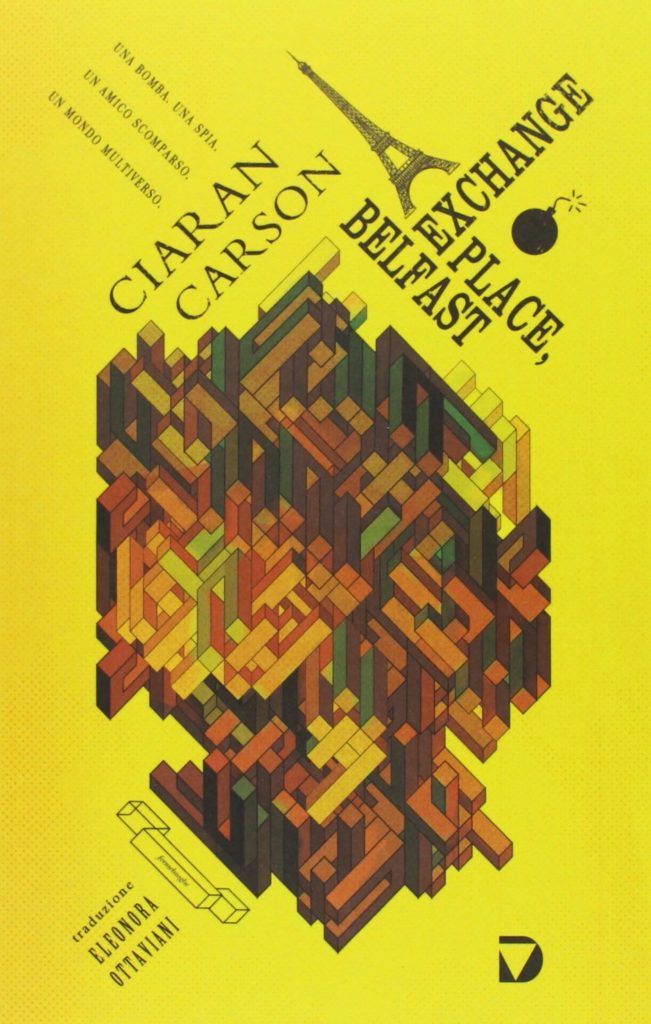

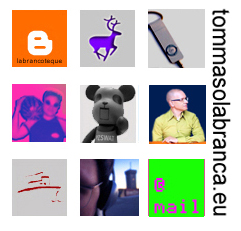 (
(

















